NOTE SU COSTITUZIONE E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE
II PARTE
Secondo la tesi di Leibnitz, sopra cennata, teologia e giurisprudenza si basano ambedue su scriptura e ratio; a giudizio di Gierke (prima ricordato) i teologi-giuristi della Seconda Scolastica si servivano con dovizia della ratio. Questo sia per il carattere razionalista della teologia cristiana, sia perché il diritto positivo costituiva solo una parte del diritto, sia perché la rivelazione divina (la scriptura) non era un insieme univoco, esauriente e per così dire, “privo di lacune” che l’interprete non dovesse colmare. In particolare la distinzione fondamentale concerneva ciò che è necessario, perché corrispondente all’ordine creato da Dio – e quindi il diritto naturale – e ciò che era frutto di decisione (divina o umana). Mentre il primo non poteva essere altro da quello che era, il secondo era rimesso alla determinazione della volontà di chi lo poneva in essere. Anche Sieyès riteneva che “Una Nazione si costituisce solo in virtù di un diritto naturale. Un governo, al contrario, è frutto solo del diritto positivo. La Nazione è tutto quel che può essere per il solo fatto di esistere”.[41] Tale distinzione era stata (in parte) ripresa (e sviluppata) da Hegel nella formulazione sopra riportata[42], tra ciò che è necessario perché una moltitudine sia uno Stato (e quindi costituisca un potere comune) e ciò che essendo solo un modo di esistenza dello Stato, appartiene “alla sfera del caso e dell’arbitrio”. Trasponendola al diritto pubblico, ciò che rende possibile la stessa esistenza dello Stato, ne pone e collega gli elementi necessari perché l’istituzione (e la comunità) esista ed agisca, è costituzionale, anche se nessun testo (o dichiarazione costituzionale) la qualifica come tale: è costituzionale per natura, non perché una dichiarazione, per quanto solenne lo statuisca[43]. Anzi è esso che, nell’extremus necessitatis casus prevale sulla vigenza dell’apparato normativo (ed anche sull’assetto “normale” dei poteri) così come, con massima evidenza) nel momento genetico è l’esistenza di quello che consente al diritto – da esso posto o riconosciuto – abbia validità ed efficacia. Ma in quanto è costituzionale in se, non c’è nessuna norma che possa “costituirlo” né eliminarlo ( e tanto meno modificarlo); onde per comprenderlo non occorre alcuna scriptura, ma necessita la ratio. E infatti la ratio appare la sola via per capire ciò che è necessario, non essendo modificabile da una decisione umana, con la conseguenza che, anche se vi fosse – ed è anche capitato che vi siano – decisioni umane, anche espresse in testi costituzionali, che contraddicano ciò che è necessario, sono inapplicabili, in primo luogo (e quel che poi conta) nella concreta realtà, e, di conseguenza, non possono essere oggetto di comandi eseguibili, quindi neppure interpretabili in quel senso. E’ appena il caso di ricordare quanto scriveva Spinoza che il sovrano può far tutto ma non modificare le leggi di natura (ovvero ciò che è necessario), e comandare cose impossibili come toccare gli anelli di Saturno o sedersi sugli angoli del triangolo (ad impossibilia nemo tenetur), o superflue perché non rientranti nell’ambito (delle possibilità di violazione e con ciò) della libertà umana (ad es. ordinare di rispettare la legge di gravità). Quel che più rileva è come in quel necessario non rientra soltanto ciò che è riconducibile alle leggi naturali (c.d. limite ontologico), ma ciò che è riconducibile alle costanti dell’azione sociale umana: come la necessità della comunità politica e dell’ordine (v. sopra); dell’assetto gerarchico del potere; della classe politica[44] .
Mano a mano che dal necessario (in senso assoluto) si passa al (relativamente) necessario[45] e all’accidentale (direbbe Hegel) si riduce l’uso necessario della ratio e cresce quella della “scriptura”, cioè della statuizione (scritta), in quanto tale oggetto d’interpretazione (nel senso tradizionale, anche se con le specificità dovute al carattere costituzionale della materia). Ad esempio, per qualificare democrazia il regime frutto della decisione costituente occorre che sia prescritto il diritto d’accesso di tutti i cittadini alla funzione pubblica (art. 51 della Costituzione) che è considerato una delle condizioni, (necessaria anche se non sufficiente) perché esista una democrazia politica da 25 secoli (cioè dal famoso passo di Tucidide in cui riporta il discorso di Pericle per i caduti della prima fase della guerra del Poleponneso): Una norma che, di converso, escludesse dall’accesso la grande maggioranza dei cittadini, sarebbe a dispetto della dichiarazione costituzionale contraria, istitutiva di un regime oligarchico.
In una recente polemica, reperibile in rete[46] si possono trovare motivi e spunti su cosa possa essere l’interpretazione della costituzione, sotto il profilo di differenti teorie del diritto. Secondo Baldassarre i tratti fondamentali del positivismo giuridico sono:
– “il diritto (oggettivo) è «posto da una volontà (se no, perché chiamarlo «positivismo»?), nel senso che è il prodotto di un «potere» o di un’autorità, ossia è un atto di volontà di un sovrano precostituito (ora soggettivizzato, come lo Stato, la Nazione, il Popolo o altro Soggetto politico; ora oggettivizzato nell’ordinamento normativo, sia quello nazionale o internazionale, sia l’una o l’altra delle norme fondamentali che si impongono «di fatto»);”
– “il diritto (oggettivo) consiste in norme assistite da una sanzione (istituzionalizzata), vale a dire consiste in norme coattive;”
– “l’applicazione del diritto (norma,legge) è il frutto di una deduzione logica, di modo che la decisione di un caso (controversia) è sempre la conclusione di un «sillogismo deduttivo (o sussuntivo)», derivante da una scelta (valutazione) interamente ascrivibile al «legislatore», ossia alla «volontà» di chi ha posto la norma considerata (sovrano).”
Da cui conclude che “questi tratti comuni ad ogni approccio giuspositivista (esclusivista)… si siano dissolti nella vita pratica del diritto costituzionale dell’ultimo cinquantennio (in Europa)”.
Ad avviso di Guastini, che cita Bobbio, l’espressione positivismo giuridico “è di fatto usata per denotare non una sola ed univoca corrente di pensiero, ma tre modi di vedere distinti e logicamente irrelati tra loro: il positivismo «metodologico», il positivismo «teorico», e il positivismo «ideologico»” di cui il positivismo teorico è “grosso modo, la teoria del diritto, dominante nel secolo XIX: quel modo di vedere secondo cui le norme giuridiche (ivi incluse quelle consuetudinarie) sono interamente riducibili a comandi coattivi del sovrano politico (i. e., di un legislatore umano), un ordinamento giuridico è un insieme di norme completo e coerente, l’interpretazione del diritto è atto di conoscenza(non di volontà), la sua applicazione è attività logico-deduttiva.”. Avendo sostenuto Baldassarre “ che l’antica massima hobbesiana –vero manifesto del positivismo giuridico in tutte le sue forme-auctoritas, non veritas, facit legem sia ormai inattuale. Se ne deve concludere che nello stato costituzionale di diritto “ratio,non auctoritas, facit legem”. Una tale tesi non è condivisa da Guastini “La tesi che il diritto nasca non dall’autorità, ma dalla “verità” o dalla “ragione” (così sostiene Baldassarre), significa che le norme giuridiche sono il prodotto non di atti di volontà, bensì di atti di conoscenza: di conoscenza, dobbiamo supporre, non della (eterna) “natura” umana, bensì dei “costumi” e della “coscienza sociale”. E ciò implica che le norme giuridiche – proprio come le proposizioni scientifiche – possono dirsi vere o false. Tesi classica dei giusnaturalisti, d’altronde, i quali disgraziatamente non hanno mai saputo indicare a noi, poveri giuspositivisti, quali mai possono essere i criteri di verità degli enunciati del discorso prescrittivo.”
In questo riepilogo – largamente parziale e sintetico di quanto scritto – entrambi gli autori presuppongono che la costituzione sia un atto (documento) scritto e statuito (mentre per le parti più importanti, non è scritto e neppure statuito): nell’esposizione di Baldassarre una importanza decisiva (specie per le sentenze dei giudici costituzionali) riveste il fatto che le costituzioni (cioè gli atti/documenti) contengono enunciazioni di principio e statuizioni di valore, onde l’applicazione/interpretazione consiste in una valutazione di compatibilità “tra due distinti ordini di «principi»: quelli stabiliti, secondo una certa gerarchia e un certo ordine di preferenza, dalla costituzione e quelli implicati… dalla «regola (generale e astratta)» contenuta nella norma legislativa della cui costituzionalità si dubita”. Tale è il modo di “operare di tutte le corti costituzionali occidentali”.
Tuttavia sia che si tratti d’interpretare norme, sia di applicare principi (e/o valori) le due posizioni si riferiscono entrambe al diritto statuito (e scritto) tralasciando così tutto ciò che non è scritto né statuito[47]. Quanto all’altra questione– che più interessa ai fini del presente scritto – se il diritto nasca dall’autorità o dalla ragione (verità), occorre appena ricordare che un simile dilemma (se la legge sia atto della volontà e dell’intelletto) era stato largamente dibattuto dai teologi[48] e la soluzione che dava Suarez non era un “aut…aut” ma un “et…et”, nel senso che la legge era atto sia d’intelletto che di volontà[49]. La legge positiva è sia ratio che voluntas; che sia la seconda è evidente; e che presupponga (e incorpori) anche la ratio (quasi altrettanto) evidente, giacché una legge bizzarra e/o superflua non è suscettibile di esecuzione e coazione, diventando così una bizzarria normativa, non potendo essere un comando eseguibile.
Se, come sostiene chi scrive, la costituzione non è (solo) un atto, e spesso neanche scritto, resta da vedere come si possa interpretare/applicare ciò che non è né scritto né statuito.
Nella realtà un problema siffatto è familiare al giurista: che come regola di una decisione (ad es. giudiziaria) il legislatore imponga all’interprete di ricavare il diritto da un comportamento (cioè da un fatto) è disposto (ad es. dall’art. 1362 c.c., o dalla previsione della consuetudine come fonte di diritto). Nel diritto internazionale è quello, analogo, dello jus non scriptum internazionale; la cui applicazione chiede in primo luogo l’accertamento storico dell’effettiva vigenza (e ancor prima esistenza) della norma.
Fatta questa premessa la disposizione costituzionale interpretanda può non essere formulata nello schema abituale “Se F (fattispecie), allora G (conseguenza giuridica)[50]” o in qualche formulazione analoga (cara alla giurisprudenza analitica); e ancor più la disposizione spesso non è espressa neanche come principio (cioè di guisa da non collegare la fattispecie alla conseguenza giuridica), e talvolta non espressa (non “statuita”). Ma se interpretare è per lo più enucleare il significato di un testo normativo, in tal caso il significato deve essere ricavato da rapporti, fatti, comportamenti (e principi) inespressi il che non è inconsueto, anche se, in un ordinamento moderno, meno frequente.
Piuttosto un’interpretazione/applicazione costituzionale richiede un cambiamento di prospettiva, che pone in secondo piano la classica dicotomia sein/sollen, per riportare in auge quella dell’Amleto: essere o non essere. Inteso in un doppio significato: che il normativo presuppone l’esistente e che l’esistente prevale sul normativo, che potremmo chiamare limite naturale e criterio funzionalistico –teleologico. Nel limite naturale non c’è solo quello ontologico, ma in genere ogni condizionamento necessario dovuto a leggi, anche dell’agire sociale; così una costituzione non può essere interpretata nel senso che non costituisca rapporti di comando/obbedienza, perché ogni comunità politica, per esistere, necessita di qualcuno che comanda e altri che obbediscano. Così, ma sul punto rinviamo alla prima parte di questo lavoro, il senso della massima salus rei publicae suprema lex, è che l’esistente (la comunità) prevale sul normativo, onde il diritto dev’essere interpretato-applicato nel senso di salvaguardare l’esistenza collettiva e non l’esattezza dell’interpretazione/applicazione delle norme o dei valori o della giustizia, implicita nella (contrapposta) espressione fiat justitia, pereat mundus.
In entrambi i casi è così l’essere che condiziona in modo cogente il dover-essere, nel primo caso perché l’ordine comunitario, se non si osservano le leggi naturali (nel senso precisato) neppure può venire ad esistenza, o la conduce breve e grama; nel secondo perché verrebbe meno alla prima crisi (seria). Ma dato che, come scriveva Jhering, il diritto serve alla vita è pertanto da interpretare di guisa da conservare l’ordine e la vita comunitaria (ed individuale).
D’altra parte il limite “ontologico” all’applicazione dei precetti (norme, comandi) giuridici è già “codificato” non solo nel codice civile vigente (v. il combinato disposto dell’art. 1418-1346 c.c. sull’impossibilità dell’oggetto come causa di nullità del contratto) ma fin dalla giurisprudenza romana come risulta dai brocardi impossibile habetur id, cui natura impedimento est quominus existat; impossibilium nulla est obligatio; quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt.
Piuttosto da ciò derivano due problemi: il primo, quello cennato, e dato per scontato che l’obbligo (dovere, obbligazione) relativo ad un oggetto impossibile per natura è nullo, occorre ricordare che lo stesso trattamento compete alla norma (precetto, obbligo, ordinamento) che pretende di violare le leggi del funzionamento e dell’equilibrio sociale, come risultano dall’uniformità sperimentale e (talvolta) dalla stessa analisi razionale. Come è (a dir poco) bizzarro presupporre una società politica senza comando, obbedienza, potere, così lo è concepire un’attività economica senza scarsità dei beni. Il secondo problema è che quei brocardi citati (ed altri) sono la conversione in termini giuridici di constatazioni e valutazioni di fatto. Potrebbe sembrare che così si violi la “legge di Hume” per la quale non è possibile dedurre giudizi precettivi da proposizioni assertive [51]. La tesi che le norme giuridiche (come il diritto) non possa essere dedotto dalle leggi di natura è stata più volte esposta – tra gli altri – da Kelsen[52]; il quale – ma non solo il giurista viennese – aveva sottolineato tuttavia un’essenziale distinzione tra diritto e morale, relativa al modo in cui essi prescrivono o vietano un certo comportamento umano[53].
Tale distinzione, ancora più dell’altra, spesso ripetuta, che il diritto sanziona comportamenti “esterni”, mentre la morale sanziona (soprattutto) quelli interni, costituisce la differenza fondamentale tra dovere giuridico e morale: esserci o meno un apparato coercitivo deputato (anche) a (prevenire e ) reprimere le violazioni del diritto (come ad incentivare l’osservanza dello stesso). Ma la violazione dev’essere possibile, la coazione – che è l’essenza della differenza – dev’essere esercitabile, così come l’obbligazione giuridica eseguibile. Come sopra cennato, un legislatore che prescrivesse di sedersi sugli angoli del triangolo, produrrebbe solo ilarità[54], ma nulla di concretamente efficace[55].
Contrariamente a quanto giudicava Hume per la morale, nel diritto che un obbligo sia coercibile o meno non è un giudizio di valore, un sollen, ma un sein. Pertanto il legislatore (o nel caso di altri precetti giuridici – e con le dovute diffferenze -, il giudice o il funzionario) compie sia un giudizio di “fatto” che una scelta di valore, nel formulare le norme legislative[56].
Anche Bobbio considerava connotato peculiare dell’ordinamento giuridico la coazione[57] pur precisando per l’appunto che “la teoria del diritto come regola della forza, sin qui esaminata, è una teoria non già della norma giuridica isolatamente considerata, come la teoria tradizionale, ma dell’ordinamento giuridico nel suo complesso”[58].
Ciò conferma che, da un lato, la differentia spaecifica del diritto, rispetto alla morale, è la coercibilità; dall’altro che, proprio per ciò l’applicazione al diritto della legge di Hume – pensata e scritta per la morale – necessita di adattamenti di guisa da non poter essere di carattere esclusivo e portata generale. Una cosa è sanzionare con qualche anno di Purgatorio i peccati; altro è adempiere un contratto d’appalto per la costruzione di una villa su Marte (o chiedere al Giudice la relativa esecuzione dell’obbligo di fare – art. 2931 c.c.). Ogni precetto richiede (quanto meno) un giudizio sulla di esso coercibilità/applicabilità/efficacia. Per cui ogni precetto giuridico consta di un duplice giudizio sia al momento della statuizione che a quello dell’applicazione: è sia un atto di conoscenza che di volontà: la tesi di Suarez (e non solo) appare confermata[59].
Infatti giudicare che un’obbligazione sia possibile è una constatazione (un giudizio) di fatto; il giudizio che tutte le costituzioni disciplinano il rapporto di comando/obbedienza (cioè il potere) può essere storicamente (e sociologicamente) verificato e così anche i corollari di questo. Ovvero che se c’è un potere di comando obbedito allora c’e una costituzione (Hegel e Santi Romano); se questo non c’è – viceversa – non vige la costituzione (nel senso di costituzione statale) – e neppure esiste lo Stato; e che una costituzione non è interpretabile nel senso che non costituisca e disciplini rapporti di comando-obbedienza: E il tutto è applicabile anche agli altri “presupposti del politico”: pubblico-privato, amico-nemico, tutti verificabili storicamente e sociologicamente.
Ulpiano sosteneva Ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto (D I, 1, 6). Concezione condivisa quindi (e per lo più) da (almeno) diciotto secoli. Ma che negli ultimi due appare un po’ in affanno. Un ausilio a capire la ragione ce l’offre Max Weber, il quale nel delineare i presupposti del potere razionale-legale (cioè la rappresentazione del potere prevalente nelle concezioni moderne) ne indica (tra gli altri) i seguenti: “ Il potere legale riposa sulla validità dei seguenti presupposti, tra loro connessi: che qualsiasi diritto possa essere statuito rispetto al valore o rispetto allo scopo (o a entrambi), mediante pattuizione o imposizione…che ogni diritto sia nella sua essenza un cosmo di regole astratte, e di norma statuite di proposito, che la giurisdizione costituisca l’applicazione di queste regole al caso particolare…il tipico detentore del potere legale – il «superiore» – mentre dispone e insieme comanda, da parte sua obbedisca all’ordinamento impersonale in base al quale orienta le sue prescrizioni…che i membri del gruppo – in conformità al n. 3 – obbedendo al detentore del potere obbediscano non alla sua persona, ma a quegli ordinamenti impersonali”[60]. L’identificazione della costituzione con un atto scritto e statuito appare quindi conseguenza della fede dei moderni nella legittimità del potere razionale-legale, d’altra parte enunciata nello (spesso ricordato) art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, dove, oltre ad essere enunciati i principi dello Stato borghese è formulata la concezione della costituzione come statuizione consapevole (e scritta) al punto di negare il carattere di costituzione agli ordinamenti privi di queste caratteristiche[61]. Com’è noto questo non era il concetto di costituzione di Weber secondo il quale “Per costituzione di un gruppo si deve intendere la possibilità effettiva di disposizione a obbedire – possibilità diversa per misura, specie e presupposti – nei confronti della forza di imposizione dell’autorità di governo sussistente” e precisa “ Il concetto di «costituzione» qui impiegato è uguale a quello usato da Lassalle: Esso non coincide con il concetto di una costituzione «scritta», e in genere di costituzione in senso giuridico. La questione sociologica è semplicemente la seguente: accertare quando, per quali oggetti ed entro quali limiti, ed eventualmente in base a quali presupposti particolari (per esempio in base all’approvazione di divinità o di sacerdoti, o al consenso di comizi elettorali) i membri del gruppo si piegano al capo”[62];concezione imperniata sul rapporto comando-obbedienza.
Il carattere necessario dei presupposti costituzionali condiziona l’interpretazione, dato che senza quelli non c’è né esistenza né capacità di azione politica. Chiedersi se la norma (costituzionale) o il valore (costituzionale) sono stati violati presuppone che ci sia unità politica e ordinamento giuridico senza i quali non si capisce come far rispettare le une e gli altri. Vale il giudizio di Hegel che lo Stato è la “realtà della libertà concreta”[63]; o come scriveva Croce “prima vivere e poi filosofare, prima essere e poi essere morale”[64]; e il giudizio del filosofo si adatta bene al rapporto tra esistenza dell’istituzione, i principi e le norme che impone o i valori cui fa riferimento. Senza vita (e vitalità) di quella non c’è possibilità di applicare o di realizzare questi. Così si può aggiungere che se le norme cambiano – spesso vorticosamente – pur lasciando sostanzialmente inalterata l’istituzione; e anche i principi e i valori mutano – anche se più lentamente – l’istituzione – Stato – è sempre la stessa, anche nel mutamento di norme, valori (e classi dirigenti), per cui, secondo i principi del diritto internazionale risponde degli obblighi contratti verso gli altri Stati, cui quei cambiamenti (di norme e/o valori) sono del tutto indifferenti.
Così l’Italia ha cambiato tre costituzioni (liberale, fascista e repubblicana) e relative “tavole di valori” senza che fosse alterata la (continuità dell’) istituzione statale. Consegue da ciò che né norme né valori possono essere interpretati nel senso che mettano in pericolo l’esistenza (e la capacità d’azione) dell’istituzione.
Nel caso questo si verifichi è l’esigenza primaria (d’esistenza) che deve prevalere sulle altre. Il tutto non è “negoziabile” né “bilanciabile” e non per la ragione onde si ritengono tali (e sottratti anche alla revisione costituzionale) i principi fondamentali (o i valori altrettanto fondamentali) della Costituzione, ma perché – come sostenuto – il normativo presuppone l’esistente[65]. E mentre questo può cambiare quello, di converso il primo non può modificare il secondo.
- La conseguenza è che, al contrario di quanto spesso si pensa, ogni conseguenzialità (e coerenza) normativa non può prevalere sull’esistenza comunitaria. In caso contrario la massima di Jhering, già sopra ricordata, che il diritto è un mezzo finalizzato alla vita sarebbe capovolta nel senso che la vita (l’esistenza) è un mezzo del diritto. Come sopra cennato, una Corte costituzionale – o un altro organo pubblico – che interpretasse il sistema normativo nel senso di attentare all’esistenza concreta (alla salus rei publicae), anche se normativamente (e logicamente) fondata (nel senso “corrente”), sarebbe invalida. Anzi potrebbe costituire (in tutti gli ordinamenti vi sono norme volte a tutelare l’esistenza e l’unità politica) un illecito penale tra i più gravi (attentato alla costituzione, usurpazione e via emunerando).
La massima fiat justitia pereat mundus non vale per gli organi statali costituiti: non è nel loro potere distruggere l’istituzione e la comunità[66], da cui dipende il loro esser costituiti.
Se si ammette, come molti giuristi, e tra questi Santi Romano, che la necessità sia fonte di diritto, vale la regola necessitas non habet legem (e infatti imporre una legge alla necessità è un bisticcio logico e una contraddizione concreta); regola che è anch’essa la specificazione della prevalenza dell’esistente (e della conservazione dell’esistente) sul normativo[67].
Per cui se per necessità è consentita la deroga alla legge (o la normazione praeter legem) a ratione majus la necessità costituisce criterio di giudizio per valutare la costituzionalità (o meno) di presunte trasgressioni alla costituzione.
- Dato che il significato usuale dell’interpretazione (e dell’attività interpretativa) è l’attribuzione di significato a un testo, un segno, un simbolo[68], ove si tratti d’interpretare lo jus involuntarium, l’operazione (prima) che si richiede all’interprete è la ricostruzione (l’individuazione) del precetto applicabile.
È stato sopra cennato come questo sia familiare al giurista. È chiaro che la ricostruzione del precetto può avvenire (talvolta) applicando i principi della logica deduttiva (identità, non contraddizione, terzo escluso e quanto ne consegue) ma per lo più attraverso verifiche storiche e sociologiche (e combinandoli, se necessario, con i primi). Ad esempio la vexata (in Italia) quaestio della legittimità costituzionale delle deroghe alla giurisdizione ordinaria (nel caso di processi a carico di personale politico apicale). Se si parte dal principio d’uguaglianza è chiaro che la deroga (di qualsiasi genere) possa essere facilmente ritenuta contrastante con quello[69]. Ma se si parte dalla natura dell’istituzione, dal carattere della forma di governo e li si verifica anche in concreto, la conclusione è opposta. Occorre tener presente quanto scriveva Santi Romano sullo jus involuntarium, la cui prima specie era costituita dai “principii generali o fondamentali che sono impliciti nella stessa esistenza dello Stato, nella sua struttura, e nei suoi atteggiamenti concreti, dai quali sono da esprimersi e desumersi. Se alla c.d. «natura delle cose» o «dei fatti» non si può riconoscere valore di vera e propria fonte formale del diritto, lo stesso non è da ritenersi per la natura delle istituzioni e, quindi, in primo luogo dello Stato, giacché queste sono da per sé diritto positivamente vigente”[70].
Per cui, operando una verifica comparativa, tutti i principali testi costituzionali vigenti stabiliscono deroghe alla giurisdizione ordinaria nel caso di “giustizia politica” (onde tutti sarebbero lesivi del principio d’uguaglianza, pur essendo stabilite nelle costituzioni moderne considerate democratiche – l’argomento criticato quindi prova troppo) per cui, oltretutto c’è una concordanza in quello che Hauriou chiamava droit commun constitutionnel; le stesse costituzioni italiane precedenti quella vigente stabilivano vistose deroghe (nel tempo e nello spazio la regola è quindi la deroga); ragione di ciò è che, se così non fosse, la scelta del personale di governo, immediatamente o mediatamente riconducibile al corpo elettorale, come naturale in democrazia, sarebbe “controllata” da un potere burocratico, non selezionato con procedimenti democratici (elezione o nomina di organi elettivi) e irresponsabile verso il corpo elettorale. Ma dato che la repubblica è democratica (e ciò sia per disposizione costituzionale espressa dall’art. 1 sia perché desumibile dall’intero testo della costituzione scritta) e che la scelta per la democrazia è un modo d’esistenza dell’istituzione, è questa a prevalere sulla competenza normale del giudice ordinario. Alla stessa conclusione si arriva partendo dalla distinzione dei poteri fatta propria dalla Costituzione (e dalla legislazione ordinaria), anche se non applicata (del tutto) coerentemente: se non fosse prevista una qualche deroga alla giurisdizione, la repubblica parlamentare diverrebbe uno Stato giurisdizionale (justizstaat) consentendo al potere giudiziario d’intromettersi (liberamente) nel funzionamento (e nella composizione) degli altri poteri costituzionali, e stravolgendo il principio di distinzione dei poteri.
Combinando le conclusioni (concordanti) di questi tre percorsi argomentativi si ha che l’applicazione “meccanica” del principio di isonomia (nel caso, della legge processuale) potrebbe ledere le capacità di azione politica, la forma democratica di Stato (e di governo) e il principio di distinzione dei poteri. Tutti principi fondamentali (due dei quali scritti), sicuramente non secondari a quello d’isonomia.
Occorre peraltro vedere se sia utilmente applicabile il criterio del bilanciamento cioè di determinare un ordine “gerarchico o preferenziale di valori o di principi” (v. Baldassarre op. cit.), e più in generale i parametri (non normativi) del giudizio di costituzionalità, come intesi da molti[71].
In effetti nel caso sopra considerato ad applicare letteralmente l’art. 3 della Costituzione, la deroga non sarebbe possibile; ma ricorrendo ai criteri di cui al passo citato di Baldassarre, e soccorrendo anche la massima di Celso scire leges non hoc est verba earum tenere sed vim ac potestatem (D I, 3, 17) – uno dei capisaldi dell’interpretazione sistematica – il risultato cambia completamente. Anche a tener conto delle considerazioni di Baldassarre che “se, per tale teoria, l’«interpretazione» è, in generale, una «mediazione creativa», nella quale il contributo degli interpreti concorre al «perfezionamento» o al «completamento» (Gadamer) del segno oggetto dell’interpretazione medesima, nel campo specifico del diritto, proprio in quanto «comprensione» eminentemente rivolta ai fini pratici, il fattore principale della mediazione ermeneutica è dato dagli «effetti veicolati dal segno» (Peirce), vale a dire dagli effetti pratici riferibili alla disposizione normativa nel relativo contesto sociale di attuazione. Sono, insomma, questi «effetti», vale a dire le conseguenze pratiche ipotizzate in relazione all’applicazione della disposizione normativa nell’ambiente sociale dato (attuale), che contribuiscono maggiormente a quella «attribuzione di significato» nella quale consiste il risultato finale (ancorché «anticipatorio» rispetto all’applicazione effettiva) di quel complesso processo chiamato «interpretazione»”.
In effetti nel caso della controversia sulla “giustizia politica”, l’inesistenza di deroghe, consentirebbe l’effetto pratico di cambiare la maggioranza parlamentare o la composizione del governo, cioè gravissime limitazioni e condizionamenti alla capacità di azione politica e/o al pouvoir déliberant del parlamento[72].
Cioè “effetti” contrari sia alla capacità d’azione dell’istituzione sia, alla specifica forma di governo scelta nella costituzione medesima.
- Più in generale occorre chiedersi come “graduare” o “bilanciare” (ovvero “determinare il valore relativo di due principi” costituzionali – Guastini). In questo caso il valore relativo tra ciò che è necessario, (assolutamente); ciò che lo è in relazione alle scelte costituzionali (relativo); e ciò che è accidentale. E insieme tra lo jus involontarium (non scritto) e il diritto statuito.
Quanto al rapporto tra ciò che è necessario (in senso assoluto) e l’ “accidentale”, sia che si tratti di norme che di principi o valori, il contrasto tra il primo e il secondo non può che risolversi con il riscontro dell’inesistenza/inapplicabilità del secondo. Almeno finché l’esistenza (e l’unità) politica perdura è sul presupposto di questa – e del suo durare – che vige un diritto e può avere efficacia concreta. Per cui è l’esistenza di quella a costituire il presupposto necessario di questo; e una decisione contraria all’esistenza è, come sopra scritto, opposta all’essenza (ai presupposti essenziali e allo scopo) della costituzione. Del pari una decisione lesiva della capacità di azione (politica), perché, avendo gli Stati un’esistenza storica e politica, è loro essenziale la capacità d’azione.
Più sfumato è ove la necessità sia relativa (cioè consegua non dalle generali condizioni d’esistenza ed azione, ma da quelle particolari della forma di stato e di governo e dalle decisioni fondamentali della costituzione; cioè di qualcosa rimesso alla volontà – ed alla possibilità di scelta – del potere costituente) È chiaro che questi precetti possono essere esplicitati nella costituzione (ad es. per quella vigente, il principio democratico) o impliciti (ad esempio la distinzione dei poteri).
Un aiuto a determinare ciò che è (relativamente) necessario lo può dare Lassalle. Questi nella (notissima) conferenza Über verfassungswesen, nel definire l’espressione legge fondamentale, diceva “ma una cosa che ha un fondamento non può più essere a piacere così o diversamente; ma deve essere così come essa è. Del fatto che essa è diversa non soffre il suo fondamento. Solo ciò che non ha fondamento e quindi anche ciò che è casuale può essere così come è e anche diversamente. Ma ciò che ha un fondamento, è necessario così come è. I pianeti hanno per esempio un certo movimento”[73].
Un altro ce lo offre il concetto di “rottura” della Costituzione. Com’è noto la prima formulazione della (necessità di istituti che comportino la )rottura della costituzione è di Machiavelli. Questi scrivendo della dittatura romana, sostiene “E però le repubbliche debbano intra loro ordini avere uno simile modo… Perché quando in una republica manca uno simile modo, è necessario, o servando gli ordini rovinare, o per non rovinare rompergli… Talché mai fia perfetta una republica se con le leggi sue non ha provvisto a tutto, e ad ogni accidente posto il rimedio e dato il modo a governarlo. E però chiudendo dico che quelle republiche le quali negli urgenti pericoli non hanno rifugio o al Dittatore o a simili autoritadi, sempre ne’ gravi accidenti rovineranno” (Discorsi, I, XXXIV). È chiaro, nel passo del Segretario fiorentino, che l’ “ottima” costituzione deve prevedere i modi per essere disapplicata o sospesai (parzialmente).
Onde potrebbe individuarsi il limite tra quello che è (relativamente) necessario a quello che è – per usare la terminologia hegeliana – accidentale in ciò che, in caso di previsione costituzionale della rottura, è immodificabile da quello che non lo è. Ad esempio nel caso dell’art. 16 della Costituzione francese vigente, il Presidente, pur utilizzando i poteri eccezionali, non può sciogliere il Parlamento; analogamente nell’art. 48 della Costituzione di Weimar il Presidente, pur potendo prendere le misure eccezionali, doveva riferire al Reichstag e revocarle a richiesta di questo. Schmitt a tale proposito sosteneva “La costituzione come un tutto resta non solo lo scopo di ogni provvedimento sulla base dell’art. 48: essa è anche determinante in quanto fondamento dei suoi presupposti… Essenzialmente ogni costituzione è l’organizzazione. Per questo l’unità dello Stato è creata come quella di un ordinamento”[74].
Da ciò consegue che, nelle rotture costituzionali, a non poter essere innovata, è la costituzione intesa come (decisione sulla) forma di Stato e di governo (e cioè sull’essenziale dell’organizzazione di governo); nei casi esaminati, come repubblica democratica semi-presidenziale, con i due organi (dotati) di rappresentanza politica (cioè Presidente della repubblica e Parlamento), che rimangono intangibili, mentre sono disapplicabili (momentaneamente l’esercizio dei) diritti, anche se garantiti dalla costituzione[75].
Tutto ciò può servire a chiarire se le decisioni riconducibili al (relativamente) necessario possano essere oggetto di valutazioni contemperabili con altre disposizioni della costituzione formale.
Ad avviso di chi scrive la risposta è negativa: non può “bilanciarsi” un principio che da forma allo Stato ed al governo – rientrando così nel “nocciolo duro” della costituzione – con prescrizioni, anche ricondotte dal testo costituzionale a quelle di principio, che comunque non sono costitutive della forma politica.
Nella costituzione vigente sicuramente di questa sono costitutivi il principio democratico (e quello – connesso – d’eguaglianza) quello di libertà nonché di tutela dei diritti dell’uomo – e le conseguenze immediate di quelli, come il diritto d’elettorato attivo e passivo, l’inviolabilità della libertà personale, di domicilio, di riunione (e, in genere, di tutti i diritti di cui agli artt. 13-27 della Costituzione vigente), mentre non sono “costitutivi” della forma politica il principio di tutela delle minoranze (art. 6) la tutela della cultura e del paesaggio (art. 9) la conformazione all’ordinamento internazionale (art. 10, I e II comma), il ripudio della guerra (art. 11).
Piuttosto un “bilanciamento” appare possibile all’interno della categoria dei precetti “costitutivi” della forma politica: ad esempio se una riduzione delle libertà di cui agli artt. 13-27 della Costituzione sia compatibile in occasione di gravi turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica, di guisa da mettere in dubbio il funzionamento delle istituzioni. In questo caso una compressione della libertà va commisurata all’ineliminabilità, specie in certi periodi (come quelli elettorali) – della fruizione delle stesse, ai fini di un corretto funzionamento dell’istituzione e della forma di governo in cui è organizzata[76].
Mentre tali esigenze di salvaguardare il “nocciolo duro” della Costituzione (cioè la costituzione e non le leggi costituzionali nel senso di Schmitt) non sussistono se i valori da bilanciare sono riconducibili a ciò che è “accidentale”; ossia non necessariamente (nei due sensi specificati) facente parte della Costituzione.
- Altro problema è quello del carattere prevalentemente teleologico dell’interpretazione. Qua s’intende per teleologico non tanto la considerazione privilegiata del “fine” della norma, quanto quello della funzione della costituzione, cioè di disciplinare l’esistenza e l’azione della comunità, anche con riguardo agli effetti concreti.
In questo senso è determinante il carattere di “comunità perfetta” che il pensiero teologico attribuisce a quella politica[77] e presente anche nel pensiero giuridico dello scorso secolo, in particolare in Santi Romano[78]; e in Rudolf Smend[79].
La conseguenza che ne traeva Santi Romano era che “il diritto costituzionale è quella parte del diritto dello Stato, in cui meglio si rivela l’esattezza del concetto sopra fugacemente accennato sulla garanzia del diritto. L’opinione comune che ripone questa garanzia in una norma che dovrebbe farsi valere da una potestà sopraordinata ai soggetti vincolati ad essa o in altra norma, cui la prima servirebbe di sanzione, nel campo del diritto costituzionale è manifestamente inammissibile. Se la costituzione è l’ordinamento supremo dello Stato, non ci può essere una norma ancora superiore che la protegga e quindi essa deve trovare nei suoi stessi elementi e atteggiamenti la propria garanzia”[80].
Dato il carattere di comunità perfetta e il fatto di non essere obbligata (o facultata) a chiedere (e ad ottenere) la garanzia del proprio ordinamento ad un’altra istituzione (tanto meno ad una norma, a un principio, o a un valore), l’interpretazione della costituzione deve avere connotati particolari, così come la decisione delle controversie costituzionali.
In effetti, e tornando al criterio di conservazione dell’esistenza (cioè la salus rei publicae…) esso è del tutto peculiare (alla costituzione e) all’interpretazione costituzionale: un giudice ordinario che applica la norma in una lite tra privati non deve porsi il problema delle salus rei publicae. Lo stesso accade in ogni caso d’applicazione di precetti giuridici che poggino (e presuppongano) la saldezza e la vitalità dell’insieme (e non li ponga a rischi – il che è un’ipotesi rarissima, quasi di scuola – per le disposizioni non aventi carattere costituzionale).
Smend scriveva in proposito che “Il criterio che distingue la costituzione dal resto dell’ordinamento giuridico è sempre e di nuovo il carattere «politico» del suo oggetto”, e “qui il metodo formalistico rinuncia consapevolmente a fondare la teoria dello Stato nel senso delle scienze dello spirito, cioè ad assumere, come punto di partenza del lavoro giuridico, una teoria dell’essenza materiale specifica del suo oggetto”. Infatti così rinuncia a comprendere la costituzione non come “regolamentazione astratta di un infinito numero di casi”, mentre “qui si tratta di una legge individuale di un’unica e concreta realtà di vita”[81]. È chiaro che la funzione d’integrazione come essenza della costituzione costituisce “il principio del divenire dinamico dell’unità politica[82].
Pertanto il criterio interpretativo, in questa come nelle altre concezioni costituzionali improntate a considerare la costituzione come “modo d’esistenza di un popolo” (de Bonald) è (segnatamente) sistematico ma soprattutto teleologico, mentre uno spazio assai minore rispetto all’interpretazione della norma legislativa è riservato all’interpretazione letterale.
E, come scrive Smend, si tratta di interpretare la costituzione, come la “legge vitale di un essere concreto”, cioè in funzione della vitalità dell’insieme; per cui il criterio teleologico non è incentrato sullo scopo che la singola norma si propone di raggiungere (la ratio legis) ma quelli che la costituzione, nel suo insieme, persegue (per così dire la ratio constitutionis).
Ne consegue che da un canto la garanzia della costituzione, come scriveva Hegel, viene dalle istituzioni stesse[83]. Il che è un modo di significare che, come per il diritto internazionale non ci sono Pretori tra gli Stati[84], anche per il diritto costituzionale la garanzia effettiva deriva più dal (complesso) assetto istituzionale che da un ricorso al “Pretore” costituzionale del tutto incongruo a proteggere effettivamente l’unità e la forma dello Stato[85]. Sul piano interpretativo ciò conferma il particolare carattere teleologico e “fattuale” dell’interpretazione costituzionale: quanto Baldassarre sostiene che occorre guardare anche agli effetti (alle conseguenze) dell’interpretazione (nel caso della Corte, delle sentenze); questo criterio che per un giudice non costituzionale, sarebbe del tutto residuale, perché, per lo più, vietato – di converso è peculiare all’interpretazione della costituzione (molto meno per le leggi costituzionali, a seguire la distinzione di Schmitt).
Anche in questo è confermata la regola che l’esistente prevale sul normativo: la costituzione – che è il modo d’esistenza politica di un popolo – va interpretata nel senso che le relative decisioni conservino quel modo d’esistenza. Se un potere costituito lo mettesse in pericolo, ciò non rientrerebbe nei suoi poteri: sarebbe come segare il ramo (o la pianta) su cui è appollaiato (e da cui è sostenuto). Cioè costituirebbe un atto rivoluzionario o almeno un atto apocrifo di sovranità, essendo riservato al sovrano (o al potere costituente, laddove l’uno e l’altro coincidono – v. sopra).
- Le tesi sopra esposte confermano quanto sostenuto (da buona parte) della dottrina politica – e del diritto pubblico – classica, le cui conseguenze si riflettono sull’interpretazione costituzionale.
In particolare che non si ha a che fare (per lo più) con un diritto scritto e statuito (de Maistre e Santi Romano, tra gli altri)[86]; in buona parte ciò che è (realmente) costituzionale non è rimesso alla volontà umana; lo jus dicere, e più ancora il condere leges è un atto di volontà, ma anche di conoscenza (assertivo) (Suarez e Vico); c’è un diritto costituzionale necessario – nei due significati indicati – e uno volontario (Vico, Spinoza ed Hegel); la ratio, dati i presupposti di cui sopra, ricopre un ruolo superiore a quanto usuale in altri campi del diritto; la distinzione tra costituzione e leggi costituzionali (Schmitt) è feconda e spesso decisiva – anche ai fini esegetici; la costituzione è il modo d’esistenza di un popolo (de Bonald) e come tale va, in primo luogo, considerata; il diritto serve alla vita e non viceversa (Jhering, tra i molti); leggi, principi e valori cambiano più o meno velocemente, mentre comunità, istituzioni, Stati cambiano i primi, ma non mutano – o mutano poco e lentamente – il loro ordinamento (Hauriou e Santi Romano).
Tutti aspetti che non risultano particolarmente frequentati né (implicitamente) condivisi: ai quali si preferiscono altrettante riduzioni/semplificazioni: che il diritto sia statuito (e scritto), che la costituzione sia un determinato (e deliberato) documento, distinguibile dalla legge solo per la sua posizione nella stufenbau; che le “regolarità” dell’agire sociale siano modificabili ad libitum del legislatore (aspetto del “prometeismo” moderno, di cui il marxismo realizzato nel socialismo reale – e la sua fine ingloriosa – hanno mostrato l’inconsistenza); che la costituzione sia (solo) un atto connotato dalla rigidità.
E altro, il cui limite manifesto e ricorrente è di spiegare solo (parte) dell’oggetto, con l’accorgimento di delimitarlo in misura assai più stretta di quello che la realtà mostra; e con l’inconveniente di lasciarne fuori gran parte: non il troppo e il vano, ma l’essenziale e il decisivo.
Teodoro Klitsche de la Grange
[41] Qu’est-ce-que le Tièrs Etat ora in Opere Milano 1993 p. 256 ss e ribadisce : “Non solo la Nazione non è sottomessa a una Costituzione, ma non può neanche esserlo, il che è come ribadire una volta di più che non lo è… (le nazioni) vanno considerate come individui privi di ogni legame sociale, ovvero, come si suol dire, nello stato di natura. L’esercizio della loro volontà è libero ed indipendente da ogni forma civile…comunque una Nazione voglia, è sufficiente che essa voglia; tutte le forme sono buone, e la sua volontà è sempre legge suprema…” op. cit, pp. 257-258 (i corsivi sono nostri). La distinzione fra potere costituente/diritto naturale e poteri costituiti/diritto positivo è chiaramente formulata.
[42] v. Behemoth n. 45 p. 12
[43] L’espressione “natura delle cose” (e quelle similari) è stata intesa come essenzialmente giusnaturalistica. Bobbio ritiene che “si tratta di una nozione di derivazione prettamente giusnaturalistica. L’essenza del giusnaturalismo consiste infatti nella convinzione di poter ricavare le regole fondamentali della condotta umana dalla natura stessa dell’uomo: ora, è evidente la stretta parentela fra il concetto di natura dell’uomo e quello di natura delle cose; intendendo il termine “cose” in senso lato (come sinonimo di “enti”), il primo concetto può essere ricompreso nel secondo”. Il Positivismo giuridico, Torino s.d., p. 265.
È chiaro che nel presente scritto s’intende qualcosa di diverso, ovvero la necessità (assoluta) di un ordinamento per le comunità umane, o la necessità (relativa) cioè in relazione al fine, al modo d’essere, alla forma di Stato e di governo. Onde appartiene alla natura delle cose (per necessità assoluta) che vi sia una società politica con un potere di comando ed obbedienza (et simili); alla natura della democrazia (ad es.) che i governati eleggano i governanti (direttamente e/o indirettamente), che abbiano il diritto d’accesso alle cariche pubbliche (e così via). Mentre nel primo caso non può esistere qualcosa di diverso, nel secondo la necessità deriva dalla scelta, libera e consapevole (e realisticamente conseguente), di quelle che Schmitt chiama le “decisioni politiche fonamentali” (cioè l’essenza della Costituzione) v. Verfassungslehre, trad. it. di A. Caracciolo, Milano 1984, pp. 38 ss.. Per una concezione della “natura delle cose” prossima a come la poteva intendere Spinoza (v. nota 54). v. M.S. Giannini Introduzione al diritto costituzionale, Roma 1984, p. 72.
[44] v. per le “regolarità” del politico la presentazione di G. Miglio alla raccolta di saggi di Schmitt Categorie del politico, Bologna 1972 p. 13; quanto alle costanti, alle leggi dell’agire sociale, basti ricordare, tra i molti, Comte, per cui la società ha una realtà naturale ed originaria: gli uomini vivono in società perché questo fa parte della loro natura sociale; la società ha proprie leggi di funzionamento; la sociologia che la studia si divide in statica sociale, che costruisce la teoria dell’ordine; e in dinamica che sviluppa la dottrina del progresso. “La liberté véritable se trouve partout inhérente et subordonnée à l’ordre, tant humain qu’extérieur”; infatti “si la liberté humaine consistait à ne suivre aucune loi, elle serait encore plus immorale qu’absurde, comme rendant impossible un régime quelconque, individuel ou collectif” in Catéchisme positiviste(I parte, IV colloquio).
[45] Sul concetto di necessità assoluta e necessità relativa (conseguente alle scelte politiche fondamentali v. supra nota 42.
[46] v. articoli di Riccardo Guastini “Sostiene Baldassarre” e Antonio Baldassarre “Una risposta a Guastini” – reperibili in rete.
[47] La distinzione tra enunciati di principio e norme giuridiche, spesso all’attenzione della dottrina contemporanea, in rapporto alla tesi esposta non fa differenza, perché sia i principi che le norme sono ricavate dal diritto statuito.
[48] V. per un’esposizione delle tesi v. F. Suarez, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, trad. it a cura di O. De Bertolis, Padova 2008, pp. 81 ss.
[49] “Per gli argomenti che abbiamo addotti a favore di queste opinioni sembrano persuaderci che l’uno o l’altro atto, di intelletto e di volontà, sono necessari per la legge, e perciò può sostenersi la terza tesi, che dice che la legge si forma e si compone con un atto di entrambe le potenze; perché in queste cose morali non si richiede di ottenere un’unità perfetta e semplice ma accade che una realtà, che moralmente è una, può constare di molte realtà fisicamente distinte, e che si aiutano l’una con l’altra” op. cit. pag. 96
[50] v. Guastini op. cit.
[51] v. “Non posso evitare di aggiungere a questi ragionamenti un’osservazione, che forse può avere una certa importanza: In ogni sistema morale che ho finora incontrato, ho sempre trovato che l’autore procede per un po’ nel consueto modo di ragionare, e afferma l’esistenza di Dio o si esprime riguardo alle questioni umane; e poi improvvisamente trovo una certa sorpresa che, invece delle abituali copule è e non è incontro soltanto proposizioni connesse con un deve, o non deve. Questo cambiamento è impercettibile; ma è comunque molto importante. Infatti, dato che questo deve, o non deve, esprime una certa nuova relazione o affermazione, è necessario che siano osservati e spiegati; e allo stesso tempo è necessario spiegare ciò che sembra del tutto inconcepibile, ossia che questa nuova relazione possa costituire una deduzione da altre relazioni completamente diverse” A treatise on human nature, trad. it. di P. Guglielmoni, Milano 2005, p. 329 (i corsivi sono nostri)
[52] V. General theory of law and state, trad. it. Milano 1952 pp. 8 ss; v. anche Reine Rechtslehre, trad. it. Torino 1968. pp. 86 ss, ma è rivisitata in altre opere
[53] e prosegue “Si può distinguere sostanzialmente il diritto dalla morale soltanto se – come si è dimostrato in precedenza – si concepisce il diritto come ordinamento coercitivo, cioè come ordinamento normativo, che tenta di generare un certo comportamento umano, ricollegando al comportamento opposto un atto coercitivo dell’organizzazione sociale, mentre la morale è un ordinamento sociale che non prevede alcuna di tali sanzioni, un ordinamento, cioè, le cui sanzioni consistono soltanto nell’approvazione del comportamento conforme alla norma e nella disapprovazione del comportamento in contrasto con essa¸un ordinamento in cui non si prende quindi neppure in considerazione la possibilità di applicare la coazione fisica. V. Reine Rechtslehre, trad. it. cit. di Mario Losano p. 78. Anche nella Reine rechtslehre Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik trad, it. Torino 1952 p. 66 Kelsen scrive “Con la categoria formale del dovere o della norma si è riusciti però soltanto a determinare il genere prossimo, non già la differenza specifica del diritto. La teoria del diritto del secolo XIX è stata in genere concorde nel ritenere che la norma giuridica fosse una norma coattiva…In questo punto la dottrina pura del diritto continua la tradizione della teoria positivistica del diritto del secolo XIX. Essa sostiene che in una proposizione giuridica, a una determinata condizione è unito come conseguenza l’atto coattivo dello Stato, cioè la pena e l’esecuzione forzata civile e amministrativa…Ciò fa si che un determinato comportamento umano valga come illecito, come delitto nel più ampio senso della parola, non è affatto una qualità immanente e neppure un rapporto con una norma meta-giuridica, con un valore morale, cioè trascendente il diritto positivo, ma è solo ed esclusivamente il fatto che nella proposizione giuridica tale comportamento sia posto come condizione di una conseguenza specifica e che l’ordinamento giuridico positivo reagisca a questo comportamento come un atto coattivo”. (I corsivi dei passi citati sono nostri)
[54] V. sul punto, la tesi, già ricordata (Trattato politico Torino 1958 pp. 204-206) di Spinoza: “Se, per esempio, io dico che ho diritto di fare quel che voglio di questo tavolo, non intendo, perbacco, di poter far sì che esso mangi erba; così, pur dicendo che gli uomini non sono liberi di sé, ma soggetti allo Stato, non intendiamo che essi perdano la natura umana e ne assumano un’altra, o che lo Stato abbia diritto di far sì che gli uomini volino… esistono certe condizioni, poste le quali si impone si impone ai sudditi il rispetto e l’ossequio verso lo Stato, e tolte le quali, non soltanto vengono meno il rispetto e l’ossequio, ma lo Stato stesso cessa di esistere: Per conservare la propria autorità, insomma, lo Stato deve badare che non gli vengano meno i motivi del rispetto e dell’ossequio, altrimenti perde il suo essere di Stato”
[55] Si nota la differenza tra la tesi qui sostenuta e quella di Bobbio dal seguente passo del filosofo torinese, sempre sulla “natura delle cose” in cui introduce (nella propria concezione del diritto) la “legge di Hume” “La natura delle cose è una nozione che nasce dunque dall’esigenza di garantire l’oggettività della regola giuridica. Il problema è appunto se esiste effettivamente questo rapporto fra la natura del fatto e la regola. A nostro avviso la nozione di natura delle cose è inficiata da quella che in filosofia morale è detta la fallacia naturalistica, cioè dall’illusoria convinzione di poter ricavare dalla constatazione di una certa realtà (il che è un giudizio di fatto) una regola di condotta (la quale implica un giudizio di valore): il sofisma della dottrina della natura delle cose, come del giunaturalismo, è il pretendere di ricavare un giudizio di valore da un giudizio di fatto”, op. ult. cit., p. 268. In effetti qua non si ricava una scelta (giudizio di valore) da un giudizio di fatto, in quanto l’atto (il fatto) non è giuridico perché non coercibile, non efficace, non applicabile. Semmai la scelta del legislatore è nel disciplinare gli effetti giuridici di un atto privo delle possibilità concrete di applicazione. In tal senso, ad esempio, il c.c. sanziona di nullità il tutto, prescrivendo alle parti (e al giudice) la restituzione delle prestazioni eseguite in “esecuzione” del contratto ad oggetto impossibile (art. 2033 c.c.) in applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum. In realtà il legislatore nel caso di prestazione impossibile non costituisce un precetto, ma riconosce ciò che risulta dal giudizio di fatto, statuendo solo sullo statuibile (la conseguenza dell’atto nullo).
[56] Per le norme d’ “applicazione” il discorso – che qui non interessa – è diverso.
[57] v. Studi per una teoria generale del diritto Torino 1970 pp. 143 ss.
[58] e prosegue “ Sia in Kelsen sia in Olivecrona e in Ross l’idea di coazione è strettamente connessa all’idea di forza (fisica): “il dire che l’ordinamento giuridico è un ordinamento coattivo (coercive order, Zwangsordnung) equivale a dire che contiene regole per l’esercizio della forza, anzi è caratterizzato da queste. Ciò presuppone che l’unico espediente cui ricorre un ordinamento giuridico per rendere efficaci le norme primarie sia il ricorso della forza”, precisando successivamente “Mi pare si possa proporre, per le nullità, questa interpretazione: quando si dice che l’ordinamento giuridico è un ordinamento coattivo, caratterizzato dall’esistenza di norme che regolano l’esercizio della forza, si vuol dire, come si è visto, che l’ordinamento giuridico stabilisce le condizioni (norme sostanziali) in base alle quali l’intervento della forza diventa lecito, e le modalità (norme procedurali) con cui questo intervento deve essere esercitato”… “ in altre parole, il giudizio di illiceità, presupposto di una pena (o un’esecuzione forzata, pone le condizioni per l’intervento di una forza vendicatrice (o riparatrice); il giudizio di invalidità presupposto della nullità, pone le condizioni per il non intervento di una forza protettrice” – p. 134-137 (i corsivi sono nostri). Bobbio non prende in considerazione le sanzioni premiali anch’esse “coercibili”, che tratta Carnelutti.
[59] È da considerare la tesi di G. B. Vico sul rapporto tra verità e certezza “Verum gignit mentis cum rerum ordine conformatio; certum gignit conscientia dubitandi secura. Ea autem conformatio cum ipso ordine rerum est et dictur «ratio». Quare, si alternus est ordo rerum, ratio est aeterna, ex qua verum aeternum est: sin ordo rerum non semper, non ubique, non omnibus constet, tunc in rebus cognitionis ratio probabilis, in rebus actionis ratio verisimilis erit” De uno universi juris principio et fine uno (proloquium); e nel cap. LXXXII “Ratio autem legis eidem dat esse verum- Verum autem est proprium ac perpetuum adiunctum iuris necessarii.
Certum est pars veri.
Certum vero est proprium et perpetuum iuris voluntarii attributum, sub aliqua tamen veri parte, ut Ulpianus nuper ius civile definivit”.
[60] Wirtschaft und Gesellschaft trad. it. vol. I. Milano 1980 pp. 212-213 (i corsivi sono nostri).
[61] In realtà si è scambiata quella che è un’aspirazione, per quanto condivisibile e diffusa, con la realtà (e la necessità) dell’esistenza politica e sociale. Per cui se è possibile (ed auspicabile) regolare molti istituti e materie, è impossibile (e dannoso) credere di poter regolare tutto. Cioè arrivando ad una giuridificazione di (tutta) la vita.
[62] Op. cit. p. 48-49
[63] Lineamenti di filosofia del diritto § 260
[64] v. B. Croce Etica e politica Bari 1931 p.185.
[65] Ovvero come sostiene Santi Romano criticando l’opinione fondata sull’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 20-26 agosto 1789 “l’errore dell’opinione di cui si è fatto cenno è evidente: Ogni Stato è per definizione, come si vedrà meglio in seguito è coevo all’esistente (politicamente), un ordinamento giuridico, e non si può immaginare, quindi, in nessuna sua forma fuori del diritto: Qualunque sia il suo governo e qualunque sia il giudizio che se ne potrà dare dal punto di vista politico, esso non può non avere una costituzione e questa non può non essere giuridica, perché costituzione significa niente altro che ordinamento costituzionale. Uno Stato «non costituito» in un modo o in un altro, bene o male, non può avere neppure un principio di esistenza, come non esiste un individuo senza almeno le parti principali del corpo. Il diritto costituzionale del c.d. Stato assoluto o dispotico sarà poco sviluppato; si concreterà in una sola istituzione fondamentale, quella del suo sovrano; sarà regolato da poche norme che, esagerandone e stilizzandone la figura tipica, si potranno ridurre magari soltanto a quella che dichiarerà l’appartenenza del sovrano di tutti i poteri; ma almeno questa norma non potrà mancare e non essere giuridica, se su di essa si impernia per intero quell’ordinamento giuridico quale è sempre, per sua indeclinabile natura, lo Stato”. Diritto Costituzionale generale Milano 1947, p. 3
[66] Il giovane Hegel esercitava la sua (amara) ironia su come il rispetto per il diritto contribuisse ad indebolire l’Impero nel momento in cui aumentava l’aggressività della Francia rivoluzionaria “è un elemento, se pur non razionale, almeno in certa misura nobile del carattere tedesco il fatto che il diritto in generale, comunque siano costituiti il suo fondamento o le sue conseguenze, è per esso qualcosa di sacro. Se pur la Germania in quanto Stato proprio e indipendente, di cui ha tutta l’apparenza, e la nazione tedesca in quanto popolo, va del tutto in rovina, tuttavia procura sempre una vista piacevole il notare tra gli spiriti distruttori il rispetto per il diritto” v. Verfassung Deutschlands, trad. it. Bari 1960, p. 21.
[67] V. l’opinione di Santi Romano “Come la consuetudine, anzi a maggior ragione, data la sua maggiore energia, la necessità è fonte autonoma del diritto, superiore alla legge. Essa può implicare la materiale e assoluta impossibilità di applicare, in certe condizioni, le leggi vigenti e, in questo senso, può dirsi che «necessitas non habet legem». Può anche implicare l’imprescindibile esigenza di agire secondo nuove norme da essa determinate e, in questo senso, come dice un altro comune aforisma, la necessità fa legge. In ogni caso «salus rei publicae suprema lex»” in Diritto costituzionale generale, Milano 1947, p. 92.
[68] Ricordiamo la concezione di Bobbio “interpretare significa risalire dal segno (signum) alla cosa significata (designatum), cioè comprendere il significato del segno individuando la cosa da esso indicata. Ora, il linguaggio umano (parlato o scritto) è un complesso di segni” op. ult. cit., p. 325.
[69] In effetti, a seguire la teoria di Rousseau sulla volontà generale, essa è tale perché lo è nell’oggetto e nell’essenza, perché “deve partire da tutti per applicarsi a tutti” (Du conrtact social, II, 4). Nella concezione dell’eguaglianza come (mera) isonomia passiva, c’è una visione estremamente riduttiva del principio d’uguaglianza, visto solo quale assoggettamento alla legge (e al comando), tralasciando la partecipazione alla funzione di “governo” (in senso lato).
[70] V. op. ult. cit., p. 92. Bobbio sostiene (v. prima) che “in realtà non è il fatto in sé che impone la regola, ma il fine che si vuole raggiungere: è il fine che fa valutare in un certo modo i fatti; nel nostro caso il fine è di garantire la sicurezza del traffico e la possibilità per tutti gli automobilisti di poter parcheggiare. Ma nell’individuazione del fine interviene necessariamente un giudizio (o una serie di giudizi) di valore” op. ult. cit., p. 269. A parte le pendenti considerazioni, qua non si nega che vi sia un giudizio di valore, ma che non vi sia quello di fatto (assertivo). Sul punto ritorniamo in seguito.
[71] Sul punto v. Baldassarre op. cit.: “Nell’ipotesi del giudizio di costituzionalità, invece, colui che interpreta/applica le norme (costituzionali) procede in modo diametralmente inverso. Innanzitutto, tutte le norme costituzionali, incluse quelle che appaiono come le più particolari (ad es. la necessità di convertire i decreti-legge entro 60 giorni dalla loro emanazione), vanno comprese nel significato loro attribuibile in modo da riferirle ai principi supremi e ai valori ultimi della costituzione (come sentiti e vissuti dalla comunità politica). Così, per riprendere l’esempio fatto, il termine di conversione dei decreti-legge entro 60 giorni è stato inteso restrittivamente, cioè nel senso di precludere la possibilità di reiterazione del medesimo decreto, solo a partire da una sentenza del 1996, in quanto solo se così interpretato il principio della conversione è stato ritenuto più coerente con il principio della democrazia parlamentare, come allora, e non prima, sentito e condiviso. In secondo luogo, dai principi costituzionali non vengono «dedotte» le «regole» per decidere il giudizio, per il semplice motivo che la questione di costituzionalità viene decisa, non in base a una (presunta) «regola», ma in base a «principi»: in genere, il giudice della costituzionalità procede a una «riduzione» della «regola» legislativa (= generale e astratta) oggetto del giudizio ai principi o ai valori ad essa sottesi, al fine di valutare la compatibilità/incompatibilità di questi ultimi con il quadro dei principi e dei valori costituzionali ritenuti rilevanti rispetto alla «regola» contestata”.
[72] E anche altro. È per lo più dimenticato che la legge sui pieni poteri al governo del Reich del 23 marzo 1933 –legge di modifica (abolizione) della costituzione di Weimar, e quindi necessitante della maggioranza qualificata – raggiunse il quorum grazie all’opportuno scioglimento del PC tedesco e l’arresto di una dozzina di deputati dell’opposizione.
[73] E proseguiva “Questo movimento o ha un fondamento, che lo determina, o non ne ha. Se non ne avesse, questo movimento, sarebbe casuale e ad ogni momento potrebbe anche essere diverso. Ma se ha un fondamento, come dicono gli scienziati, cioè la forza d’attrazione del sole, con ciò è già determinato il fatto che questo movimento dei pianeti è determinato e regolato attraverso il fondamento, la forza d’attrazione del sole, in modo tale da non potere essere altro rispetto a ciò che è. Nella rappresentazione del fondamento vi è quindi l’idea di una necessità attiva, di una forza effettiva, che con necessità rende ciò che è fondato su di essa ciò che esso è. Se quindi la costituzione rappresenta la legge fondamentale di un paese, o essa è così – e qui albeggia forse per noi la prima luce, miei Signori, – un qualcosa puramente ancora da determinare in modo più preciso ovvero, come abbiamo intanto scoperto, una forza attiva che rende obbligatoriamente tutte le altre leggi e istituzioni giuridiche che vengono varate in questo paese ciò che sono” v. trad. it. di Clemente Forte in Behemoth n. 20, p. 6 (i corsivi sono nostri).
[74] Die Diktatur (App. I) trad. it. di A. Caracciolo, Roma 2006, p. 283 (i corsivi sono nostri).
[75] E’ da notare che nell’evoluzione dell’istituto francese dell’état de siège, alle misure straordinarie non è connessa alcuna alterazione (dei rapporti) tra organi costituzionali. v. M Hauriou Prècis de droit costitutionnel. Paris 1929 p. 705 ss
[76] In questo senso quelle libertà – normalmente inquadrate, come da rubrica, tra i rapporti civili (diritti dell’uomo, libertà liberali) – sono anche condizioni per l’esercizio dei diritti (politici) del cittadino di partecipare alla formazione della volontà pubblica, e così della forma democratica di governo. Tra i (non pochi) esempi delle conseguenze di una mancata garanzia dell’esercizio di questi, ricordiamo il decreto per la protezione del popolo e dello Stato (del 28/02/1933) proposto da Hitler e sottoscritto da Hindenburg, pochi giorni prima delle elezioni del 05/03/1933 (e i risultati di queste), v. William Shirer, Storia del Terzo Reich, vol. I, Torino 1990, p. 303 ss. A tale proposito Hauriou, citando Thiers, ritiene che questi aveva ragione a sostenere che la libertà di stampa, riunione, d’associazione (e d’insegnamento) nella società moderna erano delle libertà necessarie: in questo caso il necessario era inteso sia rispetto al principio (politico) democratico sia a quello liberale di protezione delle libertà (della società civile rispetto allo Stato) Prècis de droit constitutionnel. Paris 1929 p. 711
[77] v. Suarez op. cit., p. 118 ss.. Suarez distingue – sulla base del pensiero di Aristotele e S. Tommaso – tra comunità sufficienti a se stesse (perfette) e non sufficienti a se stesse: “È detta perfetta nel suo genere quella che è capace di governo politico, che, in quanto è tale, è detta sufficiente in questo ordine; come disse Aristotele e S. Tommaso, che la città è una comunità perfetta… Ma è detta «comunità imperfetta» non in relazione ad altre, ma in senso assoluto, la casa privata, alla quale presiede il padre di famiglia, come ha notato S. Tommaso, e Soto, e sopra è preso da Aristotele.
Il motivo è che quella comunità non è sufficiente a se stessa, come ora sarà spiegato… E così tale comunità, parlando di per sé e in termini propri, non è retta da una propria potestà di giurisdizione, ma da [una potestà che si può chiamare] dominativa… Per cui [la casa privata] non possiede perfetta unità o un potere uniforme, e nemmeno partecipa propriamente di un governo [che possa essere detto] propriamente politico, e così quella comunità è detta assolutamente imperfetta” (i corsivi sono nostri).
[78] “Si possono distinguere le istituzioni perfette, che sono sempre originarie e che possono essere o semplici o complesse, dalle imperfette, che cioè si appoggiano ad altre istituzioni rispetto alle quali sono, non soltanto presupposte, ma coordinate o subordinate”, L’ordinamento giuridico, rist. Firenze 1962, p. 143; v. anche p. 38 “Ci sono istituzioni che s’affermano perfette, che bastano, almeno fondamentalmente, a se medesime, che hanno pienezza di mezzi per conseguire scopi che sono loro esclusivi. Ce ne sono altre imperfette o meno perfette, che si appoggiano a istituzioni diverse”.
[79] V. “Qui non è possibile discutere a fondo il criterio che distingue lo Stato dalle altre associazioni. Dalla particolare posizione dello Stato derivano comunque due elementi. In primo luogo, la sua stabilità non viene garantita, come per le altre associazioni, da un potere situato all’esterno; il suo funzionamento non viene mantenuto da un motore o da un giudice esterni alla sua struttura, non viene sorretto da una causa o da una garanzia eteronome, ma si integra, grazie alla legislatività oggettiva rispetto al valore, esclusivamente in un sistema di integrazione gravitante su se stesso” Verfassung und verfassungsrecht trad. it., Milano 1988, p. 156; nella voce Integration, scritta da Smend per Evangelisches Staatlexikon e riportato nel volume citato, chiarisce: “Ciò è inesatto poiché, per quanto anche le altre formazioni sociali, dal matrimonio o dalle associazioni private sino alle più complesse comunità politiche e apolitiche, necessitino di una continua e sempre nuova inclusione degli uomini che le sorreggono, dispongono tuttavia di garanzia di stabilità del tutto differenti da quelle statali. Quelle comunità e associazioni vengono garantite dalla dissoluzione interna perlopiù mediante poteri esterni: il giudice, la coercizione amministrativa, sino agli strumenti della coercizione sociale e a quelli della politica estera e del diritto internazionale. Per lo Stato, in quanto si pone semplicemente come compito, non vi sono affatto tali garanzie esterne: esso riposa in ultima istanza non sul diritto o sul suo potere di fatto, ma sulla sempre nuova e volontaria adesione dei suoi appartenenti”, op. cit., p. 286 (i corsivi sono nostri)..
Nella diversità delle concezioni, ambedue i giuristi citati concordano nel fatto che diversamente da altre (associazioni e) comunità umane lo Stato (e quindi la costituzione statale) devono trovare all’interno dell’ordinamento gli strumenti di garanzia dello stesso. Questo perché, come scriveva de Bonald, riguardo alla costituzione della monarchia francese “la nazione era costituita, e così ben costituita, che essa non ha mai chiesto a nessuna nazione vicina la protezione della sua costituzione”. Il che è un’applicazione della regola (hobbesiana) del protego ergo obligo; e in termini giuridici (e politici), significa la perdita (o la restrizione) dell’indipendenza dello Stato.
[80] Principii di diritto costituzionale generale, cit., p. 57 (i corsivi sono nostri).
[81] E prosegue “A tale metodo sfugge il fatto che si tratta della legge vitale di un essere concreto e precisamente, dal momento che tale essere concreto non è una statua ma un processo di vita unitario che riproduce di continuo questa realtà, della legge della sua integrazione… ogni singolo aspetto del diritto dello Stato è comprensibile non in se stesso e isolatamente, ma come momento della connessione di senso da realizzare, cioè della totalità funzionale dell’integrazione” op. cit., pp. 216-217. Così “non si può comprendere la giustizia costituzionale in analogia con la giustizia civile o amministrativa. La tutela delle minoranze parlamentari da parte del giudice costituzionale è una cosa diversa dalla tutela di un gruppo di azionisti, con i loro interessi individuali, da parte di un giudice civile, in quanto deve servire alla ricomposizione integrativa delle parti”, op. cit., p. 218 (i corsivi sono nostri).
[82] Così C. Schmitt op. ult. cit., p. 18.
[83] Op. cit., § 286.E anche, a seguire Hauriou – per le costituzioni liberali, dal complesso e dall’assetto generale, che fa sì che la “libertà si protegga da sola” v. Précis. cit. pag. 709.
[84] Hegel, op. cit., § 333; e anche, per conflitti acuti, all’interno dello Stato, come sosteneva Locke, che quindi non restava altro che l’appello al cielo, cioè la rivoluzione.
[85] È chiaro che nel caso di grave crisi politica la “garanzia della costituzione” dipende ancor più da circostanze meramente “fattuali”, come il consenso dei governati e la determinazione dei governanti. Ossia sulla legittimità, l’autorità, la virtù – intesa nel senso classico di Machiavelli. Anche l’assetto istituzionale (i poteri costituiti), in tali casi, diviene quasi evanescente.
[86] A tale proposito è opportuno ricordare l’introduzione di Roberto de Mattei al “Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche e delle altre istituzioni umane” da tale opera di de Maistre è “un saggio polemico rivolto contro una determinata categoria di avversari, i fabbricatori di costituzioni a tavolino, gli autori di artificiose costruzioni intellettuali, gli ideologi rivoluzionari che, disprezzando la lezione della storia e dell’esperienza, avevano preteso elaborare un modello puramente astratto delle strutture sociali e politiche” (op. cit., p. 12).









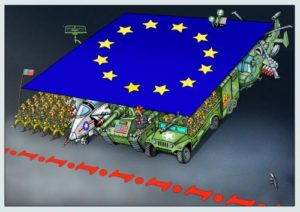 L’Europa e il progetto degli Stati Uniti d’America
L’Europa e il progetto degli Stati Uniti d’America Dal progetto UE della fase monocentrica al progetto Nato della fase multicentrica
Dal progetto UE della fase monocentrica al progetto Nato della fase multicentrica






