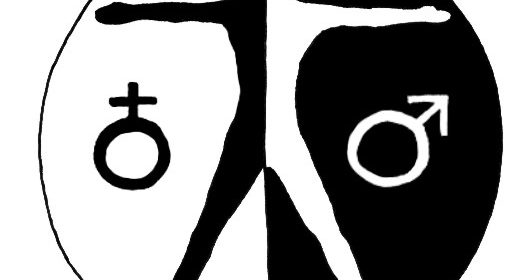NEL MONDO SIAMO SEMPRE IN DUE
(a cura di) Luigi Longo
Le donne sono strane creature, anche quelle provviste di molta intelligenza.
Karl Marx*
Il mio problema è capire come mai la donna non arriva al punto
di soggettività che crei una duplicità di coscienza sul mondo.
Siccome sento che le coscienze sono due, non è una, però poi di
fatto ce n’è solo una e quell’una va a ruota libera come se l’altra
non ci fosse e l’altra si comporta come se non ci fosse davvero.
Carla Lonzi**
Ma perché gli uomini che nascono
Sono figli delle donne
Ma non sono come noi
[…] gli uomini che cambiano
Sono quasi un ideale che non c’è
Mia Martini***
Una piccola premessa
Quando con Giuseppe Germinario parlammo della impostazione del blog Italiaeilmondo e della sua grafica proposi che non si potesse più pensare a un blog senza tenere conto che in tutto il mondo siamo sempre in due (1) e che dovevamo far diventare possibilità ciò che oggi è necessità della relazione con il pensiero femminile, nelle sue diverse articolazioni (2), per capire, interpretare, trasformare e creare un senso della vita.
Posso affermare, in estrema sintesi, che nella tradizione marxiana e marxista non c’è traccia di relazione profonda con il pensiero femminile, e questo è un’assenza che va capita storicamente e va colmata per creare le condizioni per la costruzione, teorica e pratica, di un ordine simbolico sessuato che aprirebbe nuovi orizzonti e nuove visioni del legame sociale della società data. Parafrasando lo storico Carlo Maria Cipolla (che parla di un’epoca di grandi cambiamenti scaturiti dalla rivoluzione industriale) posso dire che qualunque sia il giudizio o la critica assunti, si trova in corrispondenza della creazione del soggetto sessuato della storia un salto che non ha precedenti nella storia: un salto che introduce a un mondo completamente nuovo (3).
Lo spirito di ricerca è quello descritto efficacemente sia da Karl Marx:<< Sarà per me benvenuto ogni giudizio di critica scientifica. Per quanto riguarda i pregiudizi della cosiddetta opinione pubblica, alla quale non ho fatto mai concessioni, per me vale sempre il motto del grande fiorentino: Segui il tuo corso, e lascia dir le genti>> (4), sia di Gianfranco La Grassa:<< Un marxista deve partire da Marx; attestarsi su una determinata rotta con la convinzione di voler arrivare comunque a qualcosa di nuovo, che non può più aspettare dopo un secolo e mezzo [ periodo trascorso dalla pubblicazione del primo libro de Il Capitale curato direttamente da K. Marx,
1867-2017, precisazione e corsivo miei] di continuo calpestare il solito suolo, di ancoraggio nella solita rada. Restare attestati alla fonda dopo tanto tempo implica che non si è marinai se non a chiacchiere. Partire però senza nemmeno sapere dove si stava stazionando durante i preparativi del viaggio, significa votarsi a vagare in alto mare senza cognizione di quale rotta effettiva si sta seguendo. Si può consultare la bussola quanto si vuole; se gli occhi sono appannati, se i giramenti di testa sono incessanti, se le mani tremano e l’aggeggio continua a cadere di mano, l’aggirarsi come quando si esce ubriachi da un tugurio è garantito (5) […] Ovviamente, non ho visitato tutti i moli, tutti i docks e quant’altro ci sia. Ne ho solo tratteggiato uno schizzo e soprattutto mi sono concentrato sulla “insenatura” in cui è situato, per ben individuare quel rapporto sociale che è il capitale, secondo la nota formula marxiana. Se non si conosce questa insenatura, si salpa sbagliando rotta e ci s’incaglia fin da subito. E’ invece necessario, dopo un secolo e mezzo, prendere il mare; magari credendo di andare verso le Indie. Ci si augura che in seguito qualcun altro, assumendo il comando delle navi, si troverà magari nelle Americhe.>> (6).
Perché proporre un saggio di Nancy Fraser
Ho proposto il saggio di Nancy Fraser (7) perché è una buona base di discussione dove viene avanzata una analisi storica sul capitalismo liberale concorrenziale del XIX° secolo, sul capitalismo regolato dallo Stato nel XX° secolo e sul capitalismo finanziarizzato nell’epoca attuale. E’ un saggio che attraverso le lotte di confine tra economia e politica, tra società e natura, tra produzione e riproduzione propone una periodizzazione all’interno delle tre fasi storiche incentrate sulla casalinghizzazione, sul fordismo e salario familiare, sulle famiglie bireddito.
Di Nancy Fraser non condivido la lettura fondamentalmente economicistica nonchè la concezione dello stato, della finanza e del ruolo delle classi lavoratrici; non mi convince il suo saggio soprattutto perché non affronta il problema, fondante e di grande attualità, che invece si poneva Carla Lonzi cioè quello di capire come mai la donna non arriva al punto di soggettività che crei una duplicità di coscienza sul mondo con cui creare un’altra sintesi di ordine simbolico sessuato espressione di due soggettività differenti; per me questo scritto di Nancy Fraser resta una lettura stimolante finalizzata ad iniziare una relazione con il pensiero femminile critico (8).
Inoltre la pubblicazione del saggio di Nancy Fraser è propedeutica ai prossimi miei due scritti che riguarderanno a) Il conflitto strategico e la mossa del cavallo. Appunti di ricerca e b) Il conflitto strategico, una buona base per la costruzione dell’ordine simbolico sessuato. Tempo e spazio della ricerca.
CHI E’NANCY FRASER
Nancy Fraser, filosofa e teorica femminista statunitense, è docente di filosofia e politica alla New School for Social Research, a New York, Einstein Fellow della città di Berlino e titolare della cattedra “Giustizia globale” al College d’ètudes mondiales di Parigi.
EPIGRAFI
* Karl Marx, Lettera a Engels del 28 gennaio 1863 in Marx-Engels, Carteggio, Volume quarto (1861-1866), Editori Riuniti, Roma, 1972, pag.158.
** Carla Lonzi, Vai pure. Dialogo con Pietro Consagra, Scritti di Rivolta femminile, Milano, 1980, p.13.
*** Mia Martini, Gli uomini che non cambiano, www.angolotesti.it ,1992.
NOTE
- E’ il titolo del libro di Luce Irigaray, edito da Baldini Castoldi Dalai editore, Milano, 2006.
- Per una introduzione al pensiero femminista si veda Franco Restaino-Adriana Cavarero, Le filosofie femministe, Paravia, Torino, 1999.
- Carlo Maria Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale, il Mulino, Bologna, 2002, pag.419.
- Karl Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica, Einaudi, Torino, 1975, libro primo, pp.7-8.
- Gianfranco La Grassa, Il capitale non è cosa ma rapporto sociale, www.conflittiestrategie.it, 5/8/2011.
- Gianfranco La Grassa, Navigazione a vista. Un porto in disuso e nuovi moli, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2015, pag.79.
- Nancy Fraser, Le contraddizioni del capitale e del lavoro di cura in www.ilrasoiodioccammicromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/12/11/contraddizioni-del-capitale-e-del-lavoro-di-cura .
- Per un approfondimento delle questioni trattate nel saggio si rimanda a Nancy Fraser, Fortune del femminismo. Dal capitalismo regolato dallo Stato alla crisi neoliberista, Ombre Corte, Verona, 2014; Idem, Oltre l’ambivalenza: la nuova sfida del femminismo in Scienza & Politica n.54/2016, pp.87-102.
LE CONTRADDIZIONI DEL CAPITALE E DEL ‘LAVORO DI CURA’
di NANCY FRASER*
Senza tutto quello che va comunemente sotto il nome di ‘lavoro di cura’ – mettere al mondo e crescere bambini, occuparsi di amici e familiari eccetera – non vi sarebbero cultura, economia, organizzazione politica. Ma tutti questi processi di ‘riproduzione sociale’ – storicamente assegnati al lavoro delle donne – vivono oggi una profonda crisi. Una crisi che, secondo Nancy Fraser, autrice insieme ad Axel Honneth di Redistribuzione o riconoscimento?, è espressione più o meno acuta delle contraddizioni sociali-riproduttive del capitalismo finanziarizzato, che da un lato dipende da questo lavoro di cura per la produzione economica e dall’altro tende a penalizzare quelle stesse capacità riproduttive di cui ha bisogno.
* * *
La «crisi della cura» è oggi un argomento centrale nel dibattito pubblico[1]. Spesso associata alle idee di «mancanza di tempo», «conciliazione lavoro-famiglia» e «impoverimento sociale», fa riferimento alle pressioni che, da più direzioni, stanno attualmente limitando un insieme fondamentale di capacità sociali: mettere al mondo e crescere bambini, prendersi cura di amici e familiari, sostenere famiglie e più ampie comunità, e più in generale mantenere legami[2]. Storicamente, questi processi di «riproduzione sociale» sono stati assegnati al lavoro delle donne, anche se gli uomini ne hanno sempre svolto una parte. Si tratta di un lavoro sia affettivo che materiale, spesso svolto senza retribuzione, indispensabile alla società. In sua assenza non vi sarebbero cultura, economia, organizzazione politica. Nessuna società che indebolisca sistematicamente la riproduzione sociale può resistere a lungo. Oggi, tuttavia, una nuova forma di società capitalistica sta facendo proprio questo. Il risultato è una crisi profonda, non semplicemente della cura, ma della riproduzione sociale in senso lato.
Considero questa crisi come un aspetto di una «crisi generale» che include anche componenti economiche, ecologiche e politiche, le quali si intersecano e aggravano l’un l’altra. La componente relativa alla riproduzione sociale costituisce una dimensione importante di questa crisi generale, ma è spesso trascurata nelle discussioni attuali, che si concentrano soprattutto sui pericoli economici o ecologici. Questo «separatismo critico» è problematico; la componente sociale svolge un ruolo tanto centrale nella crisi più ampia che nessuna delle altre può essere compresa senza tenerne conto. Tuttavia, è vero anche il contrario. La crisi della riproduzione sociale non è indipendente e non può essere adeguatamente compresa da sola. Come intenderla allora? Ritengo che la «crisi della cura» sia meglio interpretata come espressione più o meno acuta delle contraddizioni sociali-riproduttive del capitalismo finanziarizzato. Ciò suggerisce due idee. In primo luogo, le attuali pressioni sulla cura non sono casuali, ma hanno profonde radici sistemiche nella struttura del nostro ordine sociale, che chiamo qui capitalismo finanziarizzato. Nonostante ciò, e questo è il secondo punto, l’attuale crisi della riproduzione sociale indica un che di viziato non solo nell’attuale forma finanziarizzata del capitalismo, ma nella società capitalistica in quanto tale.
La mia tesi è che ogni forma di società capitalistica nutra una profonda «tendenza alla crisi» o contraddizione sociale-riproduttiva: da un lato, la riproduzione sociale è una condizione di possibilità per l’accumulazione continua di capitale; dall’altro, la propensione del capitalismo all’accumulazione illimitata tende a destabilizzare i processi di riproduzione sociale da cui pure dipende. Questa contraddizione sociale-riproduttiva del capitalismo è alla radice della cosiddetta crisi della cura. Benché intrinseca al capitalismo in quanto tale, assume un carattere diverso e distintivo in ogni forma storicamente specifica di società capitalistica – nel capitalismo liberale concorrenziale del XIX secolo; nel capitalismo regolato dallo Stato del dopoguerra; e nel capitalismo neoliberale finanziarizzato del nostro tempo. I deficit di cura che oggi viviamo sono la forma che assume questa contraddizione nella sua terza, più recente fase dello sviluppo capitalistico.
Per sviluppare questa tesi, propongo in primo luogo un quadro della contraddizione sociale del capitalismo in quanto tale, nella sua forma generale. In secondo luogo, tratteggio le linee del suo dispiegamento storico nelle due fasi iniziali dello sviluppo capitalistico. Infine, suggerisco una lettura dei «deficit di cura» odierni come espressioni della contraddizione sociale del capitalismo nella sua fase finanziarizzata attuale.
Trarre vantaggio dal mondo della vita
Gran parte degli analisti della crisi contemporanea si concentrano sulle contraddizioni interne del sistema economico capitalistico. Nel suo cuore, sostengono, opera una tendenza radicata all’autodestabilizzazione, che si esprime periodicamente nelle crisi economiche. Fino a un certo punto, questa interpretazione è corretta; ma non prevede un quadro completo delle tendenze alla crisi intrinseche al capitalismo. Adottando una prospettiva economicistica, intende il capitalismo in modo troppo restrittivo, come un sistema economico simpliciter. Al contrario, intendo assumere una lettura più ampia del capitalismo, comprensiva sia dell’economia ufficiale sia delle sue condizioni «non-economiche» di sfondo. Una simile prospettiva ci consente di concettualizzare, e criticare, lo spettro complessivo delle tendenze alla crisi del capitalismo, incluse quelle riguardanti la riproduzione sociale.
Sostengo che il sottosistema economico capitalistico dipenda da attività sociali riproduttive esterne ad esso, le quali costituiscono una delle sue condizioni di possibilità fondamentali. Altre condizioni di sfondo comprendono le funzioni di governance dei pubblici poteri e la disponibilità della natura come fonte di «input produttivi» e come «canale di scarico» per gli scarti della produzione[3]. Qui, tuttavia, mi concentrerò sul modo in cui l’economia capitalistica dipende da – ma si potrebbe dire, approfitta di – attività di sostentamento, cura e interazione che producono e mantengono i legami sociali, benché non accordi loro alcun valore monetario e li tratti come se fossero gratuiti. Variamente denominata «cura», «lavoro affettivo» o «soggettivazione», quest’attività forma i soggetti umani del capitalismo, li sostiene come esseri naturali incarnati e li costituisce come esseri sociali, formando il loro habitus e l’ethos culturale in cui si muovono. Il lavoro di mettere al mondo e di socializzare i giovani svolge un ruolo centrale in questo processo, almeno quanto prendersi cura degli anziani, mantenere la sfera familiare, costruire la comunità e sostenere significati comuni, disposizioni affettive e orizzonti di valore che sono alla base della cooperazione sociale. Nelle società capitalistiche, gran parte di queste attività, benché non tutte, si svolge al di fuori del mercato – nelle case, nei quartieri, nelle associazioni della società civile, nelle reti informali e nelle istituzioni pubbliche come la scuola, e relativamente poche fra di esse prendono la forma del lavoro salariato. L’attività sociale-riproduttiva non pagata è necessaria all’esistenza del lavoro pagato, all’accumulazione di plusvalore e al funzionamento del capitalismo in quanto tale. Nulla di tutto questo potrebbe esistere in assenza del lavoro domestico, dell’educazione dei bambini, dell’istruzione scolastica, della cura affettiva e di una quantità di altre attività che servono a produrre nuove generazioni di lavoratori e a riprodurre le esistenti, nonché a mantenere legami sociali e visioni comuni. La riproduzione sociale è una condizione di sfondo indispensabile per la possibilità della produzione economica nella società capitalistica[4].
Tuttavia, almeno a partire dall’epoca industriale, le società capitalistiche hanno separato il lavoro di riproduzione sociale dal lavoro di produzione economica. Associando il primo alle donne e il secondo agli uomini, hanno ripagato le attività «riproduttive» con la moneta dell’«amore» e della «virtù», continuando a compensare il «lavoro produttivo» in denaro. In questo modo, le società capitalistiche hanno posto i fondamenti istituzionali per nuove, moderne forme di subordinazione delle donne. Separando il lavoro riproduttivo dal più vasto universo delle attività umane, in cui il lavoro delle donne occupava in precedenza un posto riconosciuto, lo hanno relegato in una «sfera domestica» di nuova istituzione, la cui importanza sociale è stata occultata. E in questo nuovo mondo, in cui il denaro è diventato il principale mezzo di potere, il carattere non remunerato del lavoro delle donne ne ha segnato il destino: chi svolge questo lavoro è in una posizione di subordinazione strutturale a chi guadagna salari in denaro, anche se soddisfa una precondizione necessaria per il lavoro salariato stesso – e viene saturato e mistificato con i nuovi ideali domestici di femminilità.
In generale, quindi, le società capitalistiche separano la riproduzione sociale dalla produzione economica, associando la prima alle donne e oscurando la sua importanza e il suo valore. Paradossalmente, tuttavia, esse rendono le loro economie ufficiali dipendenti proprio dagli stessi processi di riproduzione sociale il cui valore disconoscono. Questa peculiare relazione di separazione-dipendenza-disconoscimento è intrinseca fonte di instabilità: da un lato, la produzione economica capitalistica non è autosufficiente, ma dipende dalla riproduzione sociale; dall’altro, la sua spinta all’accumulazione illimitata minaccia di destabilizzare gli stessi processi e le capacità riproduttive di cui il capitale – e tutti noi – abbiamo bisogno. Nel tempo, come vedremo, ciò può compromettere le condizioni sociali indispensabili all’economia capitalistica. Qui, in effetti, risiede una «contraddizione sociale» intrinseca alla struttura profonda del capitalismo. Come le contraddizioni economiche evidenziate dai marxisti, anche questa è alla base di una tendenza alla crisi. In questo caso, però, la contraddizione non si colloca «all’interno» dell’economia capitalistica, bensì sul confine che separa e al contempo unisce produzione e riproduzione. Né intra-economica né intra-domestica, si tratta di una contraddizione fra questi due elementi costitutivi della società capitalistica. Spesso, beninteso, questa contraddizione è sopita, e la connessa tendenza alla crisi rimane nascosta. Si fa acuta, tuttavia, quando la spinta del capitale all’accumulazione si rende avulsa dalle sue basi sociali, rivoltandosi contro di esse. In questo caso, la logica della produzione economica prevale su quella della riproduzione sociale, destabilizzando i processi da cui dipende il capitale – a risultarne compromesse sono allora le capacità sociali, sia domestiche che pubbliche, indispensabili per sostenere l’accumulazione nel lungo periodo. Distruggendo le condizioni della sua stessa esistenza, la dinamica accumulativa del capitale finisce di fatto per mangiarsi la coda.
Realizzazioni storiche
Questa è la struttura della generale tendenza alla crisi sociale del «capitalismo in quanto tale». Tuttavia, la società capitalistica esiste solo in forme o regimi di accumulazione storicamente specifici. Infatti, l’organizzazione capitalistica della riproduzione sociale ha subìto importanti mutazioni storiche, spesso come esito di contestazioni politiche – in particolare nei periodi di crisi, quando gli attori sociali lottano sui confini che delimitano l’«economia» dalla «società», la «produzione» dalla «riproduzione», il «lavoro» dalla «famiglia», talvolta riuscendo a ridisegnarli. Queste «lotte di confine», come le ho definite, sono tanto essenziali alle società capitalistiche quanto lo sono le lotte di classe analizzate da Marx, e i cambiamenti che producono segnano trasformazioni epocali[5]. Una prospettiva che ponga in primo piano questi cambiamenti può distinguere almeno tre regimi di articolazione della coppia «riproduzione sociale-produzione economica» nella storia del capitalismo.
- Il primo è il regime del capitalismo liberale concorrenziale del XIX secolo. Combinando sfruttamento industriale nel centro europeo ed espropriazione coloniale nella periferia, questo regime si è caratterizzato per la tendenza a lasciare i lavoratori riprodursi «autonomamente», al di fuori dei circuiti di valore monetizzato, mentre gli Stati si tenevano in disparte. Tuttavia, esso ha anche creato un nuovo immaginario borghese di vita domestica. Facendo della riproduzione sociale la provincia delle donne nella famiglia privata, questo regime ha elaborato l’ideale delle «sfere separate», proprio mentre ha privato gran parte delle persone delle condizioni necessarie alla sua realizzazione.
- Il secondo regime è quello del capitalismo regolato dallo Stato del XX secolo. Basato su produzione industriale di massa e consumismo domestico al centro, e sostenuto dalla continua espropriazione coloniale e postcoloniale alla periferia, questo regime ha internalizzato la riproduzione sociale attraverso lo Stato e le prestazioni sociali aziendali. Modificando il modello vittoriano delle sfere separate, ha promosso l’ideale apparentemente più moderno del «salario familiare», anche se, ancora una volta, relativamente poche famiglie erano nelle condizioni di raggiungerlo.
- Il terzo regime è il capitalismo finanziarizzato globale dell’epoca attuale. Questo regime ha delocalizzato la produzione manufatturiera in regioni a bassi costi salariali, ha reclutato le donne nelle forza lavoro pagata e incoraggiato il disinvestimento statale e aziendale dalla protezione sociale. Esternalizzando il lavoro di cura su famiglie e comunità, ha contemporaneamente diminuito la loro capacità di sostenerlo. In un contesto di crescente diseguaglianza, il risultato è un’organizzazione duale della riproduzione sociale, mercificata per quelli che possono pagare per averla, ricondotta al privato familiare per quelli che non possono – il tutto contornato dall’ideale ancora più moderno della «famiglia bireddito».
In ogni regime, dunque, le condizioni sociali-riproduttive per la produzione capitalistica hanno assunto una forma istituzionale e incarnato un ordine normativo differenti: prima le «sfere separate», poi «il salario familiare», ora la «famiglia bireddito». In ciascun caso, inoltre, la contraddizione sociale della società capitalistica ha assunto un profilo diverso, trovando espressione in un insieme eterogeneo di fenomeni di crisi. In ogni regime, infine, la contraddizione sociale del capitalismo ha provocato diverse forme di lotta sociale – lotte di classe, senz’altro, ma anche lotte di confine – le quali si sono intrecciate anche con altre lotte, per l’emancipazione di donne, schiavi e popoli colonizzati.
“Casalinghizzazione”
Consideriamo anzitutto il capitalismo liberale concorrenziale del XIX secolo. In quest’epoca, gli imperativi di produzione e riproduzione sembravano stare in aperta contraddizione l’uno con l’altro. Nei primi centri manufatturieri del nucleo capitalista, gli industriali costrinsero donne e bambini nelle fabbriche e nelle miniere, avidi di lavoro a basso costo e data la loro reputazione di docilità. Pagate una miseria e costrette a lavorare per molte ore in condizioni malsane, queste lavoratrici diventarono il simbolo del disprezzo del sistema capitalistico per le relazioni e le capacità sociali alla base della sua produttività[6]. Ne seguì una crisi su almeno due livelli: da un lato, una crisi della riproduzione sociale fra poveri e classi lavoratrici, le cui capacità di sostentamento e riproduzione giunsero al collasso; dall’altro, un senso di panico morale fra le classi medie, scandalizzate da quella che ai loro occhi era la «distruzione della famiglia» e la «de-sessuazione» delle donne della classe operaia. La situazione era grave al punto che anche critici tanto acuti come Marx ed Engels fraintesero questi primi conflitti frontali fra produzione economica e riproduzione sociale: credendo che il capitalismo fosse entrato nella sua crisi terminale, essi pensavano che, nel distruggere la famiglia proletaria, il sistema stesse anche sradicando le basi dell’oppressione delle donne[7]. Ma quel che stava accadendo era in realtà proprio il contrario: nel corso del tempo, le società capitalistiche trovavano risorse per gestire questa contraddizione – in parte creando «la famiglia» nella sua ristretta forma moderna, reinventando e intensificando le differenze di genere, e modernizzando il dominio maschile.
In Europa, il processo ebbe inizio con l’adozione di una legislazione protettiva. L’idea era di stabilizzare la riproduzione sociale limitando lo sfruttamento di donne e bambini nel lavoro di fabbrica[8]. Guidata dai riformisti della classe media in alleanza con le nascenti organizzazioni dei lavoratori, questa «soluzione» rifletteva un amalgama complesso di motivazioni eterogenee. Un obiettivo, descritto com’è noto da Karl Polanyi, consisteva nel difendere la «società» dall’«economia»[9]. Un altro obiettivo consisteva nel placare l’ansia per il «livellamento di genere». Ma queste ragioni si legavano anche a qualcos’altro: l’importanza assegnata all’autorità maschile su donne e bambini, in particolare all’interno della famiglia[10]. Di conseguenza, la lotta per garantire l’integrità della riproduzione sociale finì per intrecciarsi con la difesa del dominio maschile.
L’effetto voluto, tuttavia, era di mettere a tacere la contraddizione sociale nel centro capitalistico – proprio mentre la schiavitù e il colonialismo nella periferia la portavano all’estremo. Creando quella che Maria Mies ha chamato «casalinghizzazione» (housewifization), intesa come l’altra faccia della colonizzazione[11], il capitalismo liberale concorrenziale diede forma a un nuovo immaginario di genere incentrato sulle sfere separate. Rappresentando la donna come «l’angelo del focolare», i suoi sostenitori erano alla ricerca di un’àncora di stabilità che controbilanciasse la volatilità dell’economia. Lo spietato mondo della produzione andava affiancato da un «paradiso in un mondo senza cuore»[12]. Finché ogni lato si atteneva alla sua designata sfera, fungendo da complemento dell’altro, il loro potenziale conflitto sarebbe rimasto nascosto.
In realtà, questa «soluzione» si rivelò piuttosto precaria. La legislazione protettiva non poteva assicurare la riproduzione del lavoro se i salari rimanevano al di sotto del livello necessario a sostenere una famiglia, se le abitazioni affollate e immerse nell’inquinamento impedivano la vita privata e causavano malattie polmonari, se l’occupazione stessa (quando disponibile) era soggetta a fluttuazioni selvagge dovute a bancarotte, crolli di mercato e panico finanziario. Neanche i lavoratori erano soddisfatti di questo compromesso. Mobilitandosi per salari più alti e migliori condizioni di lavoro, formarono sindacati, organizzarono scioperi e aderirono a partiti socialisti e laburisti. Lacerato da un conflitto di classe sempre più acuto ed esteso, il futuro del capitalismo sembrava tutto fuorché garantito.
Le sfere separate si rivelarono anch’esse problematiche. Le donne povere e razzializzate della classe operaia non erano certo nella posizione per soddisfare gli ideali vittoriani di vita domestica; se la legislazione protettiva mitigava il loro sfruttamento diretto, non offriva loro alcun supporto materiale o compensazione per la perdita del salario. Neanche le donne della middle-class, che avevano i mezzi per conformarsi agli ideali vittoriani, erano soddisfatte della loro situazione, che combinava comodità materiale e prestigio morale con lo stato di minorità legale e dipendenza istituzionalizzata. Per entrambi i gruppi, la «soluzione» delle sfere separate si realizzava in gran parte a spese delle donne. Ma finì anche per metterle le une contro le altre – come testimoniano le lotte del XIX secolo sulla prostituzione, in cui le preoccupazioni filantropiche delle donne della middle-class vittoriana confliggevano con gli interessi materiali delle loro «sorelle perdute»[13].
Una dinamica diversa aveva luogo alla periferia. Lì, poiché il colonialismo estrattivo saccheggiava popolazioni soggiogate, né le sfere separate né la protezione sociale godevano di alcun credito. Lungi dal tentare di proteggere le relazioni locali di riproduzione sociale, i poteri delle metropoli incoraggiavano attivamente la loro distruzione. Le popolazioni rurali furono depredate e le loro comunità distrutte per fornire cibo a basso costo, tessuti, minerali ed energia, senza i quali lo sfruttamento dei lavoratori industriali delle metropoli non sarebbe stato redditizio. Nelle Americhe, intanto, le capacità riproduttive delle donne ridotte in schiavitù furono asservite ai calcoli di profitto dei piantatori, che regolarmente distruggevano le famiglie di schiavi vendendone i membri a più proprietari[14]. Anche i bambini nativi furono strappati dalle comunità, reclutati in scuole missionarie e sottomessi a discipline coercitive di assimilazione[15]. Quando si rendevano necessarie delle giustificazioni, lo stato «retrogrado, patriarcale» delle collettività parentali indigene pre-capitalistiche serviva alquanto bene allo scopo. Anche qui, fra i colonialisti, le donne filantrope fecero sentire pubblicamente la loro voce, esortando «gli uomini bianchi a salvare le donne scure dagli uomini scuri»[16].
Tanto al centro quanto alla periferia, i movimenti femministi si trovarono a negoziare un campo politico minato. Nel rifiutare la tutela maritale e le sfere separate e nel rivendicare il diritto di voto, il rifiuto del sesso, l’ accesso alla proprietà, il diritto a stipulare contratti, a svolgere professioni ed esercitare un controllo sui propri salari, le femministe liberali sembravano dare più valore all’aspirazione «maschile» all’autonomia che agli ideali «femminili» di cura. E su questo punto, come su poco altro, le loro controparti socialiste-femministe in effetti concordavano. Considerando l’ingresso delle donne nel lavoro salariato come la strada verso l’emancipazione, anche queste ultime preferivano i valori «maschili» della produzione a quelli legati alla riproduzione. Queste associazioni erano senz’altro ideologiche, ma celavano un’intuizione profonda: nonostante le nuove forme di dominio che portava con sé, l’erosione delle relazioni di parentela tradizionali da parte del capitalismo conteneva un momento di emancipazione.
Intrappolate in questa contraddizione, molte femministe trovarono scarsa consolazione su entrambi i lati del doppio movimento di Polanyi: quello della protezione sociale, con il suo corollario di dominio maschile, e quello della logica di mercato, con il suo disprezzo per la riproduzione sociale. Incapaci tanto semplicemente di rifiutare quanto di accettare l’ordine liberale, avevano bisogno di una terza alternativa, che chiamarono emancipazione. Nella misura in cui le femministe furono capaci di impersonare quel termine, fecero effettivamente saltare la figura dualistica polanyiana, sostituendola con quello che potremmo chiamare un «triplo movimento». In questo conflitto su tre fronti, le sostenitrici della protezione e della mercatizzazione si scontravano non solo fra di loro, ma anche con chi difendeva l’emancipazione: con le femministe, certo, ma anche con socialisti, abolizionisti e anticolonialisti, i quali si sforzavano di mettere le due forze polanyiane l’una contro l’altra, proprio mentre si scontravano fra di loro. Per quanto in teoria promettente, una simile strategia era difficile da realizzare. Finché gli sforzi di «proteggere la società dall’economia» si confondevano con la difesa della gerarchia di genere, l’opposizione femminista al dominio maschile poteva facilmente essere accusata di avallare le forze economiche che stavano distruggendo la classe operaia e le comunità della periferia. Queste associazioni si sarebbero rivelate sorprendentemente durevoli, molto tempo dopo il collasso del capitalismo liberale concorrenziale sotto il peso delle sue molteplici contraddizioni, nell’agonia di guerre inter-imperialistiche, depressioni economiche e caos finanziario internazionale – aprendo la strada a un nuovo regime nella metà del XX secolo, quello del capitalismo regolato dallo Stato.
Fordismo e salario familiare
Emergendo dalle ceneri della Grande Depressione e della seconda guerra mondiale, il capitalismo regolato dallo Stato disinnescava la contraddizione fra produzione economica e riproduzione sociale in un altro modo – affidandosi al potere dello Stato sul lato della riproduzione. Assumendosi qualche responsabilità pubblica per la «previdenza sociale», gli Stati di quest’epoca cercarono di contrastare gli effetti corrosivi sulla riproduzione sociale non solo dello sfruttamento, ma anche della disoccupazione di massa. Tale obiettivo fu perseguito dagli Stati socialdemocratici del centro capitalistico e dagli Stati in via di sviluppo della periferia da poco indipendenti – nonostante le diseguali capacità di realizzarlo.
Le ragioni erano, ancora una volta, eterogenee. Un gruppo di élite illuminate era giunto a credere che l’interesse a breve termine del capitale nello spremere massimi profitti andasse subordinato all’esigenza più a lungo termine di sostenere l’accumulazione nel corso del tempo. L’istituzione del regime regolato dallo Stato rispondeva all’esigenza di salvare il sistema capitalistico dalle sue stesse propensioni a destabilizzarsi – nonché dallo spettro della rivoluzione in un’epoca di mobilitazioni di massa. La produttività e la ricerca del profitto richiedevano la coltivazione «biopolitica» di una forza lavoro in salute e istruita dotata di un interesse nel sistema, in opposizione alla cenciosa folla rivoluzionaria[17]. L’investimento pubblico in sanità, istruzione, servizi per l’infanzia e pensioni, con la partecipazione finanziaria delle imprese, era percepito come una necessità in un’epoca in cui i rapporti capitalistici avevano penetrato la vita sociale al punto che le classi lavoratrici non avevano più i mezzi per riprodurre se stesse in modo autosufficiente. In una tale situazione, la riproduzione sociale andava internalizzata, portata sotto il dominio ufficiale dell’ordine capitalista.
Il progetto rispondeva anche alla nuova problematica della «domanda» economica. Mirando ad appianare i cicli endemici di espansione e contrazione del capitalismo, i riformatori economici cercarono di assicurare la crescita continua consentendo ai lavoratori nel centro capitalista di assolvere a un doppio dovere di produttori e consumatori. Accettando la sindacalizzazione, che portava salari più alti, e la spesa pubblica, che creava occupazione, i decisori politici reinventarono ora la casa come uno spazio privato per il consumo domestico di oggetti di uso quotidiano prodotti in serie[18]. Legando la catena di montaggio al consumismo familiare della classe operaia da un lato, e alla riproduzione sostenuta dallo Stato dall’altro, tale modello fordista diede forma a una nuova sintesi di mercatizzazione e protezione sociale – progetti che Polanyi aveva considerato antitetici.
Ma furono soprattutto le classi lavoratrici – sia donne che uomini – a guidare la lotta per i servizi pubblici, agendo per proprie ragioni. In questione per loro era la piena appartenenza alla società come cittadini e cittadine democratici – quindi dignità, diritti, rispettabilità e benessere materiale, tutti elementi che erano intesi richiedere una vita familiare stabile. Appoggiando la socialdemocrazia, allora, le classi lavoratrici stavano anche valorizzando la riproduzione sociale contro il dinamismo divorante della produzione economica. In effetti, i lavoratori votavano per famiglia, territorio e mondo-della-vita contro fabbrica, sistema e macchine. Diversamente dalla legislazione protettiva del regime liberale, la politica del capitalismo regolato dallo Stato era il frutto di un compromesso di classe e rappresentava un progresso democratico. Diversamente dal regime precedente, inoltre, questi nuovi compromessi servirono, almeno per alcuni e per un po’ di tempo, a stabilizzare la riproduzione sociale. Per i lavoratori delle nazionalità maggioritarie dei paesi nel centro capitalista, esse alleviarono le pressioni materiali sulla vita familiare e favorirono l’integrazione politica.
Ma prima di affrettarci a proclamare un’età dell’oro, dovremmo tenere conto delle esclusioni costitutive che resero possibili questi risultati. Come in precedenza, la difesa della riproduzione sociale al centro si intrecciava con il (neo)imperialismo; i regimi fordisti finanziavano i diritti sociali in parte attraverso la continuazione dell’espropriazione della periferia – inclusa la «periferia nel centro» – che persisteva in vecchie e nuove forme dopo la decolonizzazione[19]. Nel frattempo, gli Stati postcoloniali stretti nella morsa della Guerra fredda diressero gran parte delle loro risorse, già impoverite dalla predazione imperiale, verso progetti di sviluppo su larga scala, che spesso comportavano l’espropriazione dei «propri» popoli indigeni. Per la grande maggioranza nella periferia la riproduzione sociale rimaneva esterna, dal momento che le popolazioni rurali furono abbandonate a loro stesse. Come il regime che lo aveva preceduto, anche il regime regolato dallo Stato si intrecciava con le gerarchie razziali: le assicurazioni sociali statunitensi escludevano lavoratori domestici e agricoli, di fatto tagliando fuori molti afroamericani dalle prestazioni sociali[20]. E la divisione razziale del lavoro riproduttivo, cominciata durante la schiavitù, assunse una nuova forma sotto Jim Crow, considerato che le donne di colore trovavano lavoro mal pagato crescendo i bambini e facendo le pulizie nelle case delle famiglie «bianche», a scapito delle loro[21].
Neanche la gerarchia di genere mancava in questo compromesso. In un periodo – approssimativamente dagli anni Trenta fino alla fine degli anni Cinquanta – in cui i movimenti femministi non godevano di molta visibilità pubblica, difficilmente qualcuno contestava l’idea che la dignità proletaria richiedesse «il salario familiare», un’autorità maschile in casa e un forte senso della differenza di genere. Di conseguenza, la tendenza generale del capitalismo regolato dallo Stato nei paesi del centro era di valorizzare il modello eteronormativo, maschio-capofamiglia e donna-casalinga, della famiglia basata sul genere. L’investimento pubblico nella riproduzione sociale rafforzava queste norme. Negli Stati Uniti, il sistema previdenziale assumeva una forma duale, divisa in assistenza per donne povere («bianche») e bambini senza accesso a un salario maschile, da un lato, e un’assicurazione sociale considerata rispettabile per quelli che venivano costruiti come «lavoratori», dall’altro[22]. Invece, i provvedimenti europei rafforzavano la gerarchia androcentrica in modo diverso, nell’opposizione fra sussidi destinati alle madri e diritti legati al lavoro salariato – promossa in molti casi attraverso programmi a favore delle nascite nati dalla concorrenza fra Stati[23]. Entrambi i modelli legittimavano, assumevano e incoraggiavano il salario familiare. Istituzionalizzando una visione androcentrica della famiglia e del lavoro, essi naturalizzavano l’eteronormatività e la gerarchia di genere, sottraendoli ampiamente alla contestazione politica.
Sotto tutti questi aspetti, la socialdemocrazia sacrificava l’emancipazione in nome di un’alleanza fra protezione sociale e mercatizzazione, nonostante per molti decenni avesse mitigato la contraddizione sociale del capitalismo. Tuttavia, il regime di Stato capitalistico cominciava a disfarsi; prima politicamente, negli anni Sessanta, quando la New Left globale fece irruzione denunciando, in nome dell’emancipazione, le sue esclusioni imperialistiche, di genere e razziali, nonché il suo paternalismo burocratico; e poi economicamente, negli anni Settanta, quando la stagflazione, la «crisi di produttività», e il calo dei tassi di crescita nella produzione manufatturiera rinvigorirono gli sforzi neoliberali di dare il via libera alla mercatizzazione. Ad essere sacrificata nell’unione delle forze di queste due fazioni, sarebbe stata la protezione sociale.
Famiglie bireddito
Come il precedente regime liberale, l’ordine del capitalismo regolato dallo Stato si è dissolto nel corso di una lunga crisi. A partire dagli anni Ottanta, alcuni osservatori potevano distinguere precocemente i primi tratti di un nuovo regime, che sarebbe diventato il capitalismo finanziarizzato dell’epoca attuale. Questo regime, globalizzato e neoliberale, promuove il disinvestimento pubblico e privato dalla protezione sociale mentre recluta le donne nella forza lavoro pagata – esternalizzando il lavoro di cura verso le famiglie e le comunità nell’atto stesso di indebolire la loro capacità di realizzarlo. Il risultato è una nuova organizzazione duale della riproduzione sociale, mercificata per quelli che possono pagare per averla, e ricondotta al privato familiare per quelli che non possono, considerato che alcuni membri della seconda categoria offrono lavoro di cura ad alcuni membri della prima, in cambio di (bassi) salari. Nel frattempo, l’azione congiunta della critica femminista e della deindustrializzazione ha definitivamente spogliato «il salario familiare» di ogni credibilità. Quell’ideale ha aperto la strada alla norma contemporanea della «famiglia bireddito».
Il principale motore di questi sviluppi, nonché tratto distintivo del regime, è la nuova centralità del debito. Il debito è lo strumento attraverso cui le istituzioni globali finanziarie premono sugli Stati per tagliare la spesa sociale, imporre l’austerità, e in generale colludere con gli investitori nell’estrazione di valore da popolazioni inermi. Di più, è soprattutto attraverso il debito che i contadini nel Sud Globale sono spossessati da un nuovo giro di appropriazioni private del suolo, finalizzato a monopolizzare l’offerta di energia, acqua, terra coltivabile e delle «compensazioni per l’emissione di anidride carbonica». È sempre più attraverso il debito che procede anche l’accumulazione nel nucleo storico del capitalismo: dal momento che il lavoro precario e malpagato nei servizi sostituisce il lavoro sindacalizzato industriale, i salari cadono al di sotto dei costi socialmente necessari di riproduzione; in questa «economia dei lavoretti» («gig economy»), la spesa costante per i consumi richiede un’espansione del volume dei crediti al consumatore, che cresce in modo esponenziale[24]. È sempre più attraverso il debito, in altre parole, che il capitale oggi cannibalizza il lavoro, disciplina gli Stati, trasferisce ricchezza dalla periferia al centro ed estrae valore da case, famiglie, comunità e natura.
L’effetto è quello di intensificare la contraddizione insita nel capitalismo fra produzione economica e riproduzione sociale. Mentre il regime precedente consentiva agli Stati di subordinare gli interessi a breve termine delle aziende private all’obiettivo a lungo termine dell’accumulazione, in parte stabilizzando la riproduzione con le prestazioni pubbliche, questo regime autorizza il capitale finanziario a subordinare Stati e istituzioni agli interessi immediati degli investitori privati, non ultimo chiedendo il disinvestimento pubblico dalla riproduzione sociale. Se il regime precedente alleava la mercatizzazione con la protezione sociale contro l’emancipazione, questo genera una configurazione anche più perversa, in cui l’emancipazione si unisce alla mercatizzazione per indebolire la protezione sociale.
Il nuovo regime è emerso dalla fatale intersezione fra due insiemi di lotte. Un insieme opponeva una fazione ascendente di sostenitori del libero mercato, decisi a liberalizzare e globalizzare l’economia capitalistica, contro i movimenti dei lavoratori in declino nei paesi del centro; se in passato erano la base più forte di supporto alla socialdemocrazia, sono adesso sulla difensiva, se non del tutto sconfitti. L’altro insieme di lotte opponeva i «nuovi movimenti sociali» progressisti, che contestavano le gerarchie di genere, sesso, «razza», etnia e religione, contro popolazioni intenzionate a difendere mondi-della-vita stabiliti e privilegi, ora minacciati dal «cosmopolitismo» della new economy. Dalla collisione di questi due insiemi di lotte è emerso un risultato inatteso: un neoliberalismo «progressista», che celebra la «diversità», la meritocrazia e l’«emancipazione» mentre smantella le protezioni sociali e ri-esternalizza la riproduzione sociale. La conseguenza non è solo l’abbandono delle popolazioni inermi alle predazioni del capitale, ma anche la ridefinizione dell’emancipazione in termini di mercato[25]. Alcuni movimenti per l’emancipazione hanno partecipato a questo processo. Tutti – compresi i movimenti antirazzisti, multiculturalisti, per la liberazione LGBT e per l’ecologia – hanno dato vita a correnti neoliberali favorevoli al mercato. Ma la traiettoria femminista si è rivelata particolarmente fatale, dato il legame capitalistico di lunga data fra genere e riproduzione sociale. Come i regimi precedenti, il capitalismo finanziarizzato istituzionalizza la divisione produzione-riproduzione su una base di genere. Diversamente dai regimi precedenti, però, il suo immaginario dominante è liberale-individualista ed egualitarista rispetto al genere: le donne sono considerate uguali agli uomini in ogni sfera, meritevoli di uguali opportunità per realizzare i loro talenti, compreso – forse in modo particolare – nella sfera della produzione. La riproduzione, per contro, appare come un residuo arretrato, un ostacolo al progresso da eliminare, in un modo o nell’altro, nella strada verso la liberazione.
A dispetto o forse a causa della sua aura femminista, questa concezione incarna l’attuale forma della contraddizione sociale del capitalismo, che assume una nuova intensità. Oltre a ridurre le prestazioni pubbliche e ad assumere donne nel lavoro salariato, il capitalismo finanziarizzato ha abbassato i salari reali, così portando i membri dei nuclei familiari ad aumentare il numero di ore di lavoro pagato necessario a sostenere una famiglia, e spingendo a una corsa disperata per trasferire ad altri il lavoro di cura[26]. Per colmare il «divario della cura» (care gap), il regime importa lavoratrici migranti dalle nazioni più povere a quelle più ricche. Tipicamente, si tratta di donne razzializzate, spesso donne rurali provenienti da regioni povere che si fanno carico del lavoro riproduttivo e di cura che prima era svolto da donne più privilegiate. Ma per poterlo fare, le migranti devono trasferire le proprie responsabilità familiari e comunitarie ad altre lavoratrici della cura ancora più povere, che a loro volta devono fare lo stesso – e così via, in sempre più lunghe «catene globali della cura». Lungi dal colmare il divario della cura, l’effetto netto è di delocalizzarlo – dalle famiglie più ricche alle più povere, dal Nord globale al Sud globale[27]. Questo scenario incontra le strategie di genere degli Stati postcoloniali a corto di denaro e indebitati, soggetti ai programmi di regolazione strutturale dell’FMI. Alla disperata ricerca di valuta forte, alcuni fra loro hanno promosso attivamente l’emigrazione delle donne per svolgere all’estero lavoro di cura pagato e così beneficiare delle rimesse, mentre altri hanno corteggiato l’investimento estero diretto creando zone di trasformazione per l’esportazione, spesso nelle industrie, per esempio tessili o di elettronica, che preferiscono impiegare lavoratrici donne[28]. In entrambi i casi, le capacità sociali-riproduttive sono ulteriormente colpite.
Due recenti sviluppi negli Stati Uniti offrono un esempio della gravità della situazione. Il primo è la crescente popolarità del «congelamento degli ovuli», una procedura che normalmente costa 10 mila dollari, ma adesso offerta gratuitamente dalle aziende IT come beneficio aggiuntivo alle impiegate più qualificate. Impazienti di attirare e trattenere queste lavoratrici, aziende come Apple e Facebook offrono loro un forte incentivo a rimandare la gravidanza, dicendo, di fatto: «Aspetta e abbi i tuoi bambini a quaranta, cinquanta, o anche sessant’anni; dedica a noi i tuoi anni più produttivi, quelli in cui hai più energia»[29].
Un secondo sviluppo negli Stati Uniti è ugualmente sintomatico della contraddizione fra riproduzione e produzione: la proliferazione di tiralatte meccanici molto costosi ad alta tecnologia, per la raccolta del latte materno. Questa è la «soluzione» a cui ricorrere in un paese con un alto tasso di partecipazione della forza lavoro femminile, privo di congedo obbligatorio di maternità o parentale, e una relazione d’amore con la tecnologia. Questo è un paese, inoltre, in cui l’allattamento al seno è de rigueur, ma è cambiato radicalmente, più di quanto venga riconosciuto. Non si tratta più di allattare un bambino al seno, ora «si allatta» raccogliendo il proprio latte meccanicamente e depositandolo per l’alimentazione con il biberon in un secondo momento da parte della tata. In un contesto caratterizzato da cronica mancanza di tempo, i tiralatte a doppia coppa che non richiedono l’uso delle mani sono considerati preferibili, perché permettono di raccogliere il latte contemporaneamente da entrambi i seni durante la guida in autostrada per andare al lavoro[30].
Date simili pressioni, c’è forse da stupirsi se negli ultimi anni sono esplose le lotte sulla riproduzione sociale? Le femministe del Nord spesso descrivono il fulcro delle loro rivendicazioni in termini di «conciliazione lavoro-famiglia»[31]. Ma le lotte sulla riproduzione sociale includono molto di più: movimenti comunitari per la casa, le cure sanitarie, la sicurezza alimentare e un reddito di base incondizionato; lotte per i diritti di migranti, lavoratrici domestiche e impiegati pubblici; campagne per sindacalizzare le lavoratrici del settore dei servizi in case di cura, ospedali e centri per l’infanzia privati; lotte per i servizi pubblici come asili e centri per gli anziani, per una settimana lavorativa più corta, per un generoso congedo di maternità e parentale pagato. Considerate insieme, queste rivendicazioni equivalgono alla richiesta di una massiccia riorganizzazione del rapporto fra produzione e riproduzione: per delle soluzioni sociali che possano mettere persone di ogni classe, genere, sessualità e colore, nelle condizioni di coniugare attività sociali-riproduttive con un lavoro sicuro, interessante e ben remunerato.
Le lotte sui confini della riproduzione sociale sono tanto centrali nell’attuale congiuntura quanto lo sono le lotte di classe per la produzione economica. Esse rispondono prima di tutto a una «crisi della cura» radicata nelle dinamiche strutturali del capitalismo finanziarizzato. Globalizzato e alimentato dal debito, questo capitalismo sta espropriando sistematicamente le capacità disponibili per sostenere i legami sociali. Annunciando il nuovo ideale della famiglia bireddito, esso attira a sé movimenti per l’emancipazione, che si uniscono ai sostenitori della mercatizzazione per opporsi ai partigiani della protezione sociale, ora diventati sempre più risentiti e sciovinisti.
Un’altra mutazione?
Cosa potrebbe emergere da questa crisi? Nel corso della sua storia, la società capitalistica ha reinventato se stessa molte volte. Specie nei momenti di crisi generale, quando molteplici contraddizioni – politica, economica, ecologica e sociale-riproduttiva – si intrecciano e inaspriscono l’un l’altra, le lotte di confine sono esplose nelle giunture delle divisioni istituzionali costitutive del capitalismo: dove l’economia incontra la politica, dove la società incontra la natura, e dove la produzione incontra la riproduzione. Gli attori sociali si sono mobilitati su questi confini per ridisegnare la mappa istituzionale della società capitalistica. I loro sforzi hanno alimentato il passaggio prima dal capitalismo liberale concorrenziale del XIX secolo al capitalismo regolato dallo Stato del XX, e in seguito al capitalismo finanziarizzato dell’epoca attuale. Inoltre, la contraddizione sociale del capitalismo costituisce storicamente una componente essenziale nelle dinamiche che conducono alla crisi, dato che il confine che divide la riproduzione sociale dalla produzione economica si è rivelato come la sede e la posta in gioco fondamentale della lotta. Ogni volta, l’ordine di genere della società capitalistica è stato contestato, e l’esito è dipeso dalle alleanze formatesi fra i poli principali di un triplo movimento: mercatizzazione, protezione sociale, emancipazione. Queste dinamiche sono il motore della transizione, prima dalle sfere separate al salario familiare, poi alla famiglia bireddito.
Cosa aspettarsi dalla congiuntura attuale? Le contraddizioni odierne del capitalismo finanziarizzato sono tanto gravi da configurarsi come una crisi generale, e dovremmo aspettarci un’altra mutazione della società capitalistica? L’attuale crisi alimenterà le lotte, con ampiezza e prospettiva tali da trasformare l’attuale regime? Una nuova forma di femminismo socialista potrebbe riuscire a rompere la storia d’amore fra mercatizzazione e movimento mainstream, creando una nuova alleanza fra emancipazione e protezione sociale? E, se sì, a che fine? Come si potrebbe reinventare oggi la divisione riproduzione-produzione, e cosa potrebbe prendere il posto della famiglia bireddito?
Nulla di ciò che ho detto qui serve direttamente a rispondere a queste domande. Ma nel tracciare le basi che ci permettono di porle, ho provato a gettare un po’ di luce sulla congiuntura attuale. Più precisamente, ho suggerito che le radici della «crisi della cura» odierna risiedono nella contraddizione sociale insita nel capitalismo – o piuttosto nella forma acuta che la contraddizione assume oggi, nel capitalismo finanziarizzato. Se questa interpretazione è corretta, allora la crisi non sarà risolta tentando di dare una ritoccata alle politiche sociali. Il percorso per la sua risoluzione può passare solo attraverso una profonda trasformazione strutturale dell’ordine sociale. Quel che è necessario, prima di tutto, è porre fine alla sottomissione rapace della riproduzione alla produzione compiuta dal capitalismo finanziarizzato – stavolta però senza sacrificare l’emancipazione o la protezione sociale. Ciò a sua volta richiede di reinventare la distinzione produzione-riproduzione e di reimmaginare l’ordine di genere. Resta da vedere se il risultato sarà del tutto compatibile con il capitalismo.
[* Questo saggio è uscito originariamente sulla New Left Review, n. 100/2016, con il titolo «Contradictions of Capital and Care» (goo.gl/wGYPFL). Su autorizzazione della NLR avrebbe dovuto essere pubblicato all’interno dell’Almanacco di filosofia di MicroMega in uscita il 14 dicembre ma la casa editrice Mimesis (chiedendo direttamente all’autrice che però non ha comunicato l’autorizzazione alla NLR), ha dato alle stampe una traduzione italiana che ci ha quindi indotti a scegliere di pubblicarlo sul sito anziché sul cartaceo.]
NOTE
[1] Una traduzione francese di questo saggio è stata presentata a Parigi il 14 giugno 2016 alla Marc Bloch Lecture dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales ed è disponibile sul sito dell’École. Ringrazio Pierre-Cyrille Hautcoeur per l’invito alla conferenza, Johanna Oksala per le discussioni stimolanti, Mala Htun ed Eli Zaretsky per gli utili commenti, e Selim Heper per l’assistenza nella ricerca.
[2] Si vedano, fra i molti altri esempi recenti, R. Rosen, «The Care Crisis», The Nation, 27/2/2007; C. Hess, «Women and the Care Crisis», Institute for Women’s Policy Research Briefing Paper n. 401/2013; D. Boffey, «Half of All Services Now Failing as UK Care Sector Crisis Deepens», The Guardian, 26/9/2015. Sulla «mancanza di tempo», cfr. A. Hochschild, The Time Bind, Henry Holt and Company, New York 2001; H. Boushey, Finding Time, Harvard University Press, Cambridge 2016. Sulla «conciliazione lavoro-famiglia», cfr. H. Boushey-A. Rees Anderson, «Work–Life Balance», Forbes, 26/7/2013; M. Beck, «Finding Work-Life Balance», The Huffington Post, 10/3/2015. Sull’«impoverimento sociale», cfr. S. Rai-C. Hoskyns- D. Thomas, «Depletion: The Cost of Social Reproduction», International Feminist Journal of Politics, n. 1/2013.
[3] Per un quadro sulle condizioni politiche di sfondo necessarie a un’economia capitalistica, cfr. N. Fraser, «Legitimation Crisis?», Critical Historical Studies, n. 2/2015. Sulle condizioni ecologiche, cfr. J. O’Connor, «Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction», Capitalism, Nature, Socialism, n. 1/1988; J. Moore, Capitalism in the Web of Life, Verso, London-New York 2015.
[4] Molte teoriche femministe hanno proposto delle versioni di questo argomento. Per formulazioni marxiste-femministe, cfr. L. Vogel, Marxism and the Oppression of Women, Pluto Press, London 1983; S. Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, New York 2012 (trad. it. di A. Curcio, Il punto zero della rivoluzione, Ombre corte, Verona 2014); C. Delphy, Close to Home, University of Massachusetts Press, Amherst 1984. Un’altra potente elaborazione si trova in N. Folbre, The Invisible Heart, The New Press, New York 2002 (trad. it. di F. Pretolani, Il cuore invisibile, EGEA, Milano 2014). Per la «teoria della riproduzione sociale», cfr. B. Laslett-J. Brenner, «Gender and Social Reproduction», Annual Review of Sociology, vol. 15, 1989; K. Bezanson-M. Luxton (a c. di), Social Reproduction, Montréal 2006; I. Bakker, «Social Reproduction and the Constitution of a Gendered Political Economy», New Political Economy, n. 4/2007; C. Arruzza, «Functionalist, Determinist, Reductionist», Science & Society, n. 1/2016.
[5] Sulle lotte di confine e per una critica della visione del capitalismo come economia, cfr. N. Fraser, «Behind Marx’s Hidden Abode», New Left Review, 2/2014.
[6] L. Tilly-J. Scott, Women, Work, and Family, Methuen, London 1987 (trad. it. di A. Lamarra, Donne, lavoro e famiglia nell’evoluzione della società capitalistica, De Donato, Bari 1981).
[7] K. Marx-F. Engels, «Manifesto of the Communist Party», in The Marx-Engels Reader, W.W. Norton and Company, New York 1978, pp. 487–8 (trad. it. di P. Togliatti, Manifesto del partito comunista, Editori Riuniti, Roma 1980); F. Engels, The Origins of the Family, Private Property and the State, Charles H. Kerr & Co., Chicago 1902, pp. 90–100 (trad. it. di D. Della Terza, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, Editori Riuniti, Roma 2005).
[8] N. Woloch, A Class by Herself, Princeton University Press, Princeton 2015.
[9] K. Polanyi, The Great Transformation, Beacon Press, Boston 2001, pp. 87, 138-9, 213 (trad. it. di R. Vigevani, La grande trasformazione, Einaudi, Torino 2010).
[10] A. Baron, «Protective Labour Legislation and the Cult of Domesticity», Journal of Family Issues, n. 1/1981.
[11] M. Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale, Zed Books, London 2014, p. 74.
[12] E. Zaretsky, Capitalism, the Family and Personal Life, Harpercollins, New York 1986; S. Coontz, The Social Origins of Private Life, Verso, London-New York 1988.
[13] J. Walkowitz, Prostitution and Victorian Society, Cambridge University Press, Cambridge 1980; B. Hobson, Uneasy Virtue, University of Chicago Press, Chicago 1990.
[14] A. Davis, «Reflections on the Black Woman’s Role in the Community of Slaves», The Massachusetts Review, n. 2/1972 (trad. it. di M. Cartosio-L. Percovich, «Riflessioni sul ruolo della donna nera nella comunità degli schiavi», in A. Gordon et al., Donne bianche e donne nere nell’America dell’uomo bianco, La Salamandra, Milano 1975).
[15] D. W. Adams, Education for Extinction, University Press of Kansas, Kansas 1995; W. Churchill, Kill the Indian and Save the Man, City Lights Publishers, San Francisco 2004.
[16] G. Spivak, «Can the Subaltern Speak?» in C. Nelson-L. Grossberg (a c. di), Marxism and the Interpretation of Culture, Palgrave Macmillan, London 1988, p. 305 (trad. it. di A. D’Ottavio, in Critica della ragione postcoloniale, Meltemi, Roma 2004, p. 296).
[17] M. Foucault, «Governmentality», in G. Burchell-C. Gordon-P. Miller (a c. di), The Foucault Effect, The University of Chicago Press, Chicago 1991, pp. 87–104 (trad. it. di P. Pasquino, «Governamentalità», Aut Aut, n. 28/1978); Id., The Birth of Biopolitics, Lectures at the Collège de France 1978–1979, Picador, New York 2010, p. 64 (trad. it. di M. Bertani-V. Zini, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France 1978-1979, Feltrinelli, Milano 2005).
[18] K. Ross, Fast Cars, Clean Bodies, The MIT Press, Cambridge, 1996; D. Hayden, Building Suburbia, Pantheon Books, New York 2003; S. Ewen, Captains of Consciousness, McGraw-Hill, New York 1976.
[19] A quest’epoca, il sostegno statale alla riproduzione sociale era finanziato dal gettito fiscale e da fondi dedicati cui contribuivano, in diverse proporzioni, sia i lavoratori delle metropoli che il capitale, a seconda dei rapporti di forza fra le classi di ogni Stato. Ma questi flussi di entrate lievitavano col valore sottratto alla periferia mediante i profitti dall’investimento estero diretto e il commercio basato su uno scambio diseguale: R. Prebisch, The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, United Nations, Department of Economic Affairs, New York 1950; P. Baran, The Political Economy of Growth, Monthly Review Press, New York 1957; G. Pilling, «Imperialism, Trade and “Unequal Exchange”: The Work of Aghiri Emmanuel», Economy and Society, n. 2/1973; G. Köhler-A. Tausch, Global Keynesianism, Nova Publishers, New York 2001.
[20] J. Quadagno, The Color of Welfare, Oxford University Press, Oxford 1994; I. Katznelson, When Affirmative Action Was White, W. W. Norton & Company, New York 2005.
[21] J. Jones, Labor of Love, Labor of Sorrow, Basic Books, New York 1985; E. Nakano Glenn, Forced to Care, Harvard University Press, Cambridge 2010.
[22] N. Fraser, «Women, Welfare, and the Politics of Need Interpretation», in Id., Unruly Practices, University of Minnesota Press, Minneapolis 1989; B. Nelson, «Women’s Poverty and Women’s Citizenship», Signs: Journal of Women in Culture and Society, n. 2/1985; D. Pearce, «Women, Work and Welfare», in K. Wolk Feinstein (a c. di), Working Women and Families, Sage Publications, Beverly Hills 1979; J. Brenner, «Gender, Social Reproduction, and Women’s Self-Organization», Gender & Society, n. 3/1991.
[23] H. Land, «Who Cares for the Family?», Journal of Social Policy, n. 3/1978; H. Holter (a c. di), Patriarchy in a Welfare Society, Universitetsforlaget, Oslo 1984; M. Ruggie, The State and Working Women, Princeton University Press, Princeton 1984; B. Siim, «Women and the Welfare State», in C. Ungerson, (a c. di), Gender and Caring, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, New York 1990; A.S. Orloff, «Gendering the Comparative Analysis of Welfare States», Sociological Theory, n. 3/2009.
[24] A. Roberts, «Financing Social Reproduction», New Political Economy, n. 1/2013.
[25] Frutto di un’improbabile alleanza fra sostenitori del libero mercato e «nuovi movimenti sociali», il nuovo regime sta rimescolando tutti i consueti allineamenti politici, opponendo femministe «progressiste» neoliberali come Hillary Clinton a populisti autoritari nazionalisti come Donald Trump.
[26] E. Warren-A. Warren Tyagi, The Two-Income Trap, Basic Books, New York 2003 (trad. it. di P. Salerno, Ceti medi in trappola, Sapere 2000 Ediz. Multimediali, Roma 2004).
[27]A. Hochschild, «Love and Gold», in B. Ehrenreich-A. Hochschild (a c. di), Global Woman, Holt Paperbacks, New York 2002, pp. 15–30 (trad. it. di V. Bellazzi-A. Bellomi, Donne globali, Feltrinelli, Milano 2004); B. Young, «The “Mistress” and the “Maid” in the Globalized Economy», Socialist Register, n. 37/2001.
[28] J. Bair, «On Difference and Capital», Signs, n. 1/2010.
[29] «Apple and Facebook offer to freeze eggs for female employees», The Guardian, 15/10/2014. Significativamente, questo beneficio non è più riservato esclusivamente alla classe professionale-tecnica-manageriale. L’esercito degli Stati Uniti adesso rende gratuitamente disponibile il congelamento degli ovuli alle donne arruolate che hanno accettato di impegnarsi per lunghi periodi di servizio: «Pentagon to Offer Plan to Store Eggs and Sperm to Retain Young Troops», The New York Times, 3/2/2016. Qui la logica del militarismo prevale su quella della privatizzazione. A mia conoscenza, nessuno ha ancora affrontato l’impellente questione di cosa fare con gli ovuli di una donna arruolata che muore in guerra.
[30] C. Jung, Lactivism, Basic Books, New York 2015, in particolare pp. 130–1. L’Affordable Care Act (alias «Obamacare») adesso impone alle assicurazioni sanitarie di offrire questi tiralatte gratuitamente alle loro beneficiarie. Così persino questo beneficio non è più prerogativa esclusiva delle donne privilegiate. L’effetto è di creare un nuovo enorme mercato per produttori che realizzano i tiralatte nei grandi stabilimenti dei loro subappaltatori cinesi: S. Kliff, «The breast pump industry is booming, thanks to Obamacare», The Washington Post, 4/1/2013.
[31] L. Belkin, «The Opt-Out Revolution», The New York Times, 26/10/2003; J. Warner, Perfect Madness, Riverhead Books, New York 2006; L. Miller, «The Retro Wife», New York Magazine, 17/3/2013; A.M. Slaughter, «Why Women Still Can’t Have It All», The Atlantic, 7-8/2012; Id., Unfinished Business, Random House, New York 2015; J. Shulevitz, «How to Fix Feminism», The New York Times, 10/6/2016.
(11 dicembre 2017)