Pubblichiamo qui sotto un interessante saggio di Gianfranco La Grassa sul concetto di razionalità strategica e razionalità strumentale. La definizione ad inizio dello scritto introduce, in realtà, rapidamente al tema dell’analisi concreta delle formazioni sociali partendo dalle dinamiche conflittuali tra centri strategici e dal tentativo di riproporre in maniera più corretta e realistica la questione di una loro trasformazione che porti all’emancipazione degli strati subalterni. Un chiaro superamento della rappresentazione dualistica del conflitto sociale.
Lo scritto, tuttavia, apre più o meno esplicitamente numerose questioni piuttosto che risolverne come del resto è ovvio che sia per un tentativo di rottura critica di chiavi di interpretazioni ormai inadeguate e deleterie.
- tende a liquidare troppo sbrigativamente il lavoro di ricerca teorico-filosofico teso ad individuare le caratteristiche intrinseche del politico e le relazioni di questo con gli altri ambiti dell’agire umano e tra esse la funzione della cooperazione oltre che del conflitto; un tale impegno è ovviamente parte integrante del contesto storico, sociale e culturale nel quale agisce ma è altrettanto indispensabile per individuare ed inquadrare sistemicamente le nuove chiavi di interpretazione, l’analisi concreta e gli obbiettivi politici senza sostituirsi ad essi, specie in Italia dove il dibattito in merito langue da almeno quarant’anni
- il saggio, al pari delle precedenti elaborazioni di La Grassa, attribuisce un ruolo prioritario all’azione dei centri strategici, quindi all’azione e ai loro disegni politici; sottolinea che, con il rapporto capitalistico, il politico pervade ed agisce nell’economico; per meglio dire, è una mia precisazione, il ruolo politico della e nella funzione economica si accresce. Ma sino a che punto in termini assoluti e soprattutto rispetto agli altri ambiti?
- l’autore parla di conflitto tra formazioni sociali capitalistiche e tra centri strategici (capitalistici?) in esse e tra di esse. Poiché, secondo definizione marxiana, il capitalismo è un rapporto sociale di produzione, laddove il possessore dei mezzi di produzione sovrasta il salariato, non si rischia di tornare alla surdeterminazione dell’economico, al meglio del politico nell’economico, rispetto agli altri ambiti?
- GLG sancisce l’inesistenza del “popolo”; sembra ricondurre la sua estinzione al processo di frammentazione e specializzazione proprio delle formazioni capitalistiche più mature ed evolute e all’incapacità, quindi, dei loro centri strategici di garantire i sufficienti livelli di coesione e di assimilazione identitaria necessari a garantire la sostenibilità interna ed esterna di esse. Mi pare una affermazione troppo apodittica che tende a sottovalutare le capacità di ricomposizione, magari sotto nuove vesti e nuovi nuclei, dei centri strategici e ad assecondare la facile, ma a mio avviso poco fondata, contrapposizione tra ad esempio i comunitaristi portatori della positiva pienezza dei valori umani, alla Fusaro e de Benoist, e i mercificatori alienatori della natura umana, propri dei capitalisti globalizzatori
- con l’occasione il prof. La Grassa riprende il tema dell’emancipazione degli strati subalterni e delle particolari condizioni di crisi sistemica di particolari formazioni che potrebbero favorire la loro sollevazione e affermazione. Non si tratterebbero più di classi in sé, ma di gruppi o strati ben condotti da centri ben determinati ed alternativi. Il discorso nella fattispecie, una caratteristica comune a tutti, compreso chi scrive, rischia di cadere nell’indeterminatezza ed oscillare inconsapevolmente tra l’utopia di una società libera e egualitaria e l’azione magari anche meritoriamente redistributiva interna al sistema, ivi comprese le gerarchie stabilite. GLG avverte per altro saggiamente delle capacità dinamiche, propulsive e di sviluppo di un sistema fondato sulla concorrenza; della capacità, quindi, di riassorbimento, il più delle volte, delle contraddizioni più esplosive. Si tratta comunque di un avvertimento molto più opportuno e proficuo se finalizzato ad individuare nelle formazioni sociali e nei processi riformatori e rivoluzionari quelle figure e strati sociali e quei centri strategici i quali, per acquisire il controllo del potere o la partecipazione ad esso siano disposti a riconoscere un ruolo ed una condizione diversa e migliore, ivi compresa la mobilità, agli strati più subalterni. Anche in questo caso, però, il rischio di scambiare il classico piatto di lenticchie alle prospettive di sviluppo dinamico e duraturo è sempre presente. L’esperienza dei paesi socialisti, ancorché poco studiata, è tutta lì a dimostrarlo.
Mi sembrano cinque dei punti già sufficienti a consentire un’ulteriore spinta alle ipotesi di ricerca suggerite dal professore. Buona lettura_ Giuseppe Germinario

GIANFRANCO LA GRASSA _ RAZIONALITA’ STRATEGICA E RAZIONALITA’ STRUMENTALE http://www.conflittiestrategie.it/razionalita-strategica-e-razionalita-strumentale-di-g-la-grassa
- Non intendo qui diffondermi troppo sui due tipi di razionalità (e di funzioni); su entrambe sono state scritte infinite pagine e considerazioni. Mi interessa semmai chiarire alcune differenze e distinzioni. Innanzitutto, la metis – l’astuzia, il raggiro, l’inganno, ecc. (“il cavallo di Troia”) – fa parte dell’arte strategica, ne può in certi casi costituire l’aspetto principale, ma non fa conseguire, in ultima analisi, una vera supremazia, non consente di prevalere se non in casi assai particolari e magari in presenza di una discreta dose di ingenuità dell’avversario. Nemmeno credo si possa identificare la funzione strategica con la mera volontà di potenza, comunque quest’ultima possa essere intesa.
La strategia non è solo “arte”, non è solo carattere vitalistico e prorompente di una “personalità” – anche collettiva, in senso allora assai lato – portata a prevalere e a subordinare le altre, quelle “nemiche”. La strategia esige un elemento intuitivo (almeno all’apparenza), il cosiddetto colpo d’occhio, ma deve strettamente intrecciarsi con una precisa valutazione della situazione sul campo: risorse a disposizione, articolazione e movimento delle forze in campo, attenta mappatura e studio di quest’ultimo; con rapida presa in esame di ogni mutamento della situazione stessa e delle risposte da dare ai cambiamenti.
D’altra parte, la valutazione della situazione sul campo non è eseguita in base alla semplice razionalità strumentale, quella del minimo mezzo o del massimo risultato; quest’ultima attiene principalmente all’ambito economico in senso stretto, pur se poi è stata ampliata ai vari aspetti della vita personale e collettiva (sociale). Sia per quanto concerne la sua applicazione in campo economico sia per il suo generalizzarsi ad altri settori di attività, detta razionalità si è affermata essenzialmente in epoca capitalistica. Nella stessa conduzione delle attività produttive, agricole e artigianali, in formazioni precapitalistiche, essa non veniva affatto in evidenza; i saperi produttivi, frutto di una lunghissima e in genere lenta accumulazione storico-culturale, non avevano molto a che vedere con una mentalità semplicemente strumentale, che sarebbe anzi stata una vera “palla di piombo ai piedi” per artigiani e contadini delle società precapitalistiche, e avrebbe condotto alla disgregazione delle stesse per l’impossibilità di conciliare la struttura produttiva con quella del potere (che è poi quanto in definitiva accaduto durante la lunga transizione dal feudalesimo al capitalismo). In ogni caso, anche nella formazione sociale del capitale la posizione di preminenza attribuita alla razionalità strumentale ha carattere largamente ideologico. Certamente essa è creazione del capitalismo, e in quest’ultimo viene largamente utilizzata nei vari ambiti dell’attività sociale, ma non assurge affatto alla posizione di vertice nell’agire delle “classi” dominanti nemmeno in questa forma di società.
E’ stato un errore dello stesso marxismo – tutto centrato sul problema dell’ottenimento del massimo profitto (e quindi della massima estrazione del pluslavoro/plusvalore) da parte del capitalista, visto come essenzialmente proprietario e non invece quale agente di strategie – pensare che la razionalità strumentale (quella della cosiddetta efficienza) sia non solo acquisizione fondamentale del “modo di produzione” capitalistico, ma sorregga l’insieme dei rapporti caratteristici della società da questo strutturata e ne alimenti la dinamica decisiva; e rappresenti addirittura una conquista della Ragione che, sciolta dall’esigenza (del puro proprietario) di conseguire il massimo utile individuale, sarebbe cruciale anche nella futura società comunista onde sviluppare le forze produttive e conseguire quella massa di beni, cui potrebbe attingere ogni membro della società “secondo i suoi bisogni”.
- L’analisi della situazione sul campo – configurazione di quest’ultimo, forze in campo, ecc. – e le risposte ai mutamenti della stessa non si basano quindi sul mero principio del minimo mezzo o del massimo risultato; nel contempo, esse non consistono certo esclusivamente nel colpo d’occhio, nell’intuizione dell’agente strategico. Quest’ultima ha un che dell’arte, ma l’analisi e le risposte di cui si parla sono più vicine allo spirito dell’osservazione scientifica. Infine, nella preliminare individuazione delle tecniche e delle metodiche da impiegare per far fronte ai problemi osservati e analizzati, inizia a farsi avanti la razionalità della “efficienza economica”, quella del minimo mezzo, insomma quella detta strumentale. Quest’ultima ha dunque un ruolo subordinato, non è funzione esplicata dagli agenti “dominanti” (sto parlando delle differenti funzioni, non degli individui empirici che le supportano e che possono esercitarne contemporaneamente più d’una). Per il dominio, cioè per conquistare la supremazia attraverso la lotta, occorre l’analisi – assimilabile all’osservazione scientifica – e l’“artistico” colpo d’occhio sull’insieme e le sue intrinseche, ma non manifeste, potenzialità dinamiche (forza e direzione dei possibili eventi da provocare o impedire o deviare, ecc.) che debbono essere volte al successo della propria lotta tesa a prevalere.
Per ottenere la “vittoria in battaglia” sono perciò necessarie soprattutto le funzioni del “comandante in capo” (che, ovviamente, non è obbligatoriamente un solo individuo), capace di cogliere quello specifico potenziale insito nell’insieme, e le funzioni dello “Stato Maggiore” atte a svolgere i compiti relativi alla lucida e “scientifica” analisi del campo e delle forze in campo, con tutto ciò che segue. Il potenziale dell’insieme è la ben nota singolarità, che non è soggetta a generalizzazioni; pur se le varie “battaglie” svoltesi in passato, e le innumerevoli mosse strategiche in esse impiegate, sono sempre sottoposte a studio e a vaglio accurato in previsione di quelle future. L’analisi e valutazione del campo e delle forze in campo sono invece soggette a queste generalizzazioni (di tipo scientifico, per l’appunto), ma non debbono pesare sulle decisioni da prendere in future “battaglie” secondo una loro scolastica e pedantesca ripetizione, che condurrebbe quasi sempre a “sconfitta”. Ancor meno debbono pesare, sulle decisioni strategiche cruciali prese nella lotta per la supremazia, le tecniche e metodiche secondo cui vengono in essa impiegate “efficientemente” determinate risorse; tecniche e metodiche che, come sopra rilevato, attengono ai compiti delle funzioni strumentali, quelle del minimo mezzo o massimo risultato.
- L’aver posto tali funzioni (rette dalla razionalità strumentale) come essenziali e pervasive dell’intera attività dei dominanti capitalistici (trattati quali meri proprietari dei mezzi produttivi e finanziari) – e averne addirittura fatto una conquista generale del pensiero umano per ogni futuro sviluppo e trasformazione della società, addirittura in direzione del presunto comunismo – ha veramente ottuso le capacità critiche degli anticapitalisti. Quella che è soltanto ideologia – con la solita funzione di mascheramento delle fonti effettive del predominio degli agenti capitalistici, che non sono affatto semplici proprietari – è passata per una conquista fondamentale del pensiero razionale; una conquista, come altre del capitalismo, da mantenere e sviluppare poiché se ne supponeva l’indispensabilità anche ai fini della transizione al socialismo e poi comunismo.
Se, come ho chiarito più volte negli ultimi anni, fosse stata valida l’ipotesi di Marx relativa alla formazione, per dinamica intrinseca al modo di produzione capitalistico, del lavoratore collettivo cooperativo, in cui tutte le diverse funzioni (intellettuali e manuali, direttive ed esecutive) si sarebbero integrate in un unitario e compatto tessuto produttivo, allora la sussistenza di tale mascheramento ideologico non avrebbe alla fine nuociuto più che tanto. Il movimento reale – non l’opera di costruzione del socialismo da parte di presunte avanguardie della Classe (per antonomasia) – avrebbe condotto all’esaurirsi delle funzioni produttive dei proprietari capitalistici, trasformati in rentier, e all’affievolirsi dello spirito di competizione per la supremazia di dati gruppi sociali su altri. A questo punto, la razionalità del minimo mezzo sarebbe in effetti divenuta quella prevalentemente applicata nelle attività sociali (non della sola sfera economica) in quanto dirette soprattutto allo “sfruttamento” del “fondo naturale” per ottenere di che soddisfare i bisogni degli individui stretti in una società coordinata e di cooperazione, senza conflitti antagonistici né sfruttamento degli uomini su altri uomini.
Poiché la dinamica capitalistica, intrinseca o meno che sia, non conduce affatto in simili direzioni virtuose, è ovvio che le conclusioni da trarre sono totalmente differenti. La razionalità strumentale diventa un semplice mezzo per procurarsi, nel migliore (più efficiente) modo possibile, le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni legate alla lotta per la supremazia, e che sono quelle appena sopra illustrate. La formazione sociale si frammenta, si segmenta e si stratifica sempre più complessamente, le minoranze predominano sulle maggioranze, ma attraverso lo scontro tra i vari gruppi di agenti di cui sono composte, gruppi che applicano strategie di lotta ai fini della prevalenza di alcuni su altri. Non si va minimamente formando alcun vertice ristretto e sempre più unitario di sfruttatori. La lotta tra gruppi conosce varie “periodicità” – da me adombrate con i termini di monocentrismo e policentrismo – che sono fasi (epoche) diverse in riferimento sia a quella da me indicata quale formazione sociale in generale sia alla formazione globale, costituita da una mutevole articolazione di tante formazioni particolari fra loro in conflitto, con i connessi fenomeni comportanti lo sviluppo ineguale dei vari gruppi capitalistici, in sede “nazionale” come “internazionale”.
In una società per null’affatto interessata da un movimento interno di omogeneizzazione e compattamento “armonico”, bensì da processi di frammentazione crescente e di – più o meno acuta a seconda di un periodico “pulsare” per epoche o fasi dell’evoluzione capitalistica – interazione contraddittoria e conflittuale tra i suoi vari comparti (o raggruppamenti, dominanti e non), le funzioni strumentali, attinenti al conseguimento del massimo risultato, scadono a semplice mezzo per procurarsi, con la massima “economicità”, le risorse necessarie all’esercizio delle funzioni strategiche, compito precipuo degli agenti dominanti in reciproca lotta per gruppi (per “bande”) ai fini della supremazia. A questo punto, sono gli “Stati Maggiori” con i loro “Comandanti in capo” a rappresentare quella “classe capitalistica”, che il marxismo pensava fosse invece costituita da semplici proprietari. Questi avrebbero esercitato una funzione produttiva propulsiva nel capitalismo concorrenziale – poiché il conflitto era visto dai marxisti come un fatto prevalentemente economico, un fenomeno in ultima analisi orientato dalla finalità del massimo prelievo di plusvalore in quanto profitto dell’impresa capitalistica – mentre sarebbero divenuti parassiti e “similsignori” nel capitalismo monopolistico strutturato in grandi società per azioni. Si sarebbe trattato certamente di “signori” differenti da quelli feudali o protocapitalistici per il tipo di rendita percepita: non più dalla terra, non più dal semplice prestito in denaro, ma prevalentemente dalla proprietà azionaria, dalla “attività” di “staccare cedole”.
Nella società capitalistica realmente affermatasi, strutturata in gruppi sempre più numerosi e in crescente disarticolazione, con “successiva” (in senso logico) ri-connessione interattiva tramite forme varie di conflitto di periodicamente differente intensità e acutezza, i dominanti sono gli agenti strategici (del “colpo d’occhio d’insieme” e dell’analisi del campo e delle forze in campo) che rendono la società capitalistica un terreno di battaglia, in cui tutti, ai più vari livelli della scala sociale, sono coinvolti; anche se gli strati sociali bassi sono quasi sempre truppe al seguito degli “Stati Maggiori”, ecc. Solo raramente, in particolari frangenti storici (congiunture), le truppe – “incontrando” dati gruppi di dirigenti e di capi – sono in grado di nuocere agli agenti dominanti in una certa fase di acuto scontro tra questi ultimi; ma non è affatto deciso ineluttabilmente, come il novecento ha ampiamente dimostrato, quale sia l’effettivo sbocco degli eventi “rivoluzionari”. Sia l’ideologia dei dominanti (agenti capitalistici), sia quella degli un tempo oppositori e intenzionati a trascinare le “truppe” (le masse popolari) contro il loro potere, hanno provocato un totale annebbiamento della strutturazione della formazione capitalistica: sia di quella in generale sia di quella globale con le sue articolazioni particolari.
- E’ ormai indispensabile uscire – puntando intanto su di essa il riflettore del pensiero critico – da questa ideologia della razionalità strumentale in quanto elemento fondante e carattere decisivo della struttura capitalistica e dunque del movimento dei suoi rapporti di dominazione/subordinazione; un elemento che sarebbe negativo se utilizzato dai proprietari (dei mezzi produttivi) per sfruttare il lavoro (estorsione del massimo pluslavoro/plusvalore), ma che la “rivoluzione comunista” avrebbe potuto rovesciare in positivo, “estraendone il nocciolo razionale”, eliminando la proprietà privata e affidando il coordinamento cooperativo della produzione alla classe lavoratrice (cioè alle sue pretese “avanguardie”).
Deve essere contrastato questo ottundimento del pensiero, che ha condotto a pratiche inizialmente anche “eroiche” e che hanno rappresentato il famoso “assalto al Cielo”, ma che poi si sono, loro, rovesciate in aberrante dominazione di masse “abbrutite” da parte di capi degenerati in perpetua lotta (assassina) fra loro. Un comunismo, incapace di uscire dalla ideologia “annebbiante” fin qui illustrata, ha avuto un suo grande periodo in cui è sembrato essere il movimento di emancipazione dei diseredati contro i bestiali sfruttatori capitalisti (e colonialisti e imperialisti), ma ha poi abdicato completamente ai suoi ideali originari per divenire il peggiore e più devastante dei movimenti politici esistenti nell’ambito del capitalismo. Basta dunque con il comunismo in tutte le salse lo si voglia cucinare; e basta con il marxismo che ha toccato l’apice di quanto poteva farci conoscere per poi decadere a “dottrina religiosa” del tutto ottenebrante; una “religione” che non è nemmeno più l’oppio dei popoli, ma solo di piccole sette di inutili cultori del nulla teorico e politico.
Tuttavia, la reazione a questo annebbiamento ideologico non deve portare a rivalutare le sconfortanti banalità dell’ideologia conservatrice neoliberista o delle sue versioni “riformiste” neokeynesiane. Dalla padella nella brace; peggio la toppa dello strappo! Questa è l’alternativa che ci offre un ceto intellettuale fra i più fatui e sciocchi annoverati nella storia dell’Umanità; un vero campionario di “idioti con alto quoziente di intelligenza”, come recitava un “salmo” del movimento sessantottardo, che volentieri sostituirei con la più incisiva battuta di quel genio che fu Ettore Petrolini: “idioti con lampi di imbecillità”.
Ogni inizio è senza dubbio difficile. E’ tuttavia necessario che soprattutto i più giovani, e liberi di mente, non ottenebrati da quel cumulo di fanfaluche ammassate dagli intellettuali soprattutto negli ultimi trenta-quarant’anni, si mettano in moto al più presto; e prendano a calci chiunque parli di liberismo, di keynesismo, di marxismo; chiunque ancora si riempia la bocca di quelle ormai sconce parole – sia chiaro: di ben altro significato ed elevatezza molto tempo addietro – che sono democrazia liberale, socialismo, comunismo, con tutte le loro infinite variazioni.
- Cominciamo con il riportare al centro della questione, cioè dell’organizzazione dell’attuale società nella sua globalità (mondialità), il principio della preminenza delle funzioni strategiche che sottomettono, piegano ai loro fini, quelle strumentali, quelle del minimo mezzo o massimo risultato. In questo contesto, non mi sembra di alcun interesse lanciarsi in disquisizioni filosofiche o simili chiedendosi se lo spirito di competizione – teso però alla preminenza tramite prepotenza, sopraffazione, asservimento (e anche inganno e raggiro) esercitati dagli uni sugli altri – sia connaturato o meno all’essere umano. La millenaria storia dell’Umanità non induce certo all’ottimismo in proposito, ma tenuto conto degli orizzonti temporali su cui siamo in grado di allargare la nostra “vista” (teorica), compiendo analisi e sviluppando argomentazioni dotate di un minimo di realismo e credibilità, è assolutamente inutile arrovellarsi sulla “natura” umana, sulle “costanti antropologiche”, e via dicendo. Credo che discussioni del genere abbiano senso, così come ha senso dibattere sulla religione, sull’esistenza o meno di un Essere chiamato Dio e su molti altri problemi dello stesso ordine che, se hanno da sempre spinto grandi intelletti a profondervi le migliori energie, non sono evidentemente destituite di significato come spesso pensano coloro che hanno cervelli simili a computer, e sistemi nervosi solo dediti alle più elementari sensazioni animalesche.
Tuttavia, per una analisi che in qualche modo si richiami alla scienza della struttura e dinamica della società nell’attuale epoca storica – un’analisi che voglia porre le basi di prese di posizione pratico-politiche in essa, pur se magari ancora assai generali e non indirizzate alla soluzione di problemi “puntuali” – non è gran che rilevante decidere se le tendenze al conflitto per la preminenza, tramite sconfitta e subordinazione dell’avversario, fanno parte dell’intima costituzione dell’essere umano oppure se vi sono speranze circa l’avvento, in un futuro imprecisato, di una società fondata su rapporti interindividuali, al limite ancora competitivi, non però caratterizzati dalla prevaricazione, dalla menzogna e subornazione, ecc. Penso che chi non accetta la società così com’è adesso, diciamo pure quella capitalistica (perché abbiamo in definitiva a che fare con strutture sociali di questo tipo), debba mantenere un atteggiamento di contrasto e di critica radicale dello spirito conflittuale, basato sulla prepotenza e ricerca del predominio, che in detta società si dispiega pienamente in tutte le sue sfere (economica, politica, ideologico-culturale); non ci si deve però porre nella situazione del “profeta disarmato”.
E’ ora di farla finita con la favoletta della non violenza gandhiana, che sarebbe il miglior modo di vincere le proprie battaglie e di porre le basi per una organizzazione sociale di pace e armonia. A parte le falsità storiche raccontate dall’agiografia di Gandhi, che non era poi così pacifico come si vuol far credere (ai gonzi), la sua vittoria è nata dalla reale sconfitta subita dall’Inghilterra nella seconda guerra mondiale. Apparentemente tale paese faceva parte delle potenze vincitrici, ma in realtà uscì dalla guerra nettamente ridimensionato, avendo definitivamente perso il suo ruolo di grande potenza capitalistica e imperialistica (coloniale). Non poteva in nessun caso mantenere l’India nella situazione precedente la guerra, così come dovette rinunciare alle sue altre sfere di influenza asiatiche e africane. Non parliamo del “pacifismo” attuale dell’India, dotatasi dell’arma atomica, in ricorrente conflitto con il Pakistan, con alcuni (molti) suoi governi locali che reprimono moti popolari tipici di un paese lanciatosi nello sviluppo ad alti ritmi, con le sue “naturali” conseguenze fortemente squilibranti in termini sociali.
Oggi, c’è solo da decidere se è relativamente prossima (qualche decennio) una nuova epoca policentrica, con il rinnovarsi dei conflitti per la supremazia tra le diverse formazioni particolari componenti quella globale; oppure se permarrà ancora a lungo una sostanziale preminenza, sempre più deficitaria comunque, degli USA mentre altri paesi (Russia, Cina, India, Giappone, ecc.) non riusciranno ad andare oltre un conflitto tra potenze di carattere “regionale” (degli outsiders insomma). Credo che la tendenza sia verso un autentico conflitto policentrico, preceduto comunque da un periodo, probabilmente di alcuni decenni, in cui si assisterà al rafforzamento delle potenze “regionali”. E tenendo sempre in debito conto il problema dello sviluppo ineguale, per cui si verificheranno durante tale periodo delle “sorprese”: qualche formazione particolare (paese), oggi in ascesa, si arresterà e “deluderà” le aspettative, mentre magari ne verrà fuori alla distanza qualche altra.
Non si deve comunque contare – per tutto il periodo lungo il quale si sarà in grado di formulare qualche previsione in base al processo di gestazione di nuove categorie teoriche interpretative (ipotetiche) – sull’affievolirsi delle tendenze al conflitto e al predominio. E si deve tener presente che le tendenze in questione saranno prevalentemente guidate dai gruppi dominanti strategici di diverse formazioni capitalistiche. I conflitti più acuti si svilupperanno tra: a) la potenza (formazione particolare) centrale odierna e le potenze per il momento regionali, che non possono rinunciare (pena la decadenza dei gruppi dominanti all’interno di esse) al tentativo di contrastare il predominio della prima; b) tra le formazioni particolari o pienamente sviluppate capitalisticamente (USA in testa) o in forte ascesa quanto a sviluppo capitalistico e quelle arretrate o che hanno appena iniziato il loro sviluppo (ad es. l’Iran). In queste formazioni, ancora non pienamente maturate dal punto di vista capitalistico, i gruppi dominanti appaiono in buona parte con-fusi con la massa del popolo, un aggregato anche in tal caso non del tutto omogeneo, ma comunque nemmeno scisso in raggruppamenti ben distinti come nel capitalismo avanzato; un aggregato spesso cementato da una solida cultura comune, spesso da una forte religione. Assai meno acuti e rilevanti appaiono, al presente, i conflitti interni alle formazioni particolari capitalisticamente avanzate, dove la frammentazione sociale è assai spinta e l’interazione tra i vari comparti, in orizzontale e in verticale, non sconvolge la riproduzione capitalistica dell’insieme societario, poiché ci si limita a ridiscutere sia la divisione della “torta” (prodotto complessivo sociale) – il che implica mutamenti di condizioni di vita e di lavoro dei vari comparti in oggetto – sia le rispettive posizioni quanto a “fette di potere”, a status, a diritti e doveri, ecc.
- Una volta fissato un quadro orientativo di larga (larghissima) massima, si deve decidere dove collocarsi nello svolgimento della propria attività teorica e pratica; ricordando che la teoria – nella misura in cui sia solo quella di carattere scientifico attinente alla “visione” della struttura e dinamica della società – è in definitiva un lato della pratica stessa. Ha certo suoi caratteri propri, esige particolari strumentazioni, ma non “sta da un’altra parte”, non risponde ad altre esigenze, quelle che definiamo, non importa se propriamente o meno, “spirituali”. In questo senso, “la teoria è grigia” e tale deve rimanere. Non è che ciò la renda impermeabile alla penetrazione, mascherata e inconsapevole, di una qualche ideologia; ma deve stare sempre in guardia contro simili influssi (pur non sapendo in anticipo da che parte arriva il pericolo), deve compiere i suoi passi con prudenza e sempre sorvegliandosi. Non punta in ogni caso ad accendere gli animi, a suscitare entusiasmi, a dare un senso alto alla propria lotta. Questi compiti spettano ad altri lati dell’agire umano.
Guai se Lenin fosse sceso nell’agone della rivoluzione russa con in mano Il Capitale o anche semplicemente il suo Che fare o il saggio sull’imperialismo; guai se avesse “predicato” la teoria del valore lavoro e insegnato che questa dà la certezza dello sfruttamento della forza lavorativa (dei dominati); guai se avesse spiegato il concetto di modo di produzione (e l’intreccio tra forze e rapporti produttivi), se si fosse messo ad elucubrare sullo sviluppo ineguale, e via dicendo. Avremmo una rivoluzione in meno e un mondo assai diverso; e chissà se in poche righe, in un qualche manuale di storia, verrebbe ricordato che in un qualche anno dell’inizio del novecento, in un qualche luogo della Russia, un pazzo furioso era stato picchiato a sangue (forse ucciso) da masse popolari mentre stava vaneggiando e pronunziando parole smozzicate, prive di senso compiuto; e aveva malamente reagito all’indifferenza degli astanti, li aveva insultati, minacciati, maledetti per la loro ignoranza.
- A me sembra evidente che chi vive nel nostro paese debba accettare la prospettiva di sviluppare la propria attività (teorica e pratica) nell’ambito di una formazione particolare appartenente all’area del capitalismo avanzato, di quella tipologia che in altra sede ho indicato quale formazione dei funzionari (strategici) del capitale. E’ nell’ambito di questa che si dovrà “studiare” come muoversi, almeno in un primo approccio orientativo. Viene in evidenza, innanzitutto, l’impossibilità di trascurare l’humus conflittuale in cui si attua la riproduzione dei rapporti tipici della società in questione. Due errori sono da evitare. In primo luogo credere di poter contrastare immediatamente e direttamente la mentalità del conflitto per il predominio, che permea la società ad ogni livello. Non si tratta di un comportamento tenuto soltanto dagli agenti dominanti. Questi, essendo una minoranza, avrebbero già perduto ogni potere – ed è quanto pensava Marx che non immaginava affatto un capitalismo tanto durevole – se la conquista della supremazia non fosse il movente dell’agire in ogni più piccolo ambito della società. L’ideologia dei dominanti chiacchiera in continuazione della cooperazione, dell’utilità di unirsi, ecc. Ma ogni coagulazione di gruppi di individui si verifica sempre con il fine di meglio lottare contro altri gruppi; non ci si allea per spirito di fratellanza, ma perché, come dice il detto popolare: “l’unione fa la forza”. Anche dove, a parole, si celebra ad ogni istante l’amore (ad es. nella famiglia), in realtà si vivacizza sovente un confronto più o meno aspro o invece attutito dalla “giusta” valutazione delle rispettive posizioni di forza.
E’ ovvio che si cerchino tutti i marchingegni (legali) possibili per contemperare l’uso reciproco della violenza, per non andare incontro alla generale disgregazione e indebolimento, ecc. Ma si tratta del conseguimento di equilibri del tutto instabili che, qualunque sia la loro assai diversa durata, sono comunque soltanto periodiche soste tra uno squilibrio e l’altro. Non si raggiunge per via puramente formale ciò che non diventa insito nel movimento riproduttivo dei rapporti sociali. Nella società capitalistica, d’altronde, si è solo verificata l’estensione alla sfera economico-produttiva del principio del conflitto, che in altre epoche storiche vigeva soprattutto in quella politico-militare e in quella ideologico-religiosa. Certamente, questa estensione ha “involgarito” le classi dominanti; la generalizzazione della forma di merce, che significa la pervasività sociale del pagamento in denaro, ha reso tutto “comprabile”: l’onore, la dignità, il coraggio, la lealtà, ecc. Tutte queste belle qualità, però, servivano nelle precedenti epoche a stabilire regole diverse, e forse più “nobili”, di scannamento generale (o di duello individuale). Il principio del conflitto per sopraffare gli altri e assumere la predominanza non è però differente da quello degli “ultimi”….cinque o diecimila anni (o quanti? Credo da sempre).
Lo sviluppo nella “pacifica” India è del tutto simile a quello in atto nella “crudele” Cina; poiché è comunque disarmonia, squilibrio, lotta. Prima si sviluppano alcune regioni del paese e poi, sussistendo certe politiche effettuate da dati gruppi dominanti, assistiamo ad un trasmissione del dinamismo all’insieme, ma senza che si verifichi alcun livellamento delle differenze; quasi sempre, invece, in accentuazione. L’arricchimento di una parte della società – dei gruppi dominanti – è poi seguito, sempre se vengono attuate le opportune politiche, da un più “timido” innalzamento del livello di vita degli strati sociali dominati, e non in modo uniforme ed eguale neppure in quest’ambito. Il realismo impone di prendere le mosse dalle considerazioni appena fatte, non dalle menzogne, consapevoli o meno che siano, di ideologi imbonitori al servizio delle classi dominanti (sempre, anche quando sembra che difendano i dominati). Qui si pone quel problema che i vecchi “marxisti” incanalavano, con “falsa coscienza”, nella discussione sul rapporto tra riforme e rivoluzione. Ormai, tale problema non mi sembra proprio debba essere più posto nei termini di un tempo ben lontano.
I vecchi comunisti e marxisti pensavano l’attività riformistica – necessitata qualora ci si trovasse in un contesto sociale ancora fortemente dominato dalla classe capitalistica proprietaria – quale periodo di training e di accumulazione delle forze della classe in sé portatrice della rivoluzione. Le riforme, attuate nella sfera della distribuzione e del miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori (salariati), avrebbero vieppiù messo in evidenza l’impossibilità di contrastare per tale via lo sfruttamento (estrazione di pluslavoro, sia pure nella ingannevole forma del valore-lavoro delle merci, che sembra assicurare il mero scambio di equivalenti); nel contempo, tramite le lotte riformistiche si sarebbe rinsaldata l’unione della classe deputata al rivolgimento dei rapporti capitalistici, già in via di compattamento a causa del movimento intrinseco alla riproduzione sociale, teso alla già rilevata formazione del lavoratore collettivo cooperativo.
Una volta abbandonata questa scorretta e ormai inaccettabile visione della dinamica capitalistica, e appurata la crescente frammentazione (segmentazione e stratificazione) del tessuto sociale, le lotte dei vari raggruppamenti – di lavoratori o meno; e di lavoratori sia salariati che cosiddetti autonomi – restano strettamente confinate al livello distributivo della riproduzione dei rapporti sociali. I problemi della crisi, non nel suo semplice aspetto economico che è il meno dannoso e pericoloso per i dominanti capitalistici (malgrado l’enfasi posta su di essa dagli epigoni di Marx), nascono proprio dalle modalità assunte dallo sviluppo nell’ambito sia della formazione in generale che, soprattutto, di quella globale con riferimento all’articolazione di quelle particolari che la compongono. Lo sviluppo, causato dalla forte tensione dinamica impressa dalla lotta per la preminenza (estesasi nel capitalismo anche alla sfera economico-produttiva), provoca scissioni e distanziamenti tra ceti sociali e tra le diverse formazioni particolari (in genere paesi o gruppi degli stessi); diventano così molto probabili periodiche acutizzazioni delle tensioni sociali e delle lotte che da queste derivano.
Tuttavia, la situazione si aggrava nettamente quando si verifica lo sviluppo ineguale: sia tra gruppi dominanti diversi in una certa formazione particolare sia tra differenti formazioni particolari nell’ambito di quella globale. E’ l’alterazione dei rapporti di forza tra gruppi sociali, in specie tra quelli dominanti e soprattutto quando i mutamenti avvengono rapidamente in seguito a lotte estremamente acute, a provocare crisi politico-istituzionali, ideologico-culturali, ecc. che lacerano il tessuto sociale con possibilità di ristrutturazioni radicali. Le stesse considerazioni valgono per le crisi legate all’affermarsi di differenti rapporti di forza tra formazioni particolari e al precipitare di scontri accesi tra di esse per la preminenza globale. Va anche detto che spesso, e più facilmente, le crisi interne a determinate formazioni e quelle inerenti al confronto tra più formazioni in ambito (geopolitico) globale si intrecciano e alimentano vicendevolmente.
E’ bene ricordare ancora una volta che, per quanto riguarda sia la lotta tra gruppi all’interno di una data formazione particolare sia il conflitto tra più formazioni particolari, le crisi di maggiore intensità e ampiezza si manifestano quando lotta e conflitto si inaspriscono soprattutto tra dominanti. Se una certa costellazione di forze dominanti (costituita da intrecci di agenti strategici delle varie sfere sociali) fa entrare una formazione particolare in situazione di difficoltà, stagnazione, crisi, malcontento sempre più generalizzato, ecc., è più probabile, almeno in un primo tempo, l’emergere di altri gruppi dominanti che si pongono in alternativa. Così pure, quando si transita alle fasi policentriche, il conflitto si acutizza specialmente, provocando i più netti risultati trasformativi (passaggi d’epoca), tra formazioni particolari dell’area a capitalismo avanzato, caratterizzate da differenti ritmi di sviluppo, che non accettano più di sottostare alla formazione particolare fino ad allora in posizione predominante.
- Non è qui il caso di riferirsi specificamente alla formazione particolare Italia, che andrà analizzata ad un “più basso” livello di astrazione teorica. Tuttavia, sia pure per linee assai generali e generiche, è bene trarre alcune conclusioni da quanto fin qui sostenuto. Non esiste intanto alcuna classe, in via di omogeneizzazione e compattamento, da cui emerga uno strato di élite in grado di avere una visione complessiva e ben delineata della necessaria prassi trasformativa del capitalismo; per di più nella direzione di una determinata società altra del tipo del comunismo. Nemmeno è più possibile pensare ancora alla formazione, pur in qualche modo artificiale, di avanguardie “di classe”, che presuppongono pur sempre la sussistenza dell’in sé di quest’ultima, dunque di un movimento oggettivo verso la suddetta sua omogeneizzazione e compattamento, che faccia da supporto alla soggettiva azione rivoluzionaria delle avanguardie in questione.
Esistono sempre, in ogni epoca e in numero maggiore o minore, singoli gruppi di soggetti (individui) – per null’affatto caratterizzati in maggioranza da una determinata collocazione “di classe”, anzi provenienti dai più svariati comparti in cui si frammenta vieppiù la società del capitale – che si pongono criticamente rispetto ai caratteri di prepotenza, sopraffazione (e certo inganno, raggiro, ecc.), tipici del conflitto in questa (come in precedenti) forma di società. Tali gruppi di “critici” si espandono e rafforzano nelle situazioni in cui le tensioni sociali si fanno via via più acute: sia all’interno di una formazione particolare come tra più formazioni (in sviluppo ineguale) nell’ambito di quella globale. Tali gruppi perdono le loro potenzialità – e al limite possono di fatto costituire una “carta di riserva” per i dominanti – se “distraggono” forze da una critica sociale adeguata; soprattutto quando, con estremismo apparente, predicano l’eguaglianza, il pacifismo e altre favole edificanti. In primo luogo, bisogna comprendere la positività della competizione, se sfrondata dei lati di aperta violenza per conquistare la supremazia eliminando o asservendo i competitori. In secondo luogo, va rilevato che la critica alla forma assunta dal conflitto nel capitalismo deve comunque tener debito conto di essa e saperla gestire e sfruttare per i propri fini.
Le “anime belle”, spesso non proprio in buona fede, sono comunque, quand’anche “oneste” (anzi, sono ancora più pericolose in tal caso), del tutto negative e vanno combattute perché indeboliscono l’azione critica. E’ perfettamente inutile cercare di sfuggire alla contraddizione: da una parte è obbligatorio criticare, anzi opporsi drasticamente alla forma capitalistica del conflitto per la preminenza; tuttavia, è nel contempo necessario condurre la propria azione contro i gruppi dominanti, sapendo di strategia e del misto di forza e malizia che l’agire trasformativo (“rivoluzionario”) comporta nell’attuale società. Così pure, è indispensabile orientare i dominati – e prima di tutto unire i raggruppamenti decisivi degli stessi (che non sono affatto in via di amalgama) – per ottenere i risultati trasformativi (di rivoluzionamento sociale); nel contempo, bisogna saper entrare, e proprio nei momenti in cui ciò diventa possibile, nelle contraddizioni tra gruppi dominanti, le cui interrelazioni conflittuali e rispettivi rapporti di forza sono differenti in epoche diverse, in fasi mono o invece policentriche. E via dicendo.
Di tutto ciò è meglio essere ben edotti, avendo inoltre la piena consapevolezza che la propria azione tende a convergere, e rischia di confondersi, con quella degli agenti politici da me denominati rivoluzionari dentro il capitale, messi in campo da nuovi gruppi di dominanti intenzionati, una volta rottisi gli equilibri precedenti, a rovesciare il potere dei vecchi gruppi, le cui strategie – sia interne ad una formazione particolare sia applicate al confronto tra più formazioni – aprono congiunture di crisi, di tensione sociale, di sfarinamento delle istituzioni, di caduta del consenso, ecc. In definitiva, si tratta delle stesse congiunture in cui si manifestano le maggiori possibilità d’azione da parte dei gruppi anticapitalistici. A causa di questa confusione, di questa “fatale” vicinanza di intenti “rivoluzionari” profondamente diversi, non è mai assicurato il successo, nemmeno nei momenti di massima crisi interna a date formazioni particolari, delle forze che agiscono specificatamente contro il capitale.
- Riassumiamo. Quella che continuiamo a chiamare società capitalistica – composta da ondate successive di sviluppo di formazioni sociali caratterizzate da via via differenti strutture di rapporti (capitalismo “borghese”, dei “funzionari del capitale”, ecc.) – non ha (più) molto a che vedere con le indicazioni forniteci dalla teoria di Marx; a meno di non rifarsi alla banale ripetizione delle “giuste” previsioni marxiane circa la centralizzazione monopolistica dei capitali, la generalizzazione della forma di merce e la continua estensione del mercato globale, e via cianciando. Se Marx avesse “scoperto” solo simile “acqua calda”, sarebbe veramente uno studioso di secondo rango. Ha detto molto di più, può quindi stimolare ben altre formulazioni teoriche; queste però debbono oggi soltanto aiutarci a percorrere nuovi sentieri. Le riflessioni di Marx vanno prese come un invito pressante a rimuginarne di nuove, che si distanzino dalle sue; è ben noto che, quando ci si allontana criticamente da un grande pensatore, non lo si abbandona e tanto meno lo si tradisce, bensì lo si usa – proprio mediante la negazione determinata delle sue tesi – quale pungolo ancora fecondo e vitale. Solo i dottrinari “chiesastici”, quali sono i rimasugli marxistoidi d’oggi, non capiscono tale problema e ci propinano sterili rimasticature del passato remoto.
I gruppi dominanti non tendono a centralizzarsi ed unificarsi, permangono invece in conflitto continuo con alternanza di acutizzazione e attenuazione dello stesso; quell’alternanza che, al livello delle interazioni fra formazioni particolari nell’ambito di quella globale, danno vita alle epoche (di lunga durata) di mono e policentrismo. All’interno delle singole formazioni particolari, le fasi di accentuazione dello scontro tra dominanti conduce, non però necessariamente e ineluttabilmente, a congiunture di “rivoluzione” con sbocchi non predeterminati: contro o dentro il capitale (più facilmente si realizza la seconda soluzione). Le modalità del conflitto sono quelle da sempre in uso tra i dominanti nelle diverse forme storiche di società; solo che in quelle precapitalistiche, le strategie del conflitto per la supremazia, fondate su forza e astuzia (detto in estrema sintesi), erano utilizzate nelle sfere politico-militare e ideologico-culturale, mentre nel capitalismo pervadono pure l’intera sfera economica duplicatasi in merce e denaro (produzione e finanza), una sfera che fornisce a questo punto i mezzi essenziali per l’attuazione delle strategie in ogni ambito sociale.
Un conflitto del genere produce sviluppo, e tramite questo consente l’egemonia dei gruppi dominanti e l’accettazione del dominio da parte dei sottoposti che migliorano comunque – come tendenza di lungo periodo – le loro condizioni di vita; diciamo pure quelle materiali, ma con ciò non si incrina di un ette il consenso generalizzato per questa forma sociale. Oltre allo sviluppo, il conflitto produce anche segmentazione e stratificazione crescenti della società, con interazione, quanto meno non armonica, tra i vari spezzoni e comparti sociali (segmenti e strati). Lo sviluppo è esso stesso disarmonico, avviene con ritmi diseguali in tempi e spazi diversi e conduce a periodi (e aree) di acutizzazione. Soprattutto nei periodi e aree (formazioni particolari o loro gruppi) in cui si accentuano disarmonia e crisi, si rafforza la “disaffezione” e spesso l’antagonismo nei confronti delle modalità di uno sviluppo fondato sulle strategie del conflitto per prevalere con la forza e con l’inganno; inizialmente lo scontro si fa più acuto tra i dominanti, ma ne vengono poi investiti sempre più largamente tutti gli altri ceti sociali.
I gruppi di agenti che criticano apertamente le caratteristiche del conflitto strategico tra dominanti – gruppi del tutto minoritari e relativamente isolati nelle fasi di attenuazione delle lotte e di prevalente consenso al capitale – non sono avanguardia di “una classe”, ma hanno anzi “estrazione sociale” assai composita. Chiedersi che cosa li unisca e che cosa essi rappresentino oggettivamente non è senza senso, ma credo costituisca in determinati periodi un esercizio perfettamente inutile. E’ più interessante chiedersi come mai essi – in genere figli di una passata epoca di acutizzazione del conflitto interdominanti – si trovino in situazione di crescente debolezza e di isolamento nell’ambito di formazioni particolari, man mano che queste accedono agli alti gradini dello sviluppo capitalistico, nel raggiungimento dei quali il processo di differenziazione sociale ha sciolto la “massa” del popolo dai suoi legami con più antiche tradizioni e culture. Non esiste anzi nemmeno più un popolo in senso proprio, bensì un insieme articolato di vari comparti sociali fra loro in interazione, diversamente posizionati sia in orizzontale che in verticale.
I gruppi critici (anticapitalistici) debbono comportarsi piuttosto differentemente nei periodi di attenuazione e in quelli di accentuazione degli scontri. Essi si muovono necessariamente tra molte contraddizioni che vanno assunte consapevolmente e senza pretese di una “purezza” di intendimenti, che si pretendono rivolti all’“amore per il popolo”, ormai del tutto inesistente come appena rilevato. E’ necessario condurre una critica delle modalità strategiche del conflitto tra dominanti, demistificando le varie ideologie “armoniciste” (e di falsa cooperazione) che le occultano e mistificano; e tuttavia si debbono conoscere tali modalità e rivolgerle contro i dominanti. Vanno condotte azioni politiche – sottoposte all’attento vaglio di date ipotesi teoriche circa la struttura e dinamica capitalistiche – atte a favorire il collegamento tra gli strati “bassi” della società (quelli più nettamente dominati) e la possibile loro alleanza in un dato “blocco sociale”; sarebbe però un errore decisivo dimenticare la lotta interdominanti e non assumere determinate posizioni in grado di acuirla e di favorire comunque i gruppi nuovi e più dinamici contro quelli ormai intorpiditisi e tendenzialmente parassitari. E’ semplicemente sciocco e avventuristico – tanto da far pensare talvolta alla mala fede di certi finti critici del capitalismo – inimicarsi proprio gli strati sociali “bassi” predicando contro lo sviluppo (solo “materiale”; che “orrore”! Questo però lo affermano certi intellettuali dalla pancia fin troppo piena); e tuttavia non vi è dubbio che non ogni tipo di sviluppo favorisce la crescita delle forze dette “antisistema”.
In ogni caso, si tenga presente che le possibilità “rivoluzionarie” si presentano soprattutto nelle congiunture di crisi. Ovviamente, come più sopra rilevato, non si tratta mai di crisi puramente economiche; occorrono ben altre condizioni di sfilacciamento della trama sociale complessiva, di affievolirsi del consenso e di forti incrinature degli apparati politici e istituzionali. Condizioni simili rendono perciò problematico lo sviluppo; questo diventa del resto ancora più debole, incerto e soggetto ad inversioni di tendenza anche in seguito al sempre più duro confronto interdominanti, che vede spesso intrecciarsi il conflitto tra formazioni particolari nel contesto globale e quello tra gruppi dominanti “vecchi” e “nuovi” all’interno delle formazioni particolari. Qui nasce allora una ulteriore complicazione per i gruppi di agenti politici che nutrono aspirazioni anticapitalistiche. La loro lotta si interseca, e rischia di confondersi, con quella degli agenti “rivoluzionari” dentro il capitale, intenzionati a rilanciare il sistema capitalistico sostenendo sia i nuovi gruppi di agenti capitalistici in una data formazione particolare, sia la propria formazione particolare contro le altre sul piano internazionale (epoche policentriche). Anche per questo, pur in congiunture adatte è comunque difficile l’attività dei gruppi anticapitalistici, che debbono porre molta attenzione a quanto predicano, pena l’alienarsi le simpatie di gran parte dei segmenti e strati – perfino di quelli situati nei bassi gradini della scala sociale (ed economica) – che tendono allora a raggrupparsi in “blocco sociale” sotto la direzione dei suddetti “rivoluzionari” dentro il capitale.
Se l’esperienza del fascismo, ma soprattutto del nazismo, non ha insegnato nulla, allora poveri noi! Vogliamo ancora sostenere la menzogna, sciocca e illusoria, che le masse erano antifasciste e antinaziste, che sono state subornate (chissà come e perché), che sono state piegate antidemocraticamente con la pura violenza? Se vogliamo continuare ad autoingannarci, seguendo i mediocri antifascisti che blaterano sciocchezze da tempo immemorabile, sotto la copertura della vittoria delle “democrazie” capitalistiche (il “migliore involucro della dittatura borghese” per Lenin), facciamolo pure; ma non avremo imparato nulla dall’esperienza storica. E ripeteremo i clamorosi errori degli anni trenta; non solo l’errore di definire socialfascisti i socialdemocratici, ma anche quello di aver in seguito costituito con questi ultimi un’alleanza “antifascista” confusa e pasticciata, che ha posto una bella pietra tombale su ogni velleità anticapitalistica. Non entro evidentemente in questa sede in una discussione, più storica che teorica (ma comunque orientata da nuove ipotesi teoriche), che sarebbe lunga e qui sviante. Certo, se qualcuno infine assolvesse un compito del genere, si farebbe chiarezza su temi ormai avvolti dalla spessa nebbia ideologica sparsa dai vincitori (capitalisti tanto quanto i perdenti).
- Questo è un altro piccolo pezzo di una lenta e faticosa costruzione teorica, che tenta in ogni caso di staccarsi dai vecchi lidi senza affatto perderne la memoria. Pur dove magari non sembra, mi confronto in realtà sempre con il passato (non solo teorico), sforzandomi però di prendere un diverso indirizzo. Non ho certo la pretesa di possedere le capacità intellettive di alcuni grandi di tempi trascorsi – non mi riferisco semplicemente a Marx e ai marxisti – che hanno dato forti contributi alla crescita di una teoria della società, soprattutto di quella capitalistica; una teoria capace anche di suggerire precise pratiche politiche ed economiche. Resto inoltre ben saldo sulla posizione assunta da Althusser quando affermò che Marx ha aperto alla scienza il Continente Storia.
Malgrado quanto appena ricordato, sono sempre più convinto della necessità di percorrere nuove strade, tornando eventualmente sui propri passi se ci si accorge di essere incappati in un “cul di sacco”; non arretrando però fino a ritrovarsi al punto di partenza per poi fermarsi e segnare il passo con stanche giaculatorie. Del resto, tanto per fare un esempio eclatante, Galileo, pur essendo un genio, non giungeva all’altezza di pensiero di Aristotele; eppure seppe mandare al diavolo gli aristotelici del suo tempo. Non mi sembra di vedere oggi in giro geni “galileiani”, ma ciò non deve impedire ad alcuna persona appena un po’ sensata di mandare infine al diavolo i marxisti o i weberiani o gli schumpeteriani o i keynesiani….ecc. ecc. (tanti sono i grandi del passato) onde avviarsi lungo sentieri non ben segnati, estirpando intanto un bel po’ di erbacce che intralciano il cammino.
Quindi mi sento tranquillo: non sono presuntuoso e tanto meno folle, so bene di essere lontanissimo dai livelli di intelligenza di Marx, ma anche di tanti altri marxisti minori. Tuttavia, sono del tutto insoddisfatto delle attuali analisi della società da qualsiasi parte provengano; credo perciò che ci sia spazio per pensare e “innovare”. Comunque tento, e andrò avanti passin passino, con estrema prudenza. Solo alla fine, se ne avrò il tempo, sonderò la possibilità di elaborare il tutto in un nuovo libro che segni un deciso passo in avanti rispetto agli Strateghi del capitale.





 Il professor DiLorenzo spiega la vera causa della guerra dell’aggressione nordica
Il professor DiLorenzo spiega la vera causa della guerra dell’aggressione nordica






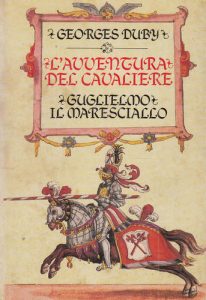 Nei vari momenti della propria storia, l’uomo ha avuto una propria particolare idea della “buona morte”. Il Medioevo non sfugge a questa particolarità e poiché il ceto sociale aveva in esso una funzione molto più codificata e ritualizzata, ogni categoria ne assumeva una propria. Contrariamente alle aspettative la buona morte del CAVALIERE, specie di alto rango, non doveva avvenire sul campo di battaglia. L’auspicio comune e dello stesso soggetto interessato era invece quello di una fine lenta e consapevole, malinconica ma non drammatica. Il tempo e la lucidità, magari nel caso indotta e interpretata dai più prossimi al capezzale, gli avrebbe consentito la spoliazione progressiva dai beni terreni e il contestuale progressivo lenimento dell’anima dalle zavorre mondane, residenza d’elezione delle tentazioni luciferine; la condizione necessaria alla ascesa verso l’Essere Supremo.
Nei vari momenti della propria storia, l’uomo ha avuto una propria particolare idea della “buona morte”. Il Medioevo non sfugge a questa particolarità e poiché il ceto sociale aveva in esso una funzione molto più codificata e ritualizzata, ogni categoria ne assumeva una propria. Contrariamente alle aspettative la buona morte del CAVALIERE, specie di alto rango, non doveva avvenire sul campo di battaglia. L’auspicio comune e dello stesso soggetto interessato era invece quello di una fine lenta e consapevole, malinconica ma non drammatica. Il tempo e la lucidità, magari nel caso indotta e interpretata dai più prossimi al capezzale, gli avrebbe consentito la spoliazione progressiva dai beni terreni e il contestuale progressivo lenimento dell’anima dalle zavorre mondane, residenza d’elezione delle tentazioni luciferine; la condizione necessaria alla ascesa verso l’Essere Supremo.