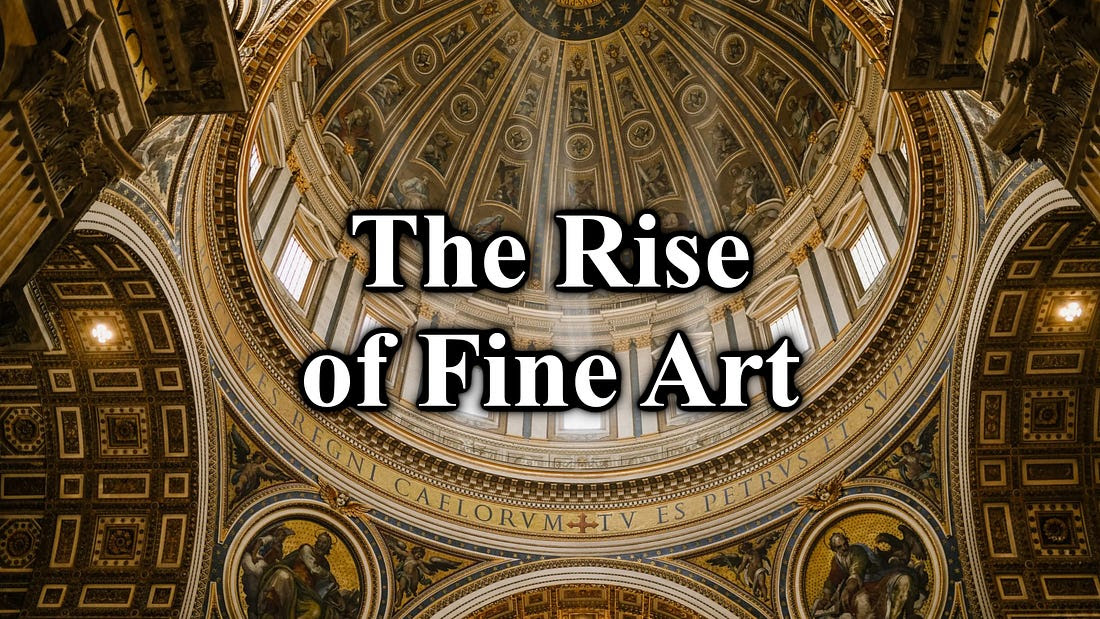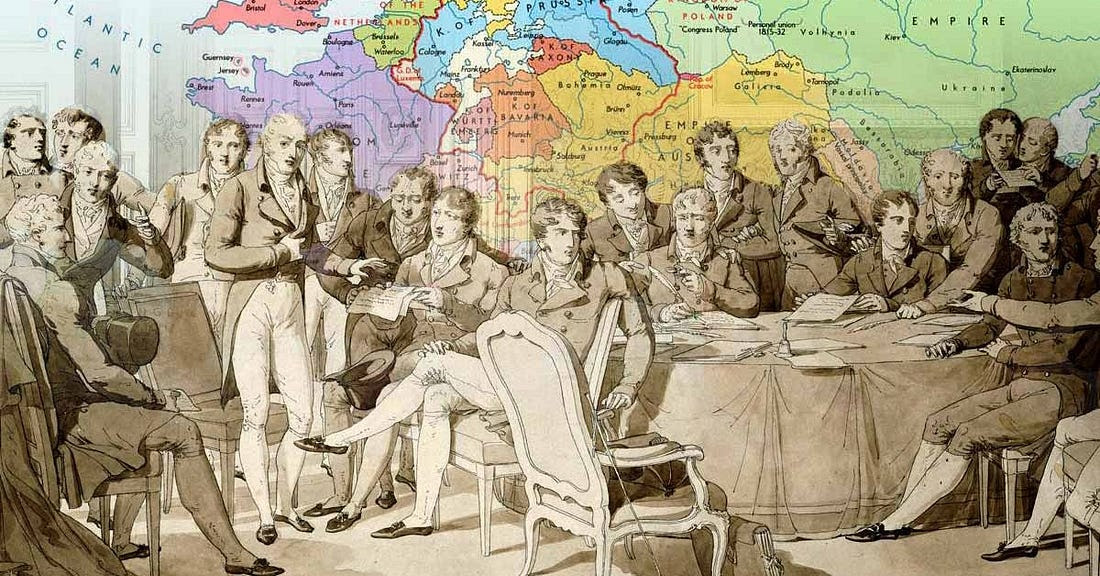I limiti del realismo offensivo e l’emergere di una nuova forma di realismo: il caso dell’OCS
Da Rassegna dei conflitti
La teoria del realismo offensivo è stata definita da John J. Mearsheimer. Questa teoria presenta alcuni limiti, come dimostrato dal caso dell’OCS
Di Cédric Garrido
Il sito Italia e il Mondo non riceve finanziamenti pubblici o pubblicitari. Se vuoi aiutarci a coprire le spese di gestione (circa 4.000 € all’anno), ecco come puoi contribuire:
– Postepay Evolution: Giuseppe Germinario – 5333171135855704;
– IBAN: IT30D3608105138261529861559
PayPal: PayPal.Me/italiaeilmondo
Tipeee: https://it.tipeee.com/italiaeilmondo
Puoi impostare un contributo mensile a partire da soli 2€! (PayPal trattiene 0,52€ di commissione per transazione).
Contatti: italiaeilmondo@gmail.com – x.com: @italiaeilmondo – Telegram: https://t.me/italiaeilmondo2 – Italiaeilmondo – LinkedIn: /giuseppe-germinario-2b804373
Introduzione
Il 9 maggio 2025, in occasione delle celebrazioni dell’80ᵉ anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui le due superpotenze eurasiatiche e i principali attori della SCO e dei BRICS, hanno denunciato in particolare gli effetti deleteri della ricerca della ” sicurezza strategica assoluta ” da parte di ” alcune potenze nucleari sostenute dai loro alleati ” sulla stabilità regionale e globale, mettendo così in discussione i dogmi del realismo offensivo;sicurezza strategica assoluta ” da parte di “alcune potenze nucleari sostenute dall’appoggio dei loro alleati ” sulla stabilità regionale e globale, mettendo così in discussione i dogmi del realismo offensivo.
Questa teoria delle relazioni internazionali sviluppata da John J. Mearsheimer[1] ed esposta nel suo libro The Tragedy of Great Powers Politics (2001)[2] afferma che l’anarchia del sistema internazionale condiziona gli Stati a massimizzare il proprio potere per garantire la propria sicurezza, avendo come obiettivo finale la sopravvivenza. Caratteristica consolidata e predominante delle relazioni internazionali, il realismo offensivo sembrava fino a poco tempo fa aver raggiunto un punto della sua storia in cui il fine perseguito – la sicurezza ottimale – e i presunti mezzi per raggiungerlo – la prevalenza all’interno di un gioco a somma zero – si confondevano. La traiettoria post-Guerra Fredda degli Stati Uniti, particolarmente ricca di insegnamenti, ha però dimostrato che la ricerca della massimizzazione del potere è alla fine controproducente, rivelandosi fonte di erosione del potere e di instabilità in una parossistica incarnazione del dilemma della sicurezza. Il fenomeno della de-occidentalizzazione è semplicemente il risultato logico di questa sequenza.
Nonostante il precedente storico così creato, un’altra discutibile equivalenza che influenza la nostra percezione delle relazioni internazionali e il comportamento atteso dei suoi attori è ancora comunemente fatta tra la ricerca della sicurezza e il desiderio di egemonia: a parte l’etnocentrismo geopolitico, Cina e Russia sono ancora percepite dall’Occidente attraverso il prisma dell’esperienza egemonica americana. In conformità con la dottrina del realismo offensivo, essi sono visti come tentativi di alterare l’ordine mondiale (o regionale) esistente a loro esclusivo vantaggio, falsando così la nostra lettura degli eventi e limitando la nostra capacità di anticipazione. Tuttavia, le caratteristiche e il funzionamento dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), un’organizzazione multilaterale per la cooperazione di sicurezza neo-westfaliana di cui Cina e Russia sono membri fondatori, tendono a confutare questi pregiudizi e ci invitano a interrogarci sui limiti del realismo offensivo, al di là delle battute d’arresto americane di questa dottrina.
L’obiettivo di questo articolo è esaminare come il modo in cui la SCO opera e la comunità di interessi che è stata in grado di costruire sfidino la nostra percezione del realismo offensivo e in che misura questa organizzazione sia indicativa dell’emergere di un nuovo paradigma nelle relazioni internazionali. A tal fine, adotteremo innanzitutto una prospettiva storica, passando in rassegna i legami tra la SCO e la de-occidentalizzazione. In seguito, ci soffermeremo sui limiti del potere normativo multilaterale occidentale, la cui perdita di attrattiva per la SCO è sintomatica. Infine, confronteremo le caratteristiche della SCO con il realismo offensivo per comprenderne i limiti e definire i contorni del nuovo paradigma che probabilmente emergerà.
Per ricordare che la SCO è un’organizzazione di cooperazione per la sicurezza fondata nel 2001, erede del “Gruppo di Shanghai”, la cui funzione principale era quella di risolvere i conflitti di confine nell’Asia centrale post-Guerra Fredda.Fondata originariamente dai Paesi dell’Asia centrale (tranne il Turkmenistan), dalla Russia e dalla Cina, vi hanno poi aderito l’India, il Pakistan, l’Iran e la Bielorussia, e conta oggi 18 Paesi osservatori e partner di dialogo, uniti da interessi primari di sicurezza (lotta ai “tre flagelli”). – terrorismo, separatismo, estremismo religioso – e criminalità transnazionale), prima di vedere la sua sfera di cooperazione estesa a tutti i settori della vita politica (economico, energetico, culturale, ecc.). Con il suo carattere eurasiatico esteso al Medio Oriente, al Nord Africa, all’Asia meridionale e sudorientale, è oggi la più grande organizzazione di cooperazione regionale del pianeta in termini economici, demografici e di superficie (42% della popolazione totale per il 24% del PIL e copertura del 66% della superficie del continente eurasiatico).
L’OCS e le origini del riflusso dell’influenza occidentale in Eurasia
Per de-occidentalizzazione si intende la perdita di influenza delle potenze occidentali o delle istituzioni multilaterali dominate dall’Occidente a favore dei Paesi, o delle istituzioni che essi costituiscono, precedentemente dominati da queste stesse potenze occidentali. Questo fenomeno è spesso associato alla “fine del mondo unipolare” o alla “transizione verso un mondo multipolare”. L’attenzione dei media sui suoi aspetti economici e diplomatici (perdita di influenza del G7, ascesa dei BRICS, rafforzamento diplomatico dei Paesi in via di sviluppo, il “Sud globale”) farebbe pensare che i suoi aspetti di sicurezza siano di secondaria importanza.
Tuttavia, la storia della cooperazione in materia di sicurezza in Eurasia è un indicatore altrettanto rilevante della natura e delle prospettive di questo fenomeno, per una serie di ragioni. È opportuno dare un rapido sguardo al contesto. Da un punto di vista geostrategico globale, la prima condizione per preservare la posizione centrale degli Stati Uniti negli affari mondiali è il mantenimento della relativa divisione del continente eurasiatico. Infatti, un eventuale coordinamento diplomatico ed economico del “mondo insulare”, che concentra la maggior parte delle risorse, dei territori e dei mercati del pianeta, marginalizzerebbe irrimediabilmente la potenza americana, riportandola allo status di isola periferica[3]. L’importanza degli aspetti di sicurezza della de-occidentalizzazione va quindi valutata con il metro delle questioni eurasiatiche, che sono di assoluta attualità, anche se discrete : Le istituzioni euro-atlantiche (NATO/UE) hanno tracciato una lunga linea di frattura tra l’Europa occidentale e la Russia, il cui avvicinamento alla Cina (bilaterale o multilaterale istituzionale nell’ambito dei BRICS o della SCO, tassati come organizzazioni ” ;anti-occidentali[4] “) viene regolarmente deplorato dagli ” strateghi ” occidentali, senza riuscire a prevenirlo. Inoltre, l’attuale posizione militare degli Stati Uniti continua a cingere il continente eurasiatico, circondandolo ai suoi confini orientali e occidentali[5].
Tuttavia, risulta che la cooperazione in materia di sicurezza in Eurasia non è mai stata occidentalizzata nel vero senso della parola. L’ascesa dell’influenza occidentale sulla sicurezza regionale, che ha beneficiato del consenso globale dei primi anni della “guerra al terrore” che ha contrapposto la coalizione occidentale ai Talebani in Afghanistan, si è scontrata nel 2005 con il desiderio dei Paesi della SCO di porre fine alle locazioni americane in Asia centrale[6] a causa delle ricorrenti interferenze negli affari interni[7] e della più generale inadeguatezza della dottrina della cooperazione (cfr. infra). sotto). Questo evento segna l’inizio del declino dell’influenza occidentale nella sicurezza regionale.
A livello istituzionale, il funzionamento dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la principale organizzazione di cooperazione per la sicurezza in Eurasia dominata dall’Occidente, è stato notevolmente ostacolato dal deterioramento delle relazioni tra Occidente e Russia. Insieme alle divisioni interne che attualmente colpiscono il campo occidentale nel contesto del conflitto russo-ucraino, è molto probabile che l’OSCE sia destinata a svolgere solo un ruolo relativamente marginale nella cooperazione per la sicurezza in Eurasia[8]. Allo stesso tempo, la SCO, che opera su una base più egualitaria e rispettosa della sovranità nazionale, ha continuato a espandersi e a istituzionalizzarsi e ha contribuito in modo significativo alla stabilizzazione dell’Asia centrale, promuovendo lo sviluppo economico regionale. Possiamo quindi notare che non solo l’aspetto della sicurezza della de-occidentalizzazione, di cui la SCO è allo stesso tempo attore, beneficiario e simbolo, non è insignificante rispetto agli aspetti economici e diplomatici, ma anche che li precede di quasi un decennio, essendo i BRICS stati formalizzati solo nel 2009. Esaminiamo ora le caratteristiche della proposta occidentale di cooperazione in materia di sicurezza e le tappe che hanno portato al suo fallimento.
I limiti del potere normativo del multilateralismo occidentale
L’aspetto interessante dell’evoluzione dell’influenza sulla sicurezza in Asia centrale dopo l’11 settembre 2001 è che, pur essendo circoscritta a un contesto relativamente limitato, è sostanzialmente simile all’evoluzione più generale del potere normativo del multilateralismo occidentale su scala globale dal 1949. In linea di massima, questa evoluzione può essere descritta in tre fasi:
Una prima fase di adesione al progetto basata sulla forza di convinzione del suo promotore (combinazione di potere oggettivo e soft power) e sull’assenza di alternative (ONU e Consiglio di Sicurezza, istituzioni di Bretton Woods, ” fine della Storia ” e ” nuovo ordine mondiale “) ;
Una seconda fase di disillusione ha visto le promesse del multilateralismo disattese dall’uso dell’utilitarismo al servizio della politica di potenza (interventi militari senza mandato ONU in Kosovo, Iraq (2003) e Libia, condizionalità della Banca Mondiale e del FMI, Washington Consensus, rivoluzioni cromatiche, invocazione del diritto internazionale a geometria variabile per quanto riguarda, tra i più noti, i conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese);
E infine, una terza fase di fine dell’ascesa dell’influenza, seguita da un riflusso non appena gli attori statali che si sentono danneggiati dal quadro esistente si trovano nella posizione di prendere nuovamente l’iniziativa (G20, SCO, BRICS, Belt and Road Initiative, Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank), finendo per proporre alternative.
Così (1ʳᵉ fase) all’indomani dell’11 settembre, grazie a un consenso globale senza precedenti, la Russia e i Paesi dell’Asia centrale (PAC), uniti intorno agli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo jihadista, hanno accettato di aprire loro le porte dell'” Heartland “, uno spazio geostrategico storicamente molto ambito. L’impatto normativo globale della dichiarazione di guerra al terrorismo è quindi piuttosto significativo; la sua elevazione al rango di minaccia strategica è gravida di conseguenze in termini di lotta al terrorismo, con l’istituzione di nuove norme e pratiche, tra cui il rafforzamento della cooperazione internazionale e la riforma dei sistemi di sicurezza statali. Va notato che già nel 1994 i PAC avevano potuto sperimentare i benefici della cooperazione con la NATO nel quadro del Partenariato per la Pace (PfP) e rivalutare le loro relazioni con il nemico eterno , il cui vantaggio istituzionale rispetto alla SCO e alla CSTO era all’epoca innegabile, consentendo di rispondere alle aspirazioni di multiallineamento dei PAC.
Fino alla (2ᵉ fase), le discrepanze dottrinali, le differenze strutturali e le priorità contrastanti hanno arrestato l’ascesa dell’influenza occidentale sulla sicurezza. È nata quindi un’opposizione dottrinale tra i sostenitori regionali della rigida sovranità westfaliana e quelli di un’agenda occidentale post-westfaliana di “sicurezza umana”[9]. Un’illustrazione degna di nota è il ritorno di molti Paesi dell’ex URSS a una nozione più tradizionale di sovranità alla fine del periodo di cooperazione dei primi anni Novanta, che stanno diventando sempre più riluttanti nei confronti di ciò che considerano un’interferenza dell’OSCE.
Inoltre, le organizzazioni regionali occidentali e non occidentali si distinguono per differenze fondamentali nella progettazione strutturale. Mentre la concezione razionale e la funzionalità condizionano le prime (l’UE è progettata per servire il federalismo europeo, indipendentemente dalle esigenze e dagli interessi specifici dei suoi Stati membri), è intorno alle esigenze e agli interessi comuni degli Stati membri che si strutturano le seconde (che cooperano per rispondere a un bisogno preesistente di sicurezza e stabilità). Questi Stati condividono valori e ideologie simili, sviluppati in linea con la propria identità, e cercano di svolgere un ruolo attivo nella loro regionalizzazione, spesso come reazione all’etnocentrismo europeo.
Allo stesso modo, l’uso della condizionalità e dell’utilitarismo per interferire sono i principali ostacoli alla penetrazione dell’influenza occidentale sulla sicurezza in Asia centrale. Gli aiuti americani all’Uzbekistan in seguito al trasferimento della base aerea di Karshi-Khanabad erano condizionati agli sforzi compiuti dalla parte uzbeka per promuovere i diritti umani e la democrazia. La repressione della rivolta di Andijan nel 2005, in spregio a questi impegni, ha portato a sanzioni economiche e politiche contro il governo uzbeko. La risposta della SCO a queste sanzioni, con la prevista espulsione delle forze statunitensi dall’Asia centrale, ha segnato un importante cambiamento nell’influenza strategica occidentale nella regione[10]. Queste sanzioni hanno avuto l’effetto di screditare la promozione delle idee democratiche, che appaiono qui strumentalizzate in nome della diffusione forzata dell’influenza occidentale.
Infatti, “l’attenzione prestata dagli Stati Uniti all’Asia centrale deriva storicamente da interessi non indigeni alla regione, una funzione delle politiche e delle priorità americane “. L’anarchia del sistema internazionale impone alle grandi potenze un utilitarismo di rigore, questo è un dato di fatto. La differenza è che, nel caso della Cina e della Russia, i loro interessi strategici sono strettamente legati alla situazione della sicurezza in Asia centrale, quindi sono vincolati dall’obbligo di ottenere risultati. A differenza degli Stati Uniti, che sono liberi di spingere l’utilitarismo fino a discutere della necessità di ostacolare attivamente le organizzazioni regionali in quanto facilitatori dell’emergere di un mondo multipolare, e quindi di ostacolare la supremazia americana. Eppure, per i PAC, le organizzazioni regionali sono proprio un fattore di stabilizzazione.
È stato inoltre stabilito che nel decennio successivo all’indipendenza dei Paesi dell’Asia centrale (1991-2001), ” la regione era lontana dall’essere una priorità per Washington “, e che una relativa mancanza di considerazione per le questioni regionali caratterizza il successivo periodo di maggiore coinvolgimento occidentale (2001-2021).Ciò si è poi riflesso in una dissonanza delle priorità di sicurezza tra gli attori della regione: la lotta al terrorismo, pur essendo ancora di indubbia importanza, non era più una priorità strategica nell’agenda occidentale. La “guerra al terrorismo” sta finendo per cedere il passo alla competizione tra grandi potenze, relegando il terrorismo allo status di “un fastidio con cui possiamo convivere, a patto di “tagliare il prato” periodicamente […] “.
Infine, l’attenzione riservata alle priorità di sicurezza regionale dell’Asia centrale è rapidamente diminuita a favore dell’Ucraina, prima all’indomani di EuroMaïdan (2014), in coincidenza con il disimpegno regionale della NATO, e poi in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina (2022). Quest’ultima è diventata la principale preoccupazione per la sicurezza dell’Occidente, catturando una quantità significativa di risorse umane, materiali e finanziarie, a scapito della questione afghana. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’UE, mentre la sua strategia per l’Asia centrale del 2007 indicava esplicitamente l’Afghanistan come una minaccia per la sicurezza regionale, nell’aggiornamento del 2019 non è più considerato tale. La diminuzione del ruolo dell’OSCE, in particolare in Afghanistan, che è “completamente sparito sotto i radar da febbraio (2022)”, conferma questo stato di cose.
In altre parole, l’approccio occidentale al multilateralismo post-Guerra Fredda e l’influenza dell’Occidente sulla sicurezza in Asia centrale stanno fallendo per le stesse ragioni, le stesse cause producono gli stessi effetti: la ricerca di ottimizzare il potere nel breve-medio termine attraverso il predominio in un gioco a somma zero (in questo caso di influenza sulla sicurezza) secondo le modalità del realismo offensivo produce l’effetto opposto a quello ricercato (perdita di capacità di proiezione militare e discredito diplomatico, compromettendo le prospettive di acquisizione di potere).
La retrocessione dell’Asia centrale nell’agenda della sicurezza occidentale è avvenuta quindi a favore di un quadro di cooperazione per la sicurezza ritenuto più appropriato, definito da e per gli attori regionali, che è quello della SCO (3ᵉ fase), e che discuteremo di seguito, non senza aver prima esaminato i postulati del realismo offensivo.
I limiti del realismo offensivo e un approccio alternativo alle relazioni internazionali
Il realismo offensivo si basa sui seguenti cinque presupposti: 1) il sistema internazionale è anarchico, 2) le grandi potenze possiedono tutte capacità militari offensive, 3) ogni Stato è incerto sulle intenzioni degli altri, 4) la sopravvivenza è la preoccupazione principale delle grandi potenze, la sicurezza il loro obiettivo principale, 5) le grandi potenze sono attori razionali. L’insieme di queste caratteristiche favorisce l’atmosfera di sfiducia strutturale che caratterizza le relazioni interstatali, incoraggiando gli Stati a ottimizzare il proprio potere e a impegnarsi nella competizione strategica. Pertanto, secondo Mearsheimer, il predominio in un gioco a somma zero sembrerebbe essere la migliore garanzia di sicurezza e la forza (forza) il mezzo per raggiungere e preservare tale sicurezza. Il potere equivarrebbe alla sicurezza, quindi più potere sarebbe sinonimo di più sicurezza, con il risultato di una competizione infinita sulla sicurezza, la “tragedia della politica delle grandi potenze”, che condanna la Storia a un eterno riavvio.
Tuttavia, l’autore riconosce alcuni limiti alla sua teoria: una semplificazione della realtà insita in tutte le teorizzazioni, l’oscuramento del ruolo degli individui e delle considerazioni di politica interna nel processo decisionale, o gli errori di calcolo derivanti da un processo decisionale poco informato, nel qual caso il realismo offensivo non è più applicabile, oltre a qualche rara eccezione alla regola.
La forza dell’impegno di Stati Uniti, Cina e Russia, solo per citarne alcuni, nella competizione strategica, testimonia l’efficacia del modello di Mearsheimer, che era ben sostenuto all’epoca della sua pubblicazione. Tuttavia, quasi un quarto di secolo dopo, la de-occidentalizzazione, la perdita di influenza e la generale perdita di slancio degli Stati Uniti, nonostante siano l’esempio del realismo offensivo, richiedono un riesame di alcune delle sue ipotesi.
Il rapporto tra egemonia e sicurezza, ad esempio, deve essere messo in discussione su più fronti. Quando il realismo offensivo difende l’idea che l’egemonia sia la migliore garanzia di sopravvivenza per uno Stato, presuppone che lo status di egemone possa essere mantenuto una volta raggiunto. Questo è tutt’altro che facile, come dimostra l’esempio americano. L’appiattimento degli Stati Uniti sulla scena internazionale, causato dalla scarsa attrattiva del modello proposto, rivela l’importanza di quest’ultimo come garanzia della durata dell’egemonia perseguita, accanto agli attributi del potere economico e militare. Inoltre, evidenzia la natura cruciale del potere normativo, che è l’argomento principale dei modelli alternativi di relazioni internazionali proposti dalla SCO o dai BRICS[11]. Si dovrebbe fare una riflessione a posteriori su come questi avrebbero potuto e dovuto preservare il potere federativo del modello di società liberale promosso. Lo stanno facendo probabilmente Paesi come la Cina e la Russia, per i quali la sconfitta degli Stati Uniti e il fallimento del progetto europeo dovrebbero fungere da istruttivi controesempi di strategia di potenza, i primi peccando di eccessiva ottimizzazione e assoluta trascuratezza del dilemma della sicurezza, i secondi di integrazione forzata e sovranazionalità.
Allo stesso modo, Mearsheimer difende l’idea che un mondo multipolare con almeno un potenziale egemone sia il più favorevole alla guerra[12], rendendo la Cina, il principale sfidante degli Stati Uniti e il principale polo di potere nel mondo multipolare emergente, una minaccia intrinseca (indipendentemente dalle sue intenzioni). Ma possiamo già vedere che la sua strategia di potere è molto diversa. Si afferma, si impone e cresce in potenza secondo le proprie modalità, escludendo a proprio vantaggio il cambio di regime, l’intervento militare o il dirottamento delle istituzioni multilaterali, affidandosi, tra l’altro, alle sue comprovate capacità di guerra economica sistemica (forze d’attacco industriali, commerciali, diplomatiche, tecnologiche, normative). Sta certamente sviluppando le sue capacità militari offensive, ma non sembra incline a usarle finché non viene superata nessuna delle sue linee rosse.
Inoltre, la consapevolezza, esacerbata dall’interconnettività digitale e logistica, dei limiti fisici del mondo e delle sfide globali (vincoli energetici, riscaldamento globale, tensioni idriche, rischi di pandemie, distruzione degli ecosistemi) sta riportando gli Stati a un comune ancoraggio terrestre, integrando questi fattori nello sviluppo della loro strategia di sicurezza. Un mondo in cui la sicurezza nazionale dipende intrinsecamente dalla cooperazione interstatale limita certamente il valore della posizione di egemonia, nella misura in cui le sfide sollevate non possono essere affrontate con la forza bruta, rendendo ancora più obsoleta la relazione causale tra egemonia e sicurezza.
Un altro dogma caratteristico della scuola “realista” oggi degno di essere riconsiderato è quello della visione deterministica e insuperabile del quadro del gioco a somma zero, secondo cui il guadagno di potere di uno Stato avviene necessariamente a spese di un altro Stato. Sebbene questo dogma rimanga sensato da un punto di vista tattico, rimane fondamentalmente controproducente nel medio-lungo termine, compromettendo di fatto qualsiasi obiettivo di sicurezza strategica attraverso comportamenti statali che favoriscono l’aumento del livello di insicurezza circostante, e minacciato di obsolescenza dal concetto più unificante e costruttivo di indivisibilità della sicurezza promosso da Cina e Russia, in particolare nel quadro della SCO.
Le conclusioni di Mearsheimer sul comportamento delle grandi potenze richiedono anche qualche commento sulle loro implicazioni per il multilateralismo. Egli afferma così :
“Le grandi potenze non sono aggressori insensati, così decisi a conquistare il potere da lanciarsi a capofitto in guerre perdenti o perseguire vittorie di Pirro. Al contrario, prima di intraprendere azioni offensive, le grandi potenze pensano attentamente all’equilibrio di potere e a come gli altri Stati reagiranno alle loro mosse”.
Approfondiamo questa affermazione: essa giustificherebbe in effetti una percezione comune del multilateralismo al tempo stesso disillusa e opportunista, secondo la quale le grandi potenze starebbero per così dire in agguato permanente, aspettando cautamente che le condizioni siano giuste prima di agire. Così sia. Resta il fatto che questa visione sottrae comunque alla nostra vigilanza analitica ogni potenziale strategia di conquista del potere che non assomigli a ciò che già conosciamo. Ad esempio, una strategia che vada oltre il quadro di un gioco a somma zero, senza (tentare di) sconvolgere improvvisamente l’equilibrio, e che si concentri sull’indivisibilità della sicurezza, non per opportunismo egemonico mascherato da benevolenza o ideologia, ma per chiaro pragmatismo, dato che la competizione per la sicurezza secondo le modalità del realismo offensivo si rivela controproducente nel medio termine.
Mearsheimer, citando Edward H. Carr[13], ci ricorda che i realisti, rassegnati all’idea dell’inevitabilità della competizione per la sicurezza e della guerra, ritengono che ” la più grande saggezza risiede nell’accettare e adattarsi a queste forze e tendenze “. Ciò che allora poteva essere inteso come un’ingiunzione ad abbracciare la competizione per la sicurezza, oggi, con il senno di poi, negli ultimi decenni, potrebbe suggerire di abbracciare la resilienza e la stabilità di fronte ai rischi geopolitici o finanziari. È questa capacità di resilienza, che sarebbe in realtà simile alla prevenzione e alla gestione del rischio applicata alla geopolitica, che la Russia e la Cina, insieme ai loro partner, intendono continuare a sviluppare attraverso organismi multilaterali come la SCO o i BRICS, o attuando politiche di buon vicinato, politiche estere di empowerment o persino emancipandosi gradualmente dalla dipendenza dal dollaro USA nel commercio internazionale.
Non si tratta di sostenere i realisti difensivi, ai quali Mearsheimer contrappone risultati statistici innegabilmente a favore degli aggressori. L’idea è piuttosto quella di indicare un cambio di paradigma che si verifichi quando quello attuale è giunto al capolinea della sua logica, e che privilegi la resilienza come garanzia di sopravvivenza e per estensione l’indivisibilità della sicurezza, avanzata da potenze che avranno compreso i limiti, se non l’utopia odierna, delle aspirazioni all’egemonia (anche solo regionale) in senso realista offensivo[14]. Un esame delle funzionalità della SCO, in particolare di quelle emergenti, dovrebbe aiutare a illustrare questa idea.
Come funziona l’OCS e i suoi vantaggi
La “fine della storia” non è ancora arrivata, quindi dobbiamo essere vigili sui nuovi sviluppi che le interpretazioni del passato non sono in grado di cogliere. La SCO è una novità sotto molti aspetti e la dottrina del realismo offensivo potrebbe non essere sufficiente per comprenderne i lati positivi e negativi. Infatti, la SCO è l’unica organizzazione di cooperazione regionale per la sicurezza che copre la maggior parte del continente eurasiatico (compreso il suo cuore asiatico centrale) e inaugura la prima iniziativa multilaterale nella storia della diplomazia cinese (SONG, 2016) ha una costituzione rigorosamente non occidentale e concretizza la convergenza degli interessi strategici sino-russi riunisce quattro potenze nucleari e la stragrande maggioranza dei suoi membri pratica il multiallineamento. Attualmente rappresenta oltre il 40% della popolazione mondiale e circa il 25% del PIL. In rottura con la tradizione cinese del bilateralismo, la SCO offre alla Cina uno spazio per la pratica della governance multilaterale, di cui si fa depositaria dell’autorità concettuale, formulando le basi dottrinali dell’organizzazione fonti della sua attrattiva, come lo ” spirito di Shanghai[15] ” o il ” Nuovo concetto di sicurezza “[16], e che riflettono l’importanza attribuita alla politica di vicinato (o diplomazia periferica) nella dottrina della politica estera cinese : L’obiettivo della Cina era quello di creare condizioni favorevoli alla solidarietà tra gli Stati membri attraverso valori e norme istituzionali in grado di convincere i Pac e la Russia che “la fiducia e il beneficio reciproci, la non alleanza, il non scontro e il non bersagliamento di una terza parte” sono condizioni sine qua non per la loro rispettiva sicurezza nazionale.
Molto più che un rozzo cavallo di Troia per l’influenza cinese in Eurasia, la SCO è stata infatti guidata fin dall’inizio dalle relazioni sino-russe e manifesta la convergenza dei loro interessi strategici in Asia centrale, così come in Asia-Pacifico da quando India e Pakistan si sono uniti nel 2017 (LUKIN et al., 2019). È essenzialmente da queste relazioni che dipende la sopravvivenza dell’organizzazione (ARIS, 2011). Le recenti dichiarazioni ufficiali e gli analisti concordano sul fatto che le loro interazioni, sebbene spesso descritte come eminentemente conflittuali per i due Paesi, non sono regolate dalle regole di un gioco a somma zero, ma rientrano nella stretta cooperazione per mantenere la sicurezza e la stabilità regionale. Pertanto, non vi sono prove che la Cina stia cercando di diminuire il ruolo della Russia nell’area. Si tratta piuttosto di preservare una sana interdipendenza tra i due vicini, che è un prerequisito per mantenere le rispettive agentività, in particolare per ragioni di know-how russo e di bilanciamento intra-organizzativo. Le risposte congiunte alle sfide di sicurezza post-Guerra Fredda (risoluzione dei conflitti di confine, smilitarizzazione delle frontiere, cooperazione in Asia centrale) e il conseguente rafforzamento della fiducia reciproca sono stati, insieme all’antagonismo americano, i fattori chiave dello sviluppo delle relazioni sino-russe[17].
Il rapporto è reso ancora più duraturo dal fatto che è complementare: la Russia cede la preminenza economica alla Cina, pur beneficiando della sua influenza sulla scena internazionale; la Cina a sua volta si affida al know-how militare[18] e istituzionale multilaterale della Russia, senza il quale l’agentività regionale della Cina sarebbe ridotta. Un accordo tacito che viene accolto con favore dai membri centroasiatici della SCO per la rilevanza dell’agenda che ne deriva. E illustra il tipo di concessioni che questi due attori principali sono disposti a fare in nome del buon funzionamento dell’organizzazione. Sebbene possa permanere un certo grado di diffidenza, il rafforzamento delle relazioni bilaterali è stato incoraggiato da una percezione comune delle sfide occidentali e dei problemi di sicurezza dell’Asia centrale. In queste condizioni, non si può pensare di sostituire gli interessi di un possibile egemone regionale a quelli della regione, come hanno fatto gli Stati Uniti nella regione del Nord Atlantico inimicandosi la Russia a scapito degli interessi europei.
La SCO è anche strutturalmente flessibile, come dimostra non solo la sua elasticità attraverso i vari meccanismi di allargamento che ha attuato e la sua capacità di conciliare politiche estere diverse, ma anche i meccanismi emergenti di regolazione dell’influenza, che impediscono a qualsiasi Stato membro di godere di un’influenza relativa sproporzionata all’interno della SCO, un sintomo egemonico se mai ce n’è stato uno. Pertanto, poiché la partecipazione ai programmi congiunti si basa sulla stretta volontà di ciascun membro (senza rischio di sanzioni in cambio), la generazione di consenso rimane la priorità della SCO se vuole agire come attore coerente. Questo quadro non vincolante ha anche l’effetto di rassicurare gli Stati membri sul rispetto della loro sovranità. L’apparente mancanza di efficacia dell’organizzazione, derivante da un alto grado di dipendenza dalla buona volontà dei singoli Stati, è in parte compensata dal fatto che essi sono in grado di concentrarsi meglio su aree di interesse comune (ARIS, 2011). Ciò contribuisce anche alla resilienza dell’organizzazione. Ad esempio, né i conflitti in Georgia o in Ucraina che hanno coinvolto la Russia, né le dispute sul lato economico dell’organizzazione, né le più recenti controversie tra India e Pakistan in seguito agli attentati del 22 aprile 2025 in Kashmir, l’hanno mai messa a rischio.
La rilevanza della SCO come forum di dialogo è confermata anche dalla valutazione di Mearsheimer sull’importanza del fattore “paura” nell’intensità della competizione per la sicurezza, dato che l’organizzazione svolge un ruolo chiave nello stabilire relazioni di fiducia e nel costruire e consolidare una comunità di interessi.
Un altro vantaggio apprezzato dagli Stati membri dell’Asia centrale è la facilitazione dell’organizzazione nella gestione della competizione tra grandi potenze: salvaguardando la coabitazione di politiche estere eterogenee, mantiene un ambiente istituzionale propizio al multiallineamento. Ciò distingue anche il modo di operare della SCO dal realismo offensivo praticato dagli Stati Uniti, che pretendono che i loro alleati o partner si allineino alle loro posizioni internazionali, ove necessario.
L’effetto di equilibrio che emerge dall’interdipendenza dei membri all’interno dell’organizzazione è un altro fattore importante che ne condiziona l’attrattività e la durata. L’effetto di bilanciamento ha dimensioni sia intra- che extra-organizzative e si manifesta in un’ampia gamma di configurazioni interattive:
-Tra la Cina, che brama sbocchi economici in Asia centrale, e la Russia che, pur frenando l’aspetto economico della SCO, accoglie con favore il riconoscimento da parte di Pechino dell’Unione economica eurasiatica (TEURTRIE, 2021), che in cambio richiede l’ascendente regionale di Mosca per sciogliere le riserve della PAC;
-Tra il binomio Cina/Russia e i PAC, dal cui consenso dipende il buon funzionamento dell’organizzazione. Infatti, la stabilità interna e le relazioni costruttive con i PAC rientrano nelle priorità della politica estera russa e cinese (ARIS, 2011), creando le condizioni per una forte interdipendenza intra-organizzativa;
-Tra i PAC, i meno potenti vedono le ambizioni regionali kazake mitigate dai vicini russi e cinesi;
-Per i PAC, un equilibrio tra l’influenza occidentale e quella regionale consente di sfruttare i vantaggi comparativi di ciascun membro dell’equazione. Pur apprezzando il contributo dell’Occidente al loro sviluppo economico e tecnologico, preferiscono un mondo con un polo di potere alternativo e organizzazioni come la SCO che si occupano delle loro questioni di sicurezza (LUKIN, 2019);
I leader dei PAC giocano anche sulla loro appartenenza simultanea alla SCO, alla CSTO e all’UEE per evitare che una di esse domini, preservando così un equilibrio inter-organizzativo;
-L’azione collettiva (esercitazioni militari congiunte), la promozione di standard istituzionali e l’allargamento sono tutti strumenti utilizzati dalla SCO per raggiungere un equilibrio flessibile dell’influenza occidentale nella regione;
La struttura della SCO, che favorisce il multiallineamento, evidenzia l’importanza delle CAP all’interno dell’organizzazione. Il loro ruolo è importante per la Cina e la Russia, poiché è essenziale per creare un clima di fiducia. In cambio, essi apprezzano la possibilità, nonostante le loro modeste dimensioni, di impegnare le due grandi potenze ;
-Questi meccanismi di bilanciamento sono stati ulteriormente rafforzati dall’adesione dell’India, terza potenza dell’Eurasia, nel 2017, compromettendo ulteriormente qualsiasi ambizione egemonica tra i suoi membri.
Poiché la SCO è definita un’organizzazione di sicurezza non tradizionale, la cooperazione militare non è un elemento centrale del suo approccio alla sicurezza nella lotta contro i “tre flagelli”. Tuttavia, non va sottovalutato il valore delle esercitazioni militari e antiterrorismo congiunte, che restano un meccanismo estremamente importante per gli Stati membri per la funzione simbolica e pratica che svolgono. In particolare, sono espressione del desiderio di autonomia della sicurezza regionale, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti, di cui non vogliono vedere il ritorno in Asia centrale dopo la loro partenza dall’Afghanistan nel 2021. Sono anche una vetrina molto concreta del loro impegno nella lotta al terrorismo (SONG, 2016), che può avere un effetto dissuasivo sui primi interessati. Da un punto di vista più pratico, in quanto meccanismo di sicurezza periodico[19] e istituzionalizzato, costituiscono una piattaforma per lo sviluppo di capacità antiterroristiche e di difesa regionale congiunta, oltre che un indiscutibile vettore di fiducia reciproca. In particolare, contribuiscono allo sviluppo di capacità operative, di spedizione e di interoperabilità, aumentando così il potere assoluto degli Stati membri.
La ricerca di visibilità e stabilità internazionale è anche una delle ragioni che spingono gli Stati partecipanti ad aderire alla proposta della SCO, percepita come un veicolo di rappresentanza e visibilità a livello interorganizzativo regionale e internazionale. Dal 2004, ciò si è tradotto nella graduale creazione di una rete di cooperazione e partenariato con diverse organizzazioni multilaterali, tra cui l’ONU e l’ASEAN.
Infine, l’aspirazione alla stabilità rimane un leitmotiv dei Paesi fondatori: la stabilità del vicinato e la priorità nazionale della stabilità interna si riecheggiano per la Cina, il concetto di ” arco di stabilità ” nella regione nord-eurasiatica per gli esperti e i decisori russi, o il ruolo di ” poli di stabilità ” svolto da Russia e Cina agli occhi della PAC.Insieme alla sicurezza, è una precondizione e una garanzia dello sviluppo economico regionale.
Conclusioni
Si può quindi constatare che le aspirazioni, il funzionamento e le dinamiche interne della SCO, pur rispondendo in modo molto pragmatico a interessi ben comprensibili, non sembrano devolversi in una ricerca di ottimizzazione sfrenata del potere, come prescriverebbe il realismo offensivo. Al contrario, essi incorporano la ” indivisibilità della sicurezza ” nel loro software, sostituendo a ogni possibile pax egemonica o ” peacebuilding ” ex nihilo più idee cardinali di stabilità e resilienza. Inoltre, è probabile che il mondo multipolare che emerge sia destinato, almeno temporaneamente, a oscillare tra due tendenze opposte. Da un lato, avremmo i sostenitori incrollabili di un realismo offensivo fino all’estremismo (compreso l’Occidente, fratturato dalle sue contraddizioni interne[20]), e dall’altro il partito di coloro che hanno compreso i limiti di questa dottrina divenuta dogma. Questi ultimi cercheranno, in uno spirito di lucido realismo e di fronte all’assenza di qualsiasi prospettiva auspicabile che essa offra nel medio-lungo termine, di uscirne a poco a poco esplorando un approccio alternativo alla sicurezza attraverso la costituzione di una comunità di interessi che dia priorità alla ricerca della stabilità. Ciò non è affatto improbabile se si conferma il quinto postulato del realismo offensivo, che prevede che le grandi potenze siano attori razionali. Le ripetute osservazioni di J.D. Vance sull’avvento di un ordine mondiale multipolare come nuova realtà del sistema internazionale e sulla natura obsoleta dell’interventismo americano vanno in questo senso. E riecheggiano le parole di A. Bezrukov[21] sull’imperativo di riprendere il dialogo strategico tra grandi potenze e sulla necessità di dare una risposta collettiva alla domanda : ” Dove vogliamo andare ? “.
Bibliografia
ARIS Stephen, “Regionalismo eurasiatico: l’organizzazione di cooperazione di Shanghai”, p.88, Palgrave MacMillan, New York, 2011.
ARRIGNON, Jean-Pierre, ” L’OCS : une institution eurasiatique puissante et efficace “, revuepolitique.fr, 26 aprile 2017, URL : https://www.revuepolitique.fr/locs-une-institution-eurasiatique-puissante-et-efficace/, consultato il 15 agosto 2024.
BAILES, Alison J.K., COTTEY, Andrew, “Regional security cooperation in the early 21st century”, SIPRI Year book 2006: Armamenti, disarmo e sicurezza internazionale, pp. 195-223.
BAILES, Alison J.K., PAN, Guang et al, “The Shanghai Cooperation Organization”, SIPRI Policy Paper No 17, maggio 2007, URL: https://www.sipri.org/publications/2007/sipri-policy-papers/shanghai-cooperation-organization, visitato il 16 agosto 2024.
BLACKWOOD Maria A. et al, “Central Asia: Implications of Russia’s war in Ukraine”, p22, Congressional Research Service (CRS), crsreports.congress.gov, 9 giugno 2023, URL: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47591.
BRZEZINSKI, Zbigniew, Le Grand Échiquier : l’Amérique et le reste du monde, Bayard éditions, Parigi, 1997.
DORY, Daniel, “L’antiterrorisme en perspective historique : quelques éclairages récents “, Sécurité globale 2021/3 (n. 27), pagine 189-199, URL : https://www.cairn.info/revue-securite-globale-2021-3-page-189.htm&wt.src=pdf , consultato il 12 aprile 2024.
GARRIDO, Cédric, ” Méprises autour de l’OCS et remise en perspective “, iris-france.org, gennaio 2025, URL : https://www.iris-france.org/meprise-autour-de-lorganisation-de-cooperation-de-shanghai-ocs-et-remise-en-perspective/
KIRTON J., LARIONOVA M., “Contagiosa cooperazione cumulativa convergente: lo sviluppo dinamico del G20, dei BRICS e della SCO”, p.17, Int Polit (2022). URL: https://doi.org/10.1057/s41311-022-00407-7, consultato il 12 aprile 2024.
KISSINGER, Henry, Diplomatie, Fayard, 1996
LEHNE, Stefan, “REVIVING THE OSCE: European Security and the Ukraine Crisis”, Carnegie Endowment for International Peace, jstor.org, 1 settembre 2015, URL: http://www.jstor.org/stable/resrep12952, visitato il 15 agosto 2024.
LEVYSTONE, Michaël, ” Gli Stati Uniti in Asia centrale : un ritorno di breve durata ? “, Foreign Policy, 2023/1 (primavera), pp. 151-160. URL : https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2023-1-page-151.htm, consultato il 15 agosto 2024.
LUKIN, Alexander V., KASHIN, Vasily B., Rossiysko-kitayskoye sotrudnichestvo i bezopasnost’ v ATR (Cooperazione russo-cinese e sicurezza nella regione Asia-Pacifico) // Comparative Politics Russia, 2019, n. 2, pp. 135-151.
MEARSHEIMER, John J. The Tragedy of Great Power Politics. WW Norton, New York, 2014.
MUKHTOROVA, Uguloy. “Central Asia and NATO against a Backdrop of Changing Geopolitical Realities”, NATO Defense College, 2018.
OLIKER, Olga e SHLAPAK David A., Interessi degli Stati Uniti in Asia centrale: Priorità politiche e ruoli militari. Santa Monica, CA : RAND Corporation, 2005. URL : https://www.rand.org/pubs/monographs/MG338.html , consultato il 12 aprile 2024.
RUMER Eugene et al., “U.S. Policy Toward Central Asia 3.0”, p.3, carnegieendowment.org, 25 janvier 2016, URL : https://carnegieendowment.org/research/2016/01/us-policy-toward-central-asia-30?lang=en, consulté le 13 mai 2025.
SONG, Weiqing, L’approccio della Cina all’Asia centrale: The Shanghai Cooperation Organisation, Routeledge, New York, 2016, 184 pagine.
ŠĆEPANOVIĆ Janko, “L’Organizzazione della cooperazione di Shanghai e la Russia”, p.2, PONARS Eurasia Policy Memo n. 845, maggio 2023.
STONIS, Danylo., “Analisi comparativa della strategia dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e dell’Unione europea sull’Asia centrale: Confronto o cooperazione?”, Annuario polacco di scienze politiche, vol. 52(1) (2023), pp. 69-90, https://doi.org/10.15804/ppsy202230
ÜNALDILAR KOCAMAZ S., “The Rise of New Powers in World Politics”, p.134, Uluslararası İlişkiler / International Relations, Vol. 16, No. 61 (2019), pp. 127-141
VOROBYOV Vitaly, “Come elevare l’organizzazione più promettente dell’Eurasia a un nuovo livello”, Russia in Global Affairs, eng.globalaffairs.ru, Janvier 2012, URL: https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-sco-as-a-rising-master-of-the-heartland/, consultato il 16 août 2024.
TEURTRIE David, Russie : Le Retour de la Puissance, Armand Colin, Malakoff, 2021.
WOLFF, Stefan et al., ” L’OSCE e l’Asia centrale: Options for engagement in the context of the crisis in Afghanistan and the war in Ukraine”, osce-academy.net, 24 février 2023, URL : https://osce-network.net/file-OSCE-Network/Publications/OSCE-CA-2023.pdf, consulté le 15 août 2024.
Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, “Carta dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai”, eng.sectsco.org, 2002, URL: https://eng.sectsco.org/documents/?year=2002, consultato il 23 maggio 2025.
[1] Nato nel 1947 a New York, John J. Mearsheimer è professore di scienze politiche all’Università di Chicago dal 1982 e influente pensatore della scuola realista di geopolitica.
[2] MEARSHEIMER, John J. The Tragedy of Great Power Politics. WW Norton, New York, 2001.
[3] Si vedano a questo proposito le opere di Zbigniew Brezinski La Grande Scacchiera o di Henry Kissinger Diplomazia.
[4] Che fondamentalmente non lo sono, vedi GARRIDO Cédric, ” Méprises autour de l’OCS et remise en perspective “, iris-france.org, gennaio 2025, URL : https://www.iris-france.org/meprise-autour-de-lorganisation-de-cooperation-de-shanghai-ocs-et-remise-en-perspective/
[5] Corrispondono alle tre zone che ospitano gli “attori chiave” identificati all’epoca da Brzezinski, ossia la zona occidentale (penisola europea), la zona meridionale (Caucaso, Medio Oriente, Golfo Persico, Asia meridionale) e la zona orientale -meno la Cina- (prima catena di isole: Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Filippine, Cambogia, Thailandia).
[6] Basi a Karshi-Khanabad (Uzbekistan) e Manas (Kirghizistan).
[7] Interferenze ritenute responsabili della Rivoluzione delle Rose in Georgia (novembre 2003), della Rivoluzione Arancione in Ucraina (novembre 2004), della Rivoluzione dei Tulipani in Kirghizistan (marzo 2005) e della Rivolta di Andijan (Uzbekistan, maggio 2005).
[8] Non è stato possibile votare un bilancio unificato dal 2023, né pubblicare un rapporto annuale dal 2021.
[9] Gli Stati membri della SCO enfatizzano la non interferenza e danno priorità alla loro stabilità interna e a quella dell’ambiente circostante, in un contesto di convinzione della necessità di sviluppare capacità militari e risposte statali forti. Mentre l’agenda occidentale promuove la democratizzazione e l’intervento umanitario.
[10] Un’altalena che il discorso di Putin alla conferenza di Monaco del 2007 non fa che sottolineare.
[11] I BRICS si allontanano dalle istituzioni di Bretton Woods per ovvie ragioni di sicurezza e stabilità finanziaria dopo la crisi del 2007-2008.
[12] Rispetto al sistema multipolare senza egemone e al sistema bipolare.
[13] Edward H. Carr (1892-1982) : storico, diplomatico e giornalista britannico, autore di The Twenty Years’ Crisis: 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations, considerata una delle opere standard del realismo classico.
[14] “Data la difficoltà di determinare quanto potere sia sufficiente per l’oggi e per il domani, le grandi potenze riconoscono che il modo migliore per garantire la loro sicurezza è raggiungere l’egemonia ora, eliminando così ogni possibilità di sfida da parte di un’altra grande potenza” (Mearsheimer, 2001). Ciò che il livellamento dei differenziali di potere tra le grandi potenze non consente più.
[15] “[…] spirito di fiducia reciproca (互信), vantaggio reciproco (互利), l’uguaglianza (平等), consultazioni reciproche (协商), il rispetto della diversità culturale (尊重多样文明) e l’aspirazione allo sviluppo congiunto (谋求共同发展)”.
[16] Questi concetti derivano da norme internazionali modificate (i cinque principi di coesistenza pacifica enunciati da Zhou Enlai nel 1953), o si ispirano a lavori accademici stranieri (il concetto di sicurezza settoriale della Scuola di Copenhagen). Si noti che il Nuovo concetto di sicurezza è stato proposto per la prima volta dalla Cina al forum dell’ASEAN nel marzo 1997.
[17] Cfr. il continuo approfondimento del partenariato sino-russo dalla metà degli anni ’90 e la quantità di documenti ufficiali bilaterali che lo testimoniano.
[18] Le preoccupazioni russe per il potenziamento militare della Cina sono mitigate dal rapporto di fiducia esistente ai confini e dalla priorità politica e militare della Cina di espansione marittima (LUKIN, 2019).
[19] La prima esercitazione bilaterale congiunta è stata condotta da Cina e Kirghizistan nel 2002. La prima esercitazione bilaterale sino-russa (Peace Mission) si è svolta nel 2005, dopo gli eventi di Andijan. La prima esercitazionemultilaterale (Missione di pace) che ha coinvolto tutti i membri della SCO è stata condotta nel 2007. La più recente esercitazione congiunta antiterrorismo (Interazione 2024) ha coinvolto tutti i 10 Paesi membri.
[20] L’Unione Europea, nel suo epidermico rifiuto della nuova presidenza Trump e nella sua irragionevole ostinazione a voler sconfiggere la Russia in Ucraina, assume così a pieno titolo il ruolo di portabandiera dei democratici neoconservatori del continente eurasiatico, la cui sconfitta è amara e per i quali c’è da sperare in vari e svariati tentativi di sovvertire e riconquistare il potere.
[21] Professore del Dipartimento di Analisi Applicata delle Questioni Internazionali presso l’Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO), ex ufficiale dei servizi segreti, autore.