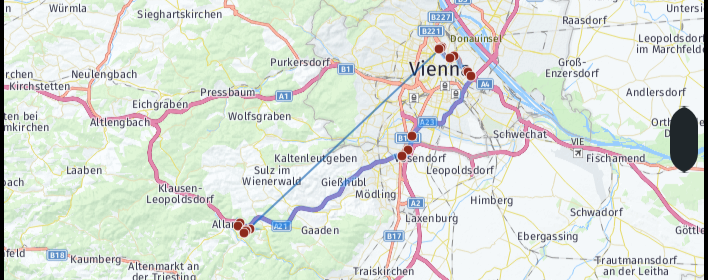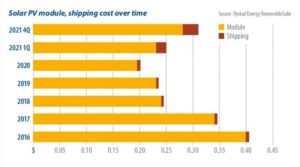FEDERALISMO E UNITÁ POLITICA (pubblicato nel 2008)
1. Nella prima metà del XIX secolo due grandi pensatori europei, Hegel e Tocqueville si posero il problema di come potesse conservarsi uno Stato federale, come gli Stati Uniti d’America, senza che l’Unione godesse di tutti quei poteri che il “centro” delle monarchie europee – cioè il governo monarchico – aveva nel proprio territorio,
Scriveva Hegel:
“Se paragoniamo poi l’America del nord con l’Europa, troviamo laggiù l’esempio costante di una costituzione repubblicana. Cioè l’unità soggettiva, perché vi è un presidente a capo dello Stato, eletto, per prevenire ogni possibile ambizione monarchica, solo per quattro anni. La protezione universale della proprietà e la quasi totale assenza d’imposte sono fatti che vengono continuamente elogiati. Ma con questo è già determinata anche la caratteristica fondamentale di questi Stati. Essa consiste nella tendenza del privato all’acquisto e al guadagno, nella prevalenza dell’interesse particolare, che si volge all’universale solo in servigio del proprio godimento. Vi sono, naturalmente, rapporti di diritto, ed una formale organizzazione giuridica: ma questa conformità al diritto è senza dirittura, e così i commercianti americani hanno la cattiva riputazione di ingannare sotto la protezone del diritto”, e prosegue “l’America del nord non va considerata come uno Stato già formato e maturo ma come uno Stato tuttora in divenire: esso non è ancora tanto progredito, da aver bisogno della monarchia. E’ uno Stato federativo: ma questi, per quel che concerne i loro rapporti con l’estero, sono gli stati peggiori. Solo la sua particolare posizione ha impedito che questa circostanza non causasse la sua totale rovina. Ciò si è visto nell’ultima guerra con l’Inghilterra. I Nord-americani non poterono conquistare il Canadà, e gli Inglesi poterono bombardare Washington, perché la tensione fra le provincie impedì ogni vigorosa azione. Inoltre, gli stati liberi nordamericani non hanno nessuno stato confinante, rispetto a cui siano nella situazione in cui gli stati europei sono reciprocamente, uno stato cioè che debbano considerare con sospetto e contro cui debbano mantenere un esercito stanziale. Il Canadà e il Messico non incutono loro timore, e l’Inghilterra ha fatto ormai esperienza da cinquant’anni che l’America le è più utile libera che dipendente”i.
Quindi da un lato Hegel connetteva la forma istituzionale dello Stato federale alla prevalenza, negli USA, del “privato” sul “pubblico” dall’altro, e più ancora, all’assenza di nemici “credibili” ai confini che consentiva di mantenere un governo debole. Considerazioni simili, e nello stesso periodo di tempo, faceva Tocqueville nella “Démocratie en Amérique”.
Sosteneva Tocqueville: “La più importante di tutte le azioni che possono far riconoscere la vita di un popolo è la guerra. Nella guerra un popolo agisce come un solo individuo di fronte a popoli stranieri: esso lotta per la sua stessa esistenza… Di qui deriva che tutti i popoli, che hanno dovuto sostenere grandi guerre, sono stati condotti, quasi loro malgrado, ad accrescere le forze del governo. Quelli che non sono riusciti a farlo, sono stati conquistati. Una lunga guerra pone quasi sempre le nazioni in questa triste alternativa, che la loro disfatta li consegna alla distruzione, e la loro vittoria al dispotismo.
Perciò, in genere, è in guerra che si rivela, nel modo più visibile e pericoloso, la debolezza di un governo; e ho mostrato come il difetto inerente ai governi federali sia appunto quello di essere molto deboli.
Nel sistema federale, non solo non c’è affatto accentramento amministrativo o qualcosa di simile, ma lo stesso accentramento politico esiste solo in modo incompleto; e questo è sempre una grave causa di debolezza, quando ci si deve difendere contro popoli nei quali è completo”. E ad esempio ricorda lo stesso episodio storico: la guerra con l’Inghilterra bel 1812ii.
Ambedue i pensatori si sono (forse) ispirati a quanto pochi anni prima, aveva cennato De Maistre sulle istituzioni europee ed inglesi in particolareiii.
Per cui la particolare conformazione della Costituzione e del diritto pubblico inglese era ricondotto, in gran parte, alla situazione geo-politica dell’Inghilterra: in analogia con Hegel e Tocqueville per l’America.
D’altro canto il rapporto tra sovranità all’esterno ed all’interno era considerato da Hegel anche nei Grundilinieniv.
2. Peraltro Hegel sottolineava il carattere politico – in quel senso . – del rapporto tra assetto interno e esterno (nemico e guerra), e lo distingueva da un mero decentramento amministrativo. Nell’opera giovanile Verfassung Deutschlands già lo scriveva, in relazione alla “costituzione” dell’Impero tedesco. Sosteneva a dimostrazione della tesi iniziale “La Germania non è più uno Stato” che “Il potere legislativo, quello giudiziario, quello spirituale, quello militare, mescolati nella maniera più disordinata e in parti le più disuguali, sono separati e congiunti, proprio variamente come la proprietà dei privati.
Attraverso dimissioni della Dieta, trattati di pace, capitolazioni elettorali, contratti domestici, deliberazioni della Corte suprema, ecc. la proprietà politica di ciascun membro del corpo statale tedesco è determinata nel modo più accurato”v, per questo ha il diritto di andare in rovinavi. Sosteneva peraltro che l’unità dello Stato non è data dall’uniformità del dirittovii né della religioneviii; ma l’essenziale per aversi uno Stato è che “una moltitudine di uomini si può chiamare uno Stato soltanto se è unita per la comune difesa della sua proprietà in generale” e “L’allestimento di questa effettiva difesa è la potenza dello Stato; esso deve da un lato essere sufficiente a difendere lo Stato contro i nemici interni ed esterni, dall’altro a mantenere se stesso contro l’impeto universale dei singoli”ix.
Le argomentazioni di Hegel e Tocqueville, comuni ad altri pensatori, si possono riassumere nei seguenti punti:
Che l’assetto dei rapporti o poteri pubblici – cioè la forma politica – è condizionata dalla situazione geo-politica, e, in particolare, dai nemici e dalle guerre possibili.
Che a costituire l’unità politica non è la comune religione, la lingua, e neanche le leggi ed i costumi o i commerci (cioè fattori in se non riconducibili al politico, anche se rilevanti, e spesso assai rilevanti, sul politico), ma è l’unità del popolo sotto un governo.
Che, quindi, ciò che rende debole il governo non è tanto la diversità di legge o di religione, costumi – spesso, si può aggiungere, “superata” grazie al federalismo o al decentramento – ma la divisione del potere politico. Per definire il quale occorre distinguerlo da quello non politico, ancorché pubblico: e in entrambi il criterio di distinzione è, per l’appunto, la guerra, cioè il rapporto estremo con l’hostis. È questo che può porre in gioco l’esistenza della comunità organizzata in Stato, così costituire l’extremus necessitatis casus ed essere la cartina di tornasole della vitalità di uno Stato.
Che, potenzialmente – le diversità ed i gruppi di interesse che sussistono in ogni comunità umana possono, nelle situazioni di crisi, se prevalenti, mettere in forse l’unità politica (e la capacità di difendersi). Se queste così diventano decisive, passano dal privato al pubblico – o meglio al politico (come gli interessi dei mercanti del Massachussets e del Connecticut nella guerra con l’Inghilterra).
3. La progressiva “tecnicizzazione” del diritto pubblico, cui probabilmente ha contribuito non solo il clima generale – di “onnipotenza normativa” – ma anche la specializzazione accademica, ha fatto si che quei rapporti, sopra elencati, tra situazione concreta e forma politica, fossero smarriti e, quel che più conta espunti dalle concezioni (e trattazioni) del diritto pubblico.
Ciò è stato l’effetto di due idola theatri diffusisi negli ultimi secoli.
In primo luogo l’onnipotenza del legislatore o (meglio ancora), del potere costituente. La frase di Sieyès, ricalcata da Rousseau, che la Nazione è “tutto ciò che può essere per il solo fatto di esistere” è stata, a dir poco, mal interpretata. Un sottile politico come Sieyès, oltretutto largamente tributario nelle sue concezioni della teologia cristianax non avrebbe mai pensato di poter prescindere nella fase “costituente” da ogni riferimento concreto e reale, a partire dalla situazione geopolitica, passando per i condizionamenti (e le determinanti) storici e naturali, per finire, in certi casi, alle leggi di “natura”, intendendole se non nel senso dell’ironia di Spinozaxi, come quelle della storia.
Ancora nell’insegnamento di Montesquieu lo “spirito” delle leggi (e a maggior ragione delle costituzioni) erano quei “rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose”xii, e capire le leggi, penetrarne lo “spirito”, era capire quei rapporti concreti e reali; onde, tra l’altro, scriveva che le leggi sono adatte al popolo che le ha “sviluppate” e non ad un altro.xiii Tutto il contrario quello che avvenne dopo, a partire dal tardo illuminismo fino all’età post-rivoluzionaria.
Ironizzava de Maistre che nel secolo XVIII ogni giovane acculturato, appena diplomato, aveva scritto almeno un trattato sull’educazione, una costituzione e un mondo. Incominciò a diffondersi non solo l’immagine del legislateur provvido e onnipotente, ma pure che all’onnipotenza (in diritto) del sovrano corrispondesse, in qualche misura, quella di fatto: la comunità politica era così considerata la materia da plasmare a piacimento dal legislateur. Tradizioni, costumi, condizionamenti politici, culturali e sociali erano conformabili a discrezione: la retta ragione e la bontà dei fini avrebbero creato istituzioni razionali, condivise e legittimate dal consenso generale di esseri razionali (nel senso dell’illuminismo). Gli sviluppi successivi, dalla Vandea agli insorgenti italiani ai guerrilleros spagnoli dimostrarono che la questione non era così semplice, ma il sogno utopico di costruire una società senza rispondenza alle situazioni (e ai problemi) concreti continuò; in particolare inverandosi nell’utopia radicale del marxismo collassato in pochi decennixiv.
Pertanto l’idea di poter elaborare costituzioni a tavolino (diversamente da quanto pensava Cicerone che fondava la superiorità politica di Roma sulla sua costituzione perché frutto delle esperienze e del lavoro di tante generazioni) sopravviveva e si sviluppava, anche per ragioni scientifiche, anche in un ambiente diverso: quello dei giuristi. Levatrice di ciò è stato, in gran parte, l’ideale “avalutativo” della scienza e, del pari, l’idea che, per il giurista interpretare tenendosi distante da tutto ciò che è politico (anche quando, come nel caso, l’oggetto – da studiare – è politico) è la via migliore per essere scientificamente “oggettivi”.
A leggere un manuale di diritto costituzionale o internazionale del periodo del positivismo affermato (cioè da metà del XIX secolo) i presupposti e i condizionamenti politici dell’assetto costituzionale sono di solito appena cennati; ciò che assume rilievo, pressoché esclusivo, è il dato positivo dell’elaborazione della costituzione in (un) atto organico, che il giurista può interpretare a guisa di un super codice. Come se le costituzioni fossero parti dei giuristi che contribuivano a stenderle (su carta). In questo orizzonte, largamente se non totalmente prevalente, la nota forse più stonata fu quella di Lassalle – non a caso un politico e non un giurista – che in una celebre conferenza formulava il concetto (moderno) di costituzione materiale, contrapponendolo a quel “pezzo di carta” (cioè i testi considerati dai giuristi) la cui funzione principale è, secondo Lassalle, di formulare e confermare i rapporti di forze realixv.
L’altro fatto rivelatore del mutato spirito è che se, ancora nel ‘700, si cercava lo “spirito” delle leggi, e la “forma” (in senso aristotelico-tomista, e non procedurale) dello Stato, col positivismo dalla forma – come oggetto d’interesse prevalente – si passa alle norme. Funzione del giurista è d’indagare sulle norme e su come si possa ricostruire l’unità di un sistema partendo dalle norme. Invece nel ‘700 un giurista come Vattel costruiva un sistema di diritto (interno ed internazionale) basandosi sulla forma: guerre in forma, soggetti (del diritto internazionale) in forma, rapporti formali.
Nel rapporto tra diritto interno ed internazionale il raccordo tra le due sfere (interna ed esterna) non si regge più sulla forma della struttura statale pubblica, ma si ricorre ad armamentario ed a principi e concetti propriamente giuridici. Scrive Triepel in un’opera “classica” sulle relazioni tra diritto interno e diritto internazionale: “La natura delle relazioni intercedenti fra questo diritto ed il diritto internazionale può essere molto varia. Vi possono essere norme di diritto interno la cui esistenza ovvero il cui contenuto dipende da norme di diritto internazionale; può darsi che le prime tutelino anche dalle seconde; le dette norme talora operano con concetti che si possono chiamare “di diritto internazionale”; di tutto ciò non mi è dato far qui che un semplice cenno, poiché sono appunto queste relazioni che dovremo esaminare minutamente nelle pagine che seguono”xvi. Per ricostruire queste relazioni tra norme è centrale il concetto d’ “impenetrabilità” dello Stato ( e cioè il monopolio territoriale della decisione su ciò che debba essere diritto – un elemento della forma-Stato) come di “recezione” o di “rinvio”. E’ chiaro tuttavia che impenetrabilità, rinvio, recezione presuppongono una struttura – una forma – dello Stato in grado in fatto prima che in diritto di “chiudere” il proprio territorio ad ogni potere esterno. Cioè (in primo luogo) eserciti stanziali e permanenti, flotte, efficienti difese delle frontiere e delle coste: strumenti per assicurare il monopolio della decisione politica e della forza legittima (e di conseguenza, anche se meno rilevante, del diritto applicato).
Ed è tale forma che garantisce non solo l’impenetrabilità, ma anche l’osservanza, ad esempio del diritto internazionale (cioè del diritto esterno): una tribù o anche uno Stato feudale ha probabilità assai minore di assicurare l’applicazione delle norme di un trattato internazionale di quanto ne abbia uno Stato moderno, anche un po’ malmesso come la Repubblica italiana. In uno Stato “fallito” (come ad es. la Somalia) la possibilità di far osservare il diritto internazionale (ed anche quello “interno”) è minima. Il tutto conferma l’immagine con cui Santi Romano sintetizzava il rapporto tra ordinamento e norme paragonando il primo al giocatore di scacchi, le seconde alle pedine mosse dallo stesso.
Ciò che è evidente è che quel rapporto tra norme è possibile solo se i soggetti tenuti ad applicarle hanno una forma ed esercitano un potere effettivo senza i quali il rapporto tra interno ed esterno può anche essere giuridicamente regolato e valido, ma è del tutto inutile. All’inizio del secolo scorso Schmitt, Hauriou e Santi Romano invertirono i termini del problema: è l’unità dell’ordinamento (l’istituzione) a dare unità al sistema normativo e non l’inverso.
4. Ad applicare alla situazione del mondo (contemporanea) le tesi desunte da Hegel e Tocqueville ne derivano conseguenze interessanti.
In primo luogo che a costituire una federazione, non è tanto necessaria l’omogeneità culturale delle comunità federate, ma l’unità politica. Ne deriva che la costituzione di super-Stati (differenti su tutto) sarebbe possibile ove vi fosse una effettiva unità politica. Dato che il criterio di quell’unità sono per l’appunto il monopolio della decisione sul nemico e la guerra (e la competenza a identificare il primo e dichiarare la seconda), ne consegue che occorre che la federazione per essere tale e non una mera unione di Stati anche se molto vicini culturalmente (come l’Unione europea), deve avere il monopolio dell’una e dell’altraxvii.
Pensare di realizzare un’unità di Stati, senza politico, è fermarsi all’anticamera dell’unità, senza raggiungerla mai.
Del pari l’entusiasmo politicamente corretto che accompagna ogni nuova istituzione, Ente, Tribunale purchè internazionale (Sabino Cassese ne ha contati oltre duemila) è mal speso e non vale a promuovere l’unità politica. Fin quando lo jus belli e le forze armate apparterranno agli Stati (e, in certi casi, ai movimenti di guerriglia) che vi siano Tribunali, agenzie (e monete) internazionali potrà essere edificante e spesso anche utile, ma non costituisce un fatto politico decisivo e tantomeno impedirà la guerra.
Neppure l’unità del diritto serve a produrre l’unità politica. A parte che per unificazione del diritto per lo più s’intende quello privato (o comunque non politico), è indubbio che una omogeneizzazione della normativa applicabile può essere d’aiuto agli scambi internazionali. Ciò che viene meno notato è come il diritto pubblico, e in particolare quello per essenza politico, non è oggetto di quasi nessun intervento. Si emanano norme e sottoscrivono trattati per i titoli di credito, società, strumenti finanziari e così via, ma non ci risulta che l’U.E. (ad esempio) abbia mai dato direttive sui poteri dei parlamenti, sulle competenze delle regioni degli Stati membri, sulle leggi elettorali, tanto meno sulla competenza a dichiarare la guerra. L’unico ambito del diritto pubblico su cui vi sia qualche normazione “internazionale” (oltre a quello amministrativo) è quello penale. Ma è troppo poco – e troppo evanescente – perché possa inficiare la regola che si omogeneizza il diritto privato ma non quello pubblico. Proprio perciò politicamente l’ “omogeneizzazione” giuridica è poco (o del tutto) irrilevante; per il suo carattere non-politico investe quello che Hauriou chiamava il diritto comune (Dike), contrapponendolo al diritto disciplinare (Thémis)xviii: il primo esterno ai gruppi (sociali), ai clan e alle famiglie e aggiunge “noi diremmo, oggigiorno, internazionale”xix,il secondo interno a quelli.
Per cui la (comune) Dike non serve a mutarla in Themis e tantomeno a farla trasformare in qualcosa di politicamente decisivo. Piuttosto il confondere gli indubbi vantaggi che sul piano economico (degli scambi) e anche per altri ambiti dell’esistenza umana (aventi carattere privato) può avere l’omogeneità giuridica significa non percepire la peculiarità del politico e la distinzione tra pubblico e privato.
5. Un’altra considerazione occorre dedicare al problema in che modo i principi sopra ripetuti possano operare in un contesto che non è più quello “classico” degli Stati moderni (o dei di essi “tipi” come quello federale).
I “tipi” di relazioni con cui le unità politiche possono limitare la sovranità e/o l’indipendenza nella produzione ed applicazione del diritto sono diversi.
In particolare, se, come scrive Schmittxx “la federazione è un’associazione permanente, che serve al comune fine di autoconservazione politica di tutti i membri della federazione”, occorre considerare anche quei tipi di rapporti non riconducibili ad una federazione (o ad uno Stato federale).
Fatta questa premessa, occorre distinguere tra limitazioni alla sovranità, e limitazioni all’indipendenza.
Tra le limitazioni alla sovranità, tra la fine della seconda guerra mondiale a oggi, ve ne sono state (frequenti), anche a quella interna non riconducibili a quei rapporti e modelli già conosciuti e “classici” (ad esempio il protettorato). Caso clamoroso quello del quale fu “esternata” la dottrina della “sovranità limitata” degli Stati aderenti al “Patto di Varsavia”. Ma una menzione particolare (anche per gli effetti) compete alla Dichiarazione di Yalta sull’Europa liberata dove, tra le molte limitazioni enunciate v’è la seguente “Nel momento in cui, secondo l’opinione congiunta dei tre Governi, le condizioni di uno degli Stati Europei liberati o di quelli satelliti dell’Asse Europeo imponessero di intervenire, i suddetti tre Governi si consulteranno immediatamente tra loro per stabilire le misure necessarie da adottare e adempiere così agli obblighi previsti da questa dichiarazione”.
Il senso e gli effetti di tale dichiarazione sono chiari: i vincitori si riservavano il diritto d’intervento all’interno dei singoli Stati occupati, diritto ovviamente indefinito nei presupposti e nel contenuto (delle misure) e quindi determinabile a discrezione degli Stati vittoriosi : tale affermazione costituisce una limitazione alla sovranità interna, quella cioè che in molti Stati membri di una federazione, compete di solito ai medesimi e non alla federazionexxi.
Diversamente da una federazione le limitazioni alla sovranità come quelle sopra ricordate non comportano la garanzia dell’esistenza politica e della sicurezza degli Stati (federati), che Schmitt ritiene una delle conseguenze del “contratto federale”xxii.
Mentre nel patto costitutivo della federazione c’è ancora un “sinallagma” come garanzia di protezione (e obbedienza) che giustifica anche la forma “pattizia” o “contrattuale”, nelle dichiarazioni di Yalta tutto si risolve nella volontà dei vincitori (quindi egemoni in forza della vittoria e della conseguente occupazione militare) i quali dettano le condizioni di sviluppo politico degli Stati occupati, si riservano la facoltà di interpretarle/applicarle e di intervenire di conseguenza.
Non meraviglia che con la firma dei trattati di pace alcune limitazioni alla sovranità (interna) divenissero clausole del trattato stesso, come notò Vittorio Emanuele Orlando nel discorso alla Costituente contro l’approvazione del trattatoxxiii. Ciò non esclude che con un Trattato possano accordarsi quelle garanzie: tuttavia mentre nel caso della federazione ineriscono alla natura dello stesso e sono, come scrive Schmitt, la conseguenza dell’esistenza associata sia degli Stati membri che dello Stato federalexxiv, nel caso del trattato dipendono totalmente dalla volontà degli Stati contraenti (e sono soggette alle riserve comuni a tutti i trattati).
Spesso connesse alle limitazioni alla sovranità vi sono quelle all’indipendenza nell’esercizio del potere normativo o in quello di “polizia” e giudiziario. La recente normativa internazionale finalizzata alla lotta al terrorismo ce ne offre diversi esempi in cui taluno, non senza fondamento, ravvisa la formazione di una sorta di controllo degli Stati Uniti sugli altri Stati del pianeta, sviluppantesi – e questo è il carattere “originale” – non tramite eserciti e occupazioni militari ma con forme di dipendenza delle burocrazie giudiziarie e amministrative degli Stati “soggetti” al potere “imperiale”xxv dello Stato-guida.
Il che costituirebbe una forma di egemonia esercitata in un’epoca in cui si fa un gran parlare di governance, termine che difetta di quella chiarezza e distinzione di solito comune alla terminologia del periodo statale “classico”.
6. È difficile definire un’impero. Il termine è stato applicato a tante diverse forme politiche, dall’impero persiano achemenide a quello romano, dal Sacro romano Impero a quelli coloniali degli Stati europei dalla Rinascenza al secolo scorso, solo per citare quelli più familiari alla nostra cultura.
Trovare forme e tratti comuni tra Dario e Carlo Magno non è facile: tuttavia un primo tentativo di delinearne i caratteri si può iniziare partendo dai connotati tipici e salienti dello Stato moderno e notare le differenze: delimitando cioè l’Impero, in modo negativo, da ciò che è Stato.
In primo luogo nell’Impero non vi è il monopolio della decisione politica e della violenza legittima, invece connotati fondamentali dello Stato moderno, come sostenuto da Max Weber e Carl Schmitt. L’individuazione/designazione del nemico e l’esercizio dello jus belli è distribuito tra il centro e le periferie dell’Impero.
L’Anabasi offre una rappresentazione di ciò che avveniva nell’Impero achemenide: Artaserse non percepisce come ostili i preparativi del fratello Ciro di muovergli guerra perché crede che lo stesso volesse far guerra a (un altro satrapo) Tissaferne e ciò oltre a sembrargli normale non gli dispiaceva “affatto che si facessero guerra tra loro”xxvi (probabilmente perché così erano troppo impegnati per farla a lui). Ciro, per raggiungere il centro dell’impero e combattere col fratello attraversa territori, ottenendo aiuti da una parte e combattendo dall’altra; lo stesso aveva giustificato la spedizione militare come rivolta contro i Pisidi, altri sudditi dell’impero Persiano; tutta la posizione e la politica di Tissaferne nei confronti dei mercenari greci in ritirata è dominata dalla preoccupazione che possano fargli guerra nei suoi domini di satrapo.
In altre parole né monopolio dello jus belli né una situazione di pace all’interno e guerra all’esterno (l’aspirazione/situazione “statale”) facevano parte della normalità dell’Impero persiano. Lo stesso per altri imperi, segnatamente per il Sacro Romano Impero e in genere la società feudale, dove le guerre tra vassalli, comuni, e di questi (e del Papa) contro l’Imperatore costituivano la situazione normale. Contrariamente a quanto accade anche negli Stati federali, lo jus belli non è monopolizzato dal centro; si ha una situazione simile a quella descritta da Grozio, quando distingue le guerre pubbliche da quelle privatexxvii.
La seconda distinzione, tipica dello Stato moderno, è quella “spaziale” tra interno ed esterno, che ha un connotato del tutto specifico il quale delinea due “status” o situazioni differenti e, in molti casi, opposti: quello tra ordinamento (e quindi diritto) interno ed esterno.
Quello interno si basa sul potere-dovere (e le correlative responsabilità, interna ed internazionale) di mantenere la pace (e l’ordine) all’interno dello Stato; a tale scopo la sovranità è irresistibile (c’è una volontà prevalente) dai poteri “interni” e ha quindi il potere (e il dovere) per mantenere la pace. All’esterno coesistono più unità politiche, in principio uguali (non c’è una volontà prevalente) e il mezzo per far valere, realizzare far riconoscere (e regolare) i propri diritti ed interessi è il trattato e, in caso di disaccordo, la guerra. Questa, che all’interno è in linea di principio vietata e considerata attività criminale, all’esterno dell’unità politica è, in linea di principio, legittima se esercitata tra Stati sovrani. In molti imperi non è così: il legame pace-interno e guerra-esterno non è netto: non c’è uno spazio pacificato, qualitativamente opposto a quello d’oltre confine. La distinzione è, al massimo, quantitativa: le guerre interne sono, per le forze relative dei contendenti, meno pericolose e dannose (ma non è sempre sicuro) di quelle esterne. Il confine tra interno ed esterno consegue a questa separazione netta: diversamente dalle società feudali (dove i rapporti di vassallaggio e i conseguenti diritti e doveri attraversavano i confini per cui il Re d’Inghilterra era vassallo – ed aveva propri vassalli – nel Regno di Francia), nello Stato moderno il confine significa l’esclusività e l’irresistibilità (all’interno) del potere sovrano che ne esclude ogni altro della stessa natura.
In terzo luogo il rapporto tra comando/obbedienza e il connesso dovere di protezione (quest’ultimo costituente, secondo Hobbes, il fondamento dell’obbligazione politica)xxviii: nello Stato la sovranità esclude che vi sia un rapporto comando/obbedienza tra i sudditi ed altri poteri che possa prevalere sullo stesso rapporto con lo Stato. Nell’impero ciò non appare definito, onde vi possono essere diversi rapporti, potenzialmente (e spesso in atto) conflittuali tra loro.
Nella società feudale si poteva essere vassalli di più signori e quindi obbligati alla fedeltà ad entrambi: in caso di conflitto politico, o di guerra tra i seniores, la situazione che ne derivava era, a dir poco, confusa. Anche il rapporto di protezione/obbedienza conseguentemente ne veniva incrinato.
Quanto alla sovranità, chiave dello Stato moderno, in conseguenza di quanto sopra, negli imperi non appare dotata dei connotati costruiti da alcuni secoli di dottrina dello Stato moderno. Dei quali, i più importanti sono: l’illimitatezza (o irresistibilità)xxix e la generalità nel senso che il sovrano è competente a provvedere su tutto e “giudice” di tutto, anche della propria competenza.
Il primo peraltro, come scriveva Romagnosi, è un carattere essenziale che distingue nettamente e qualitativamente la sovranità da ogni altro potere di comando (tutti in qualche modo limitati e resistibili); mentre il potere “imperiale” appare differire dagli altri poteri pubblici essenzialmente per dimensioni (spaziali) e per collocazione (sta “sopra” agli altri, ma essenzialmente è un primus inter pares), cioè per differenze “quantitative” (è più potente, non è illimitatamente potente).
Del pari il potere imperiale, nato generalmente come sovrapposizione a precedenti poteri e organizzazioni politiche, ha una competenza non generale, né è giudice della propria competenza (come nella società feudale).
Raymond Aron distingue di conseguenza tre tipi di pacexxx, e, correlativamente tre tipi di guerrexxxi, anche in relazione alla esistenza di imperi.
7. La lezione desumibile da Hegel e Tocqueville è quindi utilmente applicabile alla situazione contemporanea.
In primo luogo né il diritto, né l’economia (e neppure altri “ambiti” dell’esistenza umana, come la morale o l’arte) possono costituire ex se il fondamento per l’unità politica. Anzi nel pensiero di Hegel il privato (nei passi sopra citati rapportato all’attività economica) è una causa di dissoluzione dell’unità politica: è l’ordinamento privatistico (e patrimonialistico) dell’Impero germanico a determinarne la rovina, sì da soccombere a Napoleone. La stessa tendenza del privato “all’acquisto ed al guadagno, nella prevalenza dell’interesse particolare” è l’attitudine spirituale meno idonea a costituire e consolidare uno Stato; nei Grundinien des philosophie des Rechts il concetto viene ribaditoxxxii.
Neppure l’esistenza di un’amministrazione nè di una burocrazia (e di regole per il funzionamento dell’una e dell’altra) è, di per sé, decisivo per l’unità politica: l’utopia di Saint-Simon di sostituire al governo degli uomini l’amministrazione delle cose si rivela fallace anche in ambito “internazionale”. Il moltiplicarsi di Enti, istituti, funzionari internazionali non ha fatto progredire affatto la pace, né eliminato e forse neppure ridotto le guerre. La spiegazione l’aveva già data Tocqueville quando nel passo sopra citato parla di debolezza dello Stato federale in relazione all’accentramento amministrativo (non all’amministrazione in genere, men che mai “autonoma”, come va di moda).
È l’amministrazione accentrata cioè l’apparato burocratico gerarchicamente organizzato e dipendente dal vertice politico a costituire fattore e garanzia di unità. In altre parole è un’amministrazione organizzata intorno al “presupposto” del politicoxxxiii del rapporto di comando/obbedienza, (cioè a servizio di un potere politico), a poter realizzare lo scopo, e non una qualsiasi amministrazione, solo perché dotata di bolli, timbri e registri. Senza “governo” la burocrazia (di un potere razionale-legale) porta in se solo l’idea di “regola”, ma non quella, necessaria, di “coazione”.
E del pari sia Hegel che Tocqueville attribuiscono carattere decisivo alla guerra (ed all’esistenza – ed alla scelta – del nemico). E’ questo, se ne desume, anticipando Schmitt (o seguendo Hobbes) a rivestire carattere decisivo per l’unità politica – e per l’esistenza della medesima. E’ il rapporto tra interno ed esterno, forma istituzionale e situazione concreta, in particolare geo-politica, a modellarla come vitale; ciò fino a determinare, in molti casi, la scelta tra rafforzamento del governo (per esistere come unità politica) e perdita (o compressione) delle libertà sociali ed individuali, con ricaduta nel dispotismo.
Ove si costruisca un’unità politica superiore non si sfugge al “criterio del politico”, il quale è decisivo: federazioni o unioni di Stati costruiti su burocrazie zelanti e regolamentazioni economiche (e sociali) non sono unità politiche, proprio perché mille funzionari non fanno un buon esercito.
Quanto all’altro aspetto – dell’impero o meglio degli imperi prossimi venturi – appare sicuro che, per esistere politicamente, devono avere anch’essi quel carattere anche se – a differenza dello Stato – distribuito tra centro e periferia, e perciò non monopolizzato.
Le conseguenze della “costituzione” di un potere imperiale, cioè di un potere non esclusivo ma prevalente, oscillante tra mera superiorità ed egemonia, si intravedono già nelle “nuove forme” di guerra, site al confine (concettuale) tra operazioni di polizia e guerra (vera e propria), e spesso caratterizzate da un confronto tra una potenza enorme e proprio perché tale molto vulnerabile e potenze minime e di conseguenza quasi invulnerabili: costituenti il tipo ideale (ed estremo) della guerra asimmetrica.
Il tutto non lascia intravedere uno sviluppo sicuramente pacifico: se lo jus publicum europeaum aveva ridotto le occasioni di justum bellum privandone gran parte dei soggetti “legittimati” alla guerra (dai grandi feudatari ai Comuni, alle compagnie di ventura), e costruendo lo Stato moderno come produttore di pace, non appare confortante l’idea di una “redistribuzione” dello jus belli tra diversi soggetti “regolari”e “irregolari”: una situazione neo-feudale.
Augusto dispose tre volte la chiusura del Tempio di Giano come simbolo della conseguita pax imperiale. Difficilmente in un’età imperiale, come quella che si profila nel futuro, si potrà procedere ad un atto analogo.
Teodoro Klitsche de la Grange
i V. LFS trad. it. Firenze 1941, p. 229-231 (i corsivi sono nostri).
ii “La costituzione dà al Congresso il diritto di chiamare in servizio attivo la milizia dei diversi Stati, quando si tratta di reprimere un’insurrezione o di respingere un’invasione; un altro articolo dice che, in questo caso, il Presidente degli Stati Uniti è il comandante in capo dell’esercito.
All’epoca della guerra del 1812, il Presidente ordinò alle forze militari del Nord di portarsi verso le frontiere; il Connecticut e il Massachussets, i cui interessi erano danneggiati dalla guerra, rifiutarono di inviare il loro contingente.
La costituzione, essi dissero, autorizza il governo federale a servirsi delle milizie territoriali in caso di insurrezione o di invasione; ora, nel caso presente, non c’è né insurrezione né invasione. Aggiunsero poi che la stessa costituzione, che dava all’Unione il diritto di chiamare le milizie in servizio attivo, lasciava agli Stati il diritto di nominare gli ufficiali; ne deriva, secondo loro, che in guerra nessun ufficiale dell’Unione aveva il diritto di comandare le milizie, eccetto il Presidente in persona. Ora, si trattava di servire in un esercito comandato da un altro.
Queste teorie assurde e distruttrici ricevettero non solo la sanzione dei Governatori e del corpo legislativo, ma anche quella delle Corti di giustizia di questi due Stati” e prosegue “Per quale ragione, dunque, l’Unione americana, per quanto protetta dalla relativa perfezione delle sue leggi, non si dissolve in mezzo a una grande guerra? Per la semplice ragione che non ha grandi guerre da temere.
Posta al centro di un continente immenso, in cui l’industria umana può estendersi senza limiti, l’Unione è isolata dal mondo quasi come se fosse circondata da ogni parte dall’Oceano.
Il Canada non conta che un milione d’abitanti: la sua popolazione è divisa in due nazioni nemiche. I rigori del clima limitano l’estensione del suo territorio e chiudono per sei mesi i suoi porti.
Al sud l’Unione tocca l’Impero del Messico; probabilmente è di qui che, un giorno, potranno venire grandi guerre. Ma, per lungo tempo ancora, il grado poco avanzato di civiltà, la corruzione dei costumi e la miseria impediranno al Messico di occupare un posto elevato tra le nazioni. Quanto alle potenze europee, la loro lontananza le rende poco temibili” concludendo “La grande fortuna degli Stati Uniti non è, dunque, quella d’aver trovato una costituzione federale, che permetta loro di sostenere grandi guerre, ma quella di avere una posizione geografica tale da non dover temere grandi conflitti.
Nessuno saprebbe apprezzare più di me i vantaggi del sistema federale. Vi vedo una delle più valide combinazioni in favore della prosperità e della libertà umane. Invidio la sorte idi quelle nazioni alle quali è stato permesso d’adottarlo. Ma, nondimeno, mi rifiuto di credere che dei popoli confederati possano lottare a lungo, a parità di forze, contro una nazione, dove il potere di governo è centralizzato” (i corsivi sono nostri) – v. La Démocratie en Amérique, libro I, parte I, trad. it. Torino, p. 200 ss.
iii “…il più grosso problema europeo è di sapere come si possa ridurre il potere sovrano senza distruggerlo.
Si fa presto a dire: «Ci vogliono delle leggi fondamentali, ci vuole una costituzione». Ma chi istituirà queste leggi fondamentali, e chi le farà attuare? Il gruppo o l’individuo che ne avesse la forza sarebbe sovrano, poiché sarebbe più forte del sovrano, di modo che, per l’atto stesso dell’istituzione, lo detronizzerebbe. Se la legge costituzionale è una concessione del sovrano, il problema si ripresenta. Chi impedirà che uno dei suoi successori la violi?… D’altra parte, si sa che i numerosi tentativi fatti per ridurre il potere sovrano non sono mai riusciti a far venire la voglia di imitarli. L’Inghilterra sola, favorita dall’Oceano che la circonda e da una carattere nazionale che si presta a queste esperienze, ha potuto fare qualcosa del genere” Du pape, Lib. II, cap. II, trad. it. di A. Pasquali, Milano 1995, p. 158 (i corsivi sono nostri).
iv “L’idealità che fa la sua comparsa nella guerra, venendosi così a trovare come in un rapporto accidentale con l’esterno, è in realtà identica all’idealità secondo cui i poteri statuali interni sono momenti organici del Tutto.
Sul piano dei fenomeni storici, questa identità si presenta, tra l’altro, nella figura per cui guerre fortunate hanno impedito irrequietudini interne e hanno consolidato la forza interna dello Stato.
Un fenomeno che rientra appunto in questo ordine è quello dei popoli che, non volendo oppure paventando sopportare una sovranità all’interno, sono stati soggiogati da altri popoli, e che si sono impegnati per la loro indipendenza con tanto minore successo e onore quanto meno si è potuto produrre al loro interno un primo serio assetto del potere statuale – popoli la cui libertà è morta per la paura di morire” (i corsivi sono nostri) LFD § 325 di V. Cicero, Milano 1996, p. 545.
v E proseguiva “da un lato questa legalità di mantenere ogni parte nella sua separazione dallo Stato, dall’altro le necessarie pretese dello Stato sul singolo membro di esso stanno nel più completo contrasto. Lo Stato richiede un centro comune, un monarca e degli stati in cui si riuniscano i diversi poteri, i rapporti con potenze straniere, le potenze militari, le finanze che hanno con esso relazione ecc.; un centro che avrebbe anche per la direzione, la necessaria potenza di affermare se stesso e le sue decisioni e di mantenere le singole parti in dipendenza da se. Atraverso il diritto invece è assicurato ai singoli Stati un’indipendenza quasi totale o addirittura totale… L’edificio statale tedesco non è null’altro che la somma dei diritti che le singole parti hanno sottratto al tutto; e questa legalità che veglia sollecitamente a che allo Stato non rimanga più alcun potere è l’essenza della costituzione” Op. cit. pag. 19.
vi E così prosegue “la Germania può essere saccheggiata e ingiuriata: il teorico del diritto statale saprà mostrare che tutto ciò è del tutto conforme ai diritti e alla prassi e che tutti i casi di infelicità sono piccolezze nei confronti dell’uso di questa legalità. Se il modo infelice in cui la guerra è stata condotta risiede nella condotta dei singoli stati, dei quali l’uno non inviò alcun contingente, moltissimi inviarono, invece che dei soldati, delle reclute arruolate appena ora, l’altro non pagò nessuna «mensilità romana», un terzo al tempo del più grande bisogno ritirò il suo contingente, molti conclusero trattati di pace e contratti di neutralità, la maggior parte ognuno alla sua maniera, annullò la difesa della Germania: allora il diritto statale dimostra che gli Stati hanno il diritto di una siffatta condotta, hanno il diritto di portare il tutto al più grande pericolo danno e sventura; e poiché questi sono diritti, i singoli e le comunità devono salvaguardare e difendere rigorosissimamente questi diritti di essere mandati in rovina. Per questo edificio giuridico dello Stato tedesco forse non esiste dunque nessuna insegna più adatta di questa: Fiat justitia, pereat Germania!”op. cit. trad it. in Scritti politici, Bari 1961 pp. 21.
vii Riguardo alle leggi propriamente civili e alla amministrazione della giustizia, né l’uguaglianza delle leggi e della procedura giuridica potrebbero rendere l’Europa uno Stato (tanto poco quanto l’uguaglianza dei pesi, delle misure e della moneta), né la loro diversità impedisce l’unità di uno Stato” perché “ i più potenti degli Stati effettivi hanno leggi assolutamente non uniformi. La Francia aveva prima della Rivoluzione una tale molteplicità di leggi che, oltre al diritto romano che valeva in molte province, in altre dominava quello burgundisco, quello britannico, ecc. e quasi ogni provincia, anzi quasi ogni città aveva una particolare legge tradizionale; uno scrittore francese disse a ragione che chi viaggiasse lungo la Francia doveva cambiare leggi tanto frequentemente quanto i cavalli dei servizi postali.
Non meno fuori dal concetto dello Stato giace la circostanza dello stabilire da quale particolare potenza, o secondo quale rapporto di partecipazione dei diversi stati o dei cittadini in generale devono essere date le leggi; Op. cit. pp. 32-22 (i corsivi sono nostri).
viii Quanto poco, prima e in sguito, la somiglianza delle religioni nella separazione in popoli potè impedire le guerre e riunirli in uno Stato, altrettanto poco nei nostri tempi la diversità della religione sgretola uno Stato. Op. cit. p. 36
ix Op. cit. p. 44 (i corsivi sono nostri)
x Mi si consenta di rinviare a quanto da me scritto in Diritto divino provvidenziale e dottrina dello Stato borghese in Behemoth n. 41, p. 25 ss.
xi v. Trattato politico, trad. it. Torino 1958, p. 205.
xii Montesquieu, Esprit des lois I, 1, 1
xiii Montesquieu, Esprit des lois, 1. I, 3: le leggi «doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un trés grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre».
xiv Era cioè proprio il contrario di quanto sosteneva Montesquieu. Ovvero che le leggi “devono essere in armonia con la natura e col principio del governo costituito, o che si vuol costituire, sia che lo formino, come fanno le leggi politiche; oppure che lo mantengano, come fanno le leggi civili.
Queste leggi debbono essere in relazione col carattere fisico del paese, col suo clima gelato, ardente o temperato; con la qualità del terreno, con la sua situazione, con la sua estensione, col genere di vita dei popoli che vi abitano, siano essi coltivatori, cacciatori o pastori: esse debbono essere in armonia col grado di libertà che la costituzione è capace di sopportare, con la religione degli abitanti, le loro disposizioni, la loro ricchezza, il loro numero, i loro commerci, costumi, maniere. Finalmente, esse hanno relazioni reciproche; con la loro origine, col fine del legislatore, con l’ordine delle cose sulle quali esse sono state costituite. Noi le dobbiamo considerare sotto tutti questi vari aspetti, ed è appunto ciò che intendo fare nella mia opera. Esaminerò tutte queste relazioni: esse, nel loro insieme, formano ciò che viene chiamato lo spirito delle leggi”. Lo spirito delle leggi deriva quindi dalle relazioni con i condizionamenti concreti e reali (tra cui i nemici e le guerre possibili) che erano considerati nei libri IX e X, che costituicono una vera miniera di intuizioni sul rapporto tra fattori geo-politici e istituzionali.
xv V. Über verfassungswesen, trad. it. in Behemoth n. 20, p. 5 ss.. E’ da notare che Lassalle muoveva una critica penetrante ai giuristi suoi contemporanei “tutte queste definizioni giuridiche formalmente simili aono altrettanto lontane quanto la precedente risposta in ordine alla costruzione di una risposta effettiva alla mia domanda. Perché tutte queste risposte contengono sempre e solo una descrizione esterna del come una costituzione viene ad esistenza e di ciò che una costituzione fa, ma non l’informazione: cosa una costituzione è. Esse indicano criteri, segni di riconoscimento, da cui si riconosce una costituzione dall’esterno e sul piano giuridico” per cui concludeva “ Gli effettivi rapporti di potere che sussistono in ogmi società sono quella forza effettivamente in vigore che determina tutte le leggi e le istituzioni giuridiche di questa società, cosicchè queste ultime essenzialmente non possono essere diverse da come sono” i corsivi sono nostri. V. op. cit. p. 5-6.
xvi H. Triepel Völkerrecht und Laudesrechts, trad. it. Torino 1913 pp. 4-5. (i corsivi sono nostri)
xvii Montesquieu considerava con favore le repubbliche federate perché federarsi è l’unico modo per dei piccoli Stati, di difendersi. “Furono queste associazioni a render fiorente per così lungo tempo la Grecia. Grazie ad esse i Romani attaccarono il mondo intero, e grazie ad esse sole il mondo intero si difese contro di loro. Quando Roma raggiunse il massimo della propria grandezza, fu per mezzo di simili associazioni poste oltre il Danubio ed il Reno, e sorte per effetto della paura, che i barbari poterono resistere… Le associazioni tra città erano in altri tempi più necessaria di quanto non lo siano oggi. Una città mal difesa correva rischi gravissimi. Essere conquistata significava la perdita non soltanto del potere esecutivo e legislativo, come avviene oggi, ma anche di tutte le proprietà individuali”. Poco dopo specificava che il non poter contrarre alleanza significa per l’appunto di non poter condurre una politica estera diversa dalla federazione Esprit des lois, Lib. IX, cap. 1-3.
xviii “Tutte le istituzioni generano un diritto disciplinare che resta al loro interno, si caratterizza per essere gerarchico e perché, davanti ai Tribunali che lo applicano, le parti non sono in posizione d’eguaglianza” Précis de droit constitutionnel, Paris 1929, p. 98.
xix Hauriou op.loc. cit., e aggiunge “Mentre Thémis ha la propria fonte nell’organizzazione sociale, Dike trova la propria nella socievolezza umana che non perde i propri diritti neppure di fronte agli stranieri, e del pari di fronte ai nemici”.
xx Verfassungslehre trad. it. di A. Caracciolo, p. 477, Milano 1984.
xxi v. sul punto C. Schmitt op.cit.p. 493: “Ma poiché le questioni dell’esistenza politica possono presentarsi diversamente nei diversi ambiti, specialmente in politica estera ed interna, allora è possibile che la decisione su una specie determinata di siffatte questioni, per esempio le questioni dell’esistenza in politica estera, abbia luogo nella federazione, mentre la decisione di altre questioni, per esempio il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica all’interno di uno Stato membro, rimanga nello Stato membro. Questa non è una divisione della sovranità, ma deriva dalla coesistenza della federazione con i suoi membri: non si verifica una divisione, perché il caso di un conflitto, che determina la questione della sovranità, riguarda l’esistenza politica in quanto tale e la decisione nel caso singolo spetta sempre interamente all’uno o all’altro”
xxii v. op. cit., p. 480.
xxiii V. in Palomar n. 18, pp. 49 ss.
xxiv Op. cit., p. 480-481.
xxv v. gli articoli di Jean Claude Paye in Behemoth nn. 35, 37, 38.
xxvii In effetti in tali guerre, essendo “distribuito” lo jus belli, non c’è il criterio distintivo delle auctoritas cioè il diritto di dichiarare e muovere guerra, indicato da S. Tommaso e dai teologi-giuristi della Tarda Scolastica come una delle condizioni dello justum bellum.
xxviii V. Leviathan (conclusione); scrive Hobbes “E così sono giunto alla fine del mio trattato sul governo civile ed ecclesiastico, al quale hanno data occasione i disordini del tempo presente, e che è stato composto senza parzialità, senza prevenzione e senza altro scopo che di porre davanti agli occhi degli uomini la mutua relazione tra protezione ed obbedienza; alle quali la condizione della natura umana e le leggi divine – tanto naturali che positive – richiedono un’osservaznza inviolabile”, (il corsivo è nostro) trad. it. di Mario Vinciguerraq, vol. II, Bari 1974, p. 661.
xxix V. la definizione di G. D. Romagnosi in Scienza delle costituzioni, Firenze 1850 (tra i tanti che l’hanno ripetuto) v. V.E. Orlando nel discorso sopra citato alla Costituente.
xxx “Distinguo tre tipi di pace, equilibrio, egemonia, impero: in un dato spazio storico, le forze delle unità politiche o si controbilanciano o sono dominate da quelle di una di esse, oppure infine sono superate da quelle di una di esse in modo che tutte le unità, salvo una, perdono la loro autonomia e tendono a sparire in quanto centri di decisioni politiche” Paix et guerre entre les nations, trad. it. F. Airoldi Namer, Milano 1970, p. 188 (i corsivi sono nostri).
xxxi “La classificazione ternaria delle paci ci fornisce nello stesso tempo una classificazione, la più formale e la più generica, delle guerre: le guerre «perfette», conformi alla nozione politica della guerra, sono interstatali: in esse si affrontano unità politiche che si riconoscono reciprocamente esistenza e legittimità. Chiameremo soprastatali o imperiali le guerre il cui oggetto, o rigine o conseguenza, sia l’eliminazione di certi belligeranti e la formazione di un’unità al livello superiore. Chiameremo infrastatali o infraimperiali le guerre la cui posta è il mantenimento o la decomposizione di un’unità politica, nazionale o imperiale” op. cit., p. 191; si noti che Aron attribuisce allo Stato imperiale il monopolio della violenza legittima. Si può concordare a patto di chiarire che quando c’è uno Stato imperiale, questo è più Stato che Impero, e che l’essenza “statale” può essere prevalente in certe aree, e più sfumata in altre (come in molte colonie extraeuropee degli Stati europei).
xxxii Op. cit., v. (tra gli altri) §258 “Se lo Stato viene scambiato per la società civile, e se quindi la sua destinazione viene posta nella sicurezza e nella protezione della proprietà e della libertà personale, allora l’interesse dei singoli in quanto tali diviene il fine ultimo per cui essi sono uniti, e, a un tempo, il fatto di essere membro dello Stato finisce col dipendere dal capriccio individuale”, mentre “L’unione in quanto tale [degli individui nello Stato] è essa stessa l’autentico contenuto e fine, e la destinazione degli individui consiste nel condurre una vita universale: ogni loro ulteriore appagamento, attività, modo di comportarsi, ha per suo punto di partenza e risultato questo elemento sostanziale e universalmente valido”, trad. it. di V. Cicero, Milano 1996, p. 417-419.
xxxiii V. Julien Freund L’essence du politique, Paris 1965, p. 94 ss.