Sergio d’Angelo ha compiuto ottantotto anni e ne dimostra venticinque di meno anche fisicamente, oltre che di memoria. E’ a lui che il mondo deve il romanzo capolavoro di Boris Pasternak ” Il dottor Zivago” che fruttò all’autore il Nobel per la letteratura e una vita di persecuzioni, anche se la maggior parte degli italiani di tutto questo ricorda forse solo il film e Julie Christie.
Il Corriere della Collera pubblica oggi una lunga intervista a Sergio d’Angelo, di Kontinent USA e del presidente della associazione per l’amicizia Russia Stati Uniti Edward Lozansky, uno scienziato nucleare sovietico che fece il cammino inverso rispetto a Bruno Pontecorvo che scelse di andare a lavorare in Unione Sovietica. Due ebrei inquieti, su opposte sponde della guerra fredda.
IL Corriere della Collera, oggi 5 gennaio 2012, è lieto di offrire questa esclusiva ai propri lettori e promette a breve , oltre a questa verità sulla morte di Feltrinelli, anche uno studio comparativo della due inchieste della magistratura sulla morte di Enrico Mattei, curato dall’ ex A. D. dell’Agip, uno dei suoi discepoli.
L’intervista è preceduta da una nota redazionale che pubblico integralmente.
“Kontinent USA, su richiesta di alcuni suoi lettori, torna oggi sul caso Pasternak per discuterne un importante aspetto rimasto finora nell’ombra.
Per introduzione, soprattutto ad uso del pubblico più giovane, conviene qui ricordare che il geniale poeta e scrittore russo Boris Pasternak (1890-1960) subì negli ultimi anni di vita durissime persecuzioni dal regime sovietico. Ciò per aver fatto pubblicare in Occidente il suo romanzo “Dottor Zhivago”, un capolavoro proibito in patria ma presto coronato da uno strepitoso successo mondiale e dal conferimento del Premio Nobel all’autore.
La prima edizione al mondo del “Zhivago” ebbe luogo in Italia, a Milano, nel novembre 1957, presso la casa editrice fondata dal giovane Giangiacomo Feltrinelli appena due anni prima. Feltrinelli, benché avesse ereditato uno dei massimi patrimoni industrali e finanziari esistenti in Italia, era stato militante del Partito comunista italiano (PCI) e lautamente lo aveva sovvenzionato. Dal PCI si era però staccato nella primavera 1957, ribellandosi alle forti pressioni cui l’avevano sottoposto i dirigenti di quel partito nel tentativo di non fargli pubblicare il romanzo sconfessato da Mosca. E in quella circostanza professò di volersi battere, da editore di sinistra, per l’assoluta libertà del pensiero e della cultura.
Ma di fatto, negli anni successivi, smise a poco a poco di occuparsi di faccende editoriali per mobilitarsi prima come generoso finanziatore di guerriglie nel Terzo Mondo, poi come improbabile guerrigliero in Italia e dintorni. Perse la vita in un fallito attentato nella periferia di Milano (marzo 1972).
L’aspetto del caso Pasternak cui si riferisce l’inizio di questa nota è il ruolo esercitato per quasi quindici anni (1958-1972)
dalla Signora Inge Schoental nella vita di Giangiacomo Feltrinelli. Nel 1962 Inge ebbe da Giangiacomo il figlio Carlo, erede universale del patrimonio miliardario paterno: quello sul quale lei regna da vari decenni.
Per approfondire questo argomento Kontinent USA ha intervistato Sergio d’Angelo, il giornalista italiano che nella primavera del 1956 ottenne da Pasternak il dattiloscritto del “Zhivago”, con l’intesa di passarlo a Feltrinelli, ed ebbe una parte rilevante, in Russia e fuori, nelle complesse vicende originate dalla sua iniziativa. Di tutto ciò d’Angelo ha dato ampia testimonianza in un suo libro pubblicato in Italia nel 2006. Nel settembre dell’anno successivo, pochi giorni dopo l’edizione russa dello stesso libro (“Delo Pasternaka: Vospominanija Ochevidtsa”, Novoe Literaturnoe Obozrenie, Moskva 2007), d’Angelo è stato insignito del Premio Liberty (Sezione Finestra sull’Europa), fondato nel 1999 e presieduto da una giuria di illustri membri della comunità russo-americana.
Il Premio Liberty, che ogni anno viene assegnato a persone distintesi per i loro contributi alla cultura, è sponsorizzato dalla Casa Russia di Washington, dalla Università Americana di *Mosca e da Kontinent USA.
Un personaggio del “caso Pasternak”
INGE SCHOENTAL FRA LEGGENDA E REALTA’
Intervista a Sergio d’Angelo
Edward Lozansky – Premetto che solo negli ultimi giorni ho potuto vedere il DVD con cui parecchi mesi fa la Signora Inge Schoental si è raccontata al suo pubblico italiano. Si tratta, direi, di una lunga autocelebrazione con qualche diplomatico tocco di modestia: per esempio l’ammissione di non aver imparato bene l’italiano. Comunque sia, quel DVD ha riacceso in me e in altri colleghi, tutti cultori di Pasternak, tutti appassionati al “romanzo del romanzo”, il desiderio di sapere molto di più sulla influenza che Inge, con la sua indubbia personalità, ha avuto sulla sorte di Giangiacomo Feltrinelli. Per prima cosa, dunque, potresti riferirci chi era e che ha fatto Inge prima del suo incontro con l’editore milanese?
D’Angelo – A questo riguardo parecchi giornali, periodici e libri, per lo più italiani, hanno riportato le sue dichiarazioni. In sintesi ecco quanto se ne ricava. Inge nasce in Germania, a Essen (Ruhr), nel 1930. E’ ancora nella primissima infanzia quando il padre, ebreo, emigra in America per scampare al potere nazista. Lei cresce a Gottinga, nella Bassa Sassonia, accanto alla madre e a due fratelli più piccoli, fra seri pericoli e ristrettezze economiche. Durante la guerra frequenta il liceo con l’idea di proseguire gli studi, ma i soldi per farlo non ci sono.
E.L. – E alla fine della guerra?
D’A – Inge trascorre ancora a Gottinga, con la famiglia, pochi altri anni che preferisce dimenticare. Poi decide di andarsene per suo conto e, grazie al passaggio che le danno su un camion, arriva ad Amburgo. Ha pressoché vent’anni, è una bella ragazza che non passa inosservata, Molto intraprendente. Comincia a girare in bicicletta la grande città portuale che dista solo poche decine di chilometri dal confine della Germania orientale. Cerca lavoro, cerca di fare conoscenze, e infine riesce ad essere assunta come apprendista fotoreporter dalla rivista “Constanze”. Presto viene incaricata di servizi fotografici su persone di spicco della Germania occidentale e, dalla seconda metà degli anni cinquanta, può ampliare il raggio delle sue trasferte per raggiungere alcune celebrità residenti in altri paesi. La trasferta più lontana, esotica e gratificante (1957) avrà luogo nella Cuba precastrista, dove Ernest Hemingway la ospiterà per una quindicina di giorni nella propria Finca Vigia, vicino all’Avana.
E.L. – Insomma fa una fulminea carriera, anche se il nome di lei non figura fra i miti della fotografia Ma come ha avuto modo di incontrare Feltrinelli?
D’A – All’inizio del luglio 1958 Feltrinelli, separatosi poco prima dalla seconda moglie, decide di fare un viaggio in Svezia per acquistarvi
un nuovo panfilo. Nello stesso tempo comunica all’editore amburghese Heinrich Rowohlt, col quale ha già un rapporto di amicizia ed affari, che il 14 dello stesso mese, durante un’apposita tappa, vorrebbe fargli visita. Rowohlt è d’accordo e la sera del giorno stabilito, per onorare l’ospite italiano, dà una festa. Inge è lì. Sgargiantemente abbigliata. Lei partecipa alla festa, chiarisce, in quanto svolge incarichi di fotoreporter anche per Rowohlt . Cena al tavolo con i due editori e ce la mette tutta per far colpo su Feltrinelli. Riportando un successone. Lo stesso editore amburghese testimonierà molti anni dopo in un’intervista alla rivista “Panorama” (29 settembre 1985) che Inge e Feltrinelli “simpatizzarono subito e, quando lasciarono la festa, credo non avessero più bisogno di nessun altro”.
E.L. – Dopo di che mi aspetto che presto i due vadano a Milano e poi, felici e contenti, convolino a nozze. Non è così?
D’A – Parliamo di una cosa per volta. Vanno a Milano, verissimo, ma non possono sposarsi, perché lui ha un’altra moglie, sia pure separata, e in Italia il divorzio non c’è ancora. Corre voce che per aggirare l’ostacolo Feltrinelli ricorra alla “Sacra Rota”, tribunale ecclesiastico cui è consentito sciogliere i matrimoni non consumati, e si dichiari affetto da “impotentia erigendi et coeundi” [incapacità di erezione ed eiaculazione], così come ha fatto per mettere fine al suo primo matrimonio. Ma ciò non è rilevante. Infatti Feltrinelli, per la ragione di cui diremo, finisce di convivere con Inge prima del previsto e si lega sentimentalmente alla giovanissima Sibilla Melega, destinata a diventare l’ultima delle sue mogli.
E.L. – Comunque immagino che in un primo tempo Inge sia stata molto contrariata per non poter consolidare con nozze italiane la sua relazione con Feltrinelli.
D’A – Penso di sì. Ad ogni modo Inge, stabilitasi nella casa avita di Feltrinelli, inaugura con disinvoltura la sua nuova vita da miliardaria. Che però non è una vita oziosa. Chiede e ottiene infatti di essere presto inserita nella casa editrice quale incaricata dei rapporti con editori e autori stranieri e, proprio in questa veste, all’inizio del 1959 accompagna Feltrinelli in un viaggio di circa quattro mesi nel continente nord-americano. A dire il vero, i due prima si sposano in Messico (per lei anche questo è meglio niente) e festeggiano l’evento con una vacanza itinerante che include la Bassa California e Cuba. Poi si fermano a lungo negli Stati Uniti per discutere progetti e scambi di diritti con diversi illustri editori. Ma sono sicuro che incontrano pure alcuni militanti di estrema sinistra.
E.L. – Perché ne sei sicuro?
D’A – Perché proprio al ritorno da quel viaggio Feltrinelli mi dice per la prima volta di avere scoperto, parlandone con gente ben informata, che i massimi poteri degli Stati Uniti si stanno preparando alacremente a fascistizzare tutto l’Occidente e a scatenare la terza guerra mondiale. Io ci scherzo su. Ma di questa presunta scoperta lui continua a vantarsi in giro.
E.L. – E Inge è d’accordo con lui?
D’A – Di certo non in pubblico. Anzi, lei si atteggerà sempre a illuminata intellettuale che, favorita dalla sua importante posizione nell’editoria, vuole contribuire al progresso pacifico, democratico e culturale della società. Tanto che arriverà ad ammettere, quando capita il discorso, che Feltrinelli sia politicamente un po’ troppo radicale e impulsivo…
E.L. – Scusami se ti interrompo. Nel tuo libro sul caso Pasternak tu hai sostenuto che Mosca, dopo l’uscita del “Zhivago” in Italia, non poteva arrendersi all’idea di far mancare i soldi di Feltrinelli alla causa del comunismo…
D’A – Vero. E ho aggiunto che a un certo punto progettò di indurre Feltrinelli (sapendolo affetto da seri complessi, specie da megalomania infantile, e pertanto molto influenzabile) a finanziare quei focolai di guerriglia che si accendevano soprattutto nel Terzo Mondo ed erano appoggiati da Mosca nel quadro della sua strategia planetaria.
E.L. – A questo scopo, però, Mosca doveva individuare chi potesse e volesse manipolare Feltrinelli. In altre parole chi sapesse inculcargli il concetto che soltanto le sinistre rivoluzionarie, quelle già ricorse alle armi o pronte a ricorrervi, fossero veramente in grado di scongiurare il dilagare del fascismo e l’olocausto nucleare. E tu non supponi …
D’A – Al riguardo lasciamo parlare una serie di fatti. Dopo la lunga sosta negli Stati Uniti Inge convince Fertrinelli ad accreditare presso Pasternak e Olga Ivinskaia, compagna e ispiratrice dello scrittore, un proprio amico di Amburgo, il giornalista Heinz Schewe, che sta per trasferirsi a Mosca come corrispondente del quotidiano “Die Welt”. Questi assicurerà alla casa editrice, spiega lei , un canale più che sicuro per concordare con l’autore del “Zhivago” il modo di risolvere i problemi legali e giudiziari che si moltiplicano in parallelo con le nuove edizioni occidentali del “Zhivago”: in concreto per far firmare a Pasternak un contratto più favorevole all’editore, sotto il profilo dei diritti, rispetto a quello stilato inizialmente. Ma Pasternak non firmerà mai il nuovo contratto.
E.L. – Perché?
D’A – Per tre motivi. Primo: firmare il nuovo contratto gli avrebbe attirato nuove persecuzioni da parte del potere sovietico. Secondo: il testo predisposto a Milano implicava la sconfessione di una sua procuratrice parigina che fra l’altro avrebbe dovuto amministrare gli onorari spettanti all’autore per tutte le edizioni del “Zhivago”. Terzo: Il nuovo contratto avrebbe incluso, fra le clausole che lui non gradiva affatto, anche il suo consenso all’utilizzazione cinematografica del Zhivago”.
E.L. – Davvero Pasternak era contrario a un film tratto dal suo romanzo?
D’A – Sì, disse molte volte di temere una banalizzazione. Ma torniamo a Schewe. Il giornalista di Amburgo viene accolto con assoluta fiducia da Psternak e Olga, diventa ospite molto assiduo della casa di lei e dei suoi figli. Comunque il suo comportamento sembra inspiegabile dal momento in cui, poco dopo la morte dello scrittore (30 maggio 1960), Olga e la figlia Irina Emelianova vengono arrestate, processate e condannate a lunghe pene detentive. Il potere sovietico ha preso queste misure per “riabilitare” l’autore del “Zhivago” (un gigante da non regalare per sempre ai nemici dell’URSS) mediante una campagna per demonizzare Olga come una donna avida e intrigante che, complice la figlia, avrebbe tradito e fuorviato Pasternak, “ingenuo ma leale cittadino sovietico”. La campagna diffamatoria, per essere più efficace, doveva però scattare solo dopo che le condanne fossero passate in giudicato.
E.L. – Ci fu dunque un lungo segreto di Stato. Quando cessò?
D’A – Qualcosa cominciò a trapelare, in URSS e in Gran Bretagna, fin dall’inizio di gennaio, ma fu il quotidiano londinese “Daily Telegraph” a rilevare per primo, il 18 dello stesso mese, diversi particolari sul dramma delle due donne. Ebbene, Schewe era l’unico giornalista occidentale che, per aver frequentato la casa di Olga fino alla vigilia dell’arresto, sapeva quel che era successo. Avrebbe potuto fare un scoop giornalistico, soprattutto avrebbe dovuto ricordare che molte volte Pasternak aveva raccomandato a tutti i suoi amici stranieri di suonare le campane a martello se, dopo la sua morte, come presentiva, Olga fosse stata arrestata. E invece non diffuse la notizia, La dette riservatamente solo a Feltrinelli, il quale me la gridò in faccia un mese dopo per accusarmi di essere la causa dell’arresto e quindi per licenziarmi.
E.L. – A quel punto anche tu potevi rivelare la notizia. Che cosa ti trattenne?
D’A – Il sospetto che si trattasse di una balla.
E.L. – Era stato lo stesso Schewe a mettergli in testa che la colpa dell’arresto fosse tua?
D’A – Non lo so. Comunque il 17 gennaio 1961 Schewe mi rivolse la medesima accusa in un’intervista sul “Corriere della Sera”, il più importante giornale italiano. In breve, secondo la sua versione, io avevo irresponsabilmente fatto consegnare ad Olga un grosso pacco di rubli e la polizia l’aveva scoperto: donde l’arresto e poi la condanna per contrabbando di valuta. Le cose però non stavano affatto in questo modo. A cominciare dal 1959 io avevo inviato a Olga, per Pasternak, un paio di somme già convertite in rubli, quelle che potevo permettermi, utilizzando come “corriere” qualche amico molto fidato. Sapevo che Pasternak aveva estremo bisogno di aiuto perché, in seguito allo scandalo sollevato dalle autorità sovietiche quando nell’ottobre 1958 lui era stato insignito del Premio Nobel, l’Unione degli scrittori lo aveva privato delle sue uniche fonti di guadagno.
E.L. – Mi ricordo. Non gli era più permesso di pubblicare o ristampare le proprie opere, nemmeno le magistrali traduzioni dei grandi classici come Shakespeare e Goethe.
D’A – Esatto. Però nel marzo 1960 Feltrinelli (dopo aver ottenuto che la summenzionata procuratrice parigina declinasse il mandato per evitare a Pasternak le conseguenze di un rumoroso procedimento giudiziario minacciato da Milano) mi versò finalmente la somma in dollari che lo scrittore gli aveva chiesto di mettere a mia disposizione quasi un anno prima per consentirmi di gestirla come fondo per rimesse periodiche all’indirizzo di Olga. Il fondo era consistente. Proveniva dagli onorari, senza dubbio molte volte più consistenti, che spettavano allo scrittore per tutte le edizioni del “Zhivago” uscite fino a quel momento in Occidente. Pasternak aveva stabilito l’entità del fondo e me ne aveva affidato la gestione esentandomi dal renderne conto a chicchessia e raccomandandomi di iniziare le rimesse quanto prima possibile. Tutto questo sta scritto nelle sue dichiarazioni autografe, poi pubblicate integralmente.
E.L. – E subito tu cominciasti a organizzare la rimessa di cui parla Schewe…
D’A – Quasi subito. Si trattava di un’operazione complessa e purtroppo potei completarla soltanto dopo la morte di Pasternak, comunque nella certezza di eseguire la sua volontà. Riassumo la fase finale della rimessa. Verso la fine di luglio due giovani coniugi molto legati alla mia famiglia (un medico toscano e una slovena capace di cavarsela col russo) giungono a Mosca en touriste a bordo di un maggiolino Volkswagen dove sono accuratamente nascoste numerose mazzette di rubli. I due prendono posto in un grande albergo pieno di turisti stranieri e si riposano dalle fatiche del lungo viaggio automobilistico.
E.L. – Iniziato dove?
D’A – In Italia, a Roma. Poi i due coniugi hanno attraversato l’Austria, Berlino, Varsavia. All’indomani dell’arrivo a Mosca cominciano a visitare la città, usando esclusivamente mezzi pubblici e guardandosi bene dal servirsi di telefoni. Fra l’altro, avendo ricevuto da me una mappa del centro cittadino e precise istruzioni di comportamento, si fanno portare con un taxi nelle vicinanze della strada (che poi raggiungono a piedi) dove sorge l’edificio in cui abita Olga e lo osservano dall’esterno, senza fermarsi. Nello stesso modo, un paio di giorni dopo, tornano di pomeriggio davanti a quell’edificio e salgono senza preavviso all’appartamento giusto. Apre Olga. Essi, riconoscendola dal modo in cui l’avevo descritta, le porgono un generico biglietto di presentazione (lei ben conosce la mia scrittura) e si informano a gesti se possono parlare liberamente. Possono. Allora concordano che la sera del giorno successivo. per l’esattezza il primo agosto, torneranno con le mazzette di rubli prelevate all’ultimo minuto dal maggiolino e sistemate in due normali borse da viaggio. E ciò avviene puntualmente. Col seguito di una cena che Olga vuole offrire in casa.
E.L. – I “corrieri” ripartono, hanno fatto un lavoro perfetto. Quando e come poi qualcosa va storto?
D’A – Olga ci descrive minutamente in un libro di memorie, “A Captive of Time” (Doubleday, Garden City, New York 1978), le vicende dei quindici giorni che intercorrono dalla visita dei “corrieri” al suo arresto (16 agosto). Ne traggo l’essenziale. Olga confida quasi subito a Schewe, sempre suo assiduo visitatore, l’arrivo dei rubli e lui si mostra costernato. Esclama: “Adesso noi [sic!] siamo spacciati”. Olga nasconde i rubli o parte di essi in una valigia che chiude a chiave e consegna a un’ignara sarta abitante al piano di sotto, dicendole che ripasserà, appena ne avrà il tempo, per decidere le modifiche da apportare agli indumenti che stanno lì dentro. Olga non fa assolutamente menzione di sue grosse spese che possano aver dato nell’occhio.
E.L. – Esiste, di quei giorni, anche una versione di Schewe?
D’A – Nella citata intervista sul “Corriere”, quella in cui mi addita come il colpevole dell’arresto, Schewe sosterrà che Olga aveva attinto al denaro appena ricevuto per comprare una motocicletta al figlio e in quel modo (tanto più che allora pochissime motociclette giravano per Mosca) era incappata incautamente nel mirino della polizia.
E.L. – Se fosse vera la storia della motocicletta cadrebbe il sospetto di una spiata …
D’A – No, la spiata è molto più di un sospetto. Infatti la mattina del 16 agosto, come Olga racconta in “Captive of Time”, diversi agenti fanno direttamente irruzione nell’appartamento della sarta di Olga, forzano la valigia e sequestrano i rubli. In quel momento Olga non è nemmeno a Mosca. Si trova in una casetta di campagna, non molto distante dalla capitale, dove altri agenti, quella stessa mattina, l’arrestano con l’imputazione di aver contrabbandato valuta: imputazione ridicola, ovviamente, perché Olga (al pari della figlia che sarà arrestata una ventina di giorni dopo) mai ha messo piede fuori dell’URSS e mai ha ricevuto banconote estere.
E.L. – E Schewe commenta questo fatto?
D’A – In modo incredibile. Mi riferisco ancora alla sua intervista al “Corriere”. Non che lui parli dell’ incursione nell’appartamento della sarta… Però sostiene testualmente che, date le circostanze, “il tribunale sovietico non poteva far altro che condannare lei [Olga] e la figlia Irina”. In sostanza, finge di ignorare che il processo è stato preceduto da qualche mese di interrogatori nella Lubianka (dove si portano solo gli oppositori politici) e sbrigato in un solo giorno nella più assoluta segretezza, senza testimoni a discarico e senza possibilità di ricorrere in appello. E così sconfessa a priori la sentenza con cui il 2 novembre 1988, al tempo di Gorbaciov, la Corte suprema della Repubblica sovietica russa annullerà quel processo e assolverà pienamente madre e figlia per “insussistenza di reato”.
E.L – Allora si può concludere che Schewe…
D’A – La conclusione su Schewe emergerà fra poco. Nel marzo 1961, cercando di riparare allo scandalo internazionale per la sorte di Olga e figlia, Aleksei Adzhubei, direttore del giornale “Izvestia” (e genero di Krusciov), compie un giro di conferenze in Gran Bretagna. E con l’occasione tira fuori un presunto asso dalla manica. Una lettera in tedesco sequestrata dalla polizia sovietica (poi pubblicata e ripubblicata in Occidente) che Feltrinelli ha inviato ad Olga, nel tentativo di forzarne la volontà, all’indomani della morte di Pasternak. L’editore chiede ad Olga di mandargli al più presto il nuovo contratto per i diritti del “Zhivago” e qualsiasi documento riservato dello scrittore; le spiega che tutto ciò non deve mai capitare “nelle mani delle autorità o della famiglia Pasternak”; e le promette che farà del suo meglio “per evitare pagamenti a terze persone” o, se non dovesse riuscirci, per far sì che “una parte sostanziale del profitto resti per lei e per Irina”.
E.L. – Mi ricordo benissimo. In quella lettera Feltrinelli cita anche Schewe.
D’A – Lo cita eccome. Feltrinelli raccomanda ad Olga di non fidarsi di “nessuno ad eccezione di Schewe”, e poi, se un giorno questo “nostro comune amico” non fosse più a Mosca, di fidarsi soltanto di coloro che le mostreranno “una delle parti mancanti” e ai quali lei mostrerà “l’altra parte” [allegati alla lettera sono due mezzi biglietti italiani da mille lire].
E.L. – Un tocco cospiratorio in cui la propaganda sovietica ha inzuppato il pane. Ma quella lettera non provava affatto che fosse stata Olga, una donna resa molto cauta da tante tragiche esperienze di perseguitata, ad ispirare tante sciocchezze, compresa la superflua raccomandazione di non far cadere le carte riservate nelle mani delle autorità.
D’A – Su questo non può esserci il minimo dubbio. Ma il punto che ora mi preme chiarire è un altro. Sulla base di ciò che sta scritto in quella lettera Schewe dovrebbe essere giudicato dal regime sovietico come un complice di prim’ordine in attività criminose; e in quanto tale, sarebbe a dir poco espulso immediatamente dall’URSS, come accade di regola a qualsiasi corrispondente “borghese” (ossia non comunista) che abbia commesso un’ infrazione sia pure infinitamente più lieve. Invece Schewe può restare tranquillo nell’URSS fino a 1967 (e vi trova anche moglie), fruendo di una”grazia” che è anche la prova definitiva dei suoi servigi al KGB.
E.L. – Prova definitiva come una “pistola fumante” in mano al killer. Ma Inge ha mantenuto anche in seguito rapporti amichevoli con Schewe?
D’A – Che Schewe sia rimasto nel suo ambito familiare è un dato di fatto. Carlo, figlio di Feltrinelli ed Inge, riferisce nel suo libro “Senior Service” (Milano 1999) che nel mezzo degli anni sessanta suo padre e Schewe si tenevano in contatto: se non altro per capire se io avessi una “sponda” americana o sovietica [insomma se fossi al soldo della CIA o del KGB]. Ovviamente la fonte di questa notizia è sua madre, perché all’epoca lui aveva non più di quattro o cinque anni. Di prima mano (anche se forse non all’insaputa di Inge) Carlo racconta poi nello stesso libro di aver fatto una visita a Schewe, in Germania, quando questi era ormai pensionato.
E.L. – Risposta esauriente. Adesso torniamo all’impegno di Inge nella casa editrice, ai suoi viaggi con Feltrinelli…
D’A – Allo scorcio degli anni cinquanta la casa editrice presenta diverse novità significative. Licenziamenti (incluso il mio) e nuove assunzioni, cancellazione di libri tradotti o già in bozze… Più rilevante, tuttavia, è il “maggiore respiro internazionale” che Inge si vanta esplicitamente di promuovere: soprattutto affiancando Feltrinelli, dai primi anni sessanta, in moltissimi viaggi di lavoro nei paesi del Terzo Mondo.
E.L. – I due cercano libri da tradurre?
D’A – In teoria sì. In pratica, invece, quei viaggi hanno per effetto soprattutto l’iniziazione rivoluzionaria dell’editore milanese.
E.L. – Per esempio?
D’A – In Africa, dove per qualche anno si concentra il loro interesse, i due visitano ripetutamente Algeria, Marocco, Guinea, Nigeria, Ghana. Feltrinelli, coadiuvato da Inge, riesce a stabilire rapporti personali con i leader saliti di recente alla ribalta della storia anticoloniale, da Ben Barka a Sékou Touré. In particolare si infervora per la causa dell’indipendenza algerina, dandone la dimostrazione più concreta con l’offrire asilo a Milano, nei locali di un suo istituto, ad alcuni disertori francesi. E nell’estate 1962, grazie alla compiacenza del presidente ghanese Kwame Nkrumah, si infila addirittura fra i delegati dei paesi non allineati all’assemblea di Accra sul disarmo nucleare. Quanto alle scoperte editoriali i giri africani fruttano solo un manoscritto sull’Algeria (magari trovato a Parigi) che lui pubblica anche in lingua originale col proposito di contrabbandarlo in Francia.
E.L. – Effettivamente non è molto…
D’A – In compenso, durante una pausa dei viaggi in Africa, Inge dà alla luce Carlo (marzo 1972). Il neonato è senza dubbio figlio di Feltrinelli, la somiglianza con lui è fuori discussione, e poco importa se nella cerchia dell’editore corre voce che ci sia stato un ricorso all’inseminazione artificiale. Sia come sia, si deve rilevare un fatto. Questo figlio (che il padre subito riconosce e nomina per testamento suo erede universale) sarà determinante nel consentire ad Inge di mantenere la sua presa su Feltrinelli quando fra non molto finirà la loro convivenza sotto lo stesso tetto e soprattutto dopo che lui, alcuni anni più tardi, passerà alla clandestinità.
E.L. – E la passione per Cuba? Quando esattamente comincia?
D’A – Nel gennaio 1964. Inge e Feltrinelli sbarcano a Cuba, dove entrambi sono già stati. Adesso qui tutto è cambiato. C’è Fidel Castro, il socialismo caraibico, il miraggio dell’esplosione rivoluzionaria nell’intera America Latina. Feltrinelli, che di tutto ciò si entusiasma, viene ricevuto varie volte dal lider màximo, ne conquista la benevolenza, può perfino misurarsi con lui in qualche tiro di basket (ripreso dalle istantanee di Inge, l’ex fotoreporter). Anche questo viaggio, va detto, non manca di un contenuto editoriale: ottenere i diritti in esclusiva mondiale sulle memorie di Fidel Castro. Peccato che le memorie non sono state ancora scritte e che l’autore in pectore, pur avendo incassato un generoso acconto, non le scriverà mai.
E.L. – Ma i due torneranno a Cuba anche in seguito?
D’A – Ci tornerà molto spesso Feltrinelli. Ma senza Inge. La ragione è che una svolta significativa interviene di lì a poco nella vita della coppia. Durante una festa affollata lei viene scoperta in estrema intimità con un noto giornalista del PCI, suscitando a dire il vero più perplessità che scandalo. Possibile che una donna come lei, generalmente considerata molto padrona di sé, abbia agito con tanta leggerezza? Ad ogni modo il risultato è che Feltrinelli va ad abitare per conto proprio, lasciando a lei la disponibilità della dimora patrizia, la cura del figlio, l’usufrutto su una cospicua parte del patrimonio familiare e l’incarico di dirigente nella casa editrice.
E.L. – Un po’ troppo. Segno che lui resta succubo della personalità di Inge.
D’A – E’ così e sarà sempre così. Intanto il nuovo assetto non impedisce ad Inge, che conserva intatte tutte le sue funzioni materne e professionali, di incontrare e condizionare Feltrinelli tutte le volte che vuole. E le dà in più la possibilità di dissociarsi in modo naturale da quei viaggi nel Terzo mondo che finirebbero col rendere poco credibile la sua coltivata immagine pubblica di intellettuale progressista ma non rivoluzionaria. Del resto Feltrinelli è ormai caricato e prosegue sulla rotta prefissatagli. Tanto che all’inizio del 1967, visitando Cuba per l’ennesima volta, proclamerà in un discorso al College Habana Libre di aver esaurito il suo compito di editore europeo e di considerarsi soltanto “un combattente contro l’imperialismo”.
E.L. – E come combatte?
D’A – Assume l’incarico di pubblicare l’edizione italiana del bimestrale “Tricontinental”, redatto a Cuba quale organo dell’Organizzazione della solidarietà fra i popoli di Asia, Africa e America Latina; e di quel bimestrale diventa ufficialmente fiduciario e inviato, occupandosi per conseguenza di ulteriori guerre e guerriglie, dal Medio Oriente al Vietnam, dall’Angola all’Uruguay, in breve in una buona parte del terzo Mondo. Non che prenda parte personalmente ad azioni di carattere militare, ma si spinge verso molte delle aree in fermento (mentre le mete di lavoro preferite di Inge sono adesso Parigi, Londra, New York) per incontrare i giusti protagonisti e contribuire alle loro cause con elargizioni di denaro e/o forniture di materiale bellico. Per esempio, subito dopo la Guerra dei Sei Giorni, incontra, non per ossequiarli solo a parole, Yasser Arafat e altri dirigenti di al Fatah.
E.L. – Per gli affari editoriali, d’ora in poi, lui avrà poco tempo…
D’A – In realtà , prima ancora della sua solenne dichiarazione al College Havana Libre, Feltrinelli ha cominciato a mollare ad Inge, gradualmente, le redini della casa editrice. Anzi, a questo proposito vorrei fare una digressione rispetto al tema dei finanziamenti alle guerriglie. Si tratta di una mia diretta esperienza e testimonianza…
E.L. – Ti ascolto.
D’A – Dopo la scarcerazione di Olga (novembre 1964) prendo un’iniziativa che ormai non può cancellare il “gesto di clemenza” con cui è stata ridotta la sua pena detentiva (e prima ancora quella della figlia). Cioè propongo a Feltrinelli, attraverso il suo principale avvocato, di istituire e presiedere un Premio Pasternak. Per finanziarlo suggerisco di utilizzare legalmente una lettera autografa che Pasternak, alla fine del mio lavoro giornalistico in URSS, aveva inviato per mio tramite a Feltrinelli: una lettera in cui, fra l’altro, gli dava disposizione di versarmi a titolo di compenso la metà di tutti gli onorari del “Zhivago” spettanti all’autore.
E.L. – Una gran bella somma!
D’A – Equivalente oggi a molti milioni di dollari. Perciò su quella lettera, che Pasternak volle farmi leggere in sua presenza, avevo scritto un grosso NO stampatello accanto alle righe che mi riguardavano, spiegando allo scrittore che mai avrei accettato di sottrarre ai suoi onorari una cifra tanto spropositata e augurandogli di venire in possesso prima o poi di tutto ciò cui aveva diritto. Feltrinelli mostrò la lettera, appena l’ebbe ricevuta, a parecchi suoi collaboratori, lodandomi per la rinuncia al denaro…
E.L – Ma la tua rinuncia non impedisce legalmente l’operazione che proponi a Feltrinelli?
D’A – Non l’impedisce perché gli eredi di Pasternak, “per ragioni politiche e morali”, non potranno mai reclamare “quell’oro di Giuda”. Lo ha stabilito nell’ottobre 1961 il vertice del Partito comunista sovietico (PCUS), primo firmatario Mikhail Suslov. Comunque Feltrinelli rigetta la mia proposta senza una parola di spiegazione.
E.L. – Sicché tu inizi una vertenza giudiziaria contro la società editrice.
D’A – Per l’appunto. Motivi di spazio non mi permettono di ricapitolare qui tutte le fasi della vertenza giudiziaria (1965-1972) ch’io finanzio nei primi anni con il residuo del fondo rimesse. Del resto ho già assolto questo compito, con profusione di documenti, nel mio libro sul caso Pasternak; e poi chi volesse accedere direttamente agli atti processuali può rivolgersi all’Archivio di Stato in Roma. Qui, invece, ricorderò per sommi capi gli episodi che provano in modo schiacciante la stretta intesa fra la società editrice (sempre più dominata da Inge) e le competenti autorità sovietiche in tutto il corso della vertenza.
E.L. – Va’ avanti.
D’A – Dopo una lunga e debole contestazione della validità giuridica della citata lettera di Pasternak la società editrice, convintasi ch’io non ne ho fatto una copia (il che è vero), presenta in giudizio una precedente e generica lettera dello scrittore, manomessa con un NO apocrifo, sostenendo che mi sono confuso. Ma, rendendosi conto che questo falso non potrà reggere a lungo, rivela a Mosca ch’io voglio istituire un Premio Pasternak. Mosca si allarma seriamente. Si mobilita. Infatti subito dopo, nel maggio 1966, il vertice del PCUS capovolge la decisione di cinque anni prima stabilendo che i figli di Pasternak potranno ereditare i proventi del “Zhivago” (e quindi intervenire nella mia vertenza), con ciò impedendo che “determinati circoli utilizzino per fini antisovietici le rilevanti somme dello scrittore scomparso”.
E.L. – Qui sembra smentita la proverbiale inefficienza della burocrazia sovietica.
D’A – Non generalizziamo. Ascolta adesso l’esempio di un pasticcio spionistico. Nell’agosto 1967, mentre sto raccogliendo importantitestimonianze a mio favore, una signora russa, Galina Oborina, che mi ha conosciuto a Mosca e poi si è trasferita definitivamente a Roma in seguito al suo matrimonio con un italiano, mi consegna la copia di una lettera dattiloscritta che Pasternak, di cui sarebbe stata da tempo buona amica, le avrebbe dettata e firmata una quindicina di giorni prima di morire, quando già era allettato. Nella copia, si legge fra l’altro, lo scrittore insiste affinché io accetti finalmente la ricompensa che mi aveva proposto nel nostro ultimo incontro.
E.L. – E’ passato molto tempo dalla data della copia. Tu non dubiti…
D’A – L’Oborina mi racconta molte sue vicende che sembrano spiegare il ritardo della consegna. Comunque io chiedo alla signora di andare da un notaio per autenticare la copia. Ciò che lei fa senza battere ciglio. Io allora deposito in giudizio la copia autenticata. E la società editrice propone quasi subito una querela di falso corredata dalle dichiarazioni giurate di due medici sovietici in cui si afferma che Pasternak, alla data indicata nella copia, stava troppo male per dettare e firmare una lettera. L’Oborina si mostra spaventata e rifiuta di testimoniare in giudizio. Io smentirò i due medici sovietici con testimonianze molto qualificate. Una è di Valeri Tarsis, noto scrittore sovietico dissidente costretto all’esilio dopo aver subito un periodo di manicomio sulla base di diagnosi imposte dal potere. E infine, sia pure tanto tempo dopo, arriva il chiarimento: dal cosiddetto Archivio Mitrokhin spunta il nome dell’Oborina quale agente del Secondo direttorato del KGB. Insomma falsa la lettera e falsa la smentita.
E.L. – Ma come finisce la causa di falso?
D’A – Non finirà mai. Intanto per aprirla è necessario che si chiuda formalmente il giudizio in corso, ciò che richiede, senza che io ne capisca il perché, quasi un anno e mezzo. Infatti il procedimento di falso comincia nel gennaio 1969. Da quel momento la società editrice, ormai chiaramente interessata a perdere tempo, non fa altro che chiedere la comparizione degli eredi di Pasternak, ma per essi, ovviamente ignari di quanto succede a Milano, c’è sempre qualcuno che con vari pretesti chiede e ottiene il rinvio delle udienze.
E.L. – Chi sono gli eredi di Pasternak?
D’A – In questo periodo i due figli Evgheni e Leonid. A loro, però, viene presto aggiunta Olga.
E.L. – Inspiegabile.
D’A – E invece no, sta’ a sentire. Verso la fine del 1969 il console generale sovietico a Roma, Ivan Iutkin, mi invita a un colloquio riservato. Ci vado. Faccio una brevissima anticamera, durante la quale una mia vecchia conoscenza di Mosca, Lolli Zamoiski (che poi figurerà come colonnello del KGB nel citato Archivio Mitrokhin), accerta la mia identità con una furtiva occhiata dallo spiraglio di una porta. Iutkin è gentilissimo. Si dice molto dispiaciuto che gli eredi di Pasternak, in particolare la mia carissima Olga, debbano testimoniare contro di me e mi propone di parlarne, per trovare una soluzione, con due alti dirigenti del Collegio giuridico sovietico per l’estero. Mi scappa di dirgli, sorridendo, che da noi i testimoni a proprio favore non sono presi troppo su serio. Comunque, qualche giorno dopo. io e due miei avvocati incontriamo al Consolato generale, in presenza di Iutkin, il vicepresidente del Collegio giuridico Andrei Korobov e un suo assistente con l’aria di autorevole sorvegliante.
E.L. – In altre termini un occhio del KGB?
D’A – Probabile. Ad ogni modo Korobov mi consiglia con lunghi giri di parole pacate e quasi amichevoli di rinunciare alla mio genere di pretesa sugli onorari di Pasternak e a un certo punto io gli domando, per la verità retoricamente, se in questo caso tutte quelle cospicue somme finirebbero davvero nelle tasche degli eredi. Risposta: certamente sì. Una mia espressione di incredulità fa allora scattare il suo assistente. Con voce arrogante costui mi intima di non divagare. Afferma che io sto dimostrando di non nutrire alcun affetto per Olga (inclusa fra gli eredi, ormai è chiaro, con l’intenzione di condizionarmi psicologicamente). E infine mi grida che “oggi si deve decidere se ci lasciamo da amici o da nemici.” Con grande calma gli spiego che l’alternativa è molto seria e perciò mi serve altro tempo per rifletterci. Fine della seduta.
E.L. – Che è anche l’ultima, immagino.
D’A – Naturalmente. Tuttavia devo convincermi che le manovre congiunte di Milano e Mosca non mi permetteranno di arrivare in tempi men che biblici (quindi anche entro i limiti della mia resistenza finanziaria) alla conclusione dell’intera vertenza e al traguardo del Premio Pasternak. Di conseguenza i miei avvocati, in pieno accordo con me, comunicano alla società editrice che io potrei prendere in considerazione la proposta di chiudere la nostra controversia purché ciò avvenga con una transazione che la impegni a rimborsarmi tutte le spese giudiziarie e non giudiziarie che ho sostenuto di tasca mia per arrivare al punto in cui ci troviamo.
E.L. – E la risposta?
D’A – La risposta non arriva e la causa di falso continua a languire fra le convocazioni mancate dei testimoni russi. Però qualcosa di strano avviene fuori dalle aule di giudizio. Il primo marzo 1970 la Società editrice annuncia sui principali quotidiani del mondo di aver stipulato un accordo con gli eredi di Pasternak (ancora i due figli Evgheni e Leonid più Olga) rappresentati da Korobov, il vicepresidente del Collegio giuridico per l’estero. In sostanza la Società editrice avvierà subito le pratiche valutarie per versare quanto dovuto agli eredi di Pasternak e otterrà da questi ultimi il “secondo contratto” perseguito invano per anni. Questo contratto riconoscerà alla Società diritti molto più ampi sulle utilizzazioni del “Zhivago”, comprese quelle diverse dalla stampa, evitandole in questo modo il grosso delle contestazioni legali sollevate finora, soprattutto all’estero, da editori ed altri soggetti coinvolti nel giro d’affari del romanzo.
E.L. – Bel colpo, su questo non c’è che dire.
D’A – C’è da dire tuttavia che i due contraenti, come ad esempio rileva il londinese “Sunday Times”, hanno ignorato il fatto che io ho promosso un’azione legale, tuttora in corso, per rivendicare parte di quel denaro. Il loro accordo è insomma un mostro giuridico. Ma il peggio deve ancora venire.
E.L. – Un altro accordo?
D’A – No, tutt’altra cosa. Il 20 gennaio 1972 diversi grandi quotidiani del pianeta, dal “New York Times” al “Corriere della Sera”, riferiscono che il giorno prima gli eredi di Pasternak avrebbero dovuto presentarsi come testimoni al tribunale dove si celebra (si fa per dire) la causa di falso e invece hanno chiesto per telegramma di rinviare l’udienza, ora fissata al 24 marzo. La lista degli eredi, si legge ancora, ha subito una variazione. Olga è stata cancellata e al suo posto figura Katia, indicata come figlia dello scrittore. Non si tratterebbe di una notizia sensazionale se non per un dato di fatto: lo scrittore non ha mai avuto una figlia e perciò Katia Pasternak è stata inventata dal KGB.
E.L. – Con quale scopo?
D’A – Si può supporre che questa Katia, munita di tutti i necessari documenti falsi, potrebbe dichiarare di aver rinunciato all’eredità per potersi qualificare come testimone. Di sicuro, comunque, non potremo mai saperlo. La morte di Feltrinelli (14 marzo) ha per conseguenza l’annullamento dell’udienza che avrebbe dovuto tenersi dieci giorni dopo. E non solo. A questo punto comincia anche la fine dell’intera vertenza giudiziaria in quanto i miei avversari di Milano devono occuparsi di problemi societari e personali molto più pressanti (fra cui il regolamento finanziario con cui Inge, sborsando molti milioni di dollari, taciterà Sibilla Melega, ultima moglie dell’editore). In concreto la Società editrice ora accetta la transazione che io ho proposto alla fine del 1969 e che sarà eseguita, causa i tempi tecnici, alla fine del 1972.
E.L. – Toglimi una curiosità. Ti tenta mai l’idea di riaprire quel caso?
D’A – Vuoi scherzare? Solo per la verità storica, niente altro, sto citando l’insieme dei fatti che fanno luce sul ruolo di Inge nella vita di Feltrinelli. Anzi, colgo qui l’occasione per dichiarare, a scanso di equivoci, che dalla Società editrice io non pretenderò mai neanche un centesimo. A nessun titolo.
E.L. – Bene, torniamo allora all’impegno di Feltrinelli nel Terzo Mondo. Eravamo rimasti al suo incontro con Arafat.
D’A – Poco dopo quell’incontro l’editore milanese intraprende una missione anomala. Vola in Bolivia, portandosi molto denaro ritirato da un suo conto a New York, nel tentativo di aiutare in qualche modo il Che Guevara braccato nella giungla e l’intellettuale Régis Debrais rinchiuso in carcere. Si sistema in un albergo di la Paz, dove si fa raggiungere dalla moglie Sibilla Melega, ma qualcosa in cui sperava, forse un contatto con qualcuno, non funziona. Le faccenda si potrebbe mettere molto male e invece, buon per lui e Sibilla, si conclude con qualche interrogatorio e l’imbarco forzato su un aereo in partenza dal paese. A questa avventura, comunque, fa seguito un’improvvisa svolta nella visione strategica di Feltrinelli.
E.L. – In che senso?
D’A – Nel senso che Feltrinelli, appena rimpatria dalla Bolivia, concentra la sua attenzione sui prodromi del Sessantotto italiano: manifestazioni studentesche con qualsiasi possibile motivazione, occupazioni di parecchie università, violente proteste antiamericane sullo spunto della guerra del Vietnam e del colpo di Stato in Grecia, scontri fra militanti di sinistra e di destra. Quanto a lui basta per illudersi che anche qui possano funzionare i modelli insurrezionali delle aree sottosviluppate.
E.L. – E quando passa all’applicazione di questa teoria?
D’A – Quasi subito. Per cominciare sceglie la Sardegna, con l’esplicito obiettivo di trasformarla nella “Cuba del Mediterraneo”, facendo levasoprattutto su separatismo e banditismo, due fenomeni locali che spesso si integrano. Ad essi dà manforte sia con finanziamenti generosi sia con forniture di armi, apparecchi per telecomunicazioni e altri materiali utilizzabili per la guerriglia. Con il risultato di contribuire per qualche anno (promovendo anche la costituzione di un “Fronte rivoluzionario sardo per il comunismo”) a scatenare una fitta successione di gravi e gravissimi disordini, incluso perfino il sabotaggio di manovre militari. Inoltre, fin dai primi mesi del 1968, quando le agitazioni degli studenti e degli infiltrati di vario colore si inaspriscono e dilagano in tutto il territorio nazionale, Feltrinelli si convince che in Italia sia imminente un colpo di Stato ordito da CIA, NATO, grande industria e alta finanza.
E.L. – Una ragione di più, immagino, per spingerlo a stringere i tempi dell’azione rivoluzionaria.
D’A – Infatti dal 1968 e soprattutto nel 1969 (l’ anno delle bombe “rosse” e “nere” che in molte parti del paese prendono di mira sedi e simboli istituzionali, banche, borse, esposizioni industriali, stazioni ferroviarie, treni e tralicci elettrici) Feltrinelli avvia e intensifica la frequentazione e il finanziamento di vari gruppi della sinistra combattente, mette in vendita nelle sue grandi librerie apologetici opuscoli sulle guerriglie in corso nel mondo, perfino manuali per costruire bombe molotov e lanciarle con fucili a canne mozze. Per conseguenza i servizi di intelligence lo tengono d’occhio, la magistratura lo interroga e gli infligge qualche lieve condanna, la polizia compie diversi sequestri nella sue librerie, le cronache nazionali si occupano di lui sempre più spesso. Il fatto politicamente più serio, tuttavia, consiste negli attacchi che ora gli sferra la stampa del PCI.
E.L. – Perché dici che è il fatto politicamente più serio?
D’A – Da un quarto abbondante di secolo il PCI ha perseguito l’avvicinamento morbido al potere ed ha quindi avversato risolutamente qualsiasi iniziativa, fosse anche soltanto di carattere giornalistico, che intralciasse la sua marcia da una posizione “più a sinistra”. Figurarsi dunque se può tollerare che “un avventuriero dilettante” tipo Feltrinelli finanzi adesso la nascente ultrasinistra eversiva. Ma la linea morbida del PCI non nasce dal nulla. E’ in piena sintonia con una scelta strategica della politica estera sovietica. E quindi la recente svolta di Feltrinelli è vista da Mosca come uno spinoso problema.
E.L. – E lui se ne rende conto? Reagisce?
D’A – Lui ostenta disprezzo ideologico per il PCI. Accusa i dirigenti di questo partito di “ciarlatanismo ammantato di fraseologia di sinistra”. E non è tenero nemmeno con il regime sovietico che spesso identifica col capitalismo di Stato. Nello stesso tempo Inge si mostra molto costernata per tutti i rischi cui lui si espone, gli dice di essere certa che i sicari del terrorismo neofascista e di vari servizi segreti sono ormai alle sue calcagna; e lo scongiura di defilarsi, di lasciare almeno per un po’ di tempo l’Italia. Nell’autunno 1969 lui alla fine si convince, le dà ragione. Al punto da ripetere più volte agli amici fidati che presto, a Milano o nei dintorni, potrebbe essere rinvenuto il suo cadavere crivellato di colpi. Pertanto prepara il suo definitivo sganciamento dalla casa editrice (di cui conserverà solo formalmente la presidenza) con una ristrutturazione che permette ad Inge di entrare nel consiglio di amministrazione e di assumere la carica di vicepresidente.
E.L. – In pratica, insomma, lei diventa il capo dell’azienda.
D’A – Proprio così. Ad accelerare e modificare le ulteriori mosse di Feltrinelli intervengono d’altronde i fatti che si susseguono a Milano nell’ultimo bimestre del 1969: una manifestazione di operai e studenti che degenera in guerriglia con molti feriti; uno sciopero che culmina con la morte di un giovane agente di polizia colpito alla testa con un tubo di ferro; e infine la bomba che esplode – il 12 dicembre – in una grande banca del centro cittadino provocando diciotto morti e ottantotto feriti. A torto o ragione si diffonde il sospetto che dietro questi fatti possa anche esserci la mano di Feltrinelli. Un giudice ordina a titolo cautelativo il ritiro del suo passaporto e lui nello stesso giorno, con l’aiuto di un contrabbandiere, oltrepassa la frontiera svizzera, deciso a vivere in clandestinità.
E.L. – Clandestinità, se non sbaglio, con molti aspetti donchisciotteschi. Non è questo il momento in cui Feltrinelli vuole tramutarsi da sostenitore di guerriglie in guerrigliero sul campo?
D’A – Certo. Infatti comincia subito a reclutare una sua milizia con il vecchio nome di Gruppi di azione partigiana (GAP) che deve essere pronta nella prossima primavera quale componente dell’Esercito internazionale proletario. Stabilisce che almeno all’inizio, poi si vedrà, il suo principale campo d’azione sarà l’Italia, dove ogni tanto rientrerà, sempre da clandestino, nonostante che il ritiro del suo passaporto venga revocato in febbraio. Vede tutto facile, si monta ancor di più la testa, scrive e pubblica addirittura un opuscolo sull’ordinamento della società postcapitalistica: quella di cui, anche se non lo dice apertamente, si sente il capo futuro. Il 12 marzo Inge, che spesso va a trovarlo, spiega all’ad e al direttore generale della casa editrice, entrambi sinceramente affezionati a Feltrinelli e angosciati per le sue gesta spericolate, che ormai non c’è nulla da fare. “Nessuno può più capirlo… he’s lost [è perduto]” scriverà nel proprio diario. E l’ad lancia l’idea che per salvarlo conviene farlo arrestare.
E.L. – Lei si oppone?
D’A – Credo che semplicemente lasci cadere il discorso. Feltrinelli intanto si aggira vorticosamente in Austria, Svizzera e Francia. Abbastanza spesso, solo per motivi di militanza, mette piede in Italia (munito di documenti falsi, camuffato nei modi più fantasiosi, privo dei suoi tipici baffoni), tenendosi ovviamente alla larga dalla casa editrice e dintorni. Con Inge, che di solito gli porta il figlio ancora bambino, si vede assiduamente in vari luoghi del suo esilio fino a poco prima della fine. E con Sibilla, che per stargli più vicina si è scelta come base un panfilo ormeggiato in Costa Azzurra, trascorre qualche periodo di riposo in una sua villa fra i boschi della Carinzia o fissa improvvisati appuntamenti qua e là: ma non oltre la primavera del 1971, quando lei, non sopportando più le scelte esistenziali del marito, troverà a Roma un nuovo interesse sentimentale.
E.L. – Ma in concreto, a parte i finanziamenti ai gruppi della sinistra armata in Italia e magari in altri paesi europei, quante e quali sono le azioni compiute da Feltrinelli in questa fase finale delle sue avventure? Parlo di azioni eversive.
D’A – Poche e di pochissima rilevanza: messaggi “Radio GAP” che utilizzano apparecchiature tedesche ottenute per vie traverse e talvolta interferiscono con qualche trasmissione televisiva in aree dell’Italia settentrionale; attentati dinamitardi senza serie conseguenze a Milano e dintorni contro cantieri edili dove si sono verificati infortuni sul lavoro e contro imprese appartenenti a sostenitori di formazioni neofasciste. Una delle ultime azioni, una rapina al casino di Saint Vincent, resta allo stato di progetto in considerazione delle scarse probabilità di riuscita. In sostanza Feltrinelli, sempre più dominato dall’ambizione di emergere come grande teorico e capo rivoluzionario, è schiavo di un tragico gioco. Scrive scombinate risoluzioni strategiche, acquista in Svizzera e a Milano appartamenti da usare come covi per i militanti dei GAP; organizza esercitazioni con pistole, fucili e bombe a mano, sottoponendo se stesso e uno sparuto gruppetto di seguaci a esercizi faticosi, a digiuni, perfino all’ingestione di cibi avariati; e infine, per darsi l’aspetto del guerrigliero sul campo, si lava sempre di meno. Una volta Inge, tornando da uno degli incontri con lui, di dice impressionata per averlo trovato molto magro e coi denti ingialliti.
E.L. – Finché nel marzo 1972 il suo tragico gioco finisce all’improvviso…
D’A – All’improvviso e in modo imprevedibile. Il 13 di quel mese, come viene annunciato con largo anticipo, il PCI aprirà a Milano il suo XIII Congresso, destinato a concludersi al quinto giorno con l’elezione di Berlinguer alla carica di segretario generale del partito. Feltrinelli decide subito di intralciare l’evento provocando un massiccio black out della città. A questo scopo ripartisce i suoi Gap in otto piccoli commandos, uno dei quali guidato da lui, con il compito di far saltare simultaneamente altrettanti tralicci dell’alta tensione situati, a molta distanza l’uno dall’altro, nella campagna milanese. Per l’attuazione del piano sceglie la tarda sera del 14. Ma salta l’appuntamento e non salta nessun traliccio. Tutti i commandos, escluso quello formato da lui e altri due uomini, disertano.
E.L. – Quindi Feltrinelli è caduto in una trappola ben predisposta. E’ stato vittima di un vero e proprio complotto, non di un semplice incidente.
D’A – Questo e certo, ma lui non farà in tempo a saperlo. In qualche modo è ferito dall’esplosione di una carica e muore dissanguato ai piedi del traliccio mentre i suoi accompagnatori fuggono con il furgone usato per arrivare sul posto. Il suo cadavere viene scoperto da alcuni contadini nel pomeriggio del 15 e, siccome ha indosso documenti falsi, gli inquirenti non riescono a identificarlo prima della mattina del 16. La successiva inchiesta giudiziaria finisce con l’archiviazione per insufficienza di prove e in giro restano tutte le possibili voci sull’identità dei responsabili: neofascisti, comunisti, servizi segreti italiani, KGB, CIA.
E.L. – Sai se Inge ha fatto qualche ipotesi?
D’A – Francamente no. So soltanto che la mattina del 15 marzo, ossia all’indomani dell’esplosione sotto il traliccio, lei parte per Lugano insieme con il figlio e un notaio, spiegando all’ad della società editrice che Feltrinelli le ha dato appuntamento in quella città alle ore tredici dello stesso giorno per la stesura di un atto riguardante una sua villa in Italia. Poche ore dopo, nel tardo pomeriggio del 15, lei rientra a Milano. Con aria sconvolta informa l’ad, presenti altre persone, che Feltrinelli non si è presentato all’appuntamento; ed aggiunge che lui non si sarebbe mai comportato così, tanto meno potendo incontrare il figlio, se non gli fosse successo qualcosa di terribile.
E.L. – Tutto ciò è strano…
D’A – Stranissimo. Possibile che Feltrinelli abbia nascosto ad Inge, pur considerandola fino all’ultimo la sua compagna rivoluzionaria, quell’attentato dinamitardo che progettava da un po’ di tempo? Possibile che Feltrinelli le abbia dato appuntamento a Lugano, per una pratica notarile, solo poche ore dopo l’attentato? O che non abbia avuto modo di disdire l’appuntamento se per qualche imprevista evenienza fosse stato spostato il giorno dell’operazione? Io penso che in realtà Inge abbia messo in scena l’appuntamento di Lugano per far testimoniare, se mai fosse stata sfiorata da qualche sospetto nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria, che lei non sapesse nulla dell’attentato in preparazione e quindi non potesse essere accusata di omessa denuncia o di complicità.
E.L. – Bene, siamo arrivati alla fine di questa storia. Ora ti chiedo di concludere l’intervista con una valutazione sintetica della vera misura in cui Inge ha inciso sulla vita di Feltrinelli e quindi sul caso Pasternak.
D’A – Fin qui io ho riferito esclusivamente fatti incontrovertibili. Sono quelli descritti in note pubblicazioni non prevenute verso i protagonisti di cui ho trattato e da loro mai contestate (ma delle quali mi impegno a precisare in questo stesso foglio, su eventuali richieste dei lettori, i titoli e le pagine). Sono i fatti provati dagli atti della mia vertenza giudiziaria, da alcuni documenti degli archivi sovietici, da numerosi articoli e commenti di grandi giornali. Ciò detto, posso dichiarare che questi fatti, ove se ne considerino coincidenze temporali e connessioni logiche, sollevano immancabilmente pesanti interrogativi.
E.L. – Precisiamoli.
D’A – Primo: E’ stata Inge, per via diretta o indiretta, per convinzione ideologica o voglia di ricchezza, ad accettare l’incarico di manipolare psicologicamente Feltrinelli con l’intento di farne un finanziatore di guerriglie? Ossia è stata lei a rendersi corresponsabile, sia pure moralmente, della fine dell’editore milanese?
E.L. – E il secondo interrogativo?
D’A – E’ stata Inge, nel corso della mia vicenda giudiziaria con la società editrice, a governare il coordinamento di Milano con Mosca in un carosello di spie sovietiche, documenti truccati, false testimonianze e tentativi di intimidazione nei miei confronti? Ossia è stata lei ad impedire l’istituzione di un premio Pasternak e ad assicurarsi per giunta quel nuovo e più vantaggioso contratto editoriale che l’autore non avrebbe mai firmato?
E.L. – Chiaro, anzi chiarissimo. Grazie a te anche a nome dei miei amici.
D’A – Grazie a te

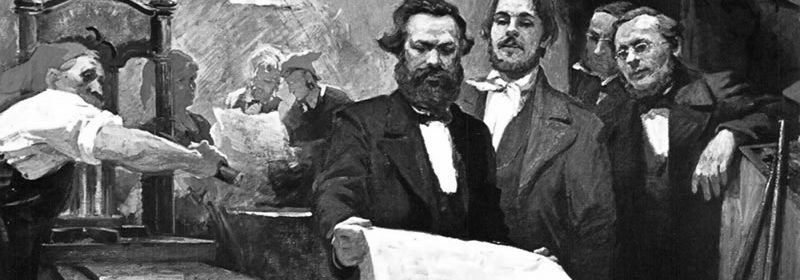











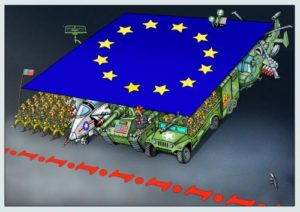 L’Europa e il progetto degli Stati Uniti d’America
L’Europa e il progetto degli Stati Uniti d’America Dal progetto UE della fase monocentrica al progetto Nato della fase multicentrica
Dal progetto UE della fase monocentrica al progetto Nato della fase multicentrica




