ESONOMIA, di Pierluigi Fagan



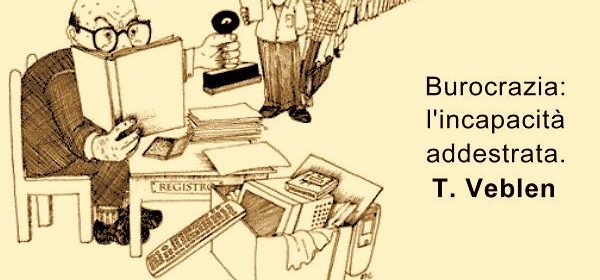
PRESCRIZIONE E BUROFILIA (II)
Aveva la vista lunga Giustino Fortunato, quando, oltre un secolo fa, sintetizzò il programma dei socialisti suoi contemporanei nello slogan “le terre ai contadini, le fabbriche agli operai, gli uffici agli impiegati”. Nel secolo passato sono venute meno le prime due rivendicazioni. La terra ai contadini, perché con la riforma agraria dei governi De Gasperi (soprattutto, ma non solo) il latifondo fu espropriato e le terre distribuite, onde la rivendicazione è cessata. Anche le fabbriche agli operai non è più d’attualità: un po’ perché di operai ce ne sono assai di meno, ma soprattutto per scarsità delle fabbriche le quali in gran parte, nell’ultimo trentennio, sono state delocalizzate in paesi dalla manodopera più economica e dal fisco meno rapace. Resta, anzi è incrementata, la terza, cioè la patrimonializzazione surrettizia degli uffici, non nelle forme delle società feudali, con le funzioni pubbliche conferite (appaltate, vendute) ai privati (che in tali casi, almeno, ne sopportavano i costi, oltre a percepirne i benefici); ma attraverso la riduzione delle responsabilità del funzionario (disciplinare ma soprattutto patrimoniale) il boicottaggio legale delle pretese dei cittadini danneggiati da atti illegittimi, la compiacenza politica e talvolta giudiziaria nei confronti dei comportamenti delle PP.AA.. Ma soprattutto, come spesso scrivo, dalla disparità – processuale e sostanziale – tra cittadino e P.P.A.A..
Fortunato avvertiva a cosa avrebbe portato l’andazzo, in gran parte confermato a distanza di oltre un secolo: che non è solo un problema di diritti lesi, ma anche di ordinamento dello Stato. Scrive l’economista lucano: “non è punto immaginario, di avere, un giorno, i pubblici poteri a disposizione de’ funzionari contro l’interesse della collettività” e “noi, vecchi liberali, crediamo ancora di parlare, come già i partiti storici della Destra e della Sinistra, in nome del popolo, ossia, secondo il significato classico della parola, in nome della universalità de’ cittadini” mentre i socialisti impiegano “le maggiori energie a vantaggio degl’impiegati dello Stato; e assumendone ufficialmente il patrocinio, mettendosi a capo di tutto il movimento burocratico”. La burocrazia “non concepì i servizi amministrativi se non immaginandoli pari a quelli di una macchina, che dovesse agire per solo uso e consumo de’ suoi congegni, nel particolare esclusivo interesse di coloro che vi fossero addetti, – la macchina per la macchina, l’ultima forma, e la più bizzarra, di un nuovo assolutismo di classe” (il corsivo è mio); e questo implica “la tendenza al dominio universale della burocrazia, – il cui trionfo sarebbe la resurrezione, sott’altra forma, dell’antico assolutismo, o, meglio, della peggiore delle tirannie, quella della servilità uniforme e meccanica”.
Dato, quindi, che tra i principi dello Stato borghese c’è che la funzione pubblica è nazionalizzata e pertanto tutti i poteri pubblici non sono appropriabili, ottundere e ridurre, escludere le correlative responsabilità e doveri è difficile.
Ma lo si è fatto, in particolare in Italia, come constatava (e prevedeva) Fortunato sia attraverso normative apposite, sia con comportamenti compiacenti ed assolutori.
Per la prescrizione la normativa non è del tutto favorevole alla P.A., e comunque la possibilità di sanzionare i funzionati inerti c’è, anche se di attivazione non facile; pertanto occorre ai burofili, come è stato fatto, cambiare il bersaglio: dal funzionario pigro al contribuente fetente. Proprio cioè il contrario di quello che succederebbe in un’impresa privata: nella quale un impiegato che, incaricato di recuperare i crediti, li facesse prescrivere, sarebbe licenziato subito e magari gli sarebbe richiesto di rifondere i danni. Nella seconda repubblica, le privatizzazioni hanno imperversato, ma spesso a chiacchiere, perché in tanti casi, come questo, i comportamenti sono stati opposti; la burofilia continua ad imperversare. E il potere non ha di meglio per occultare prassi complici o, nel migliore dei casi, fiacche e di prendersela, come il re di G.G. Belli con i vastalli buggiaroni, colpevoli di tutto. E quindi da punire, anche con la forca perché il potere, come il sovrano del poeta “la vita e la robba ve l’affitto”.
L’unico tentativo per far cessare queste mistificazioni è non fare come i sudditi nel sonetto, che rispondono, inconsapevoli, “è vero è vero”.
Teodoro Klitsche de la Grange

Qui sotto un interessante articolo grazie al quale l’autrice Claire Vergerio si pone e ci pone alcuni quesiti riguardo la genesi e il futuro degli stati-nazione. Nel saggio l’accademica ha acquisito un merito particolare nel sottolineare due aspetti spesso trattati nella saggistica, ma altrettanto spesso rimossi sia nella ricerca scientifica che ancor di più nello strumentario ideologico degli attori politici:
Una istituzione, quindi, destinata a decadere, come parrebbe in questa fase storica e a morire in un qualche tempo futuro.
Il merito della saggista, tuttavia, si esaurisce rapidamente in questo.
Il suo atteggiamento “aperto” ed attendista riguardo alla probabile e databile fine storica dello stato-nazione prescinde da troppi dati di natura empirica e di analisi qualitativa che fanno propendere invece per una trasformazione delle modalità di esercizio ed un allargamento spaziale ed intensivo delle prerogative statali piuttosto che per una sua paralisi ed estinzione in tempi storici verosimili.
Lo stato-nazione è l’unica istituzione che a tutt’oggi riesce a concentrare, delimitare territorialmente ed estendere l’esercizio del potere politico nei vari ambiti dell’attività sociale umana, da quello duro dell’esercizio della forza e dell’ordine pubblico, a quello culturale ed identitario necessario alla rappresentazione di una realtà credibile e motivante, a quello infine economico sia per vie normative che per intervento diretto. Le altre forme di esercizio del potere, connaturato per altro alla società, assumono un carattere derivato (le organizzazioni internazionali), un ambito particolare di intervento (le ONG, le Multinazionali, ect), una modalità di esercizio meno sofisticata ed adattabile nella sua efficacia (sistemi tribali, imperiali, ect.); caratteristiche peculiari per ciascuna di esse o combinate parzialmente.
In meno di un secolo gli stati, in particolare gli stati-nazione, hanno infatti proliferato a dismisura a seguito della caduta degli imperi, del processo di decolonizzazione con classi dirigenti locali formatesi per lo più in qualche maniera su modelli occidentali, dell’implosione del sistema sovietico.
In questo processo non mancano certo situazioni di crisi, di collasso e di riconfigurazione degli stati.
In esso agiscono tendenze pervasive e di lungo periodo, come l’evoluzione demografica, gli sviluppi tecnologici, la capacità di adattamento culturale le quali rendono sempre più complessi la gestione amministrativa e l’esercizio del potere su vasti territori. In controtendenza sono però proprio la ricerca di potenza e di efficacia, lo sviluppo tecnologico ad essa connessa con il corollario delle risorse necessarie, a richiedere maggiori dimensioni territoriali e demografiche degli stati, tanto più che l’azione geopolitica di questi, di offesa e di difesa, si può risolvere sempre meno a ridosso dei propri confini territoriali.
All’interno di esse agiscono le contingenze politiche e geopolitiche; di fatto la particolare conformazione territoriale degli stati seguita ai processi di decolonizzazione e di dissoluzione degli imperi, la risoluzione contingente dei rapporti di forza geopolitici, la capacità di azione e coesione delle classi dirigenti locali, il dogmatismo ideologico (ad esempio l’applicazione pedissequa dei principi democratici occidentali a società claniche e tribali).
La Vergerio non è la sola a smarrirsi su questa strada; perché non è la sola a dibattersi in un equivoco ricorrente. Al contrario si trova in buona compagnia di una folta schiera di studiosi ed attori politici anche ben più affermati.
Non è lo Stato, al pari di altre istituzioni e strutture quali le multinazionali, le ONG a muovere e sfruttare le dinamiche politiche. Sono i centri decisionali che operano all’interno di esse ad operare in cooperazione e in conflitto tra di loro; più questi centri sono ramificati e riescono ad agire nei vari ambiti e apparati dell’attività socio-politica, più hanno probabilità di essere incisivi ed efficaci; sempre che dispongano dell’intuito e dell’intelligenza necessari a cogliere, orientare e cavalcare l’onda. Coloro che riescono ad agire e muovere gli apparati statali o parti essenziali di essi godono di un particolare vantaggio difficilmente scalfibile se non in una situazione di disgregazione e di declino se non di collasso vero e proprio.
Ogni istituzione, siano esse imprese o stati o clan, per reggersi ha bisogno che i centri decisionali coltivino i necessari processi identitari tesi a garantire coesione e motivazione. Lo stato nazionale, per la sua complessità, ancora più degli altri anche se spesso in maniera più sofisticata ed indiretta. Non si tratta quindi di privilegiare ed individuare in assoluto una forma stato rispetto ad un’altra, quanto di adottare quelle particolarità necessarie a garantire coesione ed efficacia rispetto al campo di azione e all’agone nel quale si vuole o si è costretti ad agire. Su questo ha ragione la Vergerio. Ma è lo Stato Nazionale ad essere ancora, in tempi storici ragionevoli, lo strumento e il luogo di elezione della contesa politica. Più riuscirà a preservare questo carattere, più i centri potranno agire con l’incisività e la tempestività richieste da una competizione sempre più accesa e conflittuale. In questo quadro vanno considerati i temi legati al conflitto sociale, all’eguaglianza, al dinamismo e alla coesione propri ormai non solo di specifici settori politici; con quel parametro devono misurarsi le forze politiche e le élites che fanno degli interessi popolari la ragione della loro azione per avere qualche probabilità di successo.
Con ritardo e con parecchie armi ed argomenti ormai spuntati sembrano essersi accorti di questo anche in Occidente, annaspando qua e là e senza offrire qualcosa di coerente e propositivo e soprattutto incapaci di propinare quella medicina o placebo rassicuranti rappresentati dal successo garantito. I più convinti assertori del buon governo mondiale, tra di essi Habermas, lo hanno sempre affermato: il fondamento sul quale può basarsi un governo mondiale sono pochi principi rarefatti interpretati da pochi saggi. Di fatto il vuoto inquietante così distante da quella democrazia dei quali si ergono a paladini. Buona lettura_Giuseppe Germinario
La mitologia della Westfalia, che ha fatto dello stato sovrano il fondamento naturale dell’ordine politico, ha danneggiato la governance globale. Per evitare che i nazionalisti si impadroniscano di questa rappresentazione carente, dobbiamo tornare alla storia per capire quanto sia recente questo paradigma; questa divagazione offre strade per pensare oltre e riscoprire una capacità di immaginazione.
Una delle affermazioni più ripetute sulla politica internazionale riguarda il passaggio da un’era “westfaliana” a un’altra “post-westfaliana”. Molti autori, ricercatori o giornalisti, utilizzano questo quadro teorico per interrogarsi sugli aspetti essenziali di ciò che ci aspetta: quali responsabilità dovrebbero avere le multinazionali nei confronti dei diritti umani1 ? Come si svilupperà la guerra nel ventunesimo secolo?2 Le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o l’Unione Europea diventeranno sempre più autoritarie?
L’ordine della Westfalia vede la politica mondiale come un sistema di stati sovrani indipendenti, tutti uguali davanti alla legge. Il resoconto più popolare di questo sistema politico mostra come trasse le sue origini dalla pace di Westfalia nel 1648, si rafforzò in Europa, si diffuse gradualmente nel resto del mondo, per mostrare infine, al termine del XX secolo e all’inizio di questo, segni di imminente declino. Per coloro che condividono questa prospettiva, gran parte del potere che gli Stati un tempo possedevano è stato ridistribuito a varie istituzioni e organizzazioni non statali – che si pensi a organizzazioni internazionali ben note come l’ONU, l’UE o l’Unione Africana, a organizzazioni violente di attori non statali come ISIS, Boko Haram o i talebani, o ad aziende che beneficiano dell’influenza economica globale come Facebook, Google o Amazon. Questa situazione, si sostiene generalmente, si tradurrà in un ordine politico internazionale che assomiglierà all’Europa medievale più che al sistema politico mondiale del ventesimo secolo.3.
Ci sono disaccordi su cosa significhi questo ordine “post-westfaliano”. La questione se sia auspicabile o meno che le organizzazioni internazionali possano intervenire negli affari di Stato è una fonte inesauribile di dibattito. Eppure c’è un vasto consenso sugli eventi della narrazione che ci hanno portato alla situazione attuale. In breve, l’idea westfaliana offre alle analisi dominanti le basi su cui costruire la loro descrizione della politica internazionale.
Il problema con questa rappresentazione è che molto di ciò che racconta è profondamente imperfetto. Negli ultimi due decenni, gli studiosi che lavorano sulla storia dell’ordine internazionale hanno mostrato meticolosamente la disconnessione tra la narrativa della Westfalia e le prove storiche. Lo stato-nazione non è così antico e il suo emergere non è così naturale come spesso si afferma. Comprendere correttamente questa storia significa che abbiamo bisogno di creare un’altra narrazione delle origini del nostro ordine politico internazionale, che ci porti anche a presentare un altro possibile futuro.
Negli ultimi due decenni, gli studiosi che lavorano sulla storia dell’ordine internazionale hanno mostrato meticolosamente la disconnessione tra la narrativa della Westfalia e le prove storiche. Lo stato-nazione non è così antico e il suo emergere non è così naturale come spesso si afferma.
CLAIRE VERGERIO
Queste domande sono cruciali oggi. Mentre il periodo successivo alla Guerra Fredda ha effettivamente consentito l’ascesa di organizzazioni non statali, negli ultimi anni vari leader politici di destra hanno rafforzato la tesi dell’influenza dello stato-nazione. A causa dello spettacolare ritorno del nazionalismo – dalla Brexit a Donald Trump, passando per l’ascesa al potere di Narendra Modi, Jair Bolsonaro o Viktor Orbán – alcuni hanno persino ipotizzato che, dopotutto, l’ultima ora dell’ordine della Westfalia potrebbe non essere arrivata , mentre altri sostengono categoricamente che questo fenomeno sia stato solo l’ultimo spasmo di un sistema morente. Comprendere la storia del sistema internazionale ha implicazioni cruciali per entrambe le posizioni.
A generazioni di studenti di relazioni internazionali è stato ripetutamente detto che fu la Carta paneuropea della pace di Westfalia nel 1648 a creare la struttura politica che ora si trova in tutto il mondo: un sistema statale con sovrani uguali, se non materialmente, almeno in legge. Con questa struttura politica, continua la narrazione, sono emerse altre caratteristiche essenziali, come la dottrina del non intervento, il rispetto dell’integrità territoriale, la tolleranza religiosa, o la consacrazione degli equilibri di potere e l’emergere di una diplomazia europea multilaterale. Pertanto, la pace di Westfalia non è solo una pietra miliare cronologica ma, per così dire, un’ancora per il nostro mondo moderno. Con Westfalia l’Europa entra rumorosamente nella modernità politica e offre il suo modello al resto del mondo.
Negli ultimi decenni, studiosi che lavorano sulla storia dell’ordine internazionale – in una varietà di discipline, tra cui la storia globale, le relazioni internazionali e il diritto internazionale – hanno dimostrato che questa narrativa tradizionale non è solo falsa, ma anche diametralmente opposta alla realtà storica. L’articolo di Andreas Osiander, “Sovranità, relazioni internazionali e mito della Westfalia”, probabilmente l’esempio più ampiamente riconosciuto di questo sforzo di lottare con idee preconcette, è stato pubblicato ormai vent’anni fa.4. Come hanno sottolineato questi studiosi, i Trattati di pace di Westfalia, che posero fine alla Guerra dei Trent’anni (1618-1648) che devastò l’Europa, non menzionano né la sovranità statale né il principio di non intervento, né tanto meno la volontà di riorganizzare il sistema politico europeo. Lungi dal sancire il principio di tolleranza religiosa, più spesso conosciuto sotto i termini di cuius regio eius religio (“a tale principe, tale religione”), che fu messo in atto dal Trattato di Augusta nel 1555, questi trattati lo misero in discussione, giudicando che fosse stato una fonte di instabilità. Inoltre, i trattati non menzionano mai il concetto di equilibrio di potere. In realtà, la pace di Westfalia rafforza un sistema di relazioni che, appunto, non erafondato sul concetto di Stato sovrano, ma al contrario sulla riaffermazione del complesso sistema giuridico ( Landeshoheit ) di cui godeva il Sacro Romano Impero e che autorizzava unità politiche autonome a formare un conglomerato più ampio (“l’Impero”) senza avere un vero governo centrale.
Parte dell’attuale confusione è che tutti i principali trattati di pace firmati nel 1648 sono stati riuniti sotto un unico nome. Quello che spesso chiamiamo Trattato di Westfalia si riferisce in realtà a due trattati: firmati tra maggio e ottobre 1648; si trattava di accordi tra il Sacro Romano Impero e i suoi due principali avversari, ovvero la Francia (Trattato di Münster) e la Svezia (Trattato di Osnabrück). Ciascun trattato riguardava principalmente gli affari interni del Sacro Romano Impero e gli scambi territoriali bilaterali minori con la Francia e la Svezia. Oltre a questi due accordi, c’era anche un altro Trattato di Münster tra Spagna e Paesi Bassi, firmato nel gennaio dello stesso anno e che poneva fine alla guerra degli ottant’anni; ma questo precedente accordo non ha quasi alcun legame con i trattati del Sacro Romano Impero.
Al di là di questa confusione, come ha potuto questa narrazione fuorviante diventare così popolare? La mitologia di questi trattati non prese piede completamente fino all’inizio del XIX secolo, poiché gli storici europei guardavano ai tempi moderni per fabbricare resoconti che sostenessero la loro visione del mondo. Come hanno spiegato i ricercatori Richard Devetak5 e Edward Keene6, gli storici conservatori di questo periodo (in particolare quelli della scuola storica tedesca di Göttingen) volevano dipingere il periodo pre-1789 del continente europeo come un sistema ordinato di stati, caratterizzato da moderazione e rispetto reciproco, e che era stato minacciato dall’imperialismo espansionista di Napoleone. Questa reinvenzione della moderna storia europea faceva parte di un progetto più ampio e ora ben studiato per presentare l’ascesa di un sistema internazionale e di una potenza europea globale in modo tale da sembrare il risultato di un processo lineare, inevitabile e prezioso.7. Gli europei, continua questa storia, furono gli unici ad essere moderni nella loro organizzazione politica, e la donarono al resto del mondo.
Al di là di questa confusione, come ha potuto questa narrativa fuorviante diventare così popolare? La mitologia di questi trattati non prese piede completamente fino all’inizio del XIX secolo, poiché gli storici europei guardavano ai tempi moderni per fabbricare resoconti che sostenessero la loro visione del mondo.
CLAIRE VERGERIO
Come spiega Osiander, è riciclando la propaganda del diciassettesimo secolo che la pace di Westfalia ha avuto un posto d’onore in questa nuova narrativa storica. Nella ricerca sulla storia degli stati che lottano per la sovranità contro il dominio imperiale, gli storici del diciannovesimo secolo hanno trovato esattamente ciò di cui avevano bisogno nei discorsi anti-asburgici che erano stati diffusi dalle corone francese e svedese durante la Guerra dei Trent’anni.
Gli storici del ventesimo secolo hanno ulteriormente approfondito questo resoconto. Come spesso accade con i miti fondatori, un articolo sembra essere stato particolarmente influente, soprattutto nel campo delle relazioni internazionali e del diritto internazionale: il saggio di Leo Gross “The Peace of Westphalia: 1648-1948”, pubblicato nel 1948 nella Rivista americana di diritto internazionale8. Dichiarato “senza tempo” e “precursore” all’epoca, l’articolo celebrava l’emergere dell’ordine del secondo dopoguerra stabilendo una prestigiosa genealogia. Confrontando la Carta delle Nazioni Unite del 1945 con il Trattato di Westfalia, Gross ha ripreso la narrativa dei trattati che reinventano la sovranità nazionale e quindi consentono libertà, uguaglianza, non intervento e tutte le altre presunte virtù. Ha notato, tuttavia, che il testo dei trattati difficilmente rifletteva queste idee, ma ha fatto appello ai principi generali che secondo lui dovrebbero essere alla base di questi accordi. Coloro che, dopo di lui, citarono la sua opera, continuarono la costruzione del mito: nella migliore delle ipotesi, scelsero alcune clausole sugli affari interni del Sacro Romano Impero e le brandirono come le basi di un nuovo ordine paneuropeo.
Sono giunto alla seguente conclusione: il mito è sopravvissuto principalmente perché gli sforzi per confutarlo non sono riusciti a fornire una narrativa alternativa chiara e avvincente. La soluzione alla debacle della Westfalia sarebbe quindi quella di presentare una narrazione alternativa con più accuratezza storica, che riflettesse il processo molto più complesso che ha portato al moderno ordine internazionale.
Ecco, ad esempio, una storia che, sebbene incompleta, è più accurata. Fino alla fine del XIX secolo, l’ordine internazionale era basato su un mosaico di diverse entità politiche. Sebbene si faccia spesso una distinzione tra il continente europeo e il resto del mondo, lavori recenti ci ricordano che anche le entità politiche europee erano relativamente eterogenee fino alla fine del XIX secolo. Mentre alcune di queste comunità politiche erano stati sovrani, altre includevano formazioni composite come il Sacro Romano Impero e la Repubblica delle Due Nazioni (che includevano la Polonia e il Granducato di Lituania), all’interno delle quali i diritti sovrani erano divisi in modi complessi.
In effetti, molto di ciò che diamo per scontato sulla normale organizzazione del sistema internazionale è relativamente recente. Fu solo nel diciannovesimo secolo che lo stato sovrano divenne la norma, poiché entità come il Sacro Romano Impero lasciarono gradualmente il posto a stati sovrani come la Germania. È spesso dimenticato, ma anche l’America Latina ha vissuto durante il periodo una transizione verso un sistema di stati sovrani, in seguito alle sue successive rivoluzioni anticoloniali. Questo sistema divenne in seguito l’ordine di default internazionale attraverso la decolonizzazione negli anni ’50 e ’70, quando gli stati sovrani sostituirono gli imperi in tutto il mondo. Durante questa transizione, sono state prese in considerazione varie possibilità alternative, in particolare – fino agli anni Cinquanta – forme di federazioni e confederazioni che da allora sono in gran parte scomparse. Negli ultimi decenni, lo Stato non solo ha trionfato come unica parte legittima del sistema internazionale, ma ha anche plasmato il nostro immaginario collettivo in modo tale che siamo convinti che questa sia stata la norma dal 1648.
Negli ultimi decenni, lo Stato non solo ha trionfato come unica parte legittima del sistema internazionale, ma ha anche plasmato il nostro immaginario collettivo in modo tale che siamo convinti che questa sia stata la norma dal 1648.
Fino al 1800, tutta l’Europa a est del confine francese non assomigliava per niente a quella che è ora. Come descrive lo storico Peter H. Wilson nel suo recente libro Heart of Europe (2020), il Sacro Romano Impero, a lungo snobbato dagli storici degli stati-nazione, aveva allora mille anni.9. Al suo apice, rappresentava un terzo dell’Europa continentale. Continuerà ad esistere per altri sei anni prima della sua dissoluzione sotto la pressione delle invasioni napoleoniche e la sua temporanea sostituzione con la Confederazione del Reno (1806-1813), sotto la dominazione francese, poi dalla Confederazione germanica (1815-1866).
Quest’ultima era per molti versi simile al Sacro Romano Impero e difficilmente somigliava a uno stato-nazione. Gran parte del suo territorio si sovrapponeva – in modo cosiddetto “premoderno” – al territorio della monarchia asburgica, altro “stato composito” che iniziò il suo processo di accentramento prima del Sacro Romano Impero ma che, fino alla fine dello stesso diciannovesimo secolo somigliava poco a uno stato-nazione. Si consolidò e terminò nell’impero austriaco (1804-1867), poi nell’impero austro-ungarico (1867-1918); ma l’accordo del 1867 concesse all’Ungheria una notevole autonomia e di fatto la autorizzò a governare il proprio piccolo impero. Intanto, più a sud, quella che chiamiamo Italia era ancora un insieme di regni (Sardegna, Due Sicilie, Lombardo-Veneto sotto l’autorità della corona austriaca), ducati (in particolare Parma, Modena e Toscana) e stati pontifici, mentre i territori più a est erano governati dall’Impero ottomano. Fu solo verso la metà del XIX secolo che la mappa dell’Europa iniziò ad assomigliare a un gruppo di stati-nazione: Belgio e Grecia apparvero nel 1830, mentre l’unificazione italiana e tedesca non furono completate che solo nel 1871.
Siamo abituati a pensare all’Europa come al primo esempio storico di un sistema di veri Stati sovrani, ma in realtà l’America Latina è arrivata a questa forma di organizzazione politica nello stesso periodo. . Dopo tre secoli di dominazione imperiale, la regione ha visto una ridistribuzione della sua geografia politica a causa delle rivoluzioni atlantiche della fine del XVIII secolo e dell’inizio del XIX secolo. Seguendo le orme degli Stati Uniti (1776) e di Haiti (1804), conobbe una serie di guerre di indipendenza, tanto che nel 1826, con poche eccezioni, gli spagnoli e i portoghesi furono completamente espulsi. Ovviamente, La Gran Bretagna ottenne rapidamente il controllo del commercio nella regione attraverso una combinazione aggressiva di misure economiche e diplomatiche, spesso definita “impero informale”. Tuttavia, ora interagiva con stati formalmente sovrani.
Durante il resto del secolo, le strutture di sovranità federale emerse a seguito dell’indipendenza, la Grande Colombia (1819-1831), la Repubblica Federale dell’America Centrale (1823-1841) e le Province Unite del Rio de la Plata (1810-1831) – affondarono in sanguinose guerre civili che durarono per decenni, mettendo le regioni contro i governi centralizzati e portando a numerosi tentativi di ricostruire conglomerati politici più grandi. Così, come nell’Europa occidentale, non è stato fino alla fine del diciannovesimo secolo che la regione si è stabilizzata in un sistema di stati-nazione simile a quello che è oggi. Sembra ora possibile offrire una narrazione simile per il Nord America, come propone la storica Rachel St John nel suo progetto attuale,Gli Stati immaginati d’America: la storia non manifesta del Nord America del XIX secolo .
Gli imperi, ovviamente, continuarono a prosperare nonostante la crescente popolarità degli stati nazionali. Fino alla seconda guerra mondiale, il mondo era dominato dagli imperi e dalle strutture eterogenee di autorità politica che creavano. Quando la decolonizzazione iniziò dopo il 1945, lo stato-nazione non era l’unica possibilità. In Worldmaking after Empire (2019), Adom Getachew descrive il “momento federale” dell’Africa anglofona, quando i leader dei vari movimenti indipendentisti del continente hanno discusso della possibilità di organizzare un’Unione degli Stati africani nella regione e una Federazione delle Indie Occidentali nei Caraibi10. Modellandosi sugli Stati Uniti, che offrivano l’esempio di una florida federazione post-imperiale, giocarono poi con l’idea di uno Stato federale centralizzato, ma non riuscirono a mettersi d’accordo con chi preferiva una federazione meno restrittiva, che avrebbe lasciato più potere decisionale e sovranità nelle mani di ciascuno Stato.
Fino alla seconda guerra mondiale, il mondo era dominato dagli imperi e dalle strutture eterogenee di autorità politica che creavano. Quando la decolonizzazione iniziò dopo il 1945, lo stato-nazione non era l’unica possibilità.
Per quanto riguarda le colonie africane francofone, la deviazione dal modello dello stato-nazione è stata ancora più notevole. Come ha descritto Frederick Cooper in Cittadinanza tra impero e nazione (2014), il trionfo finale dello stato-nazione qui è il risultato dei disaccordi tra il governo francese nella Francia metropolitana e i leader e pensatori africani che hanno guidato il processo di decolonizzazione.- da Mamadou Dia , il Primo Ministro del Senegal, a Léopold Sédar Senghor, uno dei teorici della negritudine11. Inizialmente, la conversazione si è concentrata su formazioni politiche che non erano né imperi né stati-nazione, ma federazioni e confederazioni che vedevano la cittadinanza come un insieme di diritti che non si sovrapponevano necessariamente allo status di nazione. L’idea prevedeva una federazione di nazioni, non una federazione come nazione, come gli Stati Uniti. Ogni comunità avrebbe il proprio governo e la propria identità, ma le varie comunità agirebbero insieme e offriranno una forma condivisa di cittadinanza all’interno di uno stato multinazionale.
Questa forma di “anticolonialismo antinazionalista” si trovò infine di fronte al rifiuto del governo francese di distribuire le risorse della metropoli all’interno di una rete estesa di cittadini. Eppure dovremmo soffermarci un attimo sul fatto che se ne sia discusso seriamente. Naturalmente, nel contesto della decolonizzazione, il trionfo dello stato-nazione ha rappresentato una vittoria definitiva per i popoli colonizzati contro i loro oppressori di lunga data. Ma ha anche reciso il legame tra regioni e storie condivise e ha creato le proprie dinamiche di oppressione, principalmente per coloro a cui è stata negata l’opportunità di stabilire il proprio stato: popoli indigeni, nazioni senza stato, minoranze12. Lo strapotere di queste costruzioni statali, che hanno quasi completamente spazzato via le popolazioni indigene in insediamenti come gli Stati Uniti e l’Australia, è stato avvertito anche in situazioni in cui la costruzione dello stato era un’arma contro l’impero. Se è vero che i deboli hanno prevalso, e giustamente, a volte è stato a scapito di quelli ancora più deboli.
Poteva andare diversamente? Le analisi controfattuali sono un gioco pericoloso nel pensiero storico. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che appena settant’anni prima, quello che oggi vediamo come un modo ovvio di organizzare le comunità politiche era solo uno dei tanti disponibili nel nostro immaginario collettivo.
Quest’altro resoconto di come siamo arrivati all’ordine internazionale moderno ha importanti implicazioni sul modo in cui vediamo il passato. Ha anche gravi conseguenze per il modo in cui pensiamo al presente.
Innanzitutto, ci costringe a ripensare alle cause della stabilità internazionale. La narrativa usuale associa l’ordine internazionale all’esistenza di un sistema di stati sovrani, ma la storia alternativa suggerisce che il periodo successivo al 1648 fu caratterizzato dalla sopravvivenza di varie comunità politiche. Per quanto riguarda il continente europeo, il Sacro Romano Impero è l’esempio più eclatante di tale comunità politica, che continuò a sperimentare diverse forme di aggregazione dei diritti sovrani fino al suo crollo nel 1806. Pertanto, la relativa stabilità del periodo seguente al 1648 può essere dovuto più alla diversità delle comunità politiche nel continente che alla presunta comparsa di un sistema omogeneo di stati-nazione. Ordine internazionale nella diversità (2015)13. Questo periodo suggerisce quindi che un sistema internazionale in cui il potere è condiviso tra diversi tipi di attori potrebbe rivelarsi relativamente stabile.
La consueta narrativa associa l’ordine internazionale all’esistenza di un sistema di stati sovrani, ma la storia alternativa suggerisce che il periodo successivo al 1648 fu caratterizzato dalla sopravvivenza di varie comunità politiche.
D’altra parte, prendere sul serio questa narrativa alternativa ci costringe a ripensare a come vediamo oggi l’influenza degli attori non statali. Se si dovesse citare solo un esempio, anche le più potenti multinazionali contemporanee – Facebook, Google, Amazon, Apple e le altre – sono molto più limitate nei loro poteri formali rispetto alle famose compagnie mercantili, che furono attori centrali nel panorama internazionale ordinato fino alla metà del XIX secolo. Le due più importanti, le Compagnie delle Indie Orientali britannica e olandese, fondate rispettivamente nel 1600 e nel 1602, accumularono uno straordinario potere nei loro due secoli di esistenza, divenendo le prime promotrici dell’espansione imperialista europea.14. Quando queste società hanno iniziato come imprese mercantili che cercavano di unirsi alla redditizia rete commerciale asiatica, hanno gradualmente formato piani più ambiziosi e, dai loro avamposti in India e Indonesia, sono diventate vere comunità politiche autonome. Erano, come ora sostengono vari studiosi, “azienda-stati”, attori ibridi sia privati che pubblici, che erano legalmente autorizzati a governare su sudditi, coniare denaro e fare guerre. Da questo punto di vista, gli attori non statali contemporanei sono ancora relativamente deboli rispetto agli stati che monopolizzano ancora il potere formale più di qualsiasi altro attore del sistema internazionale.
La stratificazione della sovranità all’interno di comunità politiche come l’Unione Europea, l’emergere del potere delle multinazionali, l’importanza di gruppi violenti che non sono considerati “Stati”, nessuno di questi sviluppi è fondamentalmente in atto. hanno lavorato negli ultimi 373 anni.
L’intervista che il ricercatore di scienze politiche Francis Fukuyama ha rilasciato a Noema è rivelatrice al riguardo.15. Quando gli è stato chiesto se trovasse lo stato-nazione ora inadeguato di fronte alle questioni più urgenti del mondo, Fukuyama ha riconosciuto che tali “sfide non possono essere affrontate dai singoli stati”. Ma, ha continuato, “quante di queste sfide potrebbero essere affrontate se gli stati esistenti lavorassero insieme meglio?” “. La rivista riassume così questa prospettiva: “Di fronte alle sfide globali, lo stato-nazione è sia il problema che la soluzione”. Persino i pensatori che desiderano limitare lo stato-nazione non riescono a liberarsi dalla camicia di forza dello stato che limita l’immaginazione politica contemporanea. I dibattiti sulle istituzioni sovranazionali soffrono di un’analoga ristrettezza: dovrebbe essere concesso più potere agli Stati o alle organizzazioni internazionali, che,in definitiva , sono fondamentalmente basati su questi stessi stati? Nel bel mezzo di una crisi globale, che si pensi al COVID-19 o all’emergenza climatica, è necessario trovare possibilità alternative alle nostre visioni logore.
Quindi c’è molto di più in gioco nelle nostre discussioni sull’ordine internazionale che imbrogli sulla periodizzazione storica. La rappresentazione sbagliata della storia del sistema internazionale avvantaggia gli uomini forti del nazionalismo, che si vedono come salvare il mondo dal crollo nell’anarchia che deriverebbe dall’assenza di Stati, e dal controllo delle multinazionali che se ne fregano delle alleanze nazionali. Più in generale, comprendere bene questa storia significa impostare il quadro giusto per le nostre discussioni. Concedere il potere ad attori diversi dagli Stati non è sempre una buona idea, ma bisogna respingere il falso dilemma tra il ritorno del nazionalismo da una parte e il trionfo delle entità non democratiche dall’altra.
Quindi ora è il momento di sfruttare una comprensione più accurata del nostro passato per immaginare un futuro meno distruttivo. Avere un resoconto alternativo della nostra traiettoria in questo modo non ci offre alcuna soluzione preconfezionata, ma apre la strada a considerare un ordine internazionale che lasci spazio a una maggiore diversità delle comunità politiche e che ristabilisca l’equilibrio tra i diritti degli Stati e diritti di altre comunità. La norma oggi è che gli stati hanno molti più diritti di qualsiasi altra comunità – dai popoli indigeni ai movimenti sociali transnazionali – semplicemente perché sono stati. Ma perché questo dovrebbe essere l’unico quadro teorico per il nostro immaginario collettivo non è affatto ovvio, e tanto meno se la sua legittimità si fonda su una storia del sistema internazionale a lungo confutata. Il mito della Westfalia ha infine gravemente ostacolato la nostra capacità di immaginare in modo creativo risposte alle sfide globali che trascendono sia i confini che i livelli di organizzazione del governo, risposte che possono essere date a diverse scale, quartiere, villaggio o dalla città alle istituzioni internazionali.
Poiché il tempo che abbiamo a disposizione per immaginare modi più sostenibili di organizzare il nostro mondo sta ovviamente iniziando a esaurirsi, mettiamo fine a questo mito una volta per tutte.
La versione originale di questo articolo è apparsa sulla Boston Review .

PRESCRIZIONE E BUROFILIA
A seguire (gran parte) del dibattito sulla prescrizione, si ha l’impressione che questa sia un istituto inventato da malintenzionati (in particolare, fino a qualche anno fa Berlusconi) per evitare le giuste condanne per i reati commessi, pagando profumatamente avvocati i quali più che con i codici hanno dimestichezza col calendario e su come allungare i processi. Quasi nessuno nota che i tempi processuali si allungano – spesso – per errori degli uffici che li gestiscono.
Analogamente nessuno – o pochi pensano – che la prescrizione, pur diversamente disciplinata non è limitata al diritto ed al processo penale, ma si applica a quelli civili e, soprattutto (quel che più interessa) al diritto ed al procedimento amministrativo. Anche in tale ultimo caso a perseguire l’interesse pubblico e a dirigere il procedimento amministrativo è un funzionario, ovvero un dipendente (quasi sempre) dell’Ente. Dato che la prescrizione di una pretesa dipende dal mancato esercizio/azione/perseguimento della stessa per un determinato periodo di tempo, la suddetta inerzia è addebitabile al funzionario che aveva il dovere d’ufficio di agire per conto dell’Ente.
Quindi, avendo ogni procedimento amministrativo un funzionario responsabile c’è anche nome e cognome di chi occorre ringraziare (o meno) ove la pretesa si sia prescritta per inerzia dell’ufficio.
Inerzia che concerne un’attività semplicissima: basta inviare una raccomandata con la richiesta di adempimento per interrompere il decorso della prescrizione (che è al massimo decennale): essere inerti significa quindi omettere (per dieci anni!) qualsiasi idonea comunicazione all’obbligato.
Tale particolare è stato completamente dimenticato (mi è capitato di leggere solo un articolo di un quotidiano politicamente scorretto sulla questione). Per mesi il dibattito ricorrente, perché si riaccende ad ogni proroga della notoficazione delle cartelle esattoriali è articolato su due posizioni: i “giustizialisti” (cioè PD e 5S, ma più i primi che i secondi) i quali ricordano che vi siano qualche decina di miliardi di crediti tributari (forse oltre 100) inevasi dal 2000 in poi per colpa dei perfidi contribuenti; di rimando Salvini il quale, in nome dei tartassati contribuenti, ne propone la rottamazione con agevolazioni varie.
In realtà la questione va osservata da un’altra prospettiva, che non è (solo) quella del male o del bene, ma (anche) della colpa di chi aveva il dovere di curare l’interesse pubblico (e non l’ha fatto).
In effetti se è vero quanto affermato pubblicamente, che i crediti inevasi sono maturati dal 2000, è giusto replicare che quelli fino al 2011 sono prescritti e quindi, a meno che l’Agenzia delle Entrate non provi di aver interrotto con atto idoneo il decorso della prescrizione, sono inesigibili. Con la conseguenza duplice che porli in esecuzione significa esporre l’amministrazione ad opposizioni fondatissime, e quindi infauste per la stessa; e che i pretesi crediti non esistono più, magari da un decennio, e quindi i “dati” comunicati sono “fasulli”, relativi a pretese ormai inesigibili.
Dall’altro che ha perfettamente ragione Salvini, almeno per i prescritti, a proporne la rottamazione: a farsi pagare, anche i crediti prescritti, l’amministrazione finanziaria ha tutto da guadagnare rispetto al nulla che (ormai) le spetta. È da discutere poi per quelli non prescritti (cioè successivi al luglio 2011), ma non è tema di questo intervento.
Quel che più preme rilevare è il perché una tale (asseritamente) enorme somma non è stata richiesta. Anche perché nel periodo 2000-2011, i governi sono stati prevalentemente di centrodestra, ma col successivo sono stati tutti fiduciati dal centrosinistra (tranne il Conte 1), e c’è da capire se non sia addebitabile (anche) alla responsabilità politica di quei governi o almeno dei ministri dell’economia e delle finanze, di aver lasciato prescrivere diecine di miliardi di crediti.
Somme enormi che i “giustizialisti” vorrebbero comodamente addossare alla perfidia dei contribuenti, servendosene prima per la loro solita passerella, quali strenui difensori dell’interesse pubblico. Invece proprio per il plurimiliardario importo dei crediti prescritti per inerzia (continuata per 20 anni!), sarebbe il caso di chiedersi se non vi sia una responsabilità politica, ossia (anche) di coloro che addossano tutto alle malefatte dei contribuenti.
E, ancor più, se non vi sia una responsabilità dei funzionari. È agevole risalire al funzionario, e del pari controllare se per dieci anni ha fatto qualcosa o ha solo tenuto le pratiche nel sottoscala. E ancor più chi fossero gli obbligati a pagare i crediti erariali prescritti per inerzia; più complicato se i suddetti crediti fossero dovuti o frutto di errori degli uffici (o altro). Perché delle due l’una: o i crediti erano infondati, ed allora c’è da esaminare perché erano fatti accertamenti illegittimi da parte dei funzionari. O erano fondati ed allora la ragione per cui il funzionario responsabile non ne ha curato (almeno) le richieste onde interrompere la prescrizione. Con le conseguenze ovvie di carattere – almeno – disciplinare. Ma anche di responsabilità amministrativa. Le leggi relative ci sono: basta applicarle.
Ma finché si pone la questione dalla prospettiva del tifo da stadio, dei giustizialisti contro i garantisti non si andrà molto lontano. Si faranno tanti talk-shows (e altro) ma resteremo con un’amministrazione inefficiente ed una politica, oltre che inefficiente, chiassosa ed inetta, ma affezionata e indulgente verso il di essa aiutantato. Cioè affetta da burofilia. Alla faccia della “resilienza”.
Teodoro Klitsche de la Grange

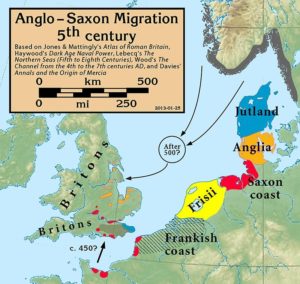

FORSE DI QUALCHE INTERESSE …
(A cura) Di Massimo Morigi
Evidentemente reminiscente del Libro I del Capitale dove Karl Marx afferma che «A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi, risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. Finché è valore d’uso, non c’è nulla di misterioso in essa, sia che la si consideri dal punto di vista che soddisfa, con le sue qualità, bisogni umani, sia che riceva tali qualità soltanto come prodotto di lavoro umano. È chiaro come la luce del sole che l’uomo con la sua attività cambia in maniera utile a sé stesso le forme dei materiali naturali. Per esempio, quando se ne fa un tavolo, la forma del legno viene trasformata. Ciò non di meno, il tavolo rimane legno, cosa sensibile e ordinaria. Ma appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta con i piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare», «Forse di qualche interesse», ha riferito Cthulhu Morbus al curatore archivista dei seguenti URL:
https://www.theblaze.com/news/wuhan-fauci-china-research-bat-coronavirus?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=20210709Trending-Wuhan&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaking%20News, Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20210709210634/https://www.theblaze.com/news/wuhan-fauci-china-research-bat-coronavirus;
https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-nih-wuhan-june-2021-00696/, Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20210709211150/https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-nih-wuhan-june-2021-00696/;
https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2021/07/JW-v-NIH-Wuhan-June-2021-00696.pdf, Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20210708165107/https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2021/07/JW-v-NIH-Wuhan-June-2021-00696.pdf;
https://www.ecohealthalliance.org/personnel/hongying-li, Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20210516124408/https://www.ecohealthalliance.org/personnel/hongying-li;
https://www.ecohealthalliance.org/, Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20210710082824/https://www.ecohealthalliance.org/;
https://en.wikipedia.org/wiki/EcoHealth_Alliance, Wayback Machine: http://web.archive.org/web/20210710083309/https://en.wikipedia.org/wiki/EcoHealth_Alliance;
https://www.dhs.gov/publication/dhscwmdpia-002-biological-detection-21st-century-bd21-technology-demonstration-td, Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20210709212219/https:/www.dhs.gov/publication/dhscwmdpia-002-biological-detection-21st-century-bd21-technology-demonstration-td;
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/privacy-pia-cwmd002-cwmdbd21td-july2021.pdf, Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20210706191939/https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/privacy-pia-cwmd002-cwmdbd21td-july2021.pdf.
R’lyeh (ExtraRomagna) – luglio 2021

Un articolo di Michael Severance per Acton Institute.
Alban Wilfert traduzione per Conflits
Nella mia introduzione a questa serie “Romenomics”, ho parlato della diversità del lavoro e della retribuzione. Questo non era, certo, un resoconto completo e colorito degli affari, del commercio e della remunerazione nell’antica Roma, ma era comunque una panoramica decente. Allo stesso modo, quando mi avvicino ai “centri di commercio”, cioè i luoghi dove gli antichi romani effettivamente facevano affari, non mi è possibile entrare nei minimi dettagli, anche perché molte testimonianze fisiche e scritte sono andate perdute . Tuttavia, sarei felice di usare la mia immaginazione per fornire le informazioni esistenti, per quanto consentito da questo breve post sul blog.
Quando si visita Roma e ciò che resta delle sue grandi città imperiali, salta all’occhio un dato di fatto: i centri vitali di commercio erano costruiti intorno a poche decine di ettari di terreno rettangolare chiamato fora (de fores , che significa “fuori”). Pioggia o sole, infatti, dall’alba al tramonto, i forum erano sempre pronti ad ospitare attività commerciali in questi ampi spazi all’aperto. Offrivano sbocchi per scambi sia spontanei che ordinati, non così diversi dai mercatini delle pulci americani, dai mercatini italiani o dai bazar turchi. Nel loro design e aspetto, i forumI romani divennero sempre più architettonicamente complessi. Al suo interno furono gradualmente integrati edifici permanenti, come negozi, bar, ristoranti, uffici commerciali, templi e persino municipi che entrarono a far parte delle famose grandi piazze delle moderne città europee.
Leggi anche: Prenota – Un viaggio a Roma? Segui la guida!
Non è raro che i turisti escano sconcertati, persino delusi, quando visitano le rovine del Foro Romano.. Lì trovano cumuli di macerie, colonne di pietra come tronchi caduti in una foresta, muri che sembrano essere stati bombardati da bombardamenti aerei, e ovunque un intero cumulo di “macerie” su cui rischiano di inciampare. I resti provengono meno da strutture commerciali che da edifici religiosi o politici, come i templi convertiti in chiese cristiane o la Curia romana. Ci vuole una fervida immaginazione e molta pazienza per immaginare, sotto il cocente sole romano, cosa stava succedendo lì durante un’intensa giornata di lavoro. È ancora più difficile immaginare dove si svolgesse esattamente questa attività nel foro prima della sua furia e completa distruzione da parte di bande di saccheggiatori e barbari del V secolo.
Partiamo dall’inizio: da piccolo mercato all’aperto sorto su un’area di paludi all’inizio del periodo repubblicano, il Forum Romanum doveva diventare, al tempo di Giulio Cesare, l’equivalente di un “centro cittadino”. Era il luogo da vedere, dove venivano negoziati gli accordi tra uomini e dei. La parte principale crebbe fino a raggiungere i 250 per 170 metri (quasi due campi da calcio), con le successive aggiunte di Augusto e Traiano. Il Foro Romanodivenne completamente satura di sofisticate strutture in laterizio e marmo: 10 templi maggiori, tre massicce basiliche (utilizzate come spazi per le trattative ufficiali, le consultazioni legali e per ripararsi in caso di maltempo), il Convento delle Vestali (di cui il compito era quello di mantenere la perpetua fuoco sacro che proteggeva Roma), la Curia (il Senato romano), i Rostra(una piattaforma rialzata colonnata utilizzata per promulgazioni e discorsi politici), una prigione per i criminali più pericolosi e un piccolo spazio aperto per la spesa quotidiana, le banche e lo scambio di beni e servizi. La sua prima ragion d’essere, per facilitare l’impresa, finì per cedere il passo a raduni dell’élite degli attori religiosi, civili e politici.
Allora, dove sono finiti i veri affari nella città di Roma? Per farla breve, in una serie di altri fori specializzati, molto più piccoli, sparsi nel centro della città, lungo le sponde del Tevere e nei dintorni. C’erano dozzine di mercati aperti che non hanno lasciato praticamente alcuna traccia archeologica, ma i cui nomi ci sono noti. In sintesi, i principali forum minori carne interessata (Forum Macellum), pesce fresco (Forum Piscarium), suini e salate (Forum Suarium), bovini, cuoio, latte (Forum Boarium), capre e formaggi (Forum Caprarium), ovini, lana e tessili (Forum Lanarium) , olio d’oliva, frutta e verdura (Forum Holitorium), vino (Forum Vinarium), pane, farina e cereali (Forum Pistorium), articoli per la casa, statue e vasi (Forum Archemonium), spezie, cibi raffinati e beni di lusso (Forum Cupedinis) .

Successivamente, ci furono diversi tentativi di consolidare i tanti piccoli mercatini specializzati in quelli che potremmo definire “centri commerciali one-stop”, come il Macellum Magnum, costruito da Nerone sul Cælius, che fu completamente distrutto. , e il primissimo ” centro commerciale coperto”: il Mercatus Traiani, tuttora esistente, sul Quirinale. Questo edificio di cinque piani ospitava dozzine di negozi ( tabernae) che vendevano principalmente beni di lusso, ma anche oggetti di uso quotidiano. Come gli attuali centri commerciali, anche i Mercati di Traiano erano destinati alla vendita di prodotti per l’ospitalità e l’intrattenimento: nell’attigua Via Biberatica (corridoio delle bibite) erano presenti diversi bar, ristoranti con terrazza al secondo piano con vista sul Foro Romano e un -Teatro aereo per festival teatrali e musicali. Ha ospitato uffici di fascia alta per entità legali e commerciali. I suoi negozi sono ancora oggi perfettamente intatti, dando a tutti un’idea chiara dello spazio fisico che l’imperatore Traiano affittava a imprenditori e mercanti di lusso in tutto l’impero.

Una struttura semplice era parte integrante di tutte le tabernae e degli stand all’aperto, in particolare i chioschi di scambio: il bancus . Costituito essenzialmente da assi di legno legate tra loro in modo da poter essere facilmente smontate alla fine di ogni giornata lavorativa, il bancus fungeva da grande bancone su cui si effettuavano le transazioni e dove si trovavano le casse per la riscossione dei pagamenti. Nessun bancus in legno è sopravvissuto al degrado naturale, ma linguisticamente sopravvivono ancora attraverso la parola “banca”, quelle preziose istituzioni di cui abbiamo ancora bisogno per rendere possibili le transazioni!
Si è detto abbastanza sulla vita commerciale nei centri urbani. E i porti marittimi? Da quando Ostia, l’antico porto di Roma, è stata completamente scavata, non mancano gli indizi visibili. Innanzitutto, se le grandi città erano dedite al commercio, le città portuali erano centri commerciali per eccellenza. Quando oggi visitiamo Ostia, vediamo diversi chilometri quadrati di tabernae , grandi e piccole, e tutti i fori sopra menzionati per l’importazione di prelibatezze, materie prime, cereali, per non parlare dei frutti di mare.Ristoranti e bar erano abbondanti e spesso specializzati in ricette a base di cibi e bevande di lusso provenienti dall’estero.
Le città portuali, come Ostia, erano generalmente costruite lungo coste poco profonde con acque naturalmente calme, e baie, o lungo gli estuari dei fiumi, in modo da essere collegate alle vie d’acqua interne. Ancora più importante, le città portuali avevano strutture speciali, chiamate horrea , che venivano utilizzate per immagazzinare tonnellate di merci fino a quando non potevano essere trasportate, ridistribuite e vendute in altri mercati. In generale, gli horrea erano progettati per immagazzinare grano, sale e materiali da costruzione come marmo e granito. Gli oggetti di lusso, come metalli preziosi, gemme e spezie, non erano conservati in questi horrea , ma intabernae più piccole, custodite e chiuse.
Leggi anche: La caduta di Roma. Fine di una civiltà, di Bryan Ward-Perkins
L’immagazzinamento divenne una parte così importante dell’infrastruttura portuale commerciale che i romani costruirono porti secondari artificiali con banchine adiacenti e enormi horrea . Nel 46 d.C., l’imperatore Claudio fece costruire l’ulteriore città di Portus (da cui il nome “porto”), pochi chilometri a nord di Ostia, per sollevarla dall’elevato volume di importazioni che riceve ogni giorno. L’imperatore Traiano poi ingrandì Portus e trasformò la struttura della sua banchina in un esagono per consentire l’installazione di sei siti di ormeggio separati che operano notte e giorno. Portus era poi collegato alle banchine del Tevere ostiense da un canale per l’entroterra.
Lo stoccaggio occupò un posto così importante nell’infrastruttura portuale commerciale che i romani costruirono porti secondari artificiali con banchine adiacenti ed enormi horrea . Nel 46 d.C., l’imperatore Claudio costruì un’ulteriore città, Portus (da cui il nome “porto”), a pochi chilometri a nord di Ostia, per alleviare l’elevato volume di importazioni che quest’ultima riceveva ogni giorno. L’imperatore Traiano poi ingrandì Portus e trasformò la struttura della sua banchina in un esagono per consentire l’installazione di sei siti di ormeggio separati che operano notte e giorno. Portus era poi collegato alle banchine del Tevere ostiense da un canale per l’entroterra.

Se abbiamo parlato di paesi e città portuali, la maggior parte dei centri commerciali romani rimase agraria, con possedimenti giganteschi utilizzati per l’agricoltura, l’allevamento di animali, il disboscamento, l’estrazione mineraria, ecc. I plebei potevano acquistare piccoli appezzamenti privati (pochi ettari) e ai soldati in pensione venivano dati piccoli terreni fertili. Tuttavia, i grandi possedimenti agrari commerciali (centinaia e migliaia di ettari) erano di proprietà di aristocratici e senatori patrizi. Si sono concentrati su industrie che hanno generato grandi profitti e una forte domanda, come la viticoltura, la produzione di cereali, l’allevamento di bestiame, la silvicoltura e l’estrazione. Le loro terre erano spesso adiacenti a corsi d’acqua, che consentiva un trasporto immediato ed economico. Quest’ultimo fattore era essenziale, per prevenire il deterioramento dei prodotti agricoli e soddisfare le esigenze urgenti di grandi progetti imperiali (costruzione, creazione di strade, fusione di armi e attrezzature militari).
Cosa dobbiamo imparare oggi dagli antichi centri commerciali? Prima di tutto, abbiamo bisogno di centri commerciali e di distribuzione sia primari che secondari. Nessuna metropoli può avere un solo centro. Il grande Foro Romanolo provò prima di essere costretto a dividersi in mercati specializzati sparsi per la città, a causa del sovraffollamento. Ciò ha consentito di decongestionare il traffico e aumentare il volume degli scambi e la concorrenza tra i diversi settori. Man mano che le città crescono e si espandono, la disgregazione dei centri di mercato finisce per creare un nuovo problema logistico legato alla distanza. Immagina di camminare e tirare carri per diversi chilometri tra i vari mercati della carne, dell’olio e della verdura dell’antica Roma: ciao bulbi! Infine, la comodità del Foro Romanosi trova in una soluzione intermedia tramite centri commerciali e centri commerciali, come i Mercati di Traiano e il Marcellum Magnum. In effetti, è l’elemento più duraturo degli immobili commerciali romani nelle principali città di oggi. Lo stesso vale per l’utilizzo dei porti marittimi, per i quali i centri primari e secondari devono essere costruiti per funzionare in armonia tra loro e con le vie di interconnessione logistica.
Se c’è una cosa che possiamo ammirare degli antichi romani, è la loro costante preoccupazione per l’efficienza. Stavano costantemente ripensando, ristrutturando e ridistribuendo per rendere il loro vasto impero più rapidamente sfruttabile commercialmente. Negli affari, ieri e oggi, tempus pecunia est (“il tempo è denaro”). Gli antichi centri commerciali di Roma erano ben attrezzati per massimizzare questa massima eterna.
https://www.revueconflits.com/romenomics-commerce-dans-la-rome-antique-mondialisation-aujourd-hui-2/

Via del Corso attraversa la città di Roma da nord a sud per un chilometro e mezzo, in linea retta da Piazza del Popolo a Piazza di Venezia. È tradizionalmente sul “Corso”, come dicono i romani, che si svolgevano le principali feste carnevalesche. Goethe, che visse nel famoso viale nel febbraio 1788, ne racconta i gioiosi eccessi nel suo Secondo soggiorno a Roma. Per lo scrittore, il carnevale romano era del resto molto più che “una festa data [al] popolo”: era una festa “che il popolo [dava] a se stesso”.
Vedi Conservatorismo nazionale: una conferenza a Roma
Ma in questo mese di febbraio 2020 il carnevale, ristabilito nel 2010, non è ancora iniziato ed è tutto un altro spettacolo quello che si svolge al numero 126 del famoso viale. Questo martedì 4 febbraio il Grand Hotel Plaza di Roma ha ospitato un grande evento intellettuale, sotto lo sguardo curioso dei passanti. Un congresso, sponsorizzato principalmente da due think tank americani (la Fondazione Edmund Burke e l’Herzl Institute), si è tenuto lì come parte di una serie di conferenze intitolate “National Conservatism”, e ha riunito quasi 250 persone.
Doveva riunire intellettuali, politici e giornalisti tutto il giorno nella sala da ballo del palazzo. Il tema di questa seconda sessione, la cui prima si è tenuta la scorsa estate a Washington, potrebbe sorprendere: “Dio, onore e patria: il presidente Ronald Reagan, papa Giovanni Paolo II e la libertà delle nazioni”.
La Piazza Romana, inizialmente residenza di una numerosa famiglia piemontese, fu trasformata in albergo nel 1860. Da allora ha ospitato numerose personalità. Papa Pio IX vi soggiornò nel 1866 quando ricevette Carlotta del Belgio, imperatrice del Messico. Ma anche, un secolo dopo, De Gaulle e Churchill. È qui che hanno soggiornato anche molti dei firmatari del Trattato europeo del 1957. Ironia della sorte, lo staff dell’hotel questa volta si aspetta di accogliere, tre giorni dopo lo storico evento Brexit, i sostenitori di un’Europa completamente diversa: l’ex ministro degli Interni e Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, oltre al premier ungherese Viktor Orbàn.
Erano attesi anche intellettuali conservatori come il britannico Douglas Murray e il polacco Ryszard Legutko; politici come il deputato del Partito conservatore britannico Daniel Kawczynski, Thierry Baudet, del Forum voor Democratie o l’ex deputato della Marina militare Marion Maréchal, nonché i francesi Édouard Husson e Alexandre Pesey. Attesi anche Mattias Karlsson dei Democratici svedesi e Georgia Meloni dei Fratelli d’Italia.
L’organizzatore principale di questa serie di conferenze è un filosofo e teologo israeliano, classe 1964: Yoram Hazony. Presidente dell’Herzl Institute, è uno dei cardini della Fondazione Burke. Lo accompagnano la moglie ei due figli, che partecipano all’accoglienza degli ospiti. Il dottore in scienze politiche, passato da Princeton, si è distinto nel 2018 con l’uscita del suo libro La virtù del nazionalismo [1], la cui traduzione è appena uscita in Italia. Con questo saggio, colui che fu anche assistente di Benjamin Netanyahu, cerca di dimostrare che ci sono due regimi politici in competizione che attraversano la storia e conducono una guerra spietata: l’impero e la nazione. L’Unione Europea apparterrebbe, nonostante la sua apparente novità, alla prima categoria.
Mentre l’impero (persiano, romano, spagnolo…), che è, secondo Yoram Hazony, universalista e progressivamente razionalista, appiana i particolarismi ed estende costantemente i suoi confini, il particolarismo della nazione sarebbe il miglior garante della cultura, di pace e libertà. Per il teorico, l’imperialismo (che oggi assume sia le nuove vesti del diritto che della cooperazione internazionale come i tratti bellicosi del passato), alla fine ci lascerebbe solo una triste alternativa: la sottomissione alla “servitù eterna. O alla “guerra”. Per difendersi da questi due mali bisognerebbe dunque evitare ogni compromesso e non rinunciare ad alcuna libertà civile a favore di alcun organismo sovranazionale.
Rispetto agli imperi cinese, egiziano e greco, la nazione era “qualcosa di nuovo nella storia”, disse Ernest Renan (1823-1892), che identificò l’essenza della nazione nel fatto che gli individui che la mantennero in forma hanno entrambi molto di punti in comune, ma anche che tutti hanno “dimenticato un sacco di cose”. “Qualsiasi cittadino francese” avrebbe così, secondo lo studioso bretone, “dimenticato Saint-Barthélemy e le stragi del Sud nel XIII secolo [2] “. Oggi, però, secondo i relatori, le nazioni sarebbero minacciate dall’oblio di ciò che costituisce il cuore della loro cultura e dal risentimento per le ferite del passato.
A sostenerlo, in ogni caso, il primo relatore della giornata, il giornalista e saggista americano classe 1967 Rod Dreher. L’autore della scommessa benedettina, dall’aspetto giovane nonostante la barba bianca e i capelli sale e pepe, ha messo in guardia il pubblico contro questa “dittatura rosa” che sovverte il nome di “giustizia sociale” per dedicare un culto “fanatico”. , sessuale…), erette come “vittime sacre”.
Rod Dreher è caporedattore di The American Conservative, dove scrive una rubrica quotidiana . Il suo intervento è disponibile in francese integralmente ed esclusivamente, su Conflits .
Dietro l’abito compassionevole, “i mezzi dello Stato e del capitalismo” si ibriderebbero infatti per dare vita a “una società di sorveglianza”, che tanto più facilmente si insedierebbe quanto più in Occidente si accentua l’atomizzazione sociale in proporzione al discredito soffrono le nostre istituzioni e il successo di nuove ideologie. Contro questa “dittatura rosa” (concetto ripreso dal saggista James Poulos), che difende certe libertà e ne aliena altre, i conservatori devono coltivare la loro memoria e trasmettere il loro patrimonio, rafforzare i loro legami di solidarietà (famiglie, istituzioni, circoli, partiti ecc. .), e soprattutto per ravvivare la loro fede, perché “contro il male che viene”, “l’umanesimo non basterà”.
L’autore, che “sta preparando un nuovo saggio sull’argomento”, racconta, a sostegno della sua tesi, le testimonianze raccolte dai dissidenti dei paesi dell’Est sulla loro lotta al comunismo e che avevano per la maggior parte di loro una fede forte e fervente, come un Vaclav Havel o un Karol Wojtyla, appunto. Per molti dei sopravvissuti a quest’epoca passata, il totalitarismo sta tornando con un volto nuovo, e non solo in Cina, ma anche in Occidente, “dove potrebbe trionfare se i cittadini non stanno attenti”.
“ Le libertà di opinione, espressione e religione ci sembrano eterne e intangibili. Ma non subiscono aggressioni quotidiane? La correttezza politica non sta sovvertendo le istituzioni liberali che stanno perdendo la loro presunta neutralità a favore di una nuova ideologia? », si sono chiesti recentemente molti intellettuali conservatori americani, vicini a Rod Dreher, e tra questi il giornalista cattolico Sohrab Ahmari e il filosofo Patrick Deneen.
Vedi i dibattiti seguiti alla pubblicazione del manifesto “Against the Dead Consensus” di First Thing , 21 marzo 2019
Fu anche uno degli ultimi moniti dell’intellettuale britannico Roger Scruton, la cui memoria fu salutata calorosamente all’inizio del Congresso e di cui Rod Dreher rese un pesante tributo. Quando era venuto a Parigi per il convegno “Democrazia e libertà”, organizzato lo scorso maggio dall’Accademia di scienze morali e politiche e dall’Istituto Thomas More, lo spiritoso filosofo aveva denunciato la violenza e la slealtà degli araldi del politicamente corretto, ai quali doveva la perdita della sua reputazione e della sua posizione nel movimento conservatore.
Istituto Thomas More: Vedi “Democrazia e libertà: i popoli moderni mettono alla prova le loro contraddizioni”
Era stato infatti sgridato per affermazioni ritenute oltraggiose (“Chi non crede che ci sia un impero di Soros in Ungheria non ha osservato i fatti”) e islamofobi (“Gli ungheresi furono spaventati da questa improvvisa e popolosa invasione. di tribù musulmane “;”L’islamofobia è una costruzione della propaganda dei Fratelli Musulmani per soffocare ogni dibattito”), tenuta durante un’intervista al magazine di sinistra The New Statesman.
È stato il suo stesso intervistatore, l’editore associato George Eaton, a denunciarlo nell’intervista prima di tagliare lo champagne e celebrare pubblicamente la caduta del “razzista e omofobo Roger Scruton” (sic). Prima di morire nel gennaio 2020, l’intellettuale ha tenuto a ricordare sulla rivista Spectator che la caduta del comunismo è stata prima di tutto la vittoria della sovranità popolare e non quella della “libertà di movimento”, come “affermava. la propaganda dell’Unione europea Unione”.
Un parere chiaramente condiviso da un oratore al Congresso, ex ministro polacco e storico membro del sindacato Solidarnosc, Ryszard Legutko. Durante una tavola rotonda con l’americano John Fonte dell’Hudson Institute e il saggista francese Édouard Husson, ha presentato gli insegnamenti della sua esperienza di dissidente e membro del governo polacco. Come ha spiegato in un libro con accenti tocquevillian, The Demon of Democracy [3] , il filosofo ed ex ministro dell’Istruzione polacco ritiene che la democrazia attuale assomigli all’ideologia comunista più di quanto pensiamo. .
Édouard Husson: Autore in particolare, per le edizioni Gallimard (novembre 2019) di Parigi-Berlino: la sopravvivenza dell’Europa .
Condividendo le stesse radici intellettuali (sia in termini di filosofia della storia che di religione), queste due ideologie perseguono gli stessi obiettivi: liberare gli uomini dagli obblighi del passato, emancipare i cittadini dalla tradizione e dal costume. Inoltre, la democrazia condivide una caratteristica distintiva con i regimi comunisti: non ammette altri criteri di giudizio se non quelli del sistema politico e quindi rifiuta di sottoporre i propri pregiudizi all’esame di criteri morali o religiosi.
È alla luce di questa storia di resistenza al comunismo che si può comprendere il persistente malinteso che oppone i difensori di un’Unione europea positivista e tecnocratica al patriottismo e all'”illiberalismo” dei paesi dell’Is. Come ha ricordato di recente il saggista Max-Erwann Gastineau, “non siamo i discendenti dello stesso trauma”. In effeti :
“ In Oriente, è la memoria del comunismo che continua a lavorare sulla memoria collettiva e a forgiare una cultura della resistenza che valorizzi le radici nazionali. In Occidente, si crede che siano i limiti della legge a proteggere l’Europa dal ritorno dell’autoritarismo nazionalista di ieri. ”
Vedere The New East Trial , Cerf, 2019 ; e l’intervista che Conflits gli ha dedicato di recente.
L’intervento più atteso, nell’imprevista assenza di Matteo Salvini, il cui gruppo politico al Parlamento europeo (il PPE), temeva di vederlo intervenire in una manifestazione che riuniva ospiti di correnti ritenute troppo disparate per non essere compromettenti, è stato quello di Viktor Orban. Il premier ungherese, che nel maggio scorso aveva dichiarato a Bernard-Henri Lévy di “non aver niente a che fare con Marine Le Pen”, non ha avuto paura da parte sua di parlare sullo stesso palco della nipote di quest’ultima, l’ex vice Anche Marion Maréchal, attualmente direttrice dell’ISSEP di Lione, è stata invitata a intervenire durante un notevole discorso di cui la stampa francese ha già fatto eco.
Il capo del governo ungherese ha voluto ricordare al suo pubblico che la politica richiedeva di saper conquistare e mantenere il potere e che il dilettantismo non era d’obbligo. Ci vuole anche, secondo lui, coraggio per difendere le sue idee e metterle in pratica una volta eletto. Questo mettere in pratica le idee su cui è stato eletto un governo è essenziale per consentire una rielezione. Una lezione che sembrò conquistare tutti i partecipanti, sedotti da un Capo di Stato che, a soli 24 anni, aveva osato sfidare il regime comunista e che parve loro incarnare una risposta coerente e solida sia sul piano culturale, sociale, che economico. Il presidente del Consiglio ha quindi voluto ricordare il vigoroso tasso di crescita del Paese (4,8% nel 2018), e di aver mantenuto all’“80%” la sua promessa di creare un milione di posti di lavoro.
Viktor Orbàn ei suoi sostenitori ritengono che il suo Paese, occupato a più riprese “dagli ottomani, dagli slavi e dai comunisti”, debba la sua sopravvivenza solo alla determinazione degli stessi ungheresi. Tuttavia, secondo lui, il liberalismo ei suoi promotori a Bruxelles si stanno rivelando una nuova forza distruttiva per questo Paese di 10 milioni di abitanti. Primo, perché il liberalismo distrugge i vincoli di solidarietà e di affetto che fondavano le nazioni, e perché le sue istituzioni, lungi dall’essere neutrali, sono sostenute da uomini che hanno una propria ideologia.
Aveva così dichiarato, nel febbraio 2019, alla piattaforma delle Nazioni Unite:
“ Da nessuna parte nel grande libro dell’umanità è scritto che gli ungheresi devono esistere. Questa legge è scritta solo nei nostri cuori – e nessuno tranne gli ungheresi se ne preoccupa . ”
Citato da Christopher Caldwell, “L’Ungheria e il futuro dell’Europa” , Claremont Review , primavera 2019
Nonostante il successo che sembrò incontrare il pubblico – che lo ricompensò con pesanti applausi, il presidente del Consiglio ungherese non si atteggiò a leader dei movimenti conservatori e sovranisti, ma anzi insistette nel ricordare il ruolo trainante dell’Italia e di Matteo Salvini in particolare.
L’impressione generale di questa convenzione, come ha notato Douglas Murray nel suo intervento, ha suggerito una serie di malintesi. Ad esempio, è possibile trovare, al di là dei comuni avversari, una dottrina comune tra sovranisti, atlantisti, conservatori, identitari, intellettuali cristiani, agnostici ed ebrei?
Questo fronte comune è davvero paragonabile a quello che si oppose al comunismo, e che già suggeriva molte differenze, se non altro tra le visioni molto diverse difese a loro tempo da Giovanni Paolo II e Ronald Reagan? C’è stato infatti un altro grande assente dal dibattito, a parte Matteo Salvini: è stata la stessa Chiesa cattolica, una delle figure più emblematiche della quale è stata convocata nella sua casa a Roma, anche se non era presente nessun ecclesiastico a rappresentarla. La religione, tuttavia, vi occupava un posto importante. Forse si dovrebbe capire, come ha suggerito Max-Erwann Gastineau nel suo lavoro sull’Europa orientale, che i relatori avevano fatto propria questa massima di Alexis de Tocqueville:
“Non dipende dalle leggi per far rivivere credenze sbiadite; ma dipende dalle leggi interessare gli uomini ai destini del loro paese”.
D’altronde è certo che i temi sollevati in questa giornata alimenteranno un dibattito che non potrà che essere fertile, se non altro per chiarire le differenze tra generazioni e correnti molto disparate.
https://www.revueconflits.com/nationalisme-conservatisme-souverainisme-eglise-viktor-orban/

Un articolo di Michael Severance per Acton Institute.
Alban Wilfert traduzione per Conflits
La Caput Mundi non è sempre stata al vertice dell’economia. Gli 11 secoli di esistenza dell’antica Roma furono quelli di un lungo e faticoso viaggio. Quando fu fondata nel 753 a.C., fece i primi passi come un’ambiziosa rete di villaggi. Successivamente, ha dimostrato la sua potenza politica durante un’inarrestabile espansione repubblicana nel bacino del Mediterraneo per mezzo millennio. Infine, per cinque secoli, fu quell’Impero onnipresente e onnipotente, anche se spesso disfunzionale, che occupò il 25% del mondo conosciuto. Alla fine cadde sotto il peso della propria decadenza morale, politica ed economica dopo la deposizione nel 476 dell’ultimo imperatore d’Occidente, Romolo Augustolo, da parte di invasori barbari.
Proprio come studiamo ancora il latino per comprendere meglio la nostra lingua moderna, riflettere sull’economia antica è utile per comprendere alcune delle leggi economiche fondamentali dei mercati e dei relativi sistemi culturali, che sono sopravvissuti fino alla stessa Città Eterna.
Avvertimento : Molte persone credono ingenuamente nella gloria dell’antica Roma. Vedendola attraverso un prisma di archi trionfali, palazzi di marmo, vasti fori [1] e iconici busti di uomini che hanno portato ordine, pace e prosperità in un’era primitiva della storia umana, sono abbagliati. Lo pensiamo anche noi, sapendo che la Roma pagana non era nell’insieme migliore, almeno moralmente e spiritualmente, dei cosiddetti barbari da essa conquistati.
Spesso, l’antica economia romana è essa stessa osservata attraverso questi occhiali idealistici. Non c’è dubbio che abbia creato il primo Commonwealth operativo transcontinentale e che abbia rappresentato il primo vero tentativo di globalizzazione, ma non si può dire che la sua vita commerciale sia sfuggita a tutte le crisi o che sia stata diretta con mano divina da guru degli affari.
È tuttavia affascinante osservare il funzionamento e, a fortiori , l’efficienza dell’economia romana in un tempo così lungo, con un flusso costante di invenzioni, connessioni e creazione di ricchezza su tre continenti. Questa serie “Romenomics” offrirà l’opportunità di esaminare diversi fattori importanti dell’economia antica, vale a dire:
Leggi anche: La caduta di Roma. Fine di una civiltà, di Bryan Ward-Perkins
Poiché il cuore di qualsiasi mercato funzionante – antico o moderno – essendo il talento umano e la produzione dietro compenso, vale la pena iniziare con una panoramica dei mestieri, delle professioni, delle industrie e dei servizi quotidiani che esistevano nell’antica Roma, compreso il lavoro non retribuito o forzato ( servitù ). A meno che tu non abbia mai aperto un libro di storia antica o visto un peplo come Spartacus, tu sai che la schiavitù rappresentava proporzioni immense della produzione economica romana, per opere private e pubbliche. Si stima che al suo apice, l’Impero Romano avesse un PIL equivalente agli odierni 32 miliardi di dollari. Durante il periodo più intenso di costruzione finanziata dallo stato (strade, stadi, teatri, templi, ingegneria civile), il lavoro degli schiavi ha rappresentato circa il 20-30% dell’attività economica. Questo era particolarmente vero durante i regni di Traiano e Adriano, che costruirono alcuni dei monumenti più antichi di Roma.
Gli schiavi, serviti in latino, fornivano anche una serie di servizi di cui oggi nessuno si lamenterebbe troppo, tanto più che ora sono ben pagati: cucina, parrucchiere, massoterapia, e anche assistenza tecnica a professioni come avvocati, cartografi, ingegneri e persino coloro che hanno aiutato la nomenclatura a mantenere enormi elenchi di nomi e associazioni in rete per politici e l’élite degli affari (molto simile a un antico Rolodex o ai profili dei social network di oggi).
Va da sé che i servi erano chiamati a sfidare la morte negli spettacoli, nei combattimenti di gladiatori e nelle corse dei carri, e nella sicurezza alimentare, cioè nei compiti di garanzia della qualità, quando assaggiavano cibi e bevande per assicurarsi che non fossero avvelenati. Le schiave erano talvolta costrette alla prostituzione o alla sua forma domestica un po’ meno dura, il contubernium , un rapporto in cui un padrone viveva apertamente con il suo schiavo.
Cosa facevano della loro vita i cives , i liberi cittadini? Innanzitutto molti di loro, soprattutto i plebei di rango inferiore, vivevano in condizioni anche peggiori dei servi appartenenti o donati dai nobili patricii , cioè nei bassifondi delle insulae . Hanno dovuto lavorare sodo per raggiungere uno standard di vita molto modesto. I lavori della plebe non erano molto diversi da quelli degli operai o delle piccole imprese familiari di oggi [2]. Gestivano piccoli negozi, chioschi di mercato e taverne, noleggiavano muli, coltivavano piccoli appezzamenti, servivano come “meccanici dei carri armati”, mantenevano stalle e svolgevano compiti di segreteria e logistici. Alcuni erano guide poco pagate, ma il loro lavoro nelle terre straniere appena conquistate era importante. Per la maggior parte, i plebei erano riparatori, fornitori e prestatori di servizi quotidiani di base.
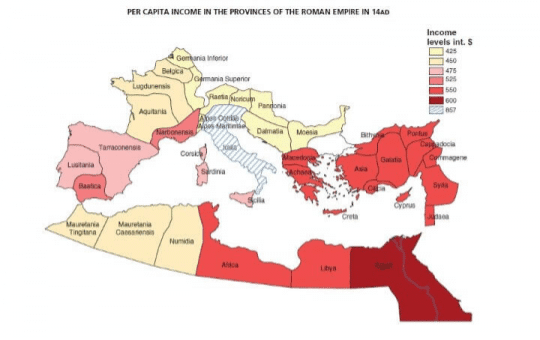
Ma quanto era alto il salario dei plebei? Gli antichi economisti hanno tentato di stimare il reddito pro capite durante il periodo di massimo splendore dell’Impero. Alcuni stimare il reddito annuo di Roma all’inizio del I ° secolo a 570 dollari di oggi. Non è molto, anche se il pane e molti altri alimenti di base fortemente sovvenzionati erano più economici, spesso gratuiti. Quasi l’intero impero viveva ben al di sotto della soglia di povertà. Come oggi, molti redditi sono stati guadagnati “al buio” e non sono stati ufficialmente dichiarati per evitare il tributo (imposta sul reddito). I registri delle entrate pubbliche erano probabilmente imprecisi.
Nel I secolo, i soldati romani potevano guadagnare una miseria o essere tra i salariati più ricchi. Gli imperatori arruolavano ogni anno decine di migliaia di soldati, comandanti e tecnici, mentre Roma si espandeva in uno slancio inarrestabile. Certo, gli stipendi dei militari rappresentavano un pesante fardello per le finanze pubbliche. Un legionario , fante, guadagnava un misero sesterzio al mese. Ma quanto era questo misero stipendio? Cercare di convertire un sesterzio nell’odierna parità di potere d’acquisto (PPP) non è un’impresa facile. Fortunatamente, i romani avevano una sorta di gold standard, poiché siamo in grado di calcolare quanti sesterzi valevano una moneta d’oro ( aureus). Se l’oro è valutato in media, diciamo, di $ 1.200 per oncia troy [3] (che in realtà vale $ 1.700 oggi, a seguito del forte aumento dovuto alla crisi legata al Covid-19), allora una singola moneta di sesterzi era vale $ 3,25 alla conversione di oggi. Citazione da GlobalSecurity.org:
Se consideriamo il valore moderno dell’oro di circa $ 1000 l’oncia, un aureus varrebbe circa $ 300, il denaro d’argento [25 per fare un aureus ] circa 12 dollari e un sesterzio [4 per un denaro] circa $ 3. A metà del 2010, il prezzo dell’oro superava i 1.200 dollari l’oncia, posizionando un aureus a circa 325 dollari, un denario d’argento a circa 13 dollari e un sesterzio [4 denari] a 3,25 dollari.
In ogni caso i soldati romani non potevano vivere con 3,25 dollari al mese. Furono quindi massicciamente incoraggiati a vincere battaglie e conquistare nuovi territori. Ottime prestazioni sul campo di battaglia hanno fruttato loro generose somme aggiuntive, “commissioni”, attraverso la distribuzione del bottino e della guerra. Inoltre, i Legionari ricevevano concessioni terriere esentasse al momento del pensionamento in alcune delle regioni più fertili dell’impero, oltre a cibo, bevande, riparo e vestiti per la durata del loro servizio attivo. Un’altra parte del loro stipendio era il “pagamento in natura”. Infatti, la parola stipendio deriva dalla parola salche significa sale. Perché ? Gli ufficiali di rango inferiore godevano di vantaggi più speciali, come ricevere piccoli sacchi di sale, che valevano all’incirca una paga giornaliera, in cambio della protezione delle strade per le miniere di sale romane o dell’accompagnamento di carovane di sale in province aspre come la Germania. Gli ufficiali più talentuosi e più anziani, come i centurioni che gestivano truppe di un centinaio di soldati, invece, non avevano salari bassi, non lavoravano a fianco e non beneficiavano di incentivi. Erano solo molto ben pagati, fino a 300 sesterzi al mese ($ 10.000).
L’equivalente dello stipendio di un lavoratore oggi era di circa 120 sesterzi (390 dollari) al mese, nella migliore delle ipotesi. Non era ancora molto, quindi le persone che guadagnavano quello stipendio facevano lavori saltuari, come molti ora sono costretti a fare di notte e nei fine settimana. I lavoratori agricoli guadagnavano fino a 150 sesterzi (circa $ 500) al mese, più parte del raccolto e spesso alloggi locali.
Stipendi patrizi mensili molto più elevati venivano concessi all’élite istruita e politica e, allo stesso modo, a coloro che seguivano percorsi professionali che si andavano esaurendo, come professori specializzati, precettori o “allenatori” della famiglia imperiale (8.000 sesterzi), medici (30.000 sesterzi) e proconsoli governatori provinciali e coloniali, che avevano redditi molto alti (82.000 sesterzi al mese).
Per quanto riguarda gli artigiani e le loro PMI, spesso hanno guadagnato molto, soprattutto nelle città. Naturalmente, questi erano profitti fluttuanti e non salari fissi come quelli dei dipendenti di oggi. I piccoli imprenditori potevano quindi avere rendite nette molto allettanti, come quelle di proconsoli e medici, soprattutto se le loro competenze tecniche erano molto richieste (come vasai, gioiellieri, metalmeccanici, mugnai e pellettieri) o se l’amministrazione imperiale li assumeva. Poiché quasi tutti i documenti aziendali (conservati su rotoli di papiro e tavolette di legno) sono andati perduti, è possibile stimare solo una somma tonda di 1.000 sesterzi (circa $ 3.300) di profitto al mese nelle grandi città come Roma, Londinium eNeapolis [4] .
Secondo un antico storico, altri professionisti erano ben pagati, specialmente nelle arti dello spettacolo, sebbene non fossero della stessa specie degli odierni “stipendi di Hollywood”:
“Erano artisti, comici, ballerini e attori, che potevano guadagnare dagli 80 ai 150 sesterzi al giorno [dagli 8000 ai 14.500 dollari al mese] senza contare le spese di vitto e viaggio, e che avevano anche la garanzia di una serie di spettacoli annuali . Certo, gli artisti più famosi potrebbero ottenere molto di più. ”
In sintesi, era possibile vivere molto bene nell’antica Roma, anche se la stragrande maggioranza del populus romanus era estremamente povera.
Sulla base di quanto abbiamo osservato, ci sono alcune leggi economiche che vale la pena considerare.
Innanzitutto, più sei qualificato nel tuo talento individuale e più rara è la tua professione, più è probabile che tu sia generosamente remunerato dal mercato per lunghi periodi di tempo. Nell’antica Roma, un educatore d’élite, un retore come il medico di oggi, era pagato molto più di un professore moderno. Non che fosse più abile nel mondo accademico, ma 2000 anni fa c’erano significativamente meno intellettuali professionisti rispetto a oggi. Oggi i dottorati si contano sulle dita di una mano. D’altra parte, si potrebbe dire che i retori valevano “diecimila” una dozzina!
Un’altra legge insuperabile del mercato è la tendenza ad aumentare la retribuzione in base al costo della vita adeguato nelle aree urbane e suburbane. Il costo della vita corretto di un calzolaio attivo potrebbe essere di 100 sesterzi al giorno a Pompei, ma raggiungere i 200 sesterzi a Roma, ed essere molto inferiore nella Sicilia agraria o nelle province periferiche come la Dacia (Romania), raggiungendo i 20 sesterzi al giorno. In particolare, i calzolai erano più richiesti dove si camminava molto ogni giorno, soprattutto se servivano la fanteria vicino ai castra.militari e cittadini. Di conseguenza, la legge non è necessariamente quella dell’offerta, ma quella della domanda. Questo è ciò che alla fine rende i redditi dei calzolai romani rispettivamente molto più alti o più bassi.
In conclusione, il divario salariale nell’antica Roma era enorme. Era più simile a quello dei moderni mercati ricchi e povericome il Brasile e l’Argentina, dove i quartieri finanziari dei grattacieli corrono lungo le baraccopoli di Rio de Janeiro e Buenos Aires a poche strade di distanza. I differenziali salariali e gli standard di vita erano estremi, soprattutto perché (come nei paesi cosiddetti meridionali di oggi) le possibilità di avanzamento erano minori e più precarie. C’erano tasse soffocanti, corruzione dilagante, criminalità organizzata, scarsa istruzione, mercati neri disconnessi e livelli più elevati di malattie, sfortuna e vincoli geografici estremi. Montagne, paludi, regioni vulcaniche e terremotate potrebbero spazzare via intere economie in un solo giorno. Ricordi cosa è successo a Pompei? Questa antica città sarà una delle protagoniste del nostro prossimo blog:
[1] plurale latino di forum (NDT).
[2] “mamma e pop” (NDT).
[3] Unità di misura dei minerali (NDT).
[4] Attuale Napoli (NDT).

“I Regimi di Verità – Il politico-impolitico, travestimenti liberali”
Questa è la terza puntata ed ultima della lettura del libro di Andrea Zhok, “Critica della ragione liberale”, uscito per l’editore Meltemi nel 2020.
In sostanza dalla ricostruzione del liberalesimo nel libro, e riportata nella prima parte, emergono, secondo quanto propone l’autore, due prescrizioni e due idealizzazioni.
La prima prescrizione scaturisce dall’idea di libertà negativa, essenzialmente interpretata come richiesta di non interferenza. La seconda è l’individualismo assiologico, ovvero una concezione per cui il valore si manifesta essenzialmente nell’acquisizione di desideri individuali. “Non interferenza” e “desiderio individuale” come valore sono, quindi, le due prescrizioni definenti la “Ragione liberale”. In loro presenza si sa di essere al cospetto di una versione, delle tante, del liberalesimo.
Queste prescrizioni reggono e sono (normalmente tacitamente) giustificate dall’esistenza di due idealizzazioni (assunzione di un’idea, o un modello, come universale).
La prima idealizzazione è l’assunto ideale dell’esistenza dei diritti naturali, che uniscono la normatività del diritto positivo con l’autoevidenza di un fondamento presente già in natura. Infine, troviamo l’assunto ideale per cui la libera interpretazione di individui, che si muovono sulla base delle prescrizioni prima e seconda, è sufficiente a generare sempre esiti positivi. In altre parole, la seconda idealizzazione è il paradigma della mano invisibile.
Se si richiede la ragione per la quale le due prescrizioni devono essere tenute per valide, si incontrano sempre versioni delle due idealizzazioni, in una delle varie forme in cui si presentano.

| Pippo Rizzo, “Treno notturno in corsa”, 1926 |
Le prime due definiscono uno spazio assiologico specifico e le seconde hanno un carattere idealizzante teologico, ovvero introducono visioni specifiche del funzionamento dei rapporti intersoggettivi. Il quadro concettuale liberale, bisogna sottolineare, non emerge come frutto di una riflessione organica, ma prende forma come collazione di argomenti di solidità dubbia, ma efficaci sul piano della tensione politica e coerenti con lo sviluppo delle forze produttive e dei rapporti sociali, nonché istituzionali e politici. Essenzialmente si afferma, in altre parole, per la sua capacità di abbattere, contestare o criticare un regime già esistente, quindi per il suo carattere negativo. Infatti, rifarsi a un ‘diritto di natura’, nelle condizioni storiche del tempo (XVI-XVII secolo), permette di delegittimare e di indebolire la sovranità regale, creando un set di giustificazioni opportunamente separate dalla tradizione. Un insieme di ragioni il cui basso contenuto veritativo e la scarsa fondazione delle premesse emerge solo ogni qual volta diventa concreto, mentre è efficacissimo e potente come arma polemica. È solo il successo finale, in ogni ambito della vita, della “Ragione liberale” che ne determina e rende visibili le disfunzioni. Tutte queste incrinature di cui parla il libro sono presenti sin dall’inizio, ma iniziano a manifestarsi solo a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo fino alla Prima guerra mondiale. Quindi si manifestano pienamente solo nel mondo contemporaneo. Naturalmente si tratta di linee di tendenza lunghe e variamente denunciate, nella letteratura sociologica, ad esempio, già la sociologia classica (da Weber[1] a Durkheim e Mauss[2]) denuncia l’erosione della coesione sociale, nello stesso momento in cui si afferma la fredda “razionalità allo scopo”. Nello stesso contesto del welfarismo imperante assistiamo all’emergere poi, da una parte, di quella che Onofrio Romano, in un bel libro chiama “una sensazione di soffocamento e disseccamento nella clausura dorata dello Stato del benessere [che] attanaglia il corpo sociale. [e] Questo nodo costituisce il comune terreno di critica su cui si trovano i neoliberali e i radicali di sinistra”[3], dall’altra si assiste agli esiti sistemici di un processo di erosione egemonica e incrudimento delle dinamiche competitive alla scala del sistema-mondo (o, meglio, delle interazioni tra il sistema-mondo occidentale, quello orientale socialista e gli emergenti[4]) che confluiscono in quello che James O’Connor, in un influente libro, chiamò “La crisi fiscale dello Stato”[5]. La drammatica crisi antropologica, segnale di quella che si ripresenterà dopo la parentesi anestetizzante degli anni novanta (un intermezzo nel quale sembrò che la crisi egemonica, al contempo economica e strategica, dell’occidente fosse superata a vantaggio delle sue élite e classi medie), fu diagnosticata tempestivamente da autori come Christopher Lasch[6], Cornelius Castoridias[7], Daniel Bell, Ronald Inghehart[8], Antonhy Giddens[9], se pure con colori e direzioni politiche diverse (negli ultimi due salutando l’era “postmaterialista”). Si possono ricordare anche Talscott Parsons, con il suo complesso ‘struttural-funzionalismo’[10] e Robert Merton, che descrive un funzionalismo senza struttura, o la ‘teoria dei sistemi’ di Niklas Luhman. Potrebbero essere citati, nella storia delle scienze, anche gli indebolimenti prodotti da Heisenberg, Einstein, e tanti altri. Da questa enorme costellazione di stimoli emerge, con differenze anche significative tra la versione anglosassone e quella continentale, la soluzione neoliberale[11] di cui vediamo in questi ultimi anni l’indebolimento[12]. Subentra una repentina “crisi da orizzontalismo”, analoga a quella mostratasi nel 1929. Il modello ha infatti prodotto, e lasciato accumulare come la cenere sotto un camino, una proliferazione della finanza speculativa ed altamente inefficiente in termini di sistema, una crescita alla lunga insostenibile di ineguaglianze che scavano sotto i bastioni del consenso e producono un’enorme quantità di disattivazione esistenziale e rabbia. Di cui è motore ed effetto al tempo l’assottigliamento, sempre più visibile, della classe media[13].
Di qui il testo finisce per concentrarsi su alcuni centri logici della costellazione di pensiero e di prassi liberale. Punti nei quali, per componenti crescenti della società, la “frizione” tra le promesse di liberazione individuale e scatenamento del desiderio (in uno sperato mondo dell’abbondanza sotto la tutela della “Ragione liberale” fattasi ideologia), e la realtà della continua crescita delle ineguaglianze più feroci e dello sfruttamento più selvaggio si fa sempre più manifesta. Quel che accade si potrebbe descrivere in questo modo: mentre la società si fraziona per strati funzionali e geografici tra chi può accedere alle risorse di capitale, ed ai relativi gradi di interconnessione, e chi resta abbandonato e sconnesso, i connessi “sovraestendono” le risorse ideologiche della “Ragione liberale” per inibire sul piano culturale, e respingere sul piano politico-organizzativo l’insorgenza potenziale dei marginali. Non è un caso che, man mano la crisi morde (alcuni), i toni (di altri) si facciano sempre più striduli e la danza totemica più frenetica. Né lo è che qualunque “vittima” sia sacralizzata, purché non sia economica, non sia un abitante delle periferie reali, materiali, e lo sia solo delle periferie mentali e “post-materiali”.
Questa ‘sovraestensione’ è lo sfondo sulla base del quale Zhok, nel 2020, sente l’urgenza di scrivere questo importante libro. Si tratta della risposta che strati sociali minoritari (ma non trascurabili quantitativamente) che si sentono superiori esprimono verso la sfida esistenziale portata dai “paria”. La superiorità percepita si esplica nella dotazione di ‘capitale culturale’, ‘relazioni sociali’, disponibilità di ‘capitale spaziale’[14], accesso a ‘risorse simboliche’ e ad ‘attività dinamiche’ che restituiscono prospettive esistenziali (se pure, per molti illusorie) e, non ultimo ma non necessariamente, ‘capitale economico’ fisso o mobile. Si tratta di una differenza di status non necessariamente di censo. Proprio il rischio che il censo declinante impedisca la conservazione dello status (autopercepito e riconosciuto tra pari) sottende alle danze totemiche più frenetiche. Naturalmente la sfida è portata, a questa ‘compagnia di danza’, solo dai veri “paria”, non certo dagli oggetti sacrificali (‘resi sacri’) scelti da individui “desideranti” che, interpretando lo spirito del tempo ed in coerenza con questo, fanno leva sui “capitali” detenuti per sottrarsi a regole e solidarietà percepiti come soffocanti. Scelti precisamente per la loro capacità di attivare un rito la cui principale funzione è l’autolegittimazione degli officianti.
Possiamo riassumere lo sfondo in questo modo. Le disastrose tensioni introdotte dalla “Ragione liberale” e dal suo braccio armato neoliberale nella struttura sociale e nelle personalità socialmente confermate, dopo la ‘felice’ pausa degli anni Novanta (nei quali permanevano comunque sufficienti strutture welfaristiche e strutture di senso per controbilanciare l’acido dissolutore che le stava intaccando), nel primo decennio del nuovo millennio giungono ad una rottura. Nel secondo decennio, quindi, il caos sistemico ha preso il sopravvento, le potenze politico-militari e i sistemi d’ordine che lo trattenevano hanno perso influenza. La fragilità finanziaria si è resa manifesta, l’assurdità delle regole scritte per tempi diversi è emersa fragorosamente, altri centri d’ordine sono emersi. Dentro lo stomaco delle ex ricche società occidentali il gemito dei troppi esclusi si è fatto continuo ed insopportabile, elezione dopo elezione. Il triplice colpo della Brexit, venuto dopo la lezione greca (e quella Irlandese), dell’elezione di Trump, delle tornate “antisistemiche”, ha evocato a questo punto il fantasma del “populismo”.
Ora, dopo due decenni così interessanti, in questo avvio del terzo decennio, apparentemente di pausa e riflusso, si gioca il destino a medio termine del mondo. L’ossessione della crescita fondata sulle esportazioni, in un mondo nel quale la cosiddetta mondializzazione ripiega per “grandi spazi”[15] (e la finanza è attaccata alla tenda a ossigeno delle Banche Centrali), davanti la sfida strategica della potenza cinese e del network in formazione intorno ad essa (Russia, in primo luogo, poi Iran, Venezuela, Pakistan, Siria, Nepal) non è più credibile e sostenibile per tutti. Bisognerà che qualcuno sia salvato e altri condannati siano essi territori, settori, individui. Tutto sta giungendo al suo limite.
Stava già accadendo, ma l’intero sistema di tensioni strutturali ha visto cadere il ‘cigno nero’ della pandemia come un maglio. Il libro cade esattamente un attimo prima di questo evento.
Capita così una congiuntura particolare: si divaricano ancora le condizioni che determinano un “momento Polanyi”[16] sull’occidente, ma, al contempo, rifluisce nettamente il “momento populista”[17]. Nel decennio trascorso questo aveva preso una forma specifica. Si era presentato come chiusura nazionalistica, ricerca di purezza identitaria (se non etnica), una sorta di ostentato plebeismo, vitalismo, protezionismo. Ma non bisogna ingannarsi, a questo servono libri preziosi come questo. In tutte le forme di “populismo” (sia “di destra”, egemonico, sia di “sinistra”, poco più che abbozzato) erano comuni alcune caratteristiche, proprie della lunga fase neoliberale e della sua conseguente disgregazione sociale. Caratteristiche nella quale affondano le radici le ragioni ultime della rivolta. Si trattava, in altre parole, di un adattamento, con fortissimi elementi di continuità, allo spirito del tempo neoliberale (ovvero, alla “Ragione liberale” che Zhok qui descrive) dal quale molti si sentivano traditi pur senza essere in grado di pensare altro. Una reazione che si nutriva ambiguamente dello stesso veleno[18] che genera il “momento Polanyi”, ovvero della disgregazione e iperindividualismo. Ma se ne nutriva in larga misura inconsapevolmente, quindi senza essere in grado di dosarlo in modo da farlo divenire farmaco.
Si è, dunque, ora in un momento di stallo. Coloro i quali restano profondamente connessi alla “Ragione liberale” e, al contempo, sono (o sperano e sentono di essere) ancora connessi alla sua promessa di futuro, rispondono alla sfida “sovraestendendo” i suoi concetti per respingere “i barbari” che si erano spinti fino alle porte. Coloro che si sentono scacciati, ma sono altrettanto connessi alla “Ragione liberale” (che è, alla fine, la “Ragione” del mondo), rispondono con rabbia, ma senza una vera direzione strategica. Tra la danza rituale e la sostituzione sacrificale dei primi e la cieca rabbia dei secondi si allarga un insuperabile fossato.
Il vecchio appare sempre più morto, ma il nuovo non può nascere.
Perché si apra la possibilità della nascita bisogna, prima, sgombrare le macerie. A questo serve il libro del quale, ora, finalmente, leggeremo la terza parte.
La seconda si era chiusa con la descrizione della cultura postmoderna, la terza si apre con la superficie visibile, in un certo senso, dei “regimi della Ragione liberale”. Sulla base dell’obiettivismo naturalistico e della svolta postmoderna avviene (per ragioni di complessa costituzione, come vedremo) il rifugio nel diritto naturale soggettivo e quindi nella logica “rivendicazionista” dei “Diritti Umani”. Di qui procedono spinte alla disgregazione sociale (Zhok parla di “liquefazione”) di cui sono immagine anche apparentemente insospettabili dinamiche rivendicative come il femminismo di seconda (e successive) generazione e la danza frenetica del “politicamente corretto”.
Diritti Umani
Alcune tappe simboliche del processo di formazione del costrutto politico e giuridico dei “Diritti Umani” sono: il 1948, cioè la Dichiarazione universale dei diritti umani; il 1968, con l’imporsi della piattaforma rivendicativa fondata sulle esigenze di realizzazione dell’individuo; e l’89 o il ’91, quando il crollo del muro di Berlino e dell’URSS eliminano il contendente dell’unico egemone rimasto. Nel testo è presente un’interessantissima descrizione del tema dei diritti dell’uomo, passaggio teorico fondamentale che viene promosso nel ‘48 con la Dichiarazione universale dei diritti umani promossa dall’ONU, e per esso dagli Stati Uniti, e che si rifà, da una parte, alla Dichiarazione di indipendenza americana del 1776, dall’altra alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo del cittadino francese del 1789. C’è, però, una importante differenza tra i due antecedenti. La Dichiarazione americana non è una carta dei diritti e il testo è dedicato prevalentemente a motivare le ragioni dell’indipendenza dalla corona britannica, e gli argomenti sui diritti dell’uomo sono inseriti solo come cappello retorico introduttivo e chiave di una legittimazione che si pretende estranea alla fedeltà al re[19]. Si può dire che il famoso preambolo per il quale tutti gli uomini sono creati uguali, cioè dotati di inalienabili diritti, tra cui la vita, la libertà e il perseguimento della felicità, serve, in tutte le Dichiarazioni di questo periodo ad affermare che i governi sono istituiti per garantire questi diritti, e quindi sia diretta ad affermare che il fondamento della vita sociale non deriva dal re, non deriva dalla tradizione, ma deriva da Dio per come viene interpretato nel testo. Compiendo questo rovesciamento del canone fondativo si esprime con la massima chiarezza, e si pone al centro della scena, una mossa emancipativa di primario valore. Ma i contenuti e fondamenti dei diritti inalienabili, su cui si basa quella mossa, sono ridotti al contempo ai minimi termini; non è il caso di ricordare che in tutti gli uomini non erano incluse né le donne né, tantomeno, gli schiavi. Del resto, quando dieci anni dopo viene approvata la Costituzione americana non ci sono in essa Dichiarazioni dei diritti. Queste vengono aggiunte ancora dopo nel 1789 e nel ‘91, anche sulla scorta della Rivoluzione francese, in forma di emendamenti alla Costituzione, e in esse si parla di diritti civili interni alla nazione americana.
Invece la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 francese ha una caratterizzazione dei diritti dell’uomo molto particolare. Ci si appella qui a diritti naturali inalienabili e sacri dell’uomo, cioè ad una dimensione universalistica astorica; però, già dal terzo articolo, la Dichiarazione prende una piega storicamente determinata, eminentemente politica, e la libertà individuale viene limitata dalle leggi “espressione della volontà generale”, quindi giustificate dal bene della società verso le quali la resistenza del cittadino è giudicata inammissibile. Dunque, il protagonista della Dichiarazione del 1789 è la legge civile, definita dalla Nazione, all’interno della quale il cittadino trova il suo spazio di libertà. L’intera Dichiarazione si rivolge al cittadino.
Centocinquanta anni dopo, la Dichiarazione del 1948 è diversa. Per la prima volta l’idea di un “Diritto naturale” che appartiene individualmente a ciascun membro della specie umana è effettivamente articolato. Ci si trova di fronte a un tentativo di creare un corpus di diritti nel senso comune del diritto legale che però, diversamente dai codici delle leggi finora conosciute, non dipende da alcun organismo politico. È chiaro che una delle spinte decisive per scrivere questo documento consisteva nel desiderio di trovare un modo per condannare i criminali nazisti che non facesse riferimento alla legge tedesca. Peraltro, atrocità come l’olocausto non sarebbero risultate legali neppure secondo la legislazione razzista del Terzo Reich, ma di fronte a ciò che si presentava come male assoluto e avendo vinto la guerra emergeva con potenza, da entrambe le parti vincitrici, la necessità di trovare un punto di vista superiore astorico che non concedesse alcun terreno di legittimità la legislazione nazista. In questa ottica, storicamente data, l’idea di diritto umano con i suoi antecedenti storici si sposava perfettamente a questa funzione. Naturalmente a questa esigenza storica si univa la tendenza e la cultura individualista e antitradizionalista americana.
Ma nelle fasi preparatorie emersero subito notevoli difficoltà. Nell’inquadrare dal punto di vista etico e filosofico il testo, ad esempio, l’Associazione Antropologica Americana mosse critiche molto severe alla possibilità stessa di concepire qualcosa come una ‘dottrina universale dei diritti umani’. Gli antropologi osservarono come fosse impensabile considerare come base di partenza dell’analisi un individuo desocializzato. Ciascun individuo si determina sempre ed inevitabilmente come parte di un gruppo sociale, con una forma di vita sanzionata nei modelli il comportamento. In questa prospettiva una Dichiarazione che pretendesse di applicarsi a tutti i singoli esseri umani, prescindendo dalle appartenenze culturali (e quindi in effetti prescindendo dalle particolarità dello sviluppo della cultura nazista in Germania) rischiava di essere implicitamente imperialista. Come sostenne l’Associazione “e rischia di diventare un’affermazione di diritti concepiti solo nei termini dei valori prevalenti nei paesi dell’Europa occidentale e dell’America”[20]. In sostanza si rischiava di ripetere la mossa del “fardello dell’uomo bianco” che aveva alimentato il colonialismo. Queste ragionevoli considerazioni vennero semplicemente ignorate.
In effetti il progetto non era affatto descrittivo, nessuno pensava che i “diritti umani” fossero una sostanza data, ma espressamente normativo, tutti la ritenevano un’opportuna norma da porre. Secondo le parole di René Casin “poggiava su un atto di fede in un domani migliore”. È ovvio che sul piano logico l’idea che potesse esistere qualcosa come un “diritto di natura” è un esempio sfacciato di fallacia naturalistica che trasforma una presunta naturalità in norma. In natura noi possiamo trovare fatti, ma i valori implicano delle norme. Non le implicano ‘naturalmente’ e senza il passaggio della scelta politica e, quindi, della contingenza storica.
Nell’articolo tre della Dichiarazione troviamo scritto che “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”. Tutti possiamo leggerla come una considerazione condivisibile: chi potrebbe mai desiderare che gli sia tolta la vita o la libertà. Chi potrebbe mai desiderare di vivere nell’insicurezza. Ma da questi valori ragionevoli non scaturisce alcuna norma. Il fatto che un individuo abbia diritto alla libertà significherebbe che la sua libertà non può mai essere vincolata. Ma evidentemente esistono leggi, carceri, punizioni per i casi nei quali la libertà distrugge il vivere comune e civile. La questione è, piuttosto, sempre quanta libertà e sotto quali condizioni. La questione è quella posta dalla Costituzione francese. Ma se ammettiamo che la libertà di cui si tratta è quella consentita dal diritto positivo dei vari Stati, allora la Dichiarazione è totalmente vuota. Se, viceversa, non facciamo riferimento a nessuna registrazione reale non si sa di che cosa si sta parlando. Peraltro, nella stessa frase è dichiarato, oltre al diritto alla libertà, anche quello alla sicurezza. Dunque, si pone il problema di quanta sicurezza e del conflitto tra la sicurezza di uno e la libertà dell’altro (ad esempio, di costringerlo a lavorare, di rendere insicura la sua vita, per es. aumentando la “flessibilità” e “precarietà”, per ridurne la forza negoziale).
Il tema è sempre, in altre parole, come limitare la libertà o quanta libertà può limitare la sicurezza. Norberto Bobbio osservava che i “diritti naturali” non sono “diritti”, ma al massimo “esigenze” che poi devono essere fatte valere negli ordinamenti normativi positivi. La cosa è particolarmente evidente appena ci si accosta al gruppo dei “Diritti umani” di contenuto sociale (articoli da 22 a 27), qui la situazione è davvero paradossale. Si tratta infatti di “diritti” inseriti inizialmente sotto la pressione dell’Unione Sovietica (la quale comunque si astenne dalla votazione finale). Di norma quando si levano gli scudi per denunciare le violazioni dei “Diritti umani” questi sono sistematicamente ignorati, perché sono ininterrottamente violati ovunque dal ‘48 a oggi. Il fatto è che per essi ogni individuo ha il “diritto umano” al lavoro, o alla “protezione contro la disoccupazione”, o, ancora, ad “una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana” (art. 23). Oppure ha diritto a “ferie periodiche retribuite” (art. 24). Si tratta evidentemente di un libro dei sogni che conta violazioni innumerevoli anche nei paesi più benestanti. Anzi che è sistematicamente violato, disapplicato e distrutto tanto più quanto più il liberalismo e la sua forma pura neoliberale si afferma.
Ma questi “Diritti” hanno anche un contenuto che Zhok non esita a definire traviante. In sostanza stabiliscono il principio dell’esistenza di istanze individuali che possono legittimamente abbattere ogni altra considerazione, cioè che agiscono come assi di briscola. Che possono travolgere l’interesse collettivo, ogni sovranità nazionale, e vanno sopra e al di là di ogni consenso. In effetti sono stati espressamente preordinati come arma per andare al di là del consenso nel caso storico dato nazista. Tuttavia, essi riescono ad andare anche oltre le forme di consenso democratico. Se il discorso pubblico assume come dati, e rielabora non criticamente, la validità dei “diritti umani” e se i titolari più autorevoli se ne fanno carico sul piano operativo, la cosa diventa una potentissima arma ideologica. Una cosa che inizia a prendere forma durante la guerra fredda come arma contro un altro consenso (tramite la sistematica denuncia della violazione dei “diritti umani” da parte degli Stati Uniti a sostegno etico e legittimazione delle proprie iniziative sia contro l’Unione Sovietica e contro la Repubblica Popolare Cinese ed i loro alleati) e da allora viene usata, senza soluzione di continuità, contro chiunque si elevi ad ostacolare il dominio imperiale statunitense.
In effetti, già l’idea in sé dei “diritti umani” può essere accusata di individualismo metodologico il quale è, esso stesso, alla base della microfondazione della teoria economica. I diritti sono immaginati come inerenti all’individuo naturale, cioè a un individuo astratto astorico, aculturale e dunque sono utilizzabili come marcatore e punto di riferimento del giudizio sulle azioni e sulle dinamiche collettive. Il dispositivo dei “diritti umani” crea, cioè, un decisivo passaggio teorico in cui richieste individuali che non fanno per sé stesse riferimento a nessun organismo sociale dato (o contesto culturale noto) e che finora nessuno ha riconosciuto possono essere poste come eticamente fondanti ed esistenti in natura e restare lì, in attesa che qualcuno ad un certo punto se ne faccia carico. Magari in appoggio alle sue istanze politico-strategiche.
Questa visione è costituzionalmente irrazionalista, in quanto pone come eticamente fondanti esigenze che, per definizione, non hanno bisogno del criterio epistemico più fondamentale e sul quale c’è ampio consenso: cioè l’accordo intersoggettivo. Inoltre, è una lista aperta alla quale si può sempre aggiungere qualcosa. Negli ultimi anni si è aggiunto il “diritto alla pace”, il quale è tuttavia sistematicamente violato, ma sempre dal più forte; il “diritto alla sessualità”; il “diritto all’informazione”; il “diritto all’acqua”, eccetera. Da ora anche il “diritto alla scelta del genere”. In sostanza, dice Andrea Zhok, ciò che sta succedendo qui è che l’idea di diritto sul piano fondazionale sta diventando indistinguibile da un semplice desiderio. Il dispositivo teorico dei “diritti umani”, essendo fondato internamente su un invisibile individualismo metodologico, delegittima necessariamente gli ordinamenti sociali come sorgente di diritto e accredita, al loro posto, il desiderio individuale come fonte di diritto.
Questo è il passaggio cruciale.
Nel momento in cui si fa posto all’idea che le propensioni o i desideri personali siano fonte primaria di diritto si crea un particolare sfondo. A questo punto il desiderio personale è legittimato a imporre obblighi a terzi. Naturalmente non il desiderio del singolo individuo, perché ciò collasserebbe immediatamente nella guerra di tutti contro tutti hobbesiana; ciò che accade è che, piuttosto, la forma privilegiata per l’ottenimento di norme sociali diventa la rivendicazione.
Cioè, la forma privilegiata diventa il contenzioso, la sfida aggressiva che si appella contro un potere estraneo per avere ragione. Questa metamorfosi della sfera normativa è di primissima rilevanza. Come ricorda Zhok, in tutta la storia umana la fonte primaria della normatività sociale è sempre stata, al contrario, la concordia pratica; ovvero la capacità di certe aspettative di far funzionare un gruppo sociale.
L’obiettivo implicito è sempre stato poter creare società, dunque la norma è sempre stata incarnata in costumi prevalenti, in tradizioni, in regole sia tacite come scritte. A sua volta la legge scritta serviva a discernere i casi dubbi, districare le situazioni ambigue. Determinava, e si determinava, come fonte normativa di assemblee dei magistrati o del sovrano. Nel diritto moderno gli usi e costumi o la normatività sociale viene tacitata e retrocessa sullo sfondo, venendo in primo piano le fonti costituzionali e la creazione corrente di norme positive, in quanto si assume che il diritto scritto abbia già assorbito nel tempo quella originaria base informale e la includa in una forma particolarmente sorvegliata, precisa e razionalizzata. Ma il funzionamento di ogni regola e di ogni legge presuppone necessariamente la condivisione di abiti collettivi, di usi, di pratiche sociali, che rendono la norma intelligibile. Se si distacca eccessivamente da questi tende a rimanere sulla carta. Secondo quanto sostiene invece Zhok “il ‘rivendicazionismo’ implicito del paradigma dei ‘diritti umani’ capovolge radicalmente il senso della normatività sociale, pretendendo che i desideri soggettivi si impongano ai costumi consolidati, anzi, appellandosi spesso proprio all’esigenza di opporsi al costume consolidato, che in quanto ‘tradizionale’ e ‘collettivo’ porterebbe con sé uno stigma, un sospetto di irrazionalità ed oppressione. In quest’ottica il, ‘diritto umano’, invece di assumere come il diritto positivo ed ordinare una funzione regolatrice pacificatrice, tende a rappresentare il grido di battaglia di rivendicazioni sempre nuove, cioè di richieste che qualcun altro si adegui alle mie esigenze”[21]. Ciò accade perché ad ogni diritto di qualcuno corrisponde sempre il dovere di qualcun altro. La crescita di alcuni diritti implica sempre la dislocazione di comportamenti altrui e la limitazione di libertà altrui. Ovvero la contribuzione altrui all’implementazione di un certo diritto.
Ne scaturisce una conseguenza paradossale: ogni società infarcita di ‘diritti soggettivi’ è anche una società con elevatissimi tassi di repressione, coazione e sorveglianza. Ne deriva una società disciplinare, dove la possibilità di violare qualche diritto altrui è un fantasma ossessivo sempre presente. Inoltre, produce un’illimitata tendenza al contenzioso all’aggressione di tutti contro tutti. Se, infatti, le ragioni non sono frutto delle mediazioni, ma devono emergere contro altri e il mondo è concepito con un mondo di estranei, ciò che si afferma è sostanzialmente il principio liberale dell’interazione competitiva. Della sfida per ottenere quanto più possibile a scapito della controparte. In altre parole, “ciò che sul mercato e la competizione per il massimo vantaggio economico, sul piano normativo diviene la lotta per rivendicare il massimo riconoscimento dei propri desideri”[22]. Tutto ciò milita per la sacralizzazione delle inclinazioni, opinioni, desideri personali, che esige semplicemente di trovare qualcuno che ti dia ragione e ti attribuisca i mezzi.
Inoltre, e anche qui paradossalmente, il “paradigma rivendicazionista” dei “diritti umani”, nella generale conflittualità sociale e litigiosità produce depoliticizzazione e forme di intolleranza diffusa perché è espressione della vittoria di un desiderio armato, cioè organizzato, potentemente finanziato, e riapre le porte al diritto del più forte. Sia esso la forza di uno studio legale, di uno stato potente, di una lobby organizzata, questa forma di diritto inventata con l’imporsi del modello dei diritti umani soggettivi è una forma fluida contendibile, reinventabile, capace di superare tutte le barriere di consenso pubblico di sovranità nazionale o di legittimazione democratica. Dunque, ‘l’individualismo metodologico’, ‘il rivendicazionismo’ e la manipolabilità che caratterizzano il paradigma dei diritti umani non sono errori contingenti. Sono espressione, nella cornice intellettuale che sta venendo alla luce, di un’impostazione aliena alla fondazione democratica e parte di una dimensione sovranazionale dove i diritti sono definiti da chi li implementa di fatto. In questo modo la libertà si traduce in arbitrio, ovvero viene esercitata senza appellarsi ad alcuna dimensione razionale normativa e valoriale comune che ne circoscriva e definisca la portata, ma viene letta come “poter fare quel che si vuole perché lo si vuole”.
Ma in questo modo la libertà negativa inizia a divorare sé stessa. Questo processo involutivo mostra delle similitudini anche con fenomeni come il femminismo della ‘seconda generazione’.
Femminismo
La problematica femminista nel dopoguerra[23] è connessa in modo piuttosto intimo con l’emergere di questa forma di ‘rivendicazionismo’ dei diritti. Tuttavia, essa opera non su uno qualsiasi dei molti temi sociali ma sul più fondativo e sul più radicale. Quello da cui è sempre dipesa, cioè, la divisione e il rapporto tra i sessi e dunque la sopravvivenza di ciascuna società. La specie umana è, infatti, quella in cui la riproduzione e l’allevamento della prole impegnano di gran lunga il maggiore investimento di tempo e di risorse rispetto a qualunque altra specie. La specie umana si caratterizza per una gravidanza prolungata, per un parto di norma singolo, e per una lunga cura dopo la nascita. In altre parole, per un esteso addestramento sociale. Sono queste componenti strutturali che portano in luce le specificità, le potenzialità ed i vantaggi evolutivi che ci caratterizzano rispetto al resto del regno animale. In particolare, le caratteristiche vincenti di adattabilità e ubiquità. Ne deriva che la specie umana dispone di una complementarità funzionale davvero molto pronunciata tra i sessi. Una complementarità che si può ricostruire già a partire dalle prime “società” note, quella cosiddetta dei “cacciatori raccoglitori” (che poi, in effetti, include la gran parte della storia nota dell’umanità). In queste società, dominanti fino alla soglia dell’età moderna in gran parte del pianeta, si può dire che la caccia fosse un’attività a trazione maschile, che implicava mobilità sul territorio, mentre le raccolte implicavano meno forza e resistenza ed erano attività a trazione femminile[24]. Ciò perché, come ricorda Zhok, la prole per lungo tempo ha bisogno di sostegno e sorveglianza, cura, e qualcuno deve prestarla. All’origine di questa divisione, secondo la ricostruzione che ne fa Andrea, ci sono quindi due caratteristiche naturali: la prima è il dimorfismo sessuale che caratterizza la specie, per cui nell’uomo tendenzialmente l’esemplare maschile a una maggiore massa muscolare; la seconda caratteristica è l’asimmetria nella facoltà riproduttiva, per cui essendo la specie umana mammifera la gravidanza e l’allattamento sono esclusivamente femminili.
Tuttavia, ciò non implica, di per sé, gerarchia[25].
Molto spesso i gruppi di cacciatori raccoglitori manifestano un elevato livello di uguaglianza se si vanno ad analizzare la dignità, il potere decisionale, tra i soggetti maschili e soggetti femminili. Piuttosto che ‘dominio’ si dovrebbe qui parlare di ‘complementarità funzionale’. Una complementarità che esprime una co-essenzialità. Entrambi i sessi producono e sono indispensabili alla sopravvivenza del gruppo. Come si legge in un testo specificamente dedicato al tema, nella sua prima parte, di Emmanuel Todd[26], la situazione è altamente differenziata nelle diverse epoche e territori, tuttavia la scena originaria si può riassumere come struttura familiare nucleare (una coppia e i loro figli e figlie), con sistema parentale bilaterale, matrimonio esogamico, possibilità di divorzio, talvolta forme di poliginia o poliandria, elevato status della donna. Questa organizzazione è fluida e poco strutturata, abbastanza indifferente verso le pratiche omosessuali (assoluta in caso di quella femminile), poche fobie.
Quando questa forma sociale, molto gradualmente, viene sostituita dalle società agricole stanziali ed emergono organizzazioni anche vaste, a partire dall’età del bronzo, compaiono forme gerarchiche e maggiori differenziazione nelle forme organizzative familiari. Quella distinzione tra ‘interno’ ed ‘esterno’, per la quale il femminile aveva competenza sull’interno, quindi sostanzialmente sulla famiglia e sui rapporti intrafamiliari, e il maschile invece si occupava dei rapporti esterni, della caccia della guerra, man mano che si estendono le dimensioni dei gruppi sociali si struttura e si muta in una distinzione ‘privato’ verso ‘pubblico’. Anche qui, per lo più, la donna ha il controllo e la competenza nella sfera privata mentre l’uomo in quella pubblica. Ma la ‘sfera pubblica’ subisce una notevole estensione. In questa descrizione semplificata per funzione e ruolo sessuale andrebbe inserita una distinzione che si crea (o consolida) in questa forma sociale e che riguarda la forza gerarchica del gruppo familiare in questione nel suo complesso. Per cui ai livelli più bassi (‘subalterni’) si tende al lavoro di tutti, in parte anche all’esterno, e ai livelli più alti (‘dominanti’, o ‘aristocratici’) si tende invece a una partizione più tipica. Osservando la cosa dal punto di vista dei ceti alti che poi è quello ovviamente più noto, per effetto del tramandarsi delle fonti storiche, e al quale implicitamente la ricostruzione di Zhok fa riferimento, nella sfera pubblica nasce il potere. È del tutto evidente che questo potere, infatti, non coinvolge gli schiavi e/o vari ‘paria’. Si tratta del potere legale, del potere politico, creato nel luogo in cui vengono fatte e modificate le leggi scritte, in cui si consolidano le istituzioni, che via via si fa sempre più complesso ed esteso e che essenzialmente è definito nell’ambito extrafamiliare che, a questo punto, si configura essenzialmente come sfera di competenza maschile (maschile e nobiliare).
Questo è l’ambito di cui abbiamo ufficialmente storia, appunto l’ambito del quale la storia scritta nella sfera pubblica ci riconduce notizia. E noi abbiamo notizia scritta sempre di figure maschili che si stagliano con nettissima prevalenza rispetto alle figure femminili proprio a partire da questa arcaica divisione del lavoro. Abbiamo, naturalmente, anche notizia sempre di figure maschili dominanti (con qualche significativa eccezione nelle società più “femministe”, come, ad esempio, l’antico Egitto, o l’età ellenistica nella quale si afferma una relativa equivalenza tra uomini e donne[27]). Intendere questa asimmetria dei ruoli nel potere pubblico, nelle classi dominanti in particolare, come “oppressione” delle donne nelle medesime classi è un evidente anacronismo storico. In quanto proietta il nostro moderno, e contemporaneo, senso di giustizia, strettamente legato alle idee di parità e di uguaglianza nella versione che ci viene tramandata dalla tradizione liberale, su un passato semplificato e idealizzato. Idealizzato perché, ad esempio, trascura che i rapporti gerarchici “patrilineari” non sono uniformemente presenti nel mondo antico, e non lo sono stati sempre. Ad esempio, Sahra Pomeroy ricorda[28] che durante l’età ellenistica la situazione delle donne migliora sensibilmente, e l’educazione delle ragazze inizia ad essere di interesse per le famiglie. Nell’Egitto dei Tolomei, partendo da una tradizione molto più paritaria, la cosa è ancora più pronunciata. Ma anche nel mondo romano, nel quale, pur in un contesto patrilineare e fortemente militarista, in epoca tardo repubblicano e imperiale la situazione migliora, fino ad arrivare alla piena parità legale nel diritto ereditario con il codice Giustiniano (533 d.c.). Comunque sia, pur con significative eccezioni, l’insieme del mondo antico è dominato da assetti ‘patrilineari’ (di tipo “stipite” o “comunitari”[29]), come evoluzione da una forma arcaica meno strutturata. Anche nei casi più gerarchici e lontani dalla nostra sensibilità bisogna ricordare che il nostro ideale di eguaglianza e libertà è estraneo alla stragrande maggioranza della storia umana fino ai tempi recentissimi. Piuttosto, la nozione antica di giustizia è espressa dalla formula latina “unicuique suum tribuere” (attribuire a ciascuno ciò che gli spetta). E ciò che nel mondo antico e nelle società tradizionali spettava a ciascuno era precisamente la sua appropriata posizione e il suo compito in una società che con gli occhi contemporanei, ovvero con i miei propri occhi e con gli occhi del professore Zhok, è permeata di relazioni gerarchiche da capo a fondo. Relazioni gerarchiche costituenti la stessa personalità dei membri.
Prima del diciottesimo secolo ovunque nel mondo la posizione di ciascun individuo era, infatti, sempre definita in relazione all’armonia sociale complessiva ed alla sua relazione di subordinazione rispetto a qualcun altro. Ogni individuo era inserito in un ordine, il quale faceva riferimento ad altri ordini. In questi modelli di società e nelle personalità che in essi erano nati e si erano formati, definire un comportamento “giusto” significava ‘stare nel posto’ rappresentato da una rete di doveri di obbedienza e reciproci doveri di cura. Nella nostra sensibilità contemporanea questa idea è altamente repulsiva; l’idea di dipendere dalla benevolenza di un superiore è un affronto alla nostra originaria dignità. Ma nella storia umana questa è stata la condizione normale di tutti, non specificamente delle donne. Questa caratteristica che noi leggiamo come “paternalismo” è la nota caratterizzante tutte le etiche tradizionali a noi giunte perché informate da un modello di società a ciò ordinato. In una delle civiltà di cui abbiamo più documentazione, quella romana, per gran parte della sua storia esiste una chiara ed espressa condizione di subordinazione legale della donna rispetto al padre e al marito, ma, al contempo, abbiamo ampia testimonianza anche dell’influenza e della capacità o di farsi valere delle donne. Ovvero, l’inferiorità dello status pubblico non corrispondeva automaticamente a ‘oppressione’ e ‘sfruttamento’, e, comunque, non impediva forme compatibili con il quadro dato di “realizzazione personale”. Il punto è che questa realizzazione non ha la forma del ‘trionfo individuale’, piuttosto ha quella della ‘buona rappresentazione di ciò che compete al ruolo’. In questo sistema di concetti e valori ‘una vita ben spesa’ è una vita nella quale ‘tutto è compiuto secondo il proprio posto’. ‘Diritti’ e ‘doveri’ si bilanciavano secondo il principio di una sorta di “benevola complementarità”. Difficile, quindi, a priori (e soprattutto senza proiettare i nostri valori) dire quale fosse la posizione ‘più comoda’, se rispondere ai propri doveri di gravidanza e cura o a quelli del lavoro e della guerra. Doveri di lavoro che nelle classi inferiori erano estesi evidentemente a tutti e due i sessi (ma non quelli della guerra).
Quello che cambia avviene nella rivoluzione industriale e qui nasce anche il ‘primo femminismo’. Il suo inizio simbolico viene fatto risalire alla pubblicazione nel 1792 del libro di Marie Wollstonecraft. In effetti anche sul piano strettamente funzionale a partire dalla metà del diciottesimo secolo fino al diciannovesimo secolo diventa via via piuttosto evidente l’insostenibilità del vecchio modello sociale. Nel 1851 il censimento britannico dimostra che il 30% delle donne tra i 30 e 40 anni sono nubili, cosa che avrebbe comportato normalmente un alto rischio di mancanza dei mezzi di sussistenza. Tuttavia ciò dipendeva dal fatto che molte donne, soprattutto nelle classi popolari (anzi nelle esclusivamente classi popolari), erano, in effetti, impiegate nel lavoro e quindi a partire dalla metà del secolo, su pressione di un movimento molto forte e crescente (al quale parteciparono sia donne che uomini tra le classi alte, si pensi al ruolo di Harriet Taylor e del suo secondo marito il filosofo John Stuart Mill) si mise mano, gradualmente, ad una radicale modifica della posizione sociale della donna in direzione di una parificazione dei diritti formali con l’uomo. Un processo che implicava l’accesso a tutti i livelli educativi e la parità legale in tutte le forme il diritto di proprietà, ma poi, successivamente, anche il diritto di voto e di piena partecipazione politica. Una lotta grandiosa che occuperà il tempo dal 1906 al 1971 (l’ultimo paese a dare diritto di voto appena partecipazione politica alle donne fu la Svizzera).
A cavallo tra la fine degli anni 60 e l’inizio degli anni 70, però, anche il femminismo subisce una metamorfosi radicale. Nel ‘68 un articolo del New York Times usa per la prima volta la distinzione tra un ‘femminismo della prima ondata’, con cui nomina il femminismo tradizionale emancipativo e per il suffragio che aveva avuto evidente successo nei 150 anni precedenti, e un femminismo ‘della seconda ondata’. Questa nuova forma di femminismo nasce nell’atmosfera culturale rappresentata dal ‘68 e sulla base degli esiti delle lotte del femminismo della ‘prima ondata’ nei paesi occidentali e nella parte abbiente della popolazione occidentale. Qui l’idea di una parità completa tra uomo e donna si era ormai affermata, dunque le nuove generazioni avevano metabolizzato l’idea di uguaglianza tra i sessi e le leggi e costituzioni le assorbivano. Tra gli anni ‘50 e gli anni ‘60 questo processo si scontra con ritardi ed arretramenti, ovvero con scorie e normali inerzie. Ci sono aree più arretrate e ci sono generazioni più anziane, ci sono luoghi dove l’ordinamento tradizionale dei rapporti continua a opporre una resistenza al cambiamento, ci sono, anche legalmente, elementi di trattamento asimmetrico residuali da emendare (per esempio, in Italia l’abolizione dell’attenuante per il diritto d’onore si trascinerà fino al 1981). Inoltre, è proprio della concorrenza e dell’aver posto come ordinatore fondamentale della società all’economico che ogni fattore di debolezza dell’offerente forza lavoro sul mercato venga sfruttato per abbassarne il valore (e quindi la remunerazione).
Dunque, si aprono subito due possibilità strutturali, coerenti con il capitalismo e il suo orientamento all’accumulazione di valore astratto, per risolvere la asimmetria biologica determinata dall’impegno di cura caricato in particolare, o in modo asimmetrico, sulle donne: o queste rinunciano alla procreazione, e si riducono a fornitrici di forza lavoro esattamente analoga a quella maschile (e, quindi, dal punto di vista del capitalismo hanno pari valore); oppure la loro parziale indisponibilità ne determina necessariamente una riduzione del valore. Concretamente solo un intervento di tipo statale, che sia esterno e prescinda dalle logiche competitive del mercato, può risolvere questo problema senza costringere a una rinuncia delle funzioni di cura.
Nella versione radicale della cultura del ’68, di cui si è fatto cenno nella seconda parte di questa lettura, questi rapporti di complementarità funzionale tra uomo e donna vengono interpretati però come alias del modello del rapporto capitalistico tra ‘sfruttati’ e ‘sfruttatori’, peraltro proiettando un canone storico e contemporaneo sull’intera storia dell’umanità. Tutto il rapporto tra uomo e donna nell’intera storia della specie umana viene concepito e raccontato, anche a fini polemici, come il più antico sistema di sfruttamento ‘di classe’ (con notevole abuso di concetto). Uno sfruttamento fondato sulla divisione sessuale del lavoro che può essere superato soltanto superando questa divisione. Viene proposta una lettura della storia in cui il ‘potere maschile’ sarebbe stato costantemente esercitato utilizzando strumentalmente istituzioni come il ‘matrimonio’, l’allevamento dei figli o le pratiche sessuali. Questo sistema di sfruttamento viene considerato analogo, in alcuni casi sinonimo, del ‘capitalismo’ e godrebbe ancora di grande seguito perché gli sfruttati non avrebbero preso conoscenza della propria condizione e vi collaborerebbe, sia pure inconsapevolmente. Dunque, il ‘femminismo della seconda ondata’ predilige una militanza politica oppositiva, ma anche persuasiva, e, in alcuni casi, tende al separatismo. Esso diverge in maniera fortissima dal femminismo classico e dalle sue istanze di uguaglianza e diritti. La ‘seconda ondata’ mira, piuttosto, a un rovesciamento del potere; addirittura, ad un rovesciamento rivendicativo che sani tutte le ingiustizie del passato. Cioè il secondo femminismo è mosso da un ideale rivendicativo che non punta a costruire una nuova unità ed un nuovo equilibrio, ma punta al riconoscimento di quella che viene definita come una irriducibile ‘differenza’. È un atto di sfida nei confronti del sesso maschile che è identificato ora come nemico. Naturalmente questo processo nasce dentro lo spirito antigerarchico e antiautoritario del tempo e si sintonizza spontaneamente, con la nuova atmosfera neoliberale che si va imponendo, la quale è tutta rivolta a cancellare ogni traccia di egalitarismo e ogni senso di unità sociale. Uno dei punti di attacco è la nozione di “patriarcato” per il quale, strettamente parlando, si intende che la gestione del potere pubblico avviene per linea maschile (cosa che non implica automaticamente oppressione della parte femminile). Ma nel 1970 Kate Millett[30] individua una nuova e diversa nozione di patriarcato: in esso la subordinazione femminile nella sfera del potere pubblico è vista automaticamente, e senza bisogno di giustificazione o dimostrazione argomentativa, come espressione di un sistema di oppressione e sfruttamento delle donne da parte degli uomini. Ovvero senza porlo come tema o argomentarlo l’interpretazione presuppone le condizioni del mondo contemporaneo e le sue categorie mentali e culturali specifiche come sovrastoriche, e le utilizza per interpretare e comprendere un sistema sociale diverso (peraltro proiettando all’indietro anche i sistemi moderni di sfruttamento capitalistico). Seppure la Millett riconoscesse i progressi avvenuti sul piano legale istituzionale dal ‘femminismo la prima ondata’ lamentava la mancanza dei risultati sul piano della coscienza, degli abiti mentali. Anche questo elemento è perfettamente coerente con lo spirito del tempo e la svolta culturalista. In questa nuova accezione essenzialmente il ‘patriarcato’ non indica necessariamente una dimensione ‘strutturale’, quanto una dimensione ‘culturale’, ‘ideologica’, inerente alla struttura psichica, la quale doveva essere abbattuta per portare la “rivoluzione sessuale” a compimento. Siamo, cioè, in perfetta continuità con lo sforzo postmodernista. Anche il femminismo abbandona da allora la dimensione dell’analisi strutturale socioeconomica e si concentra sul tentativo di ottenere un rivolgimento essenzialmente culturale. Uno spostamento ricco di conseguenze perché concorda con la tendenza soggettivistica del periodo che non disturba più gli assetti che nel frattempo si stavano trasformando in direzione neoliberale[31], non toccando i processi economici, e si concentra piuttosto sul fattore di opinione; ma anche perché sposta la percezione dei rapporti di potere come fattore di natura morale. Lo sfruttamento diventa espressione di una mentalità maschile e moralmente deformata, da qui emerge l’idea che la violenza dell’uomo sulla donna è una forma costitutiva essenziale del ‘patriarcato’. Da questa struttura logica si avvia quel movimento di sensibilizzazione al tema della violenza sulle donne (che naturalmente ha tanti meriti però finisce per promuovere anche una visione unilaterale a tratti paranoica del rapporto tra i sessi).
La sottovalutazione dei rapporti strutturali, rispetto a quelli culturali, porta con sé anche una apparentemente paradossale conseguenza, in realtà espressione specifica della posizione di classe dei denuncianti o meglio delle denuncianti: creare una cornice sistematicamente accusatoria da parte della cosiddetta ‘classe femminile’, sfruttata, verso la ‘classe maschile’, sfruttatrice, che oscura quella che è da sempre, in tutta la storia dell’umanità storicamente nota (ovvero dall’epoca stanziale in poi) la principale subordinazione (se pure non sempre vissuta come tale). Le subordinazioni per ceto e quelle per censo sono, infatti, sempre state quelle dominanti, le principali, più evidenti e più determinanti nella vita concreta delle persone che hanno attraversato la storia di questo pianeta. Tutti gli uomini e tutte le donne di ceto e di censo superiore hanno sempre esercitato, entrambi, un potere su tutte le donne e su tutti gli uomini di ceto o di censo inferiore (insieme ad obblighi e responsabilità il cui tradimento, a ben vedere, provocava sempre rivolte). E questa gerarchia di potere è stata l’elemento biograficamente dominante della vita di miliardi di persone. Questo è l’enorme fenomeno che viene semplicemente oscurato e diventa trascurabile dalla scelta della divisione fondamentale ‘politica’ (ovvero tra l’amico ed il nemico) secondo l’asse maschile/femminile per il quale una principessa sarebbe per sé stessa oppressa da uno stalliere. E compare in questa costellazione di concetti e valori l’idea di dover correggere un torto storico, come se le donne contemporanee fossero eredi dirette di tutte le donne sfruttate della storia (mentre, evidentemente e se mai, ogni donna vivente è erede sia degli sfruttatori e sia delle sfruttate volendo definire gli uni e gli altri secondo il sesso, avendo sempre sia madri come padri). Ma più specificatamente, ogni donna contemporanea è, più plausibilmente, erede di una storia di sfruttamento o di dominazione che deriva dal censo della sua famiglia. Ci sono eredi degli sfruttatori ed eredi degli sfruttati.
Peraltro, in alcune versioni del pensiero femminista della ‘seconda ondata’ lo stesso amore romantico è stato visto come un ‘inganno ideologico’, un imbroglio. Alcuni esiti sono stati, coerentemente, verso il separatismo e la scelta “politica” dell’omosessualità. Anche questa è una conseguenza logica, seppure rigida, dell’individuazione come nemico dell’intero sesso maschile. Come ricorda Jessa Crispin[32], il femminismo è (o rischia di essere) un “processo mentale narcisistico autoriferito”, che classifica le proprie azioni come eroiche, una forma di esclusione di discorso particolarmente potente e subdola (solo i pari possono accedere ad esso), “un mastino che si finge un micetto con una goccia di latte sul naso” (il che, detto tra parentesi, è, in effetti, molto femminile). Si è trattato, e si tratta, anche di un’impresa di piccole élite che spingono per l’affermazione di una politica identitaria, generata con il medesimo meccanismo psicologico della formazione di tutti i gruppi umani in fusione – l’identificazione di un nemico che concentri su di sé “il male”, in modo da poter essere “il bene” -.
Sempre la Crispin ricorda quel che sopra abbiamo riportato, ma giova leggerlo anche da lei:
“le donne hanno sempre lavorato. Molte sono sempre state costrette a farlo. Le nubili, le vedove, le indigenti, le svantaggiate hanno sempre lavorato. Quando le femministe hanno deciso di combattere per il diritto al lavoro, ciò che intendevano era il diritto di diventare medici, avvocati e via dicendo. Le donne hanno sempre pulito gabinetti e pavimenti, sono sempre state pagate per toccare corpi altrui come infermiere, badanti e lavoratrici del sesso.
Né le donne combattevano per svolgere i lavori dei poveracci: in fabbrica, in miniera, nei mattatoi. Fin dall’inizio, il presupposto era che il lavoro fosse una cosa buona, gratificante, che noi ci stavamo perdendo. Non qualcosa che distrugge corpo ed anima, che ti uccide da giovane o ti spinge a desiderare che lo faccia”[33].
In una versione più recente si può registrare la dissociazione tra sesso e genere, che non significa soltanto che il primo termine indica i tratti biologici mentre il secondo quelli psicologici, ovviamente non necessariamente pienamente coincidenti, quanto la tendenza a identificare il secondo essenzialmente come pura entità culturale. In intima connessione con l’idea che il dominio ‘patriarcale’ sia un’ideologia di sfruttamento emerge a questo punto l’idea per cui lo stesso genere sarebbe un costrutto culturale, imposto su una base biologica tutto sommato malleabile, il cui scopo è di definire i generi ‘maschili’ e ‘femminili’, rispettivamente, come il gruppo ‘che comanda’ e quello ‘che obbedisce’. Nel momento in cui io concepisco il genere come un costrutto culturale e lo collego con questa narrazione semplificata (e falsa) emerge, come conseguenza politicamente logica, l’idea che sia possibile decostruire e ricostruire altrimenti i generi, per accedere a un’agenda politica diversa. Detto altrimenti, se si ammette che la distinzione polare tra ‘maschile’ e ‘femminile’ è esito di uno sfruttamento storico, e ancora pienamente operativo, è abbastanza ragionevole immaginare che se lo decostruisco, o lo cancello, allora questo sfruttamento ne viene annullato. Viene messo, quindi, sotto accusa il ‘binarismo sessuale’ e quindi anche, sulla scorta delle letture di Derrida o di Lacan, la tendenza delle categorie linguistiche di costruirsi per opposizioni binarie. Anche qui si tratta, come ovvio, di un’applicazione del post-modernismo filosofico che fa uso di alcune tesi psicanalitiche e fa riferimento soprattutto a un’autrice importante e radicale come Judith Butler[34]. In effetti per la Butler il ‘genere’ non è un nome ma un ‘performativo’ cioè un’espressione che fa essere il proprio significato. Ne consegue che il ‘corpo’ dotato di ‘genere’ è una sorta di fabbricazione, una performance, ed è ‘prodotto’ attraverso gesti ed atti a loro volta condizionati dal prevalente discorso pubblico. Per cui la ‘femminilità’ e la ‘mascolinità’ sono travestimenti del carattere performativo del genere, artificialmente plasmato dal dominio maschilista e dall’eterosessualità obbligatoria. Queste sono le ragioni per cui punto di caduta di una discussione che sopprima i condizionamenti storici e quelli culturali sull’intera divisione di genere, per Butler, è la dissoluzione di ogni opposizione, la fluidificazione del genere teorizzato dalla queer Theory. Saremmo, in un certo senso, all’apogeo della “Ragione liberale”. Viene sostituita ogni identità ed ogni normalità, come ogni naturalità con un appello all’arbitrio soggettivo di essere qualunque cosa si voglia e di rivendicare questa possibilità come diritto.
Secondo il punto di vista che si difende nel libro non si predilige ovviamente un obbligatorio necessario binarismo sessuale o una sessualità obbligatoria. Ovviamente chiunque è libero di fare le sue scelte in questo campo, purché si comprenda che la complementarità biologica tra i sessi, e quella psicologica tra i generi maschili e femminili, con tutte le articolazioni e divisioni possibili e con tutti gli stati intermedi, non può essere trattata come una distinzione sociologica accanto a mille altre. Una complementarità è necessaria, oltre che essere fondante ed essere preliminare per la riproduzione fisica ma anche e soprattutto sociale della specie, cioè per la procreazione per l’accudimento per l’esistenza di un ordinamento familiare e per la relativa educazione. Zhok sostiene, in sostanza, che ci vuole cautela per toccare questo punto, perché potrebbe provocare squilibri relazionali e reazioni violente. Non è un ambito in cui sia appropriato un atteggiamento militante, bensì un atteggiamento di equilibrato approfondimento, che consenta di comprendere e giustificare naturalmente l’esistenza di casi che non rientrano nel canale binario. Sviluppare tolleranza, accettazione, e normalizzare la diversità. Tutte cose in linea con le versioni del femminismo della ‘prima onda’, ma problematiche nell’atteggiamento rivendicativo sorto nella ‘seconda onda’. Se si prova, facendo uso di un atteggiamento forte, a spiegare a tutti coloro i quali si collocano nel quadro binario tradizionale che sono in errore, o addirittura colpevoli. Ovvero, che stanno supportando inconsapevolmente un’ideologia oppressiva e che dovrebbero educare i propri figli in modo diverso. In quanto l’educazione derivante da una millenaria ed ubiqua tradizione sarebbe solo lo sfortunato esito di condizionamenti psicologici passati, eccetera, ciò porterebbe al livello di conflittualità che il professore Zhok giudica essere elevatissimo e rovinoso. Ciò anche considerando che “naturalmente armonizzare i rapporti tra i sessi e un’operazione utile e necessaria, di per sé una operazione complessa a causa di tutte le tendenze centrifughe individualistiche competitive che sono proprie del liberalismo affermato, tuttavia si tratta di un’attività doverosa ed eticamente raccomandabile”.
Politiche delle identità
Queste tendenze si inseriscono nel più generale quadro che ha preso il nome di “politiche delle identità”. Questa è un’espressione complicata e in base alla quale i gruppi sociali che si sentono oppressi non cercano più di ottenere riconoscimento come uguali, cioè come parte della comune umanità, ma sulla base del fatto che sono speciali. Da una prospettiva egalitaria e comunitaria si passa ad una prospettiva rivendicativa e competitiva. Questo spostamento coincide con la rivoluzione liberale. Anche questo fenomeno avviene dentro uno spostamento strutturale che è a monte, cioè quello della progressiva perdita di credito a partire dai primi anni ‘70 della lezione marxiana e socialista, o comunista, che comporta una riduzione delle analisi attente alla dimensione strutturale o collettiva dei fenomeni. Tutta la prospettiva su cui muovevano le lotte sociali precedenti era, infatti, quella della costruzione di una ‘società nuova’, cioè di una ‘comunità nuova’ o di una ‘nazione nuova’ ovvero la costruzione di nuove identità collettive. Tutta questa prospettiva è interamente ed integralmente scomparsa dall’orizzonte in concomitanza con la svolta neoliberale e con essa è scomparsa sia la tradizione culturale letteraria e sia la rete dei concetti. Al suo posto è emersa una sfera di identità alternative affiancate le une alle altre, libere da scegliere individualmente come un prodotto su uno scaffale al supermercato.
In linea generale, invece, le identità fondate e capaci di riprodursi socialmente, estendendosi da una generazione all’altra, hanno una ricchezza di contenuto interno che viene coltivata ed elaborata e quindi trasmessa. Si tratta di culture che sono amate da coloro i quali vi partecipano e conciliano in sé una pluralità di differenze ed inclinazioni. Le identità che si costruiscono, invece, sulla scorta di un gesto inaugurale di negazione, quindi di aggressione e separazione, sono costruite a partire dal concetto di nemico. Sono qualcosa che assomiglia strutturalmente al processo di costruzione del “nazionalismo”, nel quale l’identità collettiva ‘nazione’ è generata per negazione di un’altra nazione: dove, cioè, non è più in questione tanto la coltivazione del proprio interno, della propria cultura, della propria società o delle proprie tradizioni, ma diventa centrale la negazione del proprio ‘esterno’. Per esempio, il disprezzo nei confronti degli altri paesi, che conferisce identità nel senso di non essere quell’altro. Potremmo ricordare il tentativo di formare l’identità italiana attraverso l’ostilità verso la ‘perfida albione’, ovvero le democrazie occidentali, che fa parte della nostra storia. Il punto è che l’identità e l’unità politica si formano attraverso la negazione del nemico. I soggetti che vi appartengono non sanno e non gli interessa sapere se c’è molto, o poco, che li unisce internamente nel lungo periodo, ma trovano un’identità nel momento in cui identificano un nemico comune. Nel farlo si sentono simili e vicini. Tipicamente questa tipologia identitaria emerge sul piano psicologico nella forma di una rivendicazione pubblica di “orgoglio”. L’orgoglio, e la risposta psicologica simmetrica ‘l’umiliazione’, e questo genere di politiche d’identità, si costruiscono come risposte ad azioni ovvero a uno stigma percepito. In questo senso è chiaramente una dinamica comprensibile, ma contiene in sé il problema di non essere in grado di istituire un’identità veramente collettiva. Porta in essere ‘comunità’ che hanno soltanto forma rivendicativa, come desiderio di conquistare tutte le garanzie e diritti speciali riservati. Le stesse sono immediatamente indisponibili ad altri compiti (come la lotta per l’emancipazione economica generale) in quanto nel porli il confine ‘amico/nemico’ che le costituisce si dissolverebbe e potrebbero scoprire di essere attraversate al loro interno dai nuovi confini.
Questo è un punto decisivo: lo spostamento dell’agenda politica, tra l’era socialdemocratica (o ‘socialista’) e quella neoliberale, ha fatto cambiare radicalmente natura al “politico”. Creando quello che ho provato a nominare come “politico-impolitico”. Nel senso che questo ‘politico’ si costruisce moltiplicando le frontiere oppositive sulla base di presunte “identità oppresse” sistematicamente scelte in modo da non porre in questione l’indisponibile assetto generale della società (colpito dal “Tina” neoliberale, o da quello che Mark Fisher chiamava “realismo capitalista”[35]), ma dissolverla attraverso l’identificazione come ‘nemici’ per lo più degli umiliati ed oppressi reali. Se si guarda da quest’angolo la natura ‘di classe’ (ovvero lo status e il ceto dal quale sono identificate queste ‘fratture’ da politicizzare) risulta chiaro. Come risulta chiara la sua natura ‘impolitica’. Allo scopo di porre in questione l’assetto generale della società (i modi di distribuzione, la creazione di ricchezza, la ripartizione del potere effettivo, etc.) questo “politico” relativo alle ‘identità’ è strutturalmente indisponibile. Anzi è neutralizzante. Lungi dai sogni di assemblaggio delle “lotte”, per farlo non bisogna porre le questioni. Non appena si ponessero queste si dissolverebbero[36].
Le lotte identitarie avviano, quindi, processi di frazionamento sociale potenzialmente illimitati, esposti nel discorso pubblico dalla sfera materiale a quella simbolica. Questo processo di frazionamento è visibile già all’interno del ‘femminismo della seconda ondata’, che iniziò subito a frazionarsi secondo ulteriori faglie rivendicative, per cui abbiamo le femministe di colore, quelle privilegiate bianche, quelle separatiste, quelle che spingono per la fluidificazione dei generi e così via. Ma, come appena detto, la cosa più rilevante è che queste dinamiche rendono impossibile impostare una lotta sociale comune per obiettivi strutturali, nel momento in cui moltiplicano le lotte individuali per obiettivi simbolici. In altre parole, ogni tentativo di unire le forze per definire politiche per una società o per una comunità, o una nazione, migliore sono sistematicamente ostacolate da una politica delle identità che si mostra essere in effetti una politica della progressiva disintegrazione di ogni identità[37].
Politicamente corretto
Il ‘politicamente corretto’ è un’operazione di organizzazione dei discorsi interna all’élite. Specificatamente è un’operazione di organizzazione egemonica interna per regolare le liti intellettuali. Il suo impatto sociale non è proporzionale dal numero delle persone coinvolte. Dal punto di vista popolare le gesticolazioni e le censure del politicamente corretto sono infatti di interesse assolutamente minoritario, restano quasi non viste, tuttavia, le minoranze coinvolte in queste pratiche sono collocate nei punti strategici della creazione dell’opinione pubblica, cioè nei giornali, nelle scuole, nell’università e si tratta quindi di minoranze il cui impatto tende a essere significativo. Il senso profondo del ‘politicamente corretto’ consiste nell’escludere dal numero del tollerabile (ovvero di ciò che si può dire e possibilmente di ciò che si può pensare) tutto quello che si presenta come potenzialmente offensivo o lesivo di gruppi presunti vittimizzati. Lo slittamento rilevante qui è che nel momento in cui la percezione soggettiva e il desiderio individuale diventano essi stessi sorgenti potenziali di diritto di normazione morale, come è stato visto, cioè quando si ammette che qualcuno può imporre limiti all’espressione altrui sulla sola base del proprio senso soggettivo di cosa sia offensivo o improprio, allora si apre un processo intrinsecamente privo di moderazione ed illimitato. Ad una parte viene attribuito un privilegio unilaterale che prescinde dal bisogno di confrontarsi con la controparte, i cui diritti vengono compressi, e le richieste di rispetto non hanno bisogno di sollevare altro argomento che non sia il proprio disagio personale, il proprio senso soggettivo di vulnerazione e di insulto di fronte a certe espressioni, oppure a certi temi o certi argomenti. Si tratta di un processo, per così dire, di sacralizzazione della vittima. Operazione assolutamente caratteristica del trionfo della “Ragione liberale”. Il punto di partenza logico è la cornice assiologica liberale, nella quale non esistendo più valori obiettivi l’unico valore sui generis è il sentimento della libertà negativa. Date queste premesse e visto che la libertà negativa non ha propri contenuti, l’unico contenuto positivo su cui si può convergere è, infatti, una doppia negazione. L’avversione verso negazioni della libertà soggettiva. Ogni negazione della libertà soggettiva è violenza. E la violenza si esercita su un oggetto passivo che è quindi la vittima. La vittima è chi ha subito, e quindi proverbialmente è ‘per definizione’ senza colpa. Come sostiene Zhok “nella cornice liberale la tutela delle vittime è perciò l’unica cosa rimasta su cui creare un simulacro di unità etica”[38].
Ma chi sono le vittime? Il punto è che la vittima è una fonte normativa primaria, quindi la creazione di un gruppo vittimizzato è la mossa etica fondante. Una volta che qualcuno è riuscito accreditarsi nella posizione di vittima acquista automaticamente quella autorità morale che nella società moderna è stata sottratta a tutte le altre voci, che quindi, a questo punto e per definizione, esprimono solo opinioni personali. Il ‘politicamente corretto’ è naturalmente un’arma asimmetrica, ed essendo essenzialmente di natura morale esercita un impatto in tutte quelle aree sociali nelle quali il discredito assume un ruolo fondamentale. Dove, cioè, la posizione di potere o di carriera è determinata dal credito presso i propri pari ed al ruolo intellettuale rivestito. Perciò il ‘politicamente corretto’ è per sua natura un’arma debole se è rivolta verso i ceti popolari o ceti subordinati, i quali vivono in un altro mondo, ma è un’arma potentissima se usata nei contesti sociali apicali, in cui la carriera si fa sulla base del consenso tra i pari. Qui violare il conformismo del ‘politicamente corretto’ può costare letteralmente l’intera vita sociale. Il ‘politicamente corretto’ esercita, quindi, la funzione di blocco sacro o tabù in senso tecnico, ovvero di interdizione sacrale.
Tra le altre cose anche l’affermarsi di queste forme di inibizione preventiva a certi discorsi crea uno scollamento tra le forme delle discussioni dell’élite e le forme di discussione popolare, dove simili censure hanno scarsa presa. In un regime democratico questo scollamento ha pesanti ripercussioni e crea fratture insanabili nel dibattito pubblico, inoltre l’articolazione dei gruppi definiti come ‘vittime’, quindi come socialmente in credito, produce una competizione sociale verso rivendicazioni particolari con esiti naturalmente divisivi senza limiti. A questo proposito è molto interessante notare ancora una volta che c’è un solo gruppo che non compare mai, neppure per caso, tra quelli letti come oppressi e bisognosi di tutele speciali e questo gruppo è il ‘proletariato’, in qualunque delle possibili definizioni contemporanee[39]. La frammentazione di ogni società in una miriade di istanze rivendicative particolari, che sono per definizione non universalizzabili è selezionata cioè favorevolmente dal sistema economico, perché crea un agone competitivo frammentato e depotenzia ogni istituzione politica che guardi alla società il suo complesso. Inoltre, colpisce sistematicamente le idee di normalità e naturalità, con tutti i loro corollari, colpisce cioè l’idea di natura umana.
Conclusioni
Il senso di questa lunga riflessione non è di condannare, in blocco, l’intero sviluppo storico del liberalismo (operazione in sé antistorica), ma di prendere le distanze dagli esiti che si generano in occidente e in questo secolo. L’emergere della “Ragione liberale”, a partire dagli impulsi determinati dalle nuove forme culturali, dall’espansione dell’economia monetaria e dalle condizioni della rivoluzione scientifica (e dagli altri fattori della “Grande convergenza”) è stata una soluzione adattiva di successo nel nostro occidente. Questo successo non è dipeso da una più organica teorizzazione ma proprio da risposte parziali, qui e lì necessarie per colmare lo spazio tra un sistema resistente e gli impulsi delle nuove classi emergenti. La tesi fondamentale di Zhok è che proprio per questo la “Ragione liberale” ha avuto successo. “l’essere un contenitore culturale vago e piuttosto informe l’ha resa permeabile a variazioni in corso d’opera, a integrazioni pragmatiche e a una certa ‘ecumenicità’ (donde la natura variegata delle istanze che si sono dette ‘liberali’)”[40].
La conseguenza è rilevante:
“In ultima istanza la ragione liberale ha trovato una chiara identità solo nei suoi tratti negativi, in ciò contro cui si schierava (il superamento dell’Ancien Régime), lasciando alla contendibilità futura ulteriori aspetti. E questo carattere che sta alla radice dell’apparente difficoltà odierna di ‘non dirsi liberali’: dopotutto in qualche senso chiunque non sostenga apertamente il ritorno a forme di vita teocratiche, monarchiche oligarchiche a base ereditaria può essere inserito in qualche modo nella grande famiglia liberale”.
Le soluzioni di successo che la Ragione liberale ha, via via, escogitato sono la “tolleranza”, la “teoria del bilanciamento dei poteri”, l’affermazione della “virtù della libera iniziativa economica”, lo “Stato di diritto”, il contributo ai moderni stati democratici. Tutte queste soluzioni per Zhok sono consolidate e vanno conservate (se pure in qualche caso temperate e comunque relativizzate).
Tuttavia, al contempo, la Ragione liberale, nel momento in cui ha manifestato quella che definisce una “forza progressiva”, ha anche mostrato dei limiti. Alla metà dell’Ottocento questi limiti sono risultati evidenti e denunciati nel “Manifesto del partito comunista” da Karl Marx con acutezza che tuttavia confermava, al contempo, la sua fascinazione per quelli che gli apparivano come gli elementi ‘progressivi’ dominanti nel lungo processo storico che stava descrivendo. I processi di disgregazione sociale e culturale derivanti, e connessi all’infittirsi delle dinamiche di competizione capitalistica per i nuovi mercati e l’espansione della fase finanziaria, già alla fine dell’Ottocento, però, portarono in luce gli elementi disgreganti decisamente distruttivi connessi con quella che si può chiamare, la “Prima globalizzazione”. Con essa il disorientamento individuale, la rabbia sociale che furono deviate verso esiti sciovinisti nazionalisti fino alla guerra mondiale.
Il vero problema per l’autore è che:
“Il nucleo portante della visione liberale non è frutto di alcuna visione etica, filosofica, religiosa, umana, non è mossa da un progetto, non da una prospettiva di civiltà, non da un quadro morale, non da un’intuizione ideale. In esso si ritrova la necessità di utilizzare ogni visione utile a liberarsi del vecchio mondo, con il peso delle sue tradizioni e dei suoi vincoli, e si ritrova la necessità di gestire un nuovo potere, conferito dalle inedite capacità di manipolazione scientifica e incremento produttivo. Non c’è mai nella ragione liberale alcuna ‘profondità etica’. E anzi per il liberale già parlare di qualcosa come una ‘profondità etica’ appare incongruo e sospetto. C’è l’esigenza per chi si va a liberando dell’ingombro del vecchio mondo di trovare coperture giustificative, soluzioni pratiche che gli consentono di cavalcare con successo le nuove forze sociali ed economiche si sono liberate. È perciò che il trascolorare dell’essenza del liberalismo classico nelle categorie dell’economia neoclassica non presenta alcuna difficoltà: non c’era una visione strutturata dell’uomo, del mondo, del giusto e dello sbagliato da trasporre, ma solo una versione minimalista e pragmatica, traducibile senza resti in una visione che rendeva l’umano un fantoccio senz’anima, la storia un non senso, e la società un’illusione. La forma di vita liberale, implementata dal sistema di relazioni capitalistiche, ha proceduto ad elevare il mezzo all’altezza del fine, lo strumento in posizione di scopo, il potere al posto del valore. Ciò ha condotto una progressiva ‘liquidazione del mondo’, concependo ogni momento dell’esistenza come uno snodo, un transito provvisorio verso la conquista di maggior potere, maggior libertà d’agire, maggior capitale. Le identità sociali sono state frammentate indefinitamente e spoliticizzate. Le identità territoriali sono state trafitte e debilitate dai movimenti di capitali e forza lavoro. Le identità personali sono state impoverite e scosse dalla rottura delle relazioni di riconoscimento, dalla mobilità e flessibilità, dalla precarietà e dall’insicurezza”[41].
L’azione collettiva è resa più ardua dalla rottura delle comunanze e dalla frammentazione dei rapporti materiali, dalla identificazione per moto proprio di sempre più ‘identità’ in reciproco conflitto.
Poiché la Ragione liberale, nella sua essenza, è assenza di limite e di senso allora sostanzialmente la natura si trasforma in una sorta di grande deposito di mezzi e strumenti, di cose indifferenti, predisposta al calcolo. L’unica radice di valore resta il singolo individuo, ed essa vale solo per sé. Una sfera residuale di valore che ha la forma di un’apparenza soggettiva insindacabile e può essere espressa solo in atti individuali, quindi nelle scelte di mercato. Ma si tratta di una sfera che non ambisce, e non può farlo, a costruire alcuna realtà condivisa. Il valore viene ridotto a emozione. Questa idea che la società può funzionare con la sola adozione di regole formali, mentre tutto il resto viene lasciato la libera scelta individuale è palesemente insostenibile, falso empiricamente, sostanzialmente disgregante ed anche logicamente incoerente. Perché dovremmo concordare nel rispetto delle stesse regole formali e sulla base di quale motivazione? Perché le regole formali permettono la pace, il benessere economico? Se fosse così sarebbe l’adesione ai valori condivisi, quelli che appunto valorizzano pace e benessere economico come valori chiave ed essenziali, a giustificare l’adozione delle regole. Allora le regole non sarebbero più ciò che dicono di essere (formali), potrebbe essere revocate in favore di regole differenti o di decisioni sostanziali che permettono di restituire in modo migliore quei valori.
Questa forma di isolamento soggettivo caratteristico e coerente con la Ragione liberale si esprime nella sua forma più sistematica attraverso le istanze del “rivendicazionismo”.
“Ogni gruppo, sottogruppo, in ultima istanza ogni individuo lotta per essere riconosciuto come vittima di qualcosa di qualcuno, in modo da poter conquistare spazio diritti a scapito di altri individui e gruppi. Un sistema di rivendicazioni oppositivo ha preso il posto del tentativo di creare consenso positivo intorno a qualcosa; al suo posto emerge la ricerca di un consenso negativo come legittima rivalsa. Vengono così a crearsi a getto continuo linee di frattura e risentimento: donne contro uomini, omosessuali contro eterosessuali, bianchi contro neri, islamici contro cristiani, nord contro sud, vegani contro carnivori, giovani contro anziani eccetera. L’epoca che inneggia la diversità fa di questa diversità un campo di battaglia in cui i rapporti tra diversi prendono una forma oscillante tra il contenzioso sindacale la causa giudiziaria”[42].
L’altra tendenza emergente è quella che porta ad individuare, come linea di frattura essenziale, quella tra ‘progressismo liberale’ e ‘reazionarismo imperialistico’. Il primo remerebbe in direzione della corrente, procedendo ancora allo smantellamento delle unità sociali residue ed alla liquidazione delle identità più coriacee. Al contrario la linea cosiddetta ‘reazionaria’ sarebbe quella che, rigettando questo movimento, cerca di ripristinare condizioni pre-liberali. Ovviamente questi ultimi, ad esempio espressi da alcune delle affermazioni del presidente Reagan o della Thatcher verso stili di vita più tradizionali o valori patriottici (ma si potrebbe elencare anche Bush junior e Trump) sono sempre stati del tutto illusori. Non si può tornare a forme di vita preesistenti.
Tuttavia, l’analisi condotta in questo libro chiede di andare oltre le forme di opposizione apparente, in realtà perfettamente in linea con la direzione liberale. È assolutamente indispensabile frenare le tendenze distruttive messe in essere dalla “Ragione liberale”, nel momento in cui si espande senza freni. Bisogna disporre, in altri termini, di un apparato frenante[43]. A questo fine, però, bisogna anche riconoscerla, perché questa, come ogni discorso egemonico largamente dominante, è presente anche nelle forme oppositive (anzi, data la sua natura storica, specialmente in queste).
L’intero discorso di Andrea Zhok, per come lo leggo, è incorporato in questa decisione di lettura, che necessariamente si fa ‘filosofia della storia’. Scriveva Benjamin in “Sul concetto di storia”:
“articolare storicamente ciò che è passato non vuol dire conoscerlo ‘come è stato veramente’. Vuol dire impadronirsi di un ricordo per come balena nell’istante di un pericolo”[44].
Ed oggi il “pericolo” al quale chiama la riflessione è questo ridursi senza resti di tutto “a strumento della classe dominante” (ancora Benjamin), e quindi bisogna “cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla”. Michael Lowy riporta[45] un passo contenuto nelle note preparatorie, che richiama direttamente la metafora del ‘sistema frenante’ proposta da Zhok: “Marx dice che le rivoluzioni sono la locomotiva della storia universale. Ma forse le cose stanno in modo del tutto diverso. Forse le rivoluzioni sono il ricorso al freno di emergenza da parte del genere umano in viaggio su questo treno”. Un passaggio non incluso nel testo finale.
Sul piano pratico bisogna quindi ostacolare l’ampliamento costante di tecnologie distruttive, di cose disponibili per gli atti di compravendita, l’estensione della capacità del denaro di esercitare il suo potere e di disporre quindi dell’esistenza di soggetti talmente immiseriti da essere a sua totale disposizione. Occorre adottare sistematicamente correttivi per modulare, arrestare e far regredire le tendenze all’opera. Realizzare un limite.
[1] – Si veda, in particolare Max Weber, “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”, del 1904, che inaugura una lunga tradizione (per la verità anticipata dalle intuizioni di Marx) poi ripresa da Benjamin nel frammento “Il capitalismo come religione”, del 1921, e riprende molti elementi da “Il capitalismo moderno”, di Werner Sombart, del 1902.
[2] – I quali già nel 1903 diagnosticano l’insostenibile antropologia liberale, decostruendo la credenza del carattere originario dell’attore sociale, gli effetti perversi derivanti da questa dimenticanza nelle strutture di produzione e riproduzione sociale. Si tratta, del resto, della ripresa di elementi di critica già presenti in Hegel che del processo storico di affermazione del liberalismo trionfante vede solo i prodromi, l’individuo ha natura intersoggettiva nel senso che è sempre il frutto di eventi storici ed è costruito a ridosso “dell’altro” (e quello di questo). Marcel Mauss “Saggio sul dono”, 1903.
[3] – Onofrio Romano, “La Libertà Verticale”, Meltemi, 2020, p.75.
[4] – Che ho cercato di descrivere in Alessandro Visalli, “Dipendenza”, Meltemi 2020.
[5] – Pur se la sensazione di assoluta assenza di vie di uscita che promana dalla lettura del libro risente dell’implicita mancata presa di consapevolezza degli spazi di espansione monetaria aperti dal delinking del dollaro con l’oro del 1971. Cfr. James O’Connor, “La crisi fiscale dello Stato”, Einaudi, 1973. Lettura parziale qui.
[6] – Christopher Lasch, “La ribellione delle élite”, 1995
[7] – Castoridias, Lasch, “La cultura dell’egoismo”, 1986.
[8] – Ronald Inglehart, “La società postmoderna”, 1996
[9] – Antony Giddens, “Identità e società moderna”, 1991
[10] – Una delle fonti principali della sistemazione habermasiana. Che riprende il particolare “automatismo” nella emergenza dell’ordine sociale in grado di spiegarlo senza deliberazione e scelta politica.
[11] – Naturalmente si deve intendere sui termini, è vero che ci sono differenze rilevanti tra il neo-liberismo e l’ordoliberismo. Le formule che scaturiscono in diversi ambienti culturali ed orientamenti politici dalla crisi del liberismo originario, nei primi anni del novecento, e fanno parte di una vasta ricerca di un “nuovo liberalismo” -Keynes- o di un “neoliberismo”. Ma mentre il primo si propone di limitare il mercato attraverso un’azione statale compensativa, che salvi di questo l’essenziale, ovvero la libertà di azione degli individui; il secondo, al contrario, intende usare una gabbia normativa sostenuta dalla forza dello stato per purificare il mercato e far affermare in esso la forma pura della concorrenza. La mossa eleva la concorrenza a principio centrale della vita sia sociale sia individuale, ma lo fa riconoscendo che l’ordine di mercato non è affatto un ordine di natura: è il prodotto di una costruzione politica intrinsecamente storica. Questo movimento che porta alla messa a punto della proposta neoliberale parte per gli autori dal “Convegno Lippman”, dal 26 al 30 agosto 1938, che precede di qualche anno la fondazione della Società Mont Pelerin (1947). Sono invitati Hayek, von Mises, Rueff, Aron, Ropke, Von Rustow, Rougier. Nel discorso inaugurale Rougier ricorda che il liberalismo non si identifica affatto con il laissez-faire, ma è un ordine legale che richiede l’intervento dello stato. Malgrado l’opposizione di Von Mises (che sarà in minoranza anche nella successiva Società Mont Pelerin), la linea centrale condivide questa impostazione, in favore di un “interventismo liberale”. Lo scontro si determina tra ortodossi (Von Mises e Hayek, Robbins e Rueff) e i riformatori (Ropke e von Rustow, che insistono sul fondamento sociale del mercato, ma anche Lippman e Rougier) per i quali ‘essere liberali significa essere progressisti’ adeguando continuamente l’ordine sociale e legale alle scoperte, ai cambiamenti strutturali, senza pianificare interamente il traffico, ma creando un “codice della strada”. Insomma, come scrive Lippman, “gli ‘ultimi liberali’ non hanno capito che ‘ben lungo dall’essere astensionista, l’economia liberista presuppone un ordine giuridico attivo e progressista, teso al continuo adattamento dell’uomo a condizioni sempre mutevoli. Serve un ‘interventismo liberista’, un ‘liberalismo costruttivo’ ed un dirigismo statale che certo si deve differenziare sostanzialmente rispetto alla pianificazione ed al collettivismo” (Dardot e Laval “Il nuovo spirito del mondo”, p.182). Un dirigismo “che implica la protezione della libertà, non il suo asservimento; deve garantire che la conquista di benefici sia il frutto di una vittoria dei più adatti all’interno di una competizione leale, e non il privilegio dei più garantiti o di coloro meglio collocati socialmente”. Questo liberismo rinnovato è, insomma, il regno della legge, e contemporaneamente il governo delle élite, uno stato forte organizzato da competenti la cui qualità sia l’esatto opposto della “mentalità magica e impaziente delle masse” (ivi. p.196). Ne deriva, ovviamente, che la democrazia è affetta da una debolezza congenita determinata dalla eccessiva influenza dei popoli sul governo, attraverso l’opinione pubblica ed il suffragio universale. L’eterno bersaglio del neoliberalismo, per la stretta logica interna che lo contraddistingue, è dunque il potere del popolo, che va limitato e ricondotto alla guida degli esperti. Ma nel neoliberalismo, e sin dai suoi esordi, è presente anche un’altra corrente, non perfettamente coincidente: l’ordoliberalismo tedesco. L’ordine è concepito come dovere politico, nato come movimento conservatore nei circoli antinazisti, prevede “una teoria della trasformazione sociale che fa appello alla responsabilità degli uomini” ed il cui problema fondamentale è come riformare l’ordine sociale dopo lo stato totalitario. Certo l’ordine liberale muove dalla creazione di uno stato di diritto che è all’origine stessa della forma capitalista, l’economico non è per loro un insieme di processi naturali ai quali in qualche modo si aggiunge la regolazione ed il diritto, in accordo o in ritardo. L’ordoliberalismo respinge dunque ogni forma di riduzione del giuridico a sovrastruttura, e ogni concezione unitaria del ‘capitalismo’ fondata su una autonomia dell’economico. Ne sono espressione autori importanti come Ropke, che in “Civitas umana” rifiuta frontalmente il laissez-faire e identifica l’economia di mercato “vitale”, come un’opera d’arte, un prodotto della civiltà particolarmente difficile e che presuppone molto. L’ordoliberalismo è, a sua volta, diviso in due gruppi principali: gli economisti e giuristi della Scuola di Friburgo, come Euckel e Bohm, i sociologi Alfred Muller-Armack, Wilhelm Ropke e Alexander von Rustow. La distinzione è tra la struttura giuridica e quella sociale come focus, i primi sono concentrati sulla crescita economica, dalla quale deriverebbero i progressi sociali, mentre i secondi sono preoccupati degli effetti di disintegrazione sociale propri dei meccanismi di mercato e allo Stato affidano anche il compito di garantire e strutturare un soziale umwelt, un ‘ambiente sociale’, che reintegri gli individui nella società. Alla wirtschaftspolitik, ‘politica economica’, si contrappone la gesellschaftspolitick, ‘politica della società’.
[12] – Un indebolimento che non produce ancora il rovesciamento che si determinò almeno altre tre volte (la prima al termine della crisi mondiale del 1875-90, quando si affermano le prime forme difensive di welfarismo conservatore al contempo della espansione e trasformazione in chiave imperialista del sistema militare/industriale/finanziario denunciato da Hobson, Hilferding e Lenin; la seconda quando il collasso delle due guerre induce ad una nuovo governo del capitalismo, sotto la ferma diarchia dei vincitori – Usa e Urss -; la terza quando il lungo ciclo avviato dalla crisi del ’29 giunge ad una svolta sistemica e si rovescia nuovamente nella soluzione neoliberale), per la persistenza delle strutture ideologiche di fondo – che il testo in oggetto cerca di disvelare e decostruire – sfidate dalla revoca delle loro strutture e condizioni di esistenza. In altre parole, una visione materialista temperata (non dogmatica, né determinista) consente di vedere che la parabola ideologica descritta poggia su una “buona novella” legittimante e su condizioni materiali che non la contraddicano almeno per i più: quella che si sia almeno su un percorso ascendente di ricchezza e benessere. Senza benessere l’intera narrazione liberale viene meno. La revoca, provocata specificamente dal successo del liberalismo nel consentire ai forti di vincere (di essere “liberi”), delle condizioni materiali di benessere per la grande maggioranza rende contraddittorio l’intero paradigma. Si tratta di una ideologia, in altre parole, che si regge necessariamente sulla promessa della “società dei due terzi” (in cui due terzi siano almeno classe media possidente). Ma questa è tramontata in occidente, in particolare dopo la violenta ristrutturazione seguita al 2008 e accelerata dal Covid. Si può vedere anche per contrasto. Oggi una ideologia sconnessa dalle sue basi materiali viene “iperestesa” come reazione. È il canto del cigno.
[13] – Per leggere un recente testo che, da parte decisamente delle élite mondiali, o presunte tali, parte dalla insostenibilità di sistema (ma propone una soluzione “recuperante”), si veda Klaus Schawb e Thierry Malleret, “Covid 19: The Great Reset”, 2021. Un altro autore specializzato in questa sottoletteratura è Richard Florida, il quale nel 2011 ha pubblicato un libro dal medesimo titolo “The Great Reset”, Harper. O Richard Baldwin, specializzatosi nel descrivere ad ampio raggio i processi di innovazione tecnologica ed i suoi effetti sul mutamento sociale e politico (e geopolitico), si tratta ti libri come “La grande convergenza”, quando nel 2016 ipotizzava una terza ondata della mondializzazione (ne abbiamo parlato in questo post), o, il più recente “Rivoluzione globotica”, di tre anni dopo. In un ambito per certi versi più ristretti, focalizzato sul mutamento tecnologico, si può leggere Brynjolfsson e McAfee (“La macchina e la folla”, 2017) Tyler Cowen (“La media non conta più”, 2015) o Jerry Kaplan (“Le persone non servono”, 2016).
[14] – Formula che allude alla differente possibilità di accesso ai diritti sociali che si manifesta e produce quando un processo di formazione della rendita (o meglio, della sua appropriazione) non ordinato al bene pubblico determina crescenti differenziali di complessità sociale, di qualità, efficienza ed interconnessione. Cfr. Bernardo secchi, “La città dei ricchi e la città dei poveri”, Laterza, 2014; David Harvey, “L’esperienza urbana”, Il Saggiatore, 1989; David Harvey, “Geografia del dominio”, Ombre Corte 2001.
[15] – Per molte ragioni che qui non si possono ripercorrere, ma è un processo già in corso almeno da un decennio e che la crisi del Covid-19 ha potentemente accelerato. Tutte le linee di connessione si stanno in questo momento, sotto i nostri occhi, riarticolando.
[16] – Una rivolta della società alla costrizione dell’economico per effetto del rovesciamento della disgregazione del sociale e la crisi di legittimazione di poteri non più in grado di contrastarlo.
[17] – La forma politica del “momento Polanyi”, che vive della caduta di legittimazione, ma necessita di un’espressione specifica per addensarsi, dunque ne dipende. L’espressione politica entra in crisi per effetto delle sue contraddizioni interne e l’incapacità manifesta a produrre una risposta e soluzione plausibile e operabile.
[18] – Il veleno è la disgregazione sociale, individualismo ‘post-materialista’, dominio dei nuovi media disintermedianti, discredito delle élite, snellezza, leaderismo.
[19] – Il problema specifico che era davanti alla Commissione ed al Congresso Continentale nel 1776, con la guerra coloniale già in corso, era di trovare un principio di legittimazione che giustificasse la secessione. Chiaramente si tratta di un processo molto complesso e convulso, la più famosa Dichiarazione di Indipendenza “continentale” fu nello stesso anno preceduta dalla Dichiarazione dei Diritti della Virginia, promossa da George Mason, e adottata dalla Quinta Convenzione della Virginia riunita a Williamsburg. La formulazione di maggio è dunque: “tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti intrinseci di cui … non possono privare o spogliare la loro posterità; vale a dire, il godimento della vita e della libertà, con i mezzi per acquisire e possedere proprietà, e perseguire e ottenere la felicità e la sicurezza”, poi tradotta nella Dichiarazione in “Riteniamo che queste verità siano evidenti, che tutti gli uomini sono creati eguali e sono dotati dal loro Creatore di certi diritti inalienabili, che tra questi sono la Vita, la Libertà, la ricerca della Felicità”.
[20] – Zhok, p. 261
[21] – Zhok, p. 272
[22] – Zhok, p. 273
[23] – Si veda, sul tema del femminismo “della seconda onda”, e sulla sua corrente principale il post “Pochi appunti sul femminismo della differenza”. Sul piano storico e della provenienza delle idee il ‘femminismo della differenza’ (che, certo, è altamente differenziato al suo interno e si può solo qui riportare idealtipicamente), muovendo dal contesto della ‘controcultura’ degli anni sessanta e dalle università americane, è fondato sulla pretesa di individuare un dimorfismo ontologico su base naturalistica per evidenza più fondamentale, o radicale, delle divisioni di classe all’epoca oggetto della critica radicale. Il contesto culturale degli studi linguistici e strutturalisti (e, poco dopo, della penetrazione del post-strutturalismo), favorisce quindi una critica con toni estetici radicali che identifica l’esteriorità del conflitto “tra i sessi” come prioritario sul conflitto “di classe”. È uno spostamento decisivo di bersaglio: invece del capitalismo viene scelto, nel contesto giova ricordarlo del welfare compiuto e di una società affluente, come bersaglio il livello più ‘profondo’ della differenza sessuale. In alcune versioni si scivola verso la costruzione di una femminilità idealizzata, materna, e quindi per definizione non violenta, armonica, naturale. In questa teologia e cristologia trasposta il maschile prende il posto del diavolo. E quindi si veste del simmetrico male, anche esso naturale e quindi ineliminabile: violento sin nelle sue manifestazioni più essenziali, gerarchico, entropico. La costruzione concettuale del “patriarcato”, e la denuncia del “fallologocentrismo” come elemento essenziale ed ineliminabile di ogni cultura umana conosciuta (in particolare scritta) e di ogni forma di organizzazione sociale, induce la duplice mossa del ‘separatismo’ (seguendo il mito della ‘sorellanza’) e della ritirata dal pubblico-politico (in favore di un privato-politico che inconsapevolmente copiaincolla la classica divisione storica premoderna dei ruoli). Tutto questo avviene, giova ricordarlo, in un clima di scoraggiamento e riflusso seguito alla perdita di spinta egemonica, e poi al crollo, del ‘mondo nuovo’ socialista. Emerge quindi la lotta sull’ordine simbolico (Muraro) che rinuncia alla critica diretta dei rapporti sociali, immaginando che la liberazione di tutti emerga come effetto spontaneo dall’azione individuale per l’affermazione femminile (un’idea straordinariamente simile a quella della ‘mano invisibile’).
[24] – Questa ricostruzione storica è sostenuta nel libro sulla scorta di un libro di B. Chapais, “Primeval Kinship”, Cambridge 2008, e sulla base di “The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers”, 1999, come anche di Marlowe “Hunting and Gathering. The human sexual division of foraging labor”, 2007, e un articolo di Dyle ed altri, “Sex equality can explain the unique social structure of hunter-gautherer bands”, “Science, 2015. Zhok, p.284.
[25] – La narrazione femminista, invece, proietta uniformemente l’esperienza media degli ultimi due secoli, interpretati solo in parte retrospettivamente (ma anche da una qualificata minoranza dei e delle contemporanee) come ‘oppressione’ a base sessuale, sull’intera storia dell’umanità nota e su tutti e cinque i continenti.
[26] – Emmanuel Todd, “Breve storia dell’umanità”, LEG 2020 (ed.or. 2017).
[27] – Todd, op.cit., p. 135
[28] – Sahra Pomeroy, “Families in Classical and Hellenistic Greece”, Oxford, 1997.
[29] – Partendo dalla forma familiare più semplice, che tuttavia permane come modello base nel mondo di lingua inglese, “nucleare pura” (coppia con figli che si allontanano e restano liberi di sperimentare, e senza vincoli di ripartizione ereditaria – non egualitaria -), si passa alla forma “stipite” (o “ceppo”), nel quale il figlio primogenito maschio eredita tutto e le giovani coppie coabitano con la famiglia del padre (patrilocalità). In questo modello le figlie sono trattate esattamente come i figli “cadetti” (si tratta del modello dominante tradizionale in Germania, Giappone, Corea, e Svezia). Quindi la forma “Comunitaria esogamica” nella quale i fratelli sono equivalenti, ma prevalgono sulle sorelle (modello Cinese e Russo). Poi ci sarebbe la famiglia “comunitaria endogamica” simile al precedente, ma con preferenza per matrimoni tra cugini (entro l’albero parentale), fino al 50% in Pakistan (è il modello arabo, con una patriliearità molto pronunciata).
[30] – Kate Millett, “La politica del sesso”, Rizzoli, ed.or. 1970
[31] – Per fare un breve promemoria, mentre negli anni che ancora risentono del grande shock della depressione degli anni trenta la questione politica essenziale era stabilizzare l’occupazione e metterla su una traiettoria crescente che coinvolgesse salari, stili di vita e capacità produttive, dalla metà degli anni settanta il clima muta radicalmente. La crisi fiscale del New Deal, in incubazione per tutti gli anni sessanta e tenuta sotto controllo dei paesi guida attraverso una continua rincorsa tra stimoli (di cui la corsa allo spazio e, soprattutto, la guerra fredda sono espressione) e deficit (nel senso di squilibri tra sistemi economici), e l’emersione dell’area dei “petrodollari”, e più in generale della ‘finanza ombra’, crea le condizioni per una inversione. Nel contesto della crescente paura per gli effetti distributivi dell’inflazione e di una stanchezza per i sistemi fortemente regolati, le classi medie occidentali si rivolgono verso un diverso schema legittimante: la questione politica diventa la libertà di scambio e di impresa. Questa nozione si ritrova, in numerose versioni, a tutte le scale. Anche l’individuo complessivamente estraneo all’accumulazione, e non dotato di capitale finanziario, ricerca ora principalmente la libertà di determinarsi e di intraprendere secondo il suo desiderio. Lo spostamento sull’enfasi per il cosiddetto “capitale culturale” ne è sia un effetto (perché questo fenomeno avviene nel contesto della maggiore istruzione provocata dall’espansione, in corso da un quindicennio e quindi giunta a maturazione, della istruzione di massa) sia una causa. In questo contesto la formazione del femminismo della ‘seconda ondata’, con la sua enfasi culturalista e l’attenzione per la liberazione individuale, ha una chiara riconoscibilità fisiognomica.
[32] – Jessa Crispin, “Perché non sono femminista. Un manifesto femminista”, SUR, 2018 (ed. or. 2017).
[33] – Crispin, op.cit., p.35
[34] – Judit Butler, “Questioni di genere”, Laterza, 2013 (ed.or. 1990); “Fare e disfare il genere”, Mimesis, 2104 /ed.or. 2004); “Parole che provocano. Per una politica del performativo”, Raffaello Cortina, 2010 (ed. or. 1997).
[35] – Mark Fischer, “Realismo capitalista”, Nero 2018 (ed. or. 2009).
[36] – Questo è un altro modo di porre la questione del populismo.
[37] – Zhok, p. 311
[38] – Zhok, p. 315
[39] – Il concetto di “proletariato” merita un appunto. Si tratta di un evidente costrutto politico e dal tempo della formulazione alla metà del secolo XIX deve essere ripensato in funzione della diversa organizzazione sociale. Per comprenderne il senso va traguardato insieme al concetto gramsciano di “blocco storico” e secondo il progetto di contendere l’egemonia nel sociale e nel politico. Il nucleo del potenziale “blocco storico” in grado di contendere l’egemonia nella sfera pubblica prima, nella società e nell’arena dello Stato poi, al quale bisogna riferirsi non può che essere il variegato e frammentato mondo delle classi lavoratrici, le più sacrificate dalla forma attuale del modo di produzione capitalista. Il concetto di “classe” che si adopera in questo contesto è quindi di natura espressamente funzionale. Non ha a che fare con la dotazione di risorse individualmente possedute, o l’accesso ai consumi, più o meno distintivi (ovvero dal “ceto”), quanto alla posizione della propria autoriproduzione rispetto al capitale. Non necessariamente, anche se principalmente, la posizione che determina l’appartenenza di classe, si cattura nell’esistenza o meno di “lavoro salariato”. Né, tanto meno, nella figura dell’operaio (ovvero del lavoratore addetto alla produzione di beni industriali).
Il punto è che la forma, storicamente determinata, del nesso tra ‘lavoro vivo’ e ‘lavoro morto’, ovvero tra attività lavorative subordinate a mezzi e oggetti del lavoro stesso, attraversa tutte le molteplici modalità della sua definizione. Riceve un salario come contropartita della sua relazione funzionale con “lavoro morto” (ovvero mezzi produttivi e forme totali della produzione dalle quali viene oggettivato) anche chi apparentemente lavora con partita Iva, è connesso ad una piattaforma, impegnato nelle varie forme di cottimo, anche iperspecializzate (anzi, soprattutto, se iperspecializzate). E la relazione funzionale implica sempre che il capitale (che si incarna nell’insieme dei mezzi produttivi e del nesso generale che li rende tali) si valorizzi. Questa relazione implica sempre dipendenza.
Fanno parte della “classe” lavoratrice, dunque, tutti coloro che si trovano connessi nella forma della remunerazione dietro prestazione a sistemi produttivi ad essi esterni e nei quali sono sussunti (e trasformati in oggetti). Ne fanno parte anche se le modalità cooperative che contraddistinguono il loro lavoro sono mediate da sistemi a maglia larga, invisibili, altamente tecnologici (è il caso delle cosiddette “piattaforme”, ma anche di tante modalità più o meno glamour di lavoro a cottimo o frammentato). Se la segmentazione dell’opera, anche nella iperspecializzazione apparentemente liberante o autonoma, rende impossibile controllare il proprio “valore” (o di “fare il proprio prezzo”). Se, infine, il senso complessivo dell’opera si perde.
Non ne fanno parte non tanto i “ceti medi” (dato che, come detto, non è questione di “ceto”), quanto coloro i quali traggono la propria autoriproduzione dal controllo di segmenti di capitale e quindi, nel nesso essenziale capitale/lavoro che costituisce la forma sociale del modo di produzione capitalistico, dipendono per la propria esistenza come soggetti economici dalla permanenza di tale nesso. Ciò anche se la frazione di capitale è piccola, periferica, subalterna (ad altre).
[40] – Zhok, p.341
[41] – Zhok, p.345
[42] – Zhok, p.352
[43] – Questa metafora riverbera le tesi “Sul concetto di storia” che Walter Benjamin compilò dalle parti del 1940. Qui è l’idea della rivoluzione come “freno di emergenza” di un mondo che, altrimenti, trascinato dall’angelo della storia andrebbe verso la distruzione. In questa idea è presente una complessa costituzione, elementi romantici, ovviamente, e anarchici, anche, ma soprattutto una forma anomala ed originalissima della tradizione ebraica (cui è, peraltro, legato anche Marx). Idea già presente in “Strada a senso unico”, del 1923-35, quando, dopo aver letto “Storia e coscienza di classe” di Lukacs, il critico tedesco si avvicina al marxismo. Nel capitolo “Segnalatore d’incendio”, scrive “se la liquidazione della borghesia non si sarà compiuta a un punto quasi esattamente calcolabile dello sviluppo economico e tecnico (lo segnalano inflazione e guerra chimica) tutto sarà perduto. Prima che la scintilla raggiunga la dinamite, la miccia accesa va tagliata”. La rivoluzione non è né il risultato inevitabile, e naturale, del progresso economico e tecnico, né la sua accelerazione e prosecuzione. Proprio il contrario, essa è la sua interruzione prima del disastro.
[44] – Walter Benjamin, “Sul concetto di storia”, 6, in Senza scopo finale. Scritti politici (1919-1940), Castelvecchi 2017 (p.242). Anche in “Angelus novus”, Einaudi, 1962, p. 77.
[45] – Michael Lowy, “La rivoluzione come freno d’emergenza”, Ombre corte, 2020 (ed. or. 2019), p. 47.