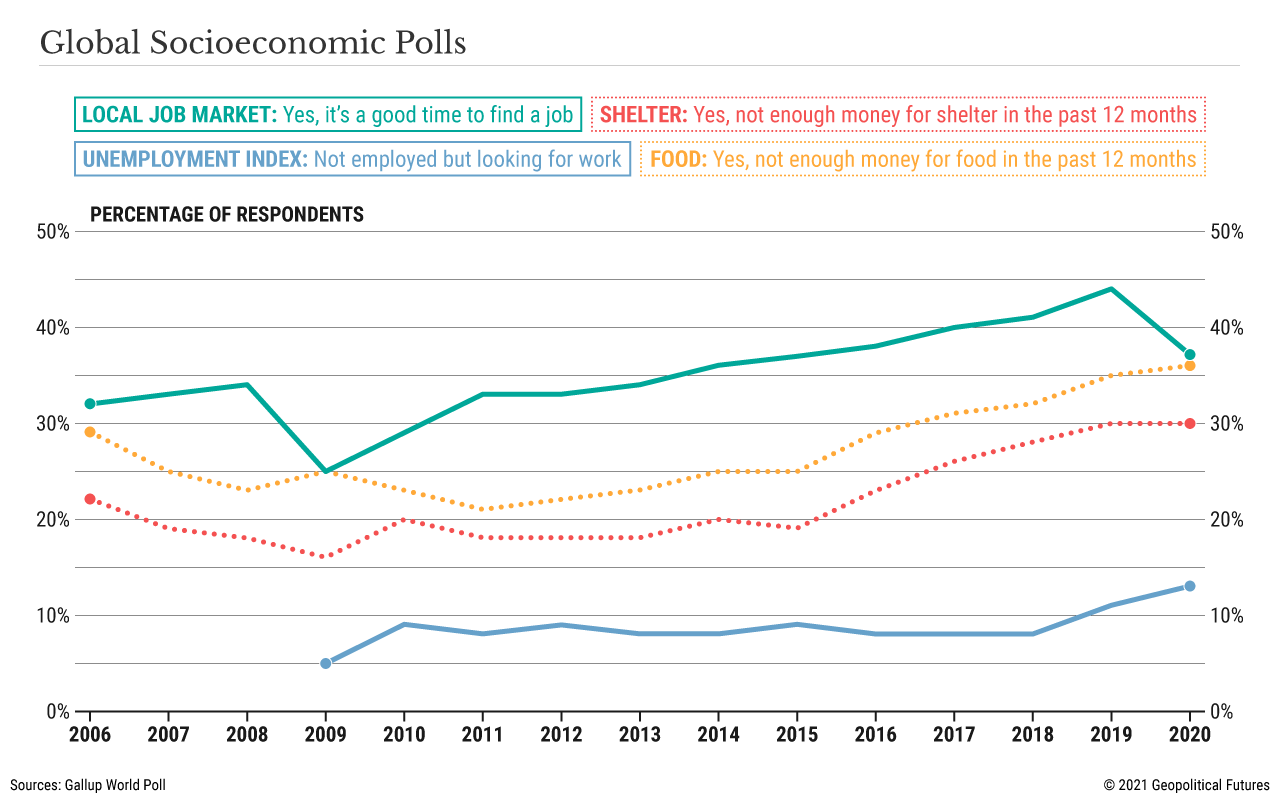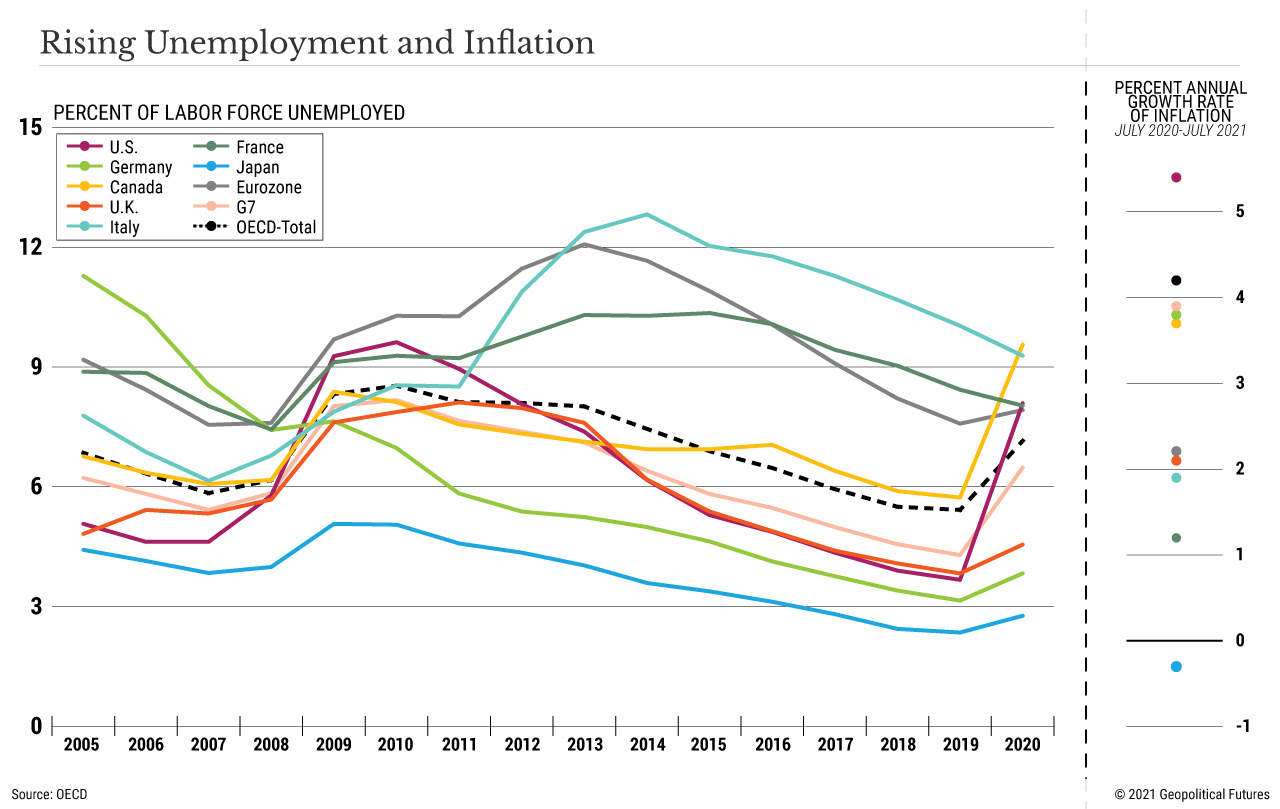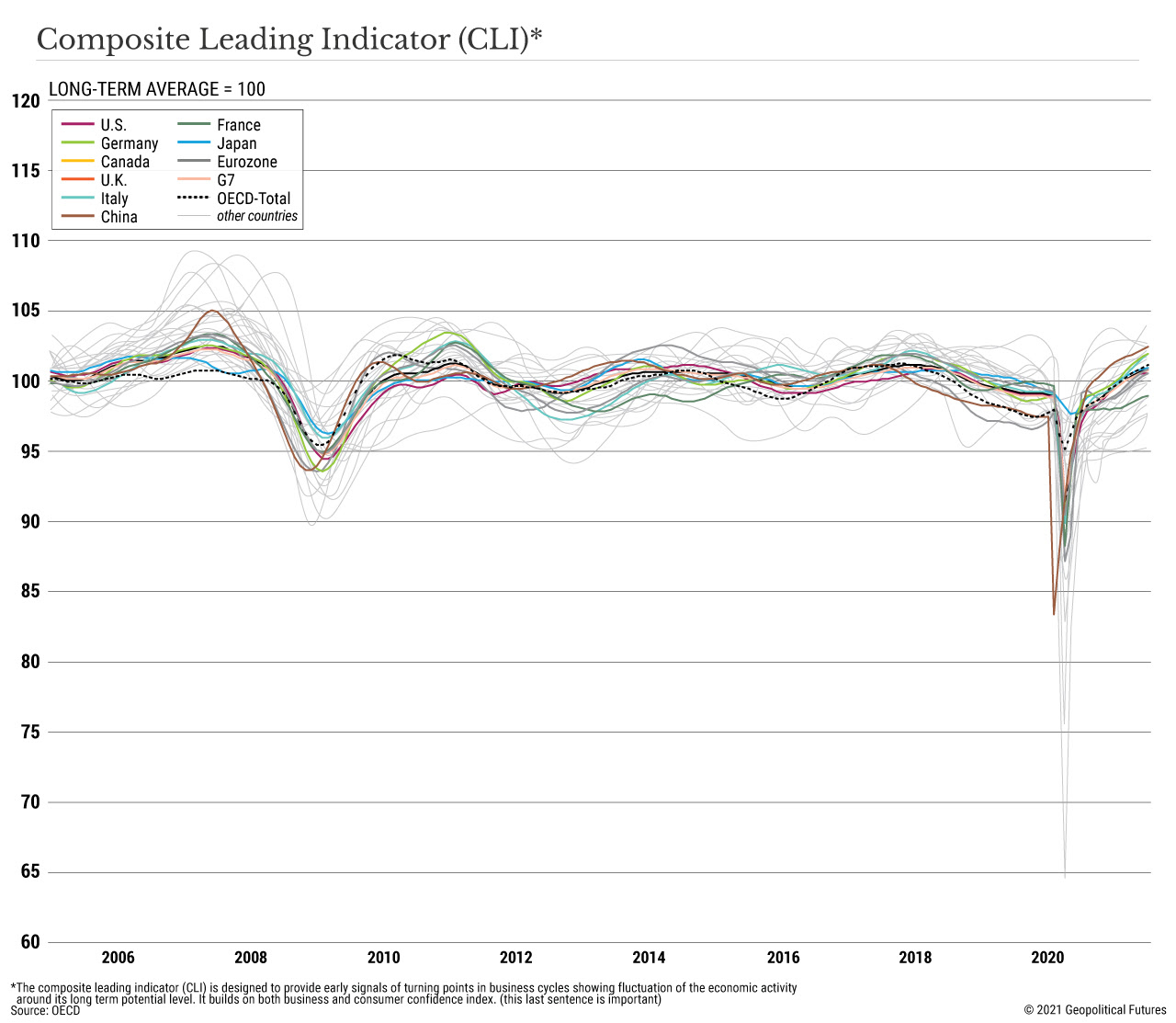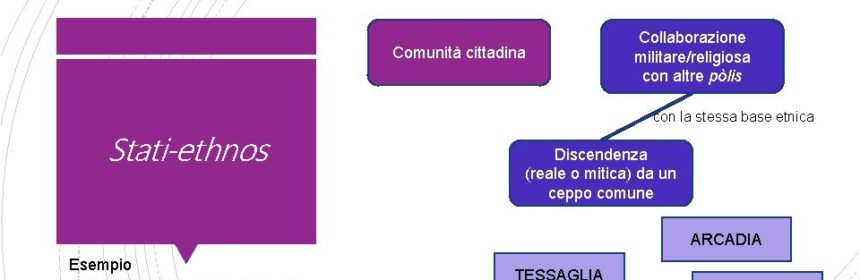Requiem per il “sovranismo”
Con il voto per il primo turno delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, il popolo italiano ha celebrato il requiem per il “sovranismo” italiano. Nelle ultime elezioni politiche di tre anni fa, metà degli elettori italiani ha votato per due partiti – M5* e Nuova Lega – che promettevano, benché confusamente e anche contraddittoriamente, di contrapporsi all’Unione Europea in nome dell’interesse della nazione e del popolo italiano; un movimento culturale e politico che si è convenuto di chiamare, goffamente, “sovranista”. Nel primo turno delle elezioni amministrative appena concluse, una metà degli elettori italiani si è astenuta dal voto.
Certo, la metà degli elettori italiani votante per il sovranismo nel 2018 e la metà astenuta nel 2021 non sono composte dalle stesse identiche persone, e sia nell’astensionismo sia nel voto confluiscono mille motivazioni. La corrispondenza, però, mi pare significativa, e logica. Perché avrebbe dovuto scomodarsi per votare nel 2021, la metà “sovranista” degli elettori italiani, quando i due partiti “sovranisti” del 2018, dopo una caotica e inconcludente esperienza di governo in comune, oggi fanno entrambi parte della maggioranza che sostiene il governo presieduto da Mario Draghi, il maggiore rappresentante italiano del “partito delle istituzioni” euro-atlantiche? Quando in effetti, il programma di governo di Mario Draghi consiste, in sostanza, nell’uniformazione dell’Italia alle linee culturali, politiche, economiche espresse dall’UE? Come ha recentemente rilevato Matteo Renzi, tre anni fa l’Italia aveva il governo più antieuropeista, e oggi ha il governo più europeista d’Europa.
Questa sconfitta del “sovranismo” italiano (non solo italiano) è una sconfitta strategica: non si è perduta una battaglia, si è perduta la guerra, o almeno una intera fase della guerra. Le ragioni pratiche della sconfitta vanno cercate nelle soggettività politiche “sovraniste”, che non sono state all’altezza del compito storico che si erano proposte; o meglio, per essere più precisi e meno ingiusti, del compito che la situazione storica presente imponeva loro malgré eux.
Così che, nonostante gli errori gravissimi commessi dall’avversario negli anni Duemila, nonostante la crisi di progettualità della UE, nonostante le disfunzionalità (tuttora non emendate, e in buona parte inemendabili) del progetto UE e del mondialismo occidentale, nonostante la finestra di opportunità apertasi, sul piano della politica di potenza, con la presidenza Trump che allentava il controllo statunitense sull’Europa; nonostante, insomma, le condizioni oggettive favorevoli alla battaglia “sovranista”, il risultato dello scontro è stata la resurrezione della UE, questo morto che camminava, e delle sue rappresentanze italiane, compreso un partito appena ieri moribondo e impresentabile come il PD; e il ralliement delle due principali formazioni sovraniste, M5* e Nuova Lega; verificatosi, per di più, nella forma ridicola e mortificante di un affannoso trepestio per salire a bordo della scialuppa di salvataggio del governo Draghi. Così agendo, M5* e Nuova Lega si sono disonorati: la parola non si usa più, ma la cosa che designa non ha smesso di esistere.
Il rovesciamento delle alleanze di M5* e Nuova Lega e la loro adesione al governo Draghi replicano infatti, farsescamente, il 9 settembre 1943, con le risse tra maggiorenti di seconda e terza fila sul molo nord di Ortona per riuscire ad imbarcarsi, al seguito della famiglia reale fuggiasca, sulla corvetta Baionetta. Come allora, e come sempre quando chi comanda si disonora, il popolo si disgusta, si rassegna, si rifugia nel cerchio di affetti e interessi personali della vita quotidiana, si spiega il mondo con le tristi ricette del cinismo, e non potendo fare il viso dell’armi tace, fissa lo sguardo a terra, si ostina in un muto diniego: neanche lo sfogo di un popolaresco vaffa gli è rimasto, perché era lo slogan battagliero del M5* “sovranista”, quando prometteva di “aprire il parlamento come una scatoletta di tonno” (!).
Sul come e il perché politici di questa sconfitta strategica c’è molto da dire, e molto ne dirà qualcun altro. Io non ne ho nessuna voglia. Sugli errori strategici della Nuova Lega, a mio avviso la formazione politica “sovranista” italiana più importante, ho già scritto qualcosa nel 2019, nel 2020 e negli anni precedenti. Chi ne avesse voglia cerca il mio nome su http://italiaeilmondo.com/ e trova quasi tutto quel che ho scritto in proposito. Con il senno del poi, mi sembra di averci indovinato spesso, e anche di avere previsto come sarebbe andata a finire, cioè molto male. Basta così. Tanto, non ha più alcuna utilità pratica ragionarci.
Beninteso: le ragioni del conflitto permangono, e con la sconfitta del “sovranismo” il conflitto non è finito: anzi. Esso si riaccenderà, più profondo e violento di prima, e continuerà a divampare per molti anni.
In questo breve scritto, mi preme di indicare – di iniziare a indicare – le cause profonde di questa sconfitta strategica del “sovranismo” italiano.
Scrivo “iniziare a indicare”, perché come cercherò di illustrare più avanti, le cause storiche profonde della sconfitta del “sovranismo” italiano sono anzitutto culturali: e il nodo culturale in cui vanno cercate è un vero e proprio nodo di Gordio, che da almeno due secoli e mezzo la cultura europea cerca di sciogliere o di tagliare, senza riuscirvi. Non ci riuscirò certo io. Mi limiterò dunque a indicare, molto sommariamente, la direzione in cui penso sia fruttuoso volgere sguardo e attenzione.
Il conflitto tra mondialismo e “sovranismo” è, ovviamente, un conflitto tra universale e particolare, o, per usare i termini cari alla cultura idealistica tedesca a cavallo tra Sette e Ottocento, tra Spirito e Natura; impiegando nozioni che datano più avanti nel tempo storico, tra Zivilisation e Kultur.
Per “Natura” va inteso, anzitutto, il mondo vitale degli uomini: i loro costumi, le loro tradizioni, i loro linguaggi, i loro legami di sangue, e in special modo le forme che storicamente integrano nella vita di una comunità tutto ciò che gli uomini non possono scegliere, le loro determinazioni esistenziali: il fatto che gli uomini nascono, maschi o femmine, in un tempo, in un luogo, in un linguaggio, da genitori che sono il loro destino; il fatto che tutti sanno di dover morire; il fatto che mondo, vita, uomo sono infinitamente più misteriosi che noti e compresi; eccetera. Il difetto, o il peccato, caratteristico della “Natura” è l’ostinazione, la cieca ostinazione nella propria particolarità, persuasa del proprio buon diritto a esistere “perché sì”, senza voler mai esaminare criticamente se stessa.
“Spirito” può essere inteso, ed è stato inteso, come “volontà di Dio”, o come “mondo trascendente delle Idee”, fonte della normatività e del giudizio assiologico su bene e male, giusto o sbagliato; oppure come leggi della ragione, pura e pratica, kantiane; oppure, ancora, come logica dell’intelletto astratto, della razionalità strumentale weberiana; eccetera. Nello Spirito, si manifesta la facoltà dell’uomo di riflettere su se medesimo, elevandosi sulla propria condizione, di prendere coscienza – ma scindendosi e alienandosi – di se stesso e del mondo; e di conseguenza, la capacità dell’uomo di modificare il mondo e modificare se stesso. Il difetto, o il peccato, caratteristico dello “Spirito” è la superbia, la cieca superbia persuasa della propria universalità e del proprio buon diritto ad asservire o sradicare ogni particolarità che gli resista: “fiat justitia o veritas o libertas, fiat spiritus – pereat mundus et vita!” scrive Thomas Mann a proposito dello “Spirito” nelle Considerazioni di un impolitico, e aggiunge: “è forse un valido argomento la verità, quando ne va della vita?”
Nelle Considerazioni manniane, la Zivilisation è collegata a concetti come progresso materiale, astrattezza, uniformità, radicalismo, bourgeoisie, politica, democrazia, pacifismo, internazionalismo, letteratura, eloquenza pedante, forma vuota, nichilismo. La Kultur è invece definita negativamente rispetto alla Zivilisation, ma anche tramite l’associazione a concetti come conservazione, interiorità, anima, etica, sostanza, Bürgerlichkeit, arte, musica, poesia, Bildung. Sempre in questo suo ricco, tormentato e contraddittorio testo, scritto nel corso della Prima Guerra Mondiale, Mann esprime il suo timore che “in una fusione delle democrazie nazionali in una democrazia europea e mondiale” non sarebbe rimasto “più nulla della sostanza tedesca”.
Forse, il momento storico in cui è più proficuo volgere lo sguardo – non perché stia all’origine del problema, ma perché lì il problema comincia a chiarirsi e a prendere le forme che tuttora conserva in questa sua fase di nuova, acuta crisi – è il Settecento europeo, e il processo di formazione dei Lumi. Con le guerre di religione, si è spezzata la Cristianità; con la pace di Westfalia nasce lo Stato assoluto. Tra chi legge, scrive, pensa e comanda, il cristianesimo comincia a perdere la sua ovvietà, la sua posizione di presupposto indubitabile e indiscusso, di contesto obbligato per ogni riflessione. C’è dunque da ripensare il mondo di qua e di là, e, sul piano politico, da cercare una nuova e più adeguata legittimazione del potere, dei suoi mezzi e dei suoi scopi.
I laboratori in cui si svolge questo radicale ripensamento, e dove si formano i Lumi, sono due: la République des lettres e la Massoneria, come illustra la bellissima tesi di dottorato (1959) di Reinhart Koselleck. La Massoneria continentale europea si divide presto in due ali, con linguaggio anacronistico denominabili come “di sinistra, progressista, illuminista” e “di destra conservatrice o reazionaria, romantica”. L’una, deistico-razionalista, è la Loggia massonica degli “Illuminati di Baviera”. Vi appartengono personalità come Goethe, Schiller (e il duca di Weimar Carl August), Fichte; si svolge al suo interno un dibattito culturale e politico vivacissimo, spesso aspramente conflittuale, nel quale si forma la cultura politica che darà origine a tutto il ventaglio di posizioni dei rivoluzionari francesi, dai girondini e foglianti ai giacobini. L’altra, cristiano-ermetica-alchemica, è composta da due Logge: l’Ordine della Rosacroce d’Oro e i Cavalieri Beneficenti della Città Santa, a cui partecipano membri della Compagnia di Gesù recentemente disciolta, aderenti al pietismo evangelico, pensatori e politici conservatori: è in queste due logge massoniche “di destra” che si forma la cultura politica che si manifesterà storicamente nella Santa Alleanza.
È interessante e significativo che Goethe, il membro più illustre della Loggia deistico-razionalista “di sinistra” degli “Illuminati di Baviera”, nella sua tarda maturità e vecchiaia sia divenuto un convinto sostenitore di Metternich e della Santa Alleanza. Il giovane incendiario che invecchiando diventa pompiere? Può darsi. Nella seconda parte della sua opera maggiore, il Faust, c’è però una spiegazione diversa, o ulteriore, di questa conversione politica.
Nell’Atto V del Secondo Faust, un Viandante – un Wanderer che è anche un autoritratto del giovane Goethe – turbato e stanco, tanto che “il cuore mi si spezza”, torna all’ “antico recinto, la capanna che mi ricoverò” da un naufragio, per ringraziare i suoi salvatori e riposarsi in un’oasi di pace. Ci vivono Filemone e Bauci, la coppia di vecchi sposi, umili e sereni, della favola ovidiana. A due passi di lì, con l’ausilio di Mefistofele e della sua magia, l’anziano Faust ha intrapreso la sua grande opera di Zivilisation: imbrigliare il mare in un vasto sistema di dighe, strappargli la terra e donarla all’operosità degli uomini. Per completare l’opera, Filemone e Bauci dovrebbero abbandonare la loro capanna, “i tigli antichi” e la cappella dove essi si affidano “alla santa custodia del Dio antico”. In cambio Faust, beninteso, gli ha offerto “una bella terra nel nuovo paese”. Ma Bauci si ostina: “Non aver fiducia nel suolo rubato alle acque: conserva la tua casetta sull’altura.” La caparbia fedeltà dei due vecchi, e il suono della loro campana, infuriano Faust: “Maledetto scampanio, che mi ferisce vergognosamente nel cuore come un colpo di fucile nei cespugli! Il mio regno si stende dinanzi a me senza confini, e consentirò io che il nemico mi derida alle spalle, e mi rammenti con questa invidiosa campana che il mio territorio è illegittimo.” Perché “La resistenza, la testardaggine, amareggiano la più ricca possessione; è solo per tuo danno e per la tua tortura che lavori a metterti sulla strada della giustizia.” Così che Faust incarica Mefistofele di occuparsene, e trasferire i due vecchi, ovviamente senza fargli alcun male: “Va’, dunque, e procura di farli sgombrare! Tu sai qual bel poderetto io abbia destinato a quella vecchia coppia.”
Ma le cose prendono un’altra piega, la piega che prendono “da lunghissimo tempo: la vigna di Naboth esisteva già.”
Insomma, il trasferimento non va liscio: come riferiscono a Faust i Tre Uomini di Mano di Mefistofele, “Perdonate! le cose non riuscirono troppo bene. Abbiamo bussato a quell’uscio, ma non venivano mai ad aprire: allora abbiamo atterrato l’uscio, il quale tutto rosicchiato dai tarli cadde sul pavimento. Abbiamo avuto un bel chiamare, minacciare, ma o non ci udivano o facevano mostra di non sentire; noi allora senza perder tempo te ne abbiamo liberato. La coppia non ha opposto una gran resistenza; essi caddero estinti e ciò fu cagionato dallo spavento. Un forestiero che si trovava colà e che cercò di resisterci, fu da noi freddato, e durante il breve intervallo scorso nel furioso combattimento, i carboni accesero la paglia sparsa intorno. Ora tutto ciò brucia liberamente come un rogo preparato per tutti e tre.”
Dall’alto della sua torre Linceo, come Goethe “nato a vedere, eletto a guardare” racconta l’atroce accaduto: “Quale orribile spavento mi minaccia dal seno di questo mondo di tenebre! Vedo lampi fiammeggianti attraverso la doppia oscurità dei tigli; l’incendio si ravviva e divampa sempre più attizzato dal vento. Ah! la capanna brucia all’interno, essa che sorgeva umida e coperta di muschio. Si sente chiamare soccorso ma invano! Ah buoni vecchi, che un tempo vegliavano vicino al fuoco con tanta cura alimentato e custodito, diventano ora preda dell’incendio! Qual orribile caso! la fiamma divampa, il cupo mucchio di muschio non è più che un braciere di porpora. Possa almeno quella brava gente salvarsi da quell’inferno incandescente e furioso! Vivi lampi s’accendono, fra i cespugli, fra il fogliame; i rami secchi che ardono scintillando, si accendono in un batter di ciglio e vanno in cenere. Toccava dunque a voi, o miei occhi, di fare una simile scoperta! Perché mi fu dato di spingere lo sguardo così lontano? La piccola cappella crolla ad un tempo sotto la caduta ed il peso dei rami; acute fiamme serpeggiano già intorno alla cima degli alberi. I ceppi vuoti e scavati s’infiammano e rosseggiano, fino alla radice.”
[Lunga pausa. Canto.]
Il paesello, così bello allo sguardo, coi suoi secoli sparì.”
E il Coro commenta, prima di uscire di scena: “L’antica parola dice: obbedisci di buon grado alla forza! e se tu sei deciso, se vuoi sostenere l’assalto, metti a repentaglio la tua casa, il tuo focolare. — e te stesso.”
Più chiaro perché il Consigliere Segreto von Goethe, reggente dei “progressisti” Illuminati di Baviera, in vecchiaia diventò un reazionario tifoso della Santa Alleanza?
Più chiaro anche perché “le ragioni del conflitto permangono, e con la sconfitta del “sovranismo” il conflitto non è finito: anzi. Esso si riaccenderà, più profondo e violento di prima, e continuerà a divampare per molti anni.”?
Mi pare di sì. Ne parleremo ancora.