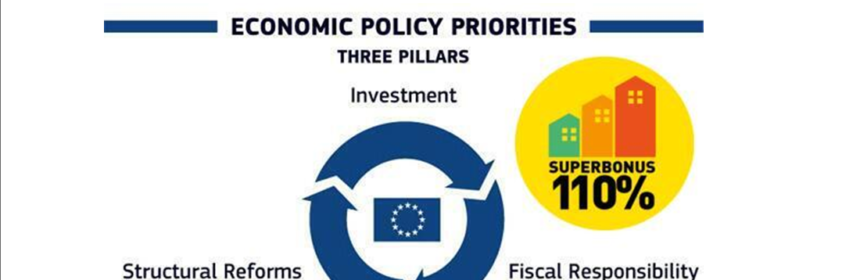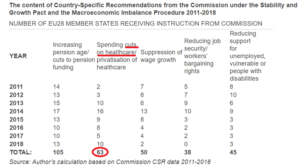Fu la lettura del saggio di Marco Geuna Machiavelli e il ruolo dei conflitti nella vita politica (2005), circa 4 o 5 anni fa, a mettermi sulla traccia di un percorso di ricerca che successivamente mi ha associato alla scoperta del «continente teorico» (per usare le parole di Luca Baccelli) del «repubblicanesimo», un continente ormai esplorato teoricamente da vari decenni, ma non ancora abitato politicamente. La fertilità di questo continente apparirà in tutta la sua potenzialità soltanto se pensiamo radicalmente, se «andiamo alla radice dei problemi».
Ritengo che il repubblicanesimo possa diventare, da corrente teorica confinata all’ambito accademico, un utile strumento per iniziare a definire una nuova teoria politica per gli emergenti movimenti, più emergenti che compiutamente formati, cosiddetti «populisti» (un epiteto con cui si vorrebbe stigmatizzare un’istanza sostanzialmente democratica). È senso comune ormai ritenere che il discredito raggiunto dai partiti politici sorti nell’ambito dello stato moderno sia radicale e definitivo. I partiti politici esistenti non sono in grado, e non ne hanno nessuna intenzione, di affrontare i problemi che assillano la maggior parte delle società odierne. Vedremo in che senso il paradigma machiavelliano può essere utile per affrontare un radicale ripensamento della politica necessario per far fronte alla crisi radicale a cui ci troviamo di fronte. E questo mio scritto vuole essere un modesto quanto iniziale contributo in tal senso.
L’epoca delle ideologie, delle visioni del mondo complessive, una patologia europea del secolo scorso, è tramontata. Machiavelli a distanza di cinque secoli può essere letto con profitto, ma il suo repubblicanesimo non dovrebbe essere considerato un’ideologia, ma un paradigma che configura una teoria politica diversa rispetto alle altre teorie politiche. Tanto più che i repubblicani, sul piano puramente nominale, in Italia ci sono già già stati (un ormai scomparso partito liberale non di massa della «I repubblica» che aveva le sue radici nella storia dell’unità d’Italia), e attualmente sono uno dei due maggiori partiti degli Stati Uniti. Anche per evitare questi equivoci preferisco parlare di paradigma machiavelliano.
Com’è noto, Machiavelli è l’autore più politico dell’intera storia del pensiero occidentale: non confonde la politica con la religione, ma nemmeno con la filosofia o con l’etica. Non per questo è immorale, privo di fini etici secondo quella che è stata una diffamazione secolare. Esiste una specifica moralità della politica che è diversa dalla morale dei rapporti intersoggettivi. Il fine della politica è di mantenere la «repubblica bene ordinata», e a questo scopo è lecito usare la violenza, se necessario, perché il male che ne risulterebbe in caso di disgregazione della collettività, cioè disordine e maggiore violenza, è minore rispetto alle violenze a cui si può essere costretti per mantenere un determinato assetto politico. Come ha chiarito definitivamente Isaiah Berlin, Machiavelli non «separa la morale dalla politica», nel senso che la politica sarebbe priva di fini etici, piuttosto ha una morale diversa rispetto a quella cristiana che ha informato l’intero pensiero moderno, secondo la quale l’individuo ha la preminenza, ma è invece quella antica secondo la quale l’insieme è prioritario rispetto al singolo, la salvezza della città è più importante della salvezza dell’anima. Machiavelli pur non mancando di fini morali (la «repubblica bene ordinata» in cui gli uomini possano vivere liberi) non confonde i piani, voler subordinare l’etica, la religione, la cultura, la filosofia, l’arte ai fini politici è l’essenza della ideologia, che finisce per cancellare qualsiasi piano culturale comune al di là dei conflitti che necessariamente attraversano le relazioni umane. Il concetto marxiano di ideologia partiva da un dato di fatto: l’arte, il diritto, la filosofia, la morale dominante, la religione, persino la ricerca scientifica riflettono i conflitti del loro tempo, ma questo non vuol dire che sono pura espressione di «classe», che i romanzi di Balzac (che Marx tanto apprezzava), espressione sicuramente di un certo mondo borghese, non possano interessare i «proletari».
Il fine della politica è un fine necessariamente particolare che riguarda i conflitti tra gli esseri umani, quindi non può innalzarsi a visione generale. Chi è alla ricerca di una visione del mondo non deve rivolgersi alla politica, ma all’arte, alla filosofia, alla religione, all’insieme del cultura del proprio tempo e di quello passato. Ma proprio perché l’individualismo su cui si regge la società moderna distruggeva ogni presupposto di una cultura comune ci si rivolse alle ideologie nella ricerca di una patria spirituale, ma il rimedio fu peggiore del male.
Se oggi continuiamo a leggere Marx, Hegel, Nietzsche, Heidegger è perché nonostante una loro precisa collocazione nei conflitti del loro tempo, e nonostante il loro essere immersi nell’ideologismo del loro tempo, le loro riflessioni superavano questo fatto contingente per toccare questioni che riguardano tutti. Uno studioso non è tale se non tocca questo livello comune, altrimenti è un puro e semplice propagandista destinato ad essere dimenticato. Nel suo tener fermo alla questione politica Machiavelli è un pensatore anti-ideologico, un salutare correttivo rispetto all’ideologismo del secolo scorso. Se si trasforma la lotta politica in una lotta ideologica, simile alle lotte di religione, il conflitto politico mira necessariamente alla conversione o al non riconoscimento come interlocutore e tendenzialmente all’annientamento di chi non condivide la propria ideologia. Quando una società si divide in gruppi impegnati in una lotta ideologica questa è una società che è destinata al declino, e sottoposta all’influenza determinante di altre società che possono manipolare queste contrapposizioni.
Dopo il «crollo del muro» nessuno più crede ad una delle ideologie concorrenti del liberalismo, il comunismo, mentre per quanto riguarda quella particolare declinazione del nazionalismo che furono il fascismo e il nazismo, la questione fu chiusa con la II guerra mondiale. Oggi esiste una solo grande ideologia, il liberalismo, che non si presenta più come tale, ma come una sorta di senso comune che ogni gruppo politico che vuole avere un ruolo non può non professare. In tale «liberal consensus» che è sempre stato dominante negli Usa, che non hanno avuto movimento nazionalisti e socialisti paragonabili a quelli europei, mentre nelle nazioni europee si è venuto affermando dopo «il crollo del muro», e mentre già negli anni settanta già si iniziava a sperimentare il cosiddetto neo-liberismo in Cile, fece discutere la scoperta del «repubblicanesimo» da parte di John Greville Agard Pocock in The Machiavellian Moment portava alla luce un filone di pensiero «sommerso» che parte dal pensiero comunale repubblicano comunale italiano e che ebbe come massimo esponente Machiavelli, e passa per i pensatori inglesi della prima rivoluzione inglese (principalmente Harrington), fino ai rivoluzionari americani. Il «repubblicanesimo» metteva radicalmente in discussione il «liberal consensus», una storia del pensiero politico statunitense che vedeva «Locke e poco altro», ma non riguardava solo tale contesto, ma il modo in cui guardiamo all’insieme delle dottrine politiche moderne occidentali.
La rilettura della storia del pensiero politico «occidentale» nasceva da un disagio, se così vogliamo chiamarlo, nei confronti di tale paradigma liberale dominante e da un’insoddisfazione per la «democrazia liberale» (come recitava il titolo di un libro di Michael J. Sandel, Democracy and its discontents). In questo modo però si dava per buono il concetto che ciò che la «democrazia liberale» sia davvero tale. Il repubblicanesimo machiavelliano, tra le altre cose, è utile per evidenziare la moderna distorsione del concetto di democrazia, che secondo il significato etimologico significa pur sempre potere del popolo. Particolarmente ostico per la mentalità indivualistica moderna che si ritiene sommamente «libera e democratica» confrontarsi con l’ideale della democrazia antica basata sul cittadino-soldato. Scrive Pocock:
«È proprio l’Arte della guerra [di Machiavelli] a fornirci il quadro preciso delle caratteristiche morali ed economiche del cittadino-soldato. Costui, infatti, per nutrire il dovuto interesse per il pubblico bene, deve possedere una famiglia e avere un’occupazione che non sia quella delle armi . Il criterio qui applicato è identico a quello cui doveva corrispondere il cittadino di Aristotele, che deve, anche lui, avere una sua famiglia da reggere e guidare per non essere servo di alcuno e per poter e conseguire di persona e con le proprie forze il bene, imparando cosí ad avvertire il rapporto che il suo bene particolare ha con il bene generale della polis». 1
Grazie alla sottolineatura della continuità del pensiero repubblicano comunale con il pensiero classico greco, principalmente quello aristotelico, in un primo momento il repubblicanesimo è stato visto come una variante del comunitarismo. Ma se è vero che Machiavelli condivide l’ideale classico della democrazia antica è pur vero che aggiunge qualcosa in più rispetto al pensiero classico che costituisce il suo contributo specifico alla storia del pensiero politico.
Con la critica dell’eccessivo avvicinamento del repubblicanesimo al comunitarismo, che rischiava di far scolorire il profilo autonomo del primo, studiosi come Quentin Skinner si sono affermati nella discussione internazionale sul repubblicanesimo (discussione soprattutto di carattere accademico). Come scrive Geuna, «Skinner cerca di dare un profilo autonomo al repubblicanesimo, sottraendolo all’abbraccio di aristotelici vecchi e nuovi . A suo giudizio, il repubblicanesimo non è una forma di politica aristotelica … Per dimostrare questo, mette in luce come nel pensiero di Machiavelli, e dei repubblicani che a lui si rifanno, non ricorrano alcuni assunti tipicamente aristotelici: l’uomo, innanzitutto, non è presentato come un animal politicum et sociale, per usare l’espressione tomistica, ma come un essere esposto alla “corruzione”, un essere che tende a trascurare i suoi doveri verso la collettività»2.
Per separare il repubblicanesimo dall’ «aristotelismo» (comunitarismo) si è individuata una componente «romana» (Skinner ha adottato la definizione «repubblicanesimo romano» avanzata da Philip Pettit), ma è stata un’operazione teoricamente poco convincente. «L’enfasi sul fatto che la tradizione repubblicana sia una tradizione esclusivamente romana, per origini e caratteri di fondo, lascia più di un dubbio: quasi che l’esperienza politica e culturale di Roma sia avvenuta senza alcun legame con quella greca, quasi che Cicerone nel redigere le sue opere non abbia avuto dei precisi modelli, primo fra tutti Platone»3. Condivisibile è il proposito di differenziare il repubblicanesimo dal comunitarismo, si tratta in effetti di dottrine diverse, senza però creare una netta separazione (ignorando i legami che pur ci sono), operazione che consente a Skinner e Pettit di riavvicinarlo al liberalismo, annacquando il carattere di alternativa teorica del repubblicanesimo.
Per i greci e i romani la libertà individuale si identifica con quella collettiva: il singolo partecipando alla determinazione dei fini collettivi si considerava libero. Nel pensiero comunale e poi nel Rinascimento si fa strada una maggiore individualizzazione, tuttavia la libertà non è ancora vista come esclusivamente individuale, divergente dai fini collettivi, come sarà poi nel liberalismo. Se è vero che la libertà è un concetto fondamentale per il pensiero comunale e rinascimentale, e certo Machiavelli conosceva i versi di Dante «Libertà va cercando che è si cara», altrettanto vero è che la libertà di Machiavelli non è quella di Hobbes o di Locke, è una libertà che comprende anche la «libertà degli antichi», è, se vogliamo dirlo con il Faust di Goehte, il «vivere libero con un popolo libero». Che si tratti di libertà come «non interferenza» (liberalismo) o di libertà come «non dominio» (repubblicanesimo come inteso da Skinner e Pettit), il fine principale è sempre la libertà dell’individuo, mentre per Machiavelli, com’è noto, la salvezza della città è prioritaria rispetto alla salvezza dell’individuo. L’«urbanizzazione» (come l’ha definita Geuna) del repubblicanesimo operata da Skinner e Pettit a me pare piuttosto una compatibilizzazione con il paradigma liberale ancora dominante. Quindi, pur condividendo il proposito di differenziare il repubblicaneismo dal comunitarismo, non condivido questo avvicinamento opposto al liberalismo. Pocock resta molto più interessante nel mettere in luce tutti gli aspetti in cui il repubblicanesimo che nasce da Machiavelli cozza contro la mentalità individualista moderna.
Machiavelli è più vicino a noi rispetto ad Aristotele non solo in senso temporale, pur perseguendo un fine «comunitario» (Machiavelli si considerò sempre un patriota, disse che bisogna amare la propria patria anche quando da questa si un cattivo trattamento4), lo fa tenendo conto della divisione in classi, mentre invece il comunitarismo può significare imporre un «patriottismo», la ricerca di un’unità sociale, che alla fine non può che essere velleitaria oltre che autoritaria, in quanto prescinde dalla mancanza di volontà delle classi superiori di integrare le classi popolari nella società. Mentre si persegue deliberatamente la precarizzazione, demolendo le conquiste del movimento operaio del secolo scorso, al fine di una esclusione delle classi non dominanti, non si può pretendere che si sentano partecipi di una società che le esclude. Machiavelli è più vicino a noi perché prendeva atto del fatto che nella società esistono due «umori diversi», e l’arte della politica consisteva nel far in modo che la conflittualità che ne scaturiva fosse fonte di dinamismo e non di disgregazione. Per quanto riguarda un comunitarismo, anch’esso aristotelico, che tiene conto della divisione in classi, abbiamo un comunitarismo abbastanza unico nel panorama teorico internazionale come quello di Costanzo Preve, per il quale la comunità si può realizzare attraverso il comunismo di Marx, cioè attraverso l’abolizione delle classi, ma tale comunitarismo oggi, dopo la passata esperienza storica, si può conservare solo come utopia, o nei termini dell’ideale regolativo kantiano, come ebbe a riformulare l’ideale comunista Costanzo Preve negli ultimi anni della sua vita.
Per quale motivo il repubblicanesimo è entrato a far parte delle storia delle «correnti sommerse» (Skinner) del pensiero umano? Diamo anche in questo caso la parola a Geuna «Qual è il senso di queste argomentazioni di Skinner? A che cosa mira questo suo lavoro di scavo? Anche in questo caso, si possono individuare due ordini di ragioni: ragioni di tipo storico e ragioni di tipo teorico. Ragioni di tipo storico, innanzitutto. Skinner è alla ricerca di spiegazioni persuasive del tramonto, della decadenza della teoria neo-romana . E effettivamente convinto che le critiche mosse alla teoria neo-romana della libertà, sul lungo periodo, abbiano contato . Menziona, a dire il vero, anche altri motivi, che non attengono al piano delle argomentazioni politiche, motivi di tipo sociale . E cioè il tramonto dell’ideale del gentiluomo indipendente, che tra Sei e Settecento aveva incarnato le aspirazioni di libertà e indipendenza dei teorici neo-romani. Ma le sue ragioni sono, ancora una volta, soprattutto di ordine teorico. Skinner intende difendere la teoria neo-romana da queste critiche. E’ convinto che queste critiche, per quanto importanti ed influenti, non si misurino con il cuore dell’argomentazione dei teorici neo-romani: con il loro modo complesso di pensare la costrizione, che assegna un ruolo di rilievo alla dipendenza. Nell’esporre e discutere le tesi dei pensatori liberali, Skinner ha dunque l’occasione per ribadire la sostanziale fondatezza, coerenza, e persuasività della teoria neo-romana»5.
Ma il repubblicanesimo machiavelliano non venne dimenticato perché soccombette alle critiche degli avversari. Federico Chabod ci fornisce una convincente esposizione dei «limiti» dell’analisi politica di Machiavelli, soprattutto per quanto riguarda la critica del «mercenarismo», cioè al suo «fissarsi» soltanto sulle questione di ordine militare, senza tenere conto delle questioni di ordine «economico». «E non s’avvedeva che proprio in quei tempi il mercenarismo militare diventava una necessità assoluta per i monarchi, volti a creare faticosamente gli Stati nazionali; e non sapeva intendere come, volendo dar loro i mezzi per trionfare delle resistenze feudali, de’ particolarismi di regioni o città, e ad un tempo per consentire l’inizio di una vera, grande politica di espansione europea, fosse necessario porre sotto gli ordini del capo del governo centrale un esercito che soltanto da lui dipendesse, da lui e dal suo tesoro, ed acquistasse, nella lunga consuetudine di una vita guerresca, la disciplina e la tecnica di battaglia necessarie per una vittoria … è superfluo mettere quindi in rilievo quanto sia errata l’affermazione di Machiavelli, che i denari non sono il nerbo della guerra, l’esperienza di quegli anni stava dimostrando proprio il contrario»6. E ciò si aggiunga la diffidenza di Machiavelli per le armi da fuoco che a suo parere non potevano sostituire la virtù.
Dunque Machiavelli non seppe vedere che il futuro apparteneva allo stato nazionale basato sulla concentrazione del potere coercitivo, nella creazione degli eserciti professionali e nello sviluppo della potenza economica atta a sostenerli. Ma Machiavelli aveva in mente uno ordinamento diverso basato sulla virtù del cittadino-soldato. Più adatta fu la teoria hobbesiana quale espressione teorica della concentrazione del potere statuale, presupposto necessario per creare quelle condizioni adatte allo sviluppo del commercio e dell’industria. In verità, Machiavelli pur cogliendo gli inizi un rivolgimento storico epocale, (la civiltà europea moderna nella fase della sua formazione) non credeva molto a ciò che stava nascendo che vedeva segnato fin dalla nascita dalla corruzione7. L’incoraggiamento della ricerca della ricchezza personale (a cui Machiavelli era contrario8 ), l’auri sacra fames, è stato il principale stimolo che ha alimentato una delle rivoluzioni tecnologiche più impressionanti dell’intera storia dell’umanità, a cui la civiltà europea si è trovata alla testa, ma che riesce a realizzare mettendo insieme le scoperte di tutte le altre civiltà (carta, polvere da sparo, sistema numerico decimale, per dirne solo alcune), conferendole un enorme vantaggio sulle altre grandi civiltà. La civiltà europea ha potuto puntare tutto sulla tecnica trascurando la virtù. La superiorità tecnica ha permesso alle società europee di superare le contraddizioni interne attraverso l’espansione coloniale e imperialistica, ed è esattamente l’opposto di quello sviluppo basato sul territorialismo a cui pensava Machiavelli rifacendosi all’esperienza di Roma.
Non è affatto «apparente»9 l’anti-imperialismo di Machiavelli, a meno di non trasformare l’anti-imperialismo in uno strumento del «politicamente corretto» con cui si condanna l’imperialismo altrui, mentre si persegue il proprio sventolando la bandiera dei diritti umani e della democrazia. Non è l’espansionismo in quanto tale ad essere imperialistico, ma un determinato tipo di espansionismo. Tutti gli stati moderni sono stati creati dall’espansionismo di una parte sull’altra che acquisisce la funzione di gruppo dominante. Il risultato finale di un anti-imperialismo basato sul concetto morale di autonomia sarebbe che ognuno dovrebbe starsene per sé. Tuttavia ci sono aggregazioni umane che lasciano uno spazio per vivere secondo i propri intendimenti e svilupparsi anche a chi è subordinato e aggregazioni basate su un dominio che tende al completo assoggettamento e controllo. Roma seguì il primo modello di dominio10 Il fascismo e il nazismo che si richiamavano per motivi propagandistici all’Impero romano seguirono il secondo. Lo sciovinismo razziale è l’antitesi della concezione imperiale romana, esso è piuttosto un prodotto dell’imperialismo europeo. Il razzialismo, poi elevato a ideologia ufficiale dal nazismo, non a caso è nato in Inghilterra. L’imperialismo vero e proprio è l’espansionismo senza limiti e senza confini che non crea un ordine, basato sulla ricerca dell’accumulazione potenzialmente illimitata di ricchezza. L’imperialismo europeo ha assoggettato e stravolto l’intero globo, ha costretto a cambiamenti radicali le altre civiltà, imponendo dappertutto il suo modello. L’imperialismo statunitense attualmente, dopo il «crollo del muro», mira alla distruzione di qualsiasi forma statuale al fine di stabilire il suo dominio mondiale. L’imperialismo europeo non ha mai creato un sistema stabile, ma ha prodotto delle «egemonie» che sono durate l’espace d’un matin rispetto all’Impero romano. Il regime finora più lungo, quello dell’egemonia britannica non è durato neanche un secolo (dalla sconfitta di Napoleone alla I guerra mondiale quando essa è già seriamente minata). Il regime statunitense sembra sulla strada di battere ogni altro «impero» (le virgolette sono d’obbligo) della storia per brevità di durata.
Per quale motivo gli stati europei non sono riusciti a costituire un sistema unitario, cioè un «impero» (tra virgolette perché a mio parere sarebbe possibile un sistema unitario di stati senza un imperatore) non può essere discusso adeguatamente in questo saggio. Dobbiamo accontentarci di riprendere alcune valutazioni di Victoria Tin-Bor Hui11: «Gli stati europei non impiegarono gli stratagemmi machiavelliani o stile-Qin l’uno contro l’altro, neanche Napoleone che “lesse avidamente e ammirò grandemente” Il Principe». Le valutazioni sul mancato impero europeo si basano su di un principio comparativo con lo sviluppo della Cina imperiale che meriterebbe di essere approfondito: «Gli europeisti credono che tale processo di formazione degli stati sia unicamente europeo e moderno. Ma le stesse dinamiche sono nel sistema dello zhongguo o stati centrali nella Cina antica»12. Possiamo dire che la politica di Napoleone fu più militaristica che strategica, motivo per cui non seppe creare un sistema di alleanze europee, come fece Roma. Non fu soltanto la mancanza dell’impiego della forza o dell’inganno, ma la mancanza soprattutto della capacità strategica che mostrarono i romani. Questo parallelo tra l’Europa moderna e la Cina antica è molto suggestivo ma data la mia scarsa conoscenza della storia cinese altro non saprei dire, mi limito a riportare un’osservazione di una certa importanza «Sun Tzu and e Fei sono talvolta chiamati i Machiavelli cinesi. Ma si potrebbe anche chiamare Machiavelli il Sun Tzu europeo»13. Rilievo ineccepibile in quanto Sun Tsu visse un millennio prima di Machiavelli. Vediamo come Machiavelli sintetizza la condotta strategica dei Romani: «Perché come ei cominciorono a uscire con gli eserciti di Italia, e ridurre i regni in provincie, e farsi suggetti color o che per essere consueti a vivere sotto i re non si curavano di esser e suggetti, ed avendo governatori romani ed essendo stati vinti da eserciti con il titolo romano, non riconoscevano per superiore altro che Roma . Di modo che quegli compagni di Roma che erano in Italia, si trovarono in un tratto cinti da’ sudditi romani ed oppressi da una grossissima città come era Roma; e quando ei s’avviddono dello inganno sotto il quale erano vissuti, non furono a tempo a rimediarvi».
Fu questo il principale stratagemma con cui Roma costituì il suo impero. Il fatto che Roma lasciò una relativa autonomia ai popoli conquistati, anche dopo che fu compiuta la sua egemonia sul Mediterraneo, dimostra che non si trattò di un puro e semplice stratagemma, ma di un carattere costitutivo della politica dei romani.
Machiavelli è il pensatore dell’Europa intesa come sistema di stati, questo è il senso principale dell’avere come modello Roma. Se è vero che un sistema di stati si è sviluppato solo in Cina e in Europa, ha molto più senso paragonare l’Europa moderna alla Cina imperiale piuttosto che all’Impero romano che si sviluppò in modo simile a quell degli altri imperi da una città-stato. Machiavelli conosceva però solo lo sviluppo dell’Impero romano e attraverso questo termine di riferimento cerca di capire la dinamica del sistema di stati europeo agli albori sotto i suoi occhi. Questo sistema implica la presenza di più stati, il che può avere sviluppi positivi in quanto «il mondo è stato più virtuoso dove sono stati più Stati che abbiano favorita la virtù o per necessità o per altra umana passione»14. Tuttavia c’è qualcosa di diverso nello sviluppo di Roma, che determina qualcosa di irrisolto nel pensiero di Machiavelli: sa che per Roma la fine del suo doppio, Cartagine (una città che aveva un sistema sociale molto simile a quello di Roma), la fine della sua sorella antagonista fu la fine della virtù di Roma. Meglio sarebbe dire che Machiavelli è fautore di quel processo che poi portò alla costituzione dell’impero. Vorrebbe che gli stati europei si indirizzassero su un percorso simile a quello di Roma e se questo sfociò nell’Impero fu negativo, ma tutte le cose di questo mondo sono finite, nondimeno Roma visse libera per 500 anni.
Se è vero che «tutto torna ma diverso», e quindi l’Europa non avrebbe seguito di pari passo l’evoluzione della Repubblica Romana#, è pur vero che qualcosa è andato storto nella storia dell’Europa moderna. Con Napoleone l’Europa si avvicinava ad un’evoluzione paragonabile a quella di Roma, ma com’è noto fu sconfitto. Noi che siamo vissuti dopo possiamo vedere come la rovina degli stati europei consista nel fatto di non esser riusciti a costruire un’aggregazione «imperiale» (secondo i termini suoi propri che non potevano essere quelli dell’antica Roma) che trascendesse e risolvesse i conflitti interni. Dalla sconfitta di Napoleone inizia una fase di decadenza dell’Europa da cui nascono le contrapposizioni ideologiche nazionalistiche o di classe. Secondo Toynbee, la nascita di un «proletariato interno» è l’indice di una frattura interna nella società che segna la sua fase di decadenza. Le contrapposizioni ideologiche non sono dovute a motivi meramente spirituali ma sono la manifestazione superficiale di fratture profonde della società.
Che Machiavelli non sia solo un patriota che auspica la nascita dello stato nazionale italiano (cosa che certamente fu, basti pensare alla parte finale de Il principe), ma che la sua ottica sia europea, lo si evince dall’analisi delle vicende dello stato francese. «Per combattere l’Inghilterra, Carlo VII costituì il primo esercito permanente in Europa, le Compagnie d’Ordinanza. Egli impose anche un drastico incremento delle tasse dirette e indirette. Sebbene rudimentali, queste furono misure auto-rafforzanti perché richiedevano alla Corte francese il miglioramento della propria capacità estrattiva [in senso finanziario]. Se la Francia avesse sviluppato queste pratiche, la storia europea sarebbe stata più simile a quella cinese … è degno di nota che Machiavelli avesse identificato il problema fin dall’inizio del sedicesimo secolo. Machiavelli elogiava la comprensione di Carlo VII della “necessità di armarsi di arme proprie”. Egli credeva che se il Regno di Francia sarebbe stato “insuperabile, se l’ordine di Carlo era accresciuto o preservato”. Sfortunatamente “re Luigi suo figliuolo spense quella de’ fanti, e cominciò a soldare Svizzeri: il quale errore, seguitato dalli altri, è, come si vede ora in fatto, cagione de’ pericoli di quello regno. Perché, avendo dato reputazione a’ Svizzeri, ha invilito tutte l’arme sua; perché le fanterie ha spento e le sua gente d’arme ha obligato alle arme d’altri; perché, sendo assuefatte a militare con Svizzeri, non par loro di potere vincere sanza essi”»15 .
Machiavelli non condivide la concezione imperiale di Dante ancora legata al medioevo e al compromesso tra i «due soli», intuendo che quanto stava venendo formandosi era qualcosa di nuovo che per affermarsi dovette lottare sia contro il Papato che il Sacro Romano Impero. La continuità tra la Roma repubblicana e quella imperiale è un elemento irrisolto del pensiero di Machiavelli, tuttavia se è vero che la fine della Roma repubblicana è la fine della virtù romana, e che fu proprio essa a dar vita all’impero si tratta di un processo inevitabile in un mondo in cui tutto è destinato a nascere, crescere e perire. Machiavelli era un patriota, ma non in senso angustamente nazionalistico. La patria di Machiavelli è laddove si sviluppa la virtù. Se la virtù muore a Roma, rinasce da qualche altra parte16.
Tuttavia vi sono delle affinità con la visione dantesca. L’Ulisse di Dante è una figura della hybris greca, la cui incarnazione con un po’ di immaginazione individuo in Alessandro Magno che dalla Persia volle raggiungere l’India in direzione di un confine ignoto, un assalto all’infinito, un voler andare oltre i limiti (come Ulisse) che poteva terminare solo con la sua sconfitta e la fine della civiltà greca.
Non a caso il Canto inizia con l’invettiva contro Firenze che stabilisce una precisa relazione con la hybris greca:
«Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande,
che per mare e per terra batti l’ali,
e per lo ‘nferno tuo nome si spande!»
(Inferno, Canto XXVI)
Lo spirito capitalistico di espansione infinita, illimitata, senza confini agli albori in Firenze per Dante è erede della hybris greca. Egualmente Machiavelli condanna Atene, Sparta e Firenze da parte di Machiavelli per aver assoggettato i territori circostanti, e la condanna è sincera perché il puro e semplice desiderio di conquista è diverso dalla capacità strategica dei Romani.
Diversamente procedette Roma. Roma nei suoi mille anni di storia arrivò ad un confronto diretto con l’impero persiano solo verso la fine dell’Impero romano (e persiano). Roma operò nell’ambito suo proprio costituito dal bacino del Mediterraneo.
L’Europa moderna invece ha varcato stabilmente le colonne d’Ercole conducendo il mondo di fronte ad un pericolo mortale.
L’imperialismo europeo trasfiguratosi nel non-luogo denominato Occidente è arrivato alla conclusione del suo percorso ora che le altre grandi civiltà, ad eccezione della civiltà islamica, sono riuscite a far fronte alla minaccia distruttiva della «civiltà occidentale». L’aver fondato tutto sulla superiorità tecnica ed economica ci rivela che la civiltà occidentale si è fondata sul nulla. Forse è questo uno dei motivi, più o meno consapevoli, per cui vari studiosi hanno ripreso a leggere Machiavelli. Ad es. Skinner dichiara che il suo interesse per Machiavelli sta proprio nella sua alterità rispetto al pensiero moderno.
In realtà il repubblicanesimo non è stato sommerso del tutto, c’è un motivo per cui continua a persistere pur all’interno di una teoria dello stato dominata dal paradigma hobbesiano. Nel conflitto tra gli stati che ha portato alla piena formazione dello stato europeo (secondo la «sociologia storica» di Charles Tilly ed altri) si è avuto ancora bisogno della virtù, in particolare durante le due più importanti rivoluzioni nell’organizzazione dello stato, la guerra civile inglese seguita dalla Glorious revolution e la rivoluzione francese, che sono due rivoluzioni principalmente statuali dettate dal conflitto tra le nazioni europee che è stato il principale motore di questo sviluppo (in tal senso vedi Tilly che ne è stato il principale teorico). «L’esercito cromwelliano fu una forza rivoluzionaria perché fu meno un’armata mantenuta dallo stato che un esercito in cerca di uno stato che potesse mantenerlo»17 Harrington non può ancora concepire l’esercito professionale, poiché era ancora in formazione, ma da ciò deriva il suo interesse per la critica machiavelliana delle milizie mercenarie.
E’ nella new model army di Cromwell che si diffondono le tendenze radicali, repubblicane, rivoluzionarie fino al radicalismo dei livellatori. Il tentativo teorico di Harrington è quello di fare una sintesi tra il repubblicanesimo e l’assolutismo. Un’eguale tendenza a conciliare il repubblicanesimo con l’assolutismo si riscontra in Rousseau «un pensatore che ha inserito sul patrimonio di concettualizzazioni del diritto naturale categorie tipiche della tradizione repubblicana moderna, pur a costo di rilevanti tensioni teoriche»18.
Se è vero che l’esercito professionale da cui poi si è sviluppato l’esercito di leva è diverso («Non è stata la coscrizione militare di per sé ma l’esercito cittadino auto-equipaggiato che storicamente ha servito come baluardo contro la dominazione»19) dall’esercito di popolo sul modello romano a cui pensava Machiavelli è pur vero che è diverso dall’esercito mercenario e dall’esercito medievale. Come scrive Max Weber:
«Il motivo della democratizzazione è sempre di natura militare; sta nella comparsa della fanteria disciplinata, dell’esercito di corporazione nel Medioevo, dove l’elemento decisivo era che la disciplina militare prevaleva sulla lotta tra eroi. La disciplina militare significò la vittoria della democrazia poiché si dovevano e volevano arruolare le masse di non cavalieri, si mettevano loro in mano le armi, e quindi il potere politico»20.
Da questa necessità di coinvolgere le popolazioni nella lotte reciproche dei principali stati europei, sorgono delle contro-tendenze democratiche nella costituzione sostanzialmente oligarchica degli stati moderni fino ai nostri giorni. Riconoscere il potere «assoluto» dello stato vuol dire riconoscere il potere assoluto di chi controlla il potere coercitivo dello stato, cioè un’oligarchia. Siccome però queste oligarchie hanno avuto bisogno del popolo si è creato quello «ossimoro» vivente che sono state le «democrazie» moderne: la democrazia oligarchica come l’ha definita il direttore di un quotidiano italiano che di repubblicano ha solo il nome, senza però tematizzare la contraddizione per cui il suo «ossimoro» è semplicemente un’assurdità, tipo il secco dell’acqua, o l’umidità della fiamma.
Il repubblicanesimo liberale di Harrington e di Locke è un sistema basato su di una contraddizione di fondo: voler conciliare il repubblicanesimo con l’assolutismo. «Né Harrington né Locke si opponevano a un potere sovrano: ritenevano entrambi che in qualunque società civile si rendesse necessaria da qualche parte la presenza di un potere politico, a cui, come si doveva sottintendere, ogni individuo avesse rimesso tutti i propri diritti e poteri, e che non fosse sottoposto a limiti da parte di qualsiasi potere umano superiore o associato. Harrington fu del tutto esplicito: “Là dove il potere sovrano non è intero e assoluto proprio come nella monarchia, non ci può assolutamente essere alcun governo” . Locke pose il potere sovrano nella società civile, cioè nella maggioranza: ammetteva che la maggioranza non volesse nient’altro che il bene pubblico, e che perciò potesse detenere senza pericolo il potere sovrano da conferire a qualcuno. Ovviamente, l’uomo o l’assemblea a cui la società civile affidava allora il potere legislativo e l’esecutivo non erano sovrani; ma in questi casi, in cui il potere veniva affidato a un’assemblea elettiva piuttosto che a un’assemblea o a un monarca auto-perpetuantesi, Locke riconosceva un esercizio virtuale del potere sovrano. Sia Harrington che Locke non videro la necessità di porre irrevocabilmente il potere sovrano nelle mani di una persona o di un’assemblea di persone con l’autorità di designare il proprio successore o i propri successori; anzi, giudicarono ciò incompatibile con gli unici scopi plausibili per cui degli individui potrebbero autorizzare un potere sovrano. In effetti, si opponevano non a un potere sovrano perpetuo, ma a una persona o a un’assemblea sovrana auto-perpentuantisi»21.
Lo stesso Hobbes aveva chiarito il potere assoluto poteva essere incarnato anche da una assemblea, tuttavia poiché riteneva necessaria l’auto-perpetuazione del potere assoluto è stato visto erroneamente come un teorico della monarchia assoluta. Poiché il suo modello, prevedeva un’inevitabile frammentazione sociale dovuta alla conflittualità generalizzata, come sostiene Macpherson, non potè considerare il dominio della borghesia in modo maggiormente flessibile ammettendo la possibilità di un assetto costituzionale che consentisse importanti cambiamenti al suo interno, pur perpetuandosi come sistema di dominio. A ciò va aggiunto il fatto che il nuovo tipo di stato è ancora un modello rigido privo di quelle articolazioni che svilupperà in seguito per restando il modello di base lo stesso.
L’equivoco riguardo al rapporto tra la teoria di Hobbes e al liberalismo è dovuto al fatto che il «collettivismo», cioè il potere assoluto dello stato, sembra escludere l’individualismo, ma si tratta di una coppia polare, l’individualismo è inseparabile dal potere assoluto dello stato, come ha brillantemente messo in luce Macpherson:. «La concezione per cui individualismo e “collettivismo” sono le estremità opposte di una scala lungo la quale si possono disporre stati e teorie dello stato, senza tener conto dello stadio di sviluppo sociale in cui si formano, appare superficiale e induce in errore. L’individualismo di Locke, cioè di una società capitalistica emergente, non esclude, ma, al contrario, richiede la supremazia dello stato sull’individuo. Non si tratta di più individualismo o di meno collettivismo. Piuttosto, quanto più compiuto è l’individualismo, tanto più totale è il collettivismo. Esempio estremamente significativo ne è la teoria di Hobbes, ma il fatto di aver negato la legge naturale della tradizione e di non aver garantito la proprietà nei confronti di un sovrano che si perpetuava, non raccomandava le sue concezioni a quelli che vedevano la proprietà al centro dei fatti sociali. Locke era più accettabile, sia per la posizione ambigua sulla legge naturale, sia per un certo tipo di garanzia che forniva ai diritti di proprietà. Se si interpreta in questo modo il carattere specifico dell’individualismo borghese del diciassettesimo secolo, non è più necessario cercare un compromesso tra le affermazioni lockiane individualiste e quelle collettiviste: nel contesto infatti si implicano a vicenda»22.
Cosa vuol dire potere assoluto dello stato? Lo stato non è e non potrà mai essere il popolo. Nietzsche la denuncia come la più «fredda menzogna del mostro», ovvero il Leviatano hobbesiano. La democrazia pura cioè basata sul governo del popolo è stata costitutivamente instabile. Machiavelli rifiuta il modello ateniese, modello di ogni forma ideale di democrazia, per la sua instabilità, dissolvendosi nella lotta tra fazioni a causa della mancanza di un governo centrale, che determina il passaggio alla monarchia (governo di uno solo), che degenera in dittatura per cui si passa all’aristocrazia che degenera a sua volta in oligarchia, da cui si passa alla democrazia determinando quel ciclo in cui si erano avvitate le città greche (ad esclusione di Sparta) che secondo Polibio il sistema misto della Roma repubblicana aveva interrotto. Il sistema non instabile più vicino alla democrazia è il sistema misto, a cui al potere dello stato si affiancano dei contro-poteri esterni allo stato. Bodin lo identifica con la democrazia tout court. Assolutismo e democrazia sono termini antitetici se stiamo al significato etimologico dei due termini. Incidentalmente Kant mise in luce il carattere non democratico del sistema parlamentare proprio perché fondato sull’assolutismo.
Che cos’è un monarca assoluto? È quello che, se dice: «Guerra sia», è subito guerra. – Che cos’è viceversa un monarca limitato? Colui che prima deve chiedere al popolo se ci debba esserci o no la guerra; e se il popolo dice «Non ci dev’essere guerra», allora non viene fatta. – La guerra, infatti, è una condizione in cui tutte le forze dello stato devono stare agli ordini del suo capo supremo. Ora, le guerre che ha condotto il monarca britannico senza chiedere alcun consenso su ciò sono davvero molte. Perciò tale re è un monarca assoluto, cosa che in base alla costituzione egli non dovrebbe essere; la quale, invece, si può sempre aggirare, proprio perché attraverso quei poteri dello stato può assicurarsi il consenso dei rappresentanti del popolo, dato cioè che egli ha il potere di affidare tutti gli uffici e gli onori. Per avere successo, un tale meccanismo di corruzione non ha certo bisogno della pubblicità. Perciò rimane sotto il velo, molto evidente, del segreto»23.
Ecco perché il potere effettivo diventa qualcosa di nascosto. Il sistema parlamentare si basa fin da Hobbes su di un patto: la sovranità, cioè il potere, la gerarchia sociale non sono legittimi in sé stessi ma derivano da un accordo collettivo che conferisce il potere a qualcuno al fine di evitare la guerra di tutti contro tutti, cioè la disgregazione sociale. In realtà il potere che non deriva da nessuna legittimazione esterna esiste eccome, come tutti sanno. Tuttavia questa finzione funzionale è essenziale al sistema, per cui la gerarchia sociale diventa qualcosa di nascosto. Per questo Marx ad es. va a ricercare dove si «nasconde» la struttura del potere effettivo, individuandola nei «rapporti di proprietà», in particolare in chi controlla i mezzi di produzione, ma è una visione parziale ed erronea, chi controlla gli strumenti coercitivi dello stato ha avuto un ruolo preponderante.
Finora nessuna società è riuscita a funzionare senza una gerarchia. Motivo per cui la gerarchia sociale non avrebbe bisogno di nessuna giustificazione. Nella Roma antica i Consoli e il Senato non avevano bisogno della legittimazione popolare (giustamente per questo Polibio dice che i Consoli erano dei re), ma oltre ai Consoli e al Senato c’era un’articolazione di varie assemblee popolari che costituivano l’aspetto democratico della Roma repubblicana.
Il potere delle classi dominanti può affermare apertamente la sua legittimità quando riconosce l’esistenza di contro-poteri nelle classi popolari. Il potere assoluto adotta invece una maschera, cioè la personae fittizia dello stato.
Oggi a noi sembra addirittura inconcepibile che il popolo possa decidere della guerra, al massimo possiamo pensare che la decisione possa essere nelle mani del parlamento, quale «rappresentante della volontà popolare», ma sappiamo che il parlamento è piuttosto uno strumento dello stato, come efficacemente mette in luce Kant. Inoltre, negli ultimi tempi si è imposta la tendenza a bypassare anche il parlamento. In Italia ad es. molte missioni all’estero sono state decise dal governo con lo strumento del decreto-legge. Nella Roma repubblicana la decisione ultima sulla guerra spettava ai comitia centuriata che erano delle assemblee popolari.
Questo patto hobbesiano fonda il sistema su basi individualistiche. L’individualismo è la radice del totalitarismo, come ha ben messo in evidenza Louis Dumont nei sui Saggi sull’individualismo: il razzialismo hitleriano era un modo meccanico per ristabilire l’unità in una società individualistica. Ma come abbiamo visto l’individualismo è inseparabile dal «collettivismo» cioè dalla concentrazione del potere statuale che crea le condizioni per cui possa esistere una «sfera privata» in cui l’individuo è «libero» di perseguire il suo «interesse privato». Tuttavia perché potesse configurarsi ciò che noi definiamo totalitarismo era necessaria un’ulteriore evoluzione dello stato, la concentrazione del potere ideologico che è stata la trasformazione precipua dello stato nel XX secolo, ragione per cui molti studiosi si sono concentrati sulla funzione svolta dai media. Con la concentrazione del potere ideologico il sistema di dominio diventa più articolato e capillare, lo stato si evolve come Apparato di dominio.
I totalitarismi sovietico e tedesco furono tentativi imperfetti, rudimentali di far fronte ai mezzi, alla capacità di mobilitazione che aveva lo stato totalitario pienamente sviluppato, cioè gli Usa, il quale proprio perché funziona bene può instaurare un controllo capillare senza abbandonare la facciata democratica. Lasciamo da parte l’Unione Sovietica che aveva la concentrazione di potere statuale necessaria per questo scopo, ma non aveva lo sviluppo economico necessario per la creazione di un’ampia classe media, per cui sviluppò un totalitarismo molto rudimentale. La Germania invece già dal finire del XIX secolo era lo stato europeo più avanzato, quello che mostrava maggiori somiglianza con gli Usa, ed è stato quello che maggiormente ha sviluppato questi nuovi aspetti dello stato (lo stesso Hitler paragonava la propaganda politica alla propaganda americana delle saponette).
Questa dinamica la si può cogliere sulla base della teoria di Charles Tilly secondo cui le strutture statuali e non solo, ma l’organizzazione complessiva della società, si sviluppano attraverso il conflitto, in pratica, ogni qualvolta uno stato introduce un cambiamento che aumenta la propria potenza costringe gli altri stati ad introdurlo anch’essi, pena la sconfitta. La stessa rivoluzione francese ha le sue radici in questa dinamica (vedi il mio Ripensare la rivoluzione francese). Gli Stati Uniti, oltre alla concentrazione del capitale e alla concentrazione del potere coercitivo (che per Tilly sono i tratti costitutivi dello stato moderno), introducono la concentrazione del potere ideologico con lo sviluppo del sistema mediatico.
Questo nuovo regime ha la sua base nella classe media, che è essa stessa prodotto di un’ulteriore concentrazione del capitale e lo sviluppo dell’economia di scala: Charles Wright Mills nel suo classico studio sui «colletti bianchi» sottolineava la somiglianza di questa classe media con gli «impiegati» tedeschi descritti da Kracauer. Una classe media semi-parassitaria, privilegiata e allo stesso tempo priva di potere, che guarda con orrore alla classe lavoratrice. Da questa condizione sociale derivano tutte le storture della sua psicologia (in merito esiste un’ampia letteratura). E’ la progenitrice del ceto medio semi-colto, che è la principale base di propagazione del diritto-umanesimo e del politicamente corretto costitutivi dell’ideologia dominante (vedi in merito il mio Tendenze totalitarie odierne: la gender theory).
Machiavelli è il pensatore anti-totalitario per eccellenza proprio perché il totalitarismo è un’evoluzione dello stato moderno rispetto alla quale Machiavelli indica un’altra direzione.
Skinner si è occupato in vari scritti della nascita del concetto di stato, lavori sicuramente interessanti, frutto di un impressionante scavo storico, tuttavia individua una inesistente continuità24, al di là delle normali interazioni tra i principali pensatori della politica. Machiavelli è l’anti-Hobbes, il suo concetto dello stato è l’opposto dell’assolutismo hobbesiano. Il sistema misto come descritto da Polibio di cui Machiavelli era fautore è ciò che principalmente rifiutano i teorici dell’assolutismo.
Skinner e Pettit hanno concorso a darne una migliore definizione, ma ritengo che l’effettiva enucleazione del paradigma repubblicano machiavelliano la si debba allo studioso italiano Marco Geuna (e sulla sua scorta Baccelli), nonostante la minore notorietà internazionale (in ambito accademico), soprattutto perché riesce a mettere in evidenza la radicale alterità di Machiavelli rispetto a Hobbes, il principale teorico dello stato moderno. Credo non vi sia campanilismo quando Baccelli sottolinea l’italianità di Machiavelli, egli è pur sempre un prodotto della cultura italiana, chi ha studiato nella scuola italiana meglio può capirne le sfumature del linguaggio. Riporto qui un’estratto che contiene in sintesi una definizione del «paradigma machiavelliano» ripresa, approfondita e differenziata in vari articoli25.
È forse utile ricordare la pluralità di termini utilizzati da Machiavelli, sia nei Discorsi sia nelle Istorie, per sviluppare le sue riflessioni. Egli si serve, per lo più, dei termini ʻdisunioniʼ e ʻtumultiʼ per riferirsi a quei conflitti fra le parti costitutive della città che trovano una sorta di composizione istituzionale e arricchiscono di leggi e ordini la vita politica della res publica, mantenendo viva la sua libertà; altre volte, per riferirsi a questo primo tipo di conflitti, usa le espressioni ʻcontroversieʼ, ʻdissensioniʼ, ʻdifferenzieʼ, ʻromoriʼ.
Ricorre, invece, alle espressioni ʻcivili discordieʼ, ʻintrinseche inimicizieʼ, per designare un altro tipo di conflitti, per riferirsi a quegli antagonismi che degenerano in scontro di ʻfazioniʼ e di ʻsetteʼ, e mettono a repentaglio la libertà stessa della res publica. Con questi termini, Machiavelli riesce a veicolare una riflessione sui conflitti assolutamente nuova e peculiare che lo colloca in posizione di marcata discontinuità rispetto alla tradizione antica e medioevale del pensiero politico occidentale; ma che lo situa anche ai margini, in una prospettiva altra, rispetto al cosiddetto progetto politico moderno, incentrato, da Bodin e Hobbes in poi, sul ruolo del potere sovrano e sulla neutralizzazione del conflitto da esso attuata.
Questo è in sintesi il paradigma machiavelliano, il suo principale apporto allo storia del pensiero politico, il nucleo concettuale attorno al quale Machiavelli articola la sua teoria politica, una nuova concezione del conflitto che in determinate condizioni, quando non si trasforma nella creazione di «sette» è fonte di dinamismo sociale, di difesa della libertà, e delle leggi che creano l’ordine sociale.
Per chi volesse farsene un’idea con le parole di Machiavelli stesso consiglio di primo acchitto la lettura del cap. IV dei Discorsi dal titolo Che la disunione della Plebe e del Senato romano fece libera e potente quella republica.
Proviamo ad applicare il paradigma alle principali ideologie moderne: tutte sono segnate dal paradigma hobbesiano, a dispetto delle loro differenze sono accomunate dalla volontà di eliminare i conflitti sociali.
Il liberalismo neutralizza il conflitto sociale attraverso una pseudo-democrazia, basata sul gioco di specchi fra destra e sinistra, che ha inondato di menzogna e corruzione il mondo.
Il socialismo/comunismo intendeva eliminare i conflitti eliminandone le cause economiche (addirittura eliminando la divisione del lavoro secondo l’estremismo individualistico del giovane Marx), ma tale intento si rovescia necessariamente una volta al potere nella soppressione autoritaria dei conflitti.
Il fascismo intendeva sopprimere i conflitti sociali attraverso il corporativismo. Il nazismo invece li soppresse nella creazione della comunità razziale saldata dal Führerprinzip.
Tutte e tre le principali ideologie moderne e loro derivati sono segnate da un totalitarismo di fondo perché tutte nascono dal paradigma individualista hobbesiano.
Voler eliminare la conflittualità dalle relazioni umane è un’aspirazione di per sé totalitaria. Polemos è il padre di tutte le cose, scriveva Eraclito 2500 anni fa. È il conflitto per l’esistenza tra le creature viventi, e tra queste e le condizioni ambientali (caldo, freddo, acqua, mancanza di acqua, vento), che ha fatto sorgere occhi per cogliere il più piccolo movimento, arti per correre velocemente, artigli, udito, olfatto ecc. Gli esseri umani lottano per l’esistenza tanto in cooperazione quanto in lotta con i propri simili. Il conflitto scaturisce dalla necessità di cooperazione stessa, in quanto necessita di stabilire dei singoli che abbiano un ruolo di comando (finora nessuno è riuscito a creare delle società senza gerarchie, le società primitive sono soltanto più semplici ma non ne sono prive). Soltanto attraverso il conflitto si può stabilire chi comanda, ed è con il conflitto che vengono spodestate le classi dominanti incapaci di svolgere il loro principale compito, quale assicurare un’adeguata riproduzione sociale. E’ attraverso il conflitto tra i vari insiemi sociali (stati-nazione) che si evolvono i vari sistemi sociali. Negare il conflitto attraverso il pacifismo finora è servito soltanto a screditare il nemico in modo totale, in quanto nemico della «pace», criminale da spazzare dalla faccia della terra (su tale questione è imprescindibile Carl Schmitt, e più recentemente Danilo Zolo), cioè per portare al nemico una guerra più totale rispetto a chi riconosce lo justus hostis (nemico legittimo: un concetto quasi inconcepibile per la mentalità moderna egemonizzata dall’ipocrita pacifismo). Voler eliminare il conflitto è un’aspirazione propriamente totalitaria, piuttosto bisognerebbe indirizzarlo verso forme non distruttive che favoriscano lo sviluppo sociale.
Acquisito il paradigma machiavelliano proveremo ad applicarlo per definire una nuova teoria politica, ma prima volevo riprendere un interessante contributo di Massimo Morigi che ci consente di articolare ulteriormente la definizione del repubblicanesimo. Libertà come non interferenza del potere o libertà come non dominio? Morigi ha effettuato un ribaltamento dei termini della questione, potenzialmente in grado di mettere fine alla diatriba, se non fosse che «il dibattito (accademico) deve continuare», ponendo la libertà come estensione e diffusione nella società del potere. In una serie di interventi, che mi auguro possano trasformarsi in un contributo più sistematico, egli ha delineato un «repubblicanesimo geopolitico», nel quale «l’accento è messo sul potere come energia generatrice di libertà mentre il marxismo classico vuole una società dove i rapporti di forza siano estinti (fine della storia, estinzione dello stato). Secondo perché se per il marxismo l’agente generatore di una società più libera è il proletariato, per il Repubblicanesimo Geopolitico l’agente per una maggiore libertà sono proprio quelle forze ed energie (quindi anche il proletariato ma pure le forze che vi si contrappongono) che scontrandosi originano una dialettica del potere che è alla base per un concreto e non astratto ampliamento della sfera della libertà (sottolineo che questa della conflittualità come origine della libertà e/o della forza di una comunità politica non è certo molto originale discendendo direttamente da Machiavelli e dalla sua spiegazione della forza militare degli antichi romani, la quale, secondo il Segretario fiorentino, discendeva direttamente dalla lotta fra patrizi e plebei che trovava una sua valvola di sfogo nella espansione territoriale di Roma). E queste forze ed energie per il Repubblicanesimo Geopolitico possono trovare la loro piena espressione solo a condizione che il quadro geopolitico in cui questa comunità vive la sua esperienza storica sia favorevole a che questa comunità possa irrobustire la sua identità e, di conseguenza, progettare e lottare per sempre maggiori spazi di libertà»26.
Inoltre, Morigi in un’intervista video27 sottolineava che che la divisione fra dominanti e dominati non deve condurre alla conclusione apparentemente logica che i dominati non decidono. I dominati decidono a loro modo, possono decidere di seguire o non seguire i dominanti, oppure se costretti possono decidere di seguire i dominanti in modo passivo, oppure facendo resistenza fino al sabotaggio. I romani lo sapevano benissimo ed è per questo che erano consci della necessità di coinvolgere il popolo, che costituiva la base dell’esercito, nelle decisioni. Gianfranco Campa, un «repubblicano» di origine italiana trasferitosi negli Usa, «appartenente prima al mondo militare e poi a quello delle forze dell’ordine», ha scritto un articolo28 in cui descrive a tinte fosche lo stato mentale dell’esercito statunitense dove imperversano malattie mentali, uso e abuso di droghe, alcol e psicofarmaci. Non è difficile capire perché i soldati rifiutano intimamente il loro ruolo pur essendo costretti ad esercitarlo per avere un salario. È evidente che l’essere pagati non è un motivo sufficiente per uccidere o essere uccisi, quando si è consapevoli che la propria famiglia non ha nessuna garanzia di appartenenza ad un sistema sociale che la protegga dal finire in mezzo alla strada (e negli Usa è molto facile che ciò accada). E quando non si capiscono i motivi per cui si combatte una determinata guerra, se non che questa guerra non migliorerà le condizioni della propria classe sociale. Le classi dominanti statunitensi non possono contare pienamente sul proprio esercito, ma proprio questo le rende molto pericolose, perché le può spingere ad una soluzione «tecnica» (cioè facendo affidamento su armi micidiali) della propria crisi di egemonia.
Geuna ha fornito un fondamentale contributo nella definizione del paradigma machiavelliano, tuttavia la radicalità del pensiero machiavelliano non può emergere se non osiamo andare oltre il recinto accademico, sfidando ciò che i colleghi accademici occidentali ritengono sia concepibile. Geuna alla fine ci propone una realizzazione pratica del conflitto tutta interna ad un pensiero dominante. La «contestazione» (nata in ambito studentesco) che ritiene una espressione del conflitto, sulla scorta di Pettit, è in realtà una sua parodia, ricorda piuttosto le recriminazioni adolescenziali relative alla paghetta. Se davvero vogliamo parlare di conflitto dobbiamo intendere il conflitto che avviene tra adulti. Le tesi di Pettit sono poco realistiche (come lamenta Baccelli) perché ricadono nel formalismo democratico, discostandosi alquanto da ogni realismo machiavelliano. Soltanto la teoria di Machiavelli può eguagliare in realismo quella di Hobbes. La legge senza la spada è nulla, e chi impugna la spada non è sottoposto alla legge, quindi la sovranità è per forza di cose assoluta, se è l’unico ad impugnare la spada. Il motivo per cui bisogna concedere la spada al popolo costituisce uno dei passi salienti dell’intera riflessione machiavelliana:
Per tanto, se tu vuoi fare uno popolo numeroso ed armato per poter fare un grande imperio, lo fai di qualità che tu non lo puoi poi maneggiare a tuo modo: se tu lo mantieni o piccolo o disarmato per poter maneggiarlo, se tu acquisti dominio, non lo puoi tenere, o ei diventa sì vile che tu sei preda di qualunque ti assalta.
Si doveva concedere la spada al popolo, anzi era necessario se si intendeva costruire quel tipo di repubblica espansiva sul modello romano. Questo fondamentale principio machiavelliano è simile un’arma che può essere utilizzata tanto in senso offensivo che difensivo, anche intende difendersi dall’espansionismo altrui deve poter contare su un popolo forte: altrimenti sei preda di chiunque ti assalta.
Il paradigma machiavelliano va inquadrato nel concetto di sistema misto di cui Machiavelli era fautore, soltanto in questo contesto può esplicarsi quella conflittualità virtuosa che costituì la grandezza di Roma. Riprendiamo la formulazione originaria di Polibio che Machiavelli ricalca nei Discorsi 29:
«Come ho detto sopra, tre erano gli organi dello stato che si spartivano l’autorità; il loro potere era così ben diviso e distribuito, che neppure i Romani avrebbero potuto dire con sicurezza se il loro governo fosse nel complesso aristocratico, democratico, o monarchico. Né è il caso di meravigliarsene, perché considerando il potere dei consoli, si sarebbe detto lo stato romano di forma monarchica, valutando quello del senato lo si sarebbe detto aristocratico; se qualcuno infine avesse considerato l’autorità del popolo, senz’altro avrebbe definito lo stato romano democratico»30.
Il governo misto romano nacque in uno specifico contesto, diverse sono le nostre società, ma possiamo ugualmente trarne un insegnamento: nei prossimi conflitti avranno la meglio quelle società che oltre a sviluppare gli strumenti difensivi e offensivi sapranno realizzare nuove forme di integrazione del popolo, quelle società che sapranno essere più compatte sviluppando un senso di appartenenza.
A partire da questi presupposti, proviamo a pensare un nuovo ruolo per degli ipotetici movimenti popolari di domani dei quali sentiamo assoluto bisogno. Essendo la mia formazione originaria marxista mi occuperò qui delle classi inferiori, ma ugualmente bisognerebbe tentare di ridefinire un ruolo per le classi medie. Per cominciare, le classi popolare dovrebbero creare delle proprie organizzazioni politiche che non abbiano come obiettivo inviare deputati al parlamento, perché questo è uno strumento delle classi dominanti. Cosa avrebbero detto i Populares qualora i Tribuni del popolo fossero diventati parte organica del Senato? È facile immaginarlo, avrebbero detto che non erano più i loro rappresentanti, mentre ciò avviene normalmente in tutti i sistemi parlamentari. Inoltre bisognerebbe pensare in prospettiva a forme di organizzazione militare finalizzata alla difese di queste organizzazioni, altrimenti esse sono ostaggio di chiunque detiene gli strumenti per l’utilizzo della forza.
Nella maggior parte delle nazioni occidentali, le classi popolari non possono utilizzare il rifiuto delle armi come strumento di pressione nei confronti delle classi dominanti, oggi la maggiori parte degli eserciti sono formati da professionisti volontari, e anche quando esisteva l’esercito di leva, la coscrizione impediva di utilizzare questo strumento, per la plebe romana invece questo era uno strumento di pressione maggiore ancora dello sciopero. Tuttavia bisogna capire che i professionisti militare non vivono nel nulla, il loro maggiore o minore impegno è determinato dal senso di appartenenza alla società, dalla presenza di motivi validi ed uno dei principali è il combattere per una società a cui si sente di appartenere.
Lo sciopero resterebbe una delle armi principali con cui le classi inferiori manifestano la loro indispensabilità per l’intera società, ma attualmente tale strumento è stato bagattellizzato da sindacati inghiottiti dallo stato. Anche in ambito sindacale bisognerebbe mirare a ricostuire delle organizzazioni autonome dei lavoratori.
I comunisti intendevano inserirsi nei parlamenti perché il loro obiettivo era il rovesciamento dello stato, mentre invece non deve essere questo l’obiettivo piuttosto quanto creare un contro-potere che difenda gli interessi delle classi popolari, consapevoli che una forma di comando, di governo ci deve pur essere altrimenti uno stato non è tale.
Le classi sociali non hanno una base esclusivamente «economica» eliminata la quale si eliminano anche le classi sociali, le classi sociali derivano dall’esistenza di chi comanda e chi è comandato. Tuttavia le classi dominanti se non hanno un contro-potere che le contrasta tendono ad assumere il massimo potere possibile, fino a forme estreme di esclusione dalla società di quote rilevanti delle classi popolari . Tra le sventure che possono colpire l’individuo l’esclusione sociale è oggi l’equivalente della schiavitù nel mondo antico, anzi forse per chi è «buttato in mezzo alla strada» e tagliato completamente fuori può sembrare preferibile la sorte dello schiavo a cui perlomeno era assicurato un tetto e del cibo. L’esclusione sociale condivide con la schiavizzazione la dimensione della «morte sociale» che Orlando Patterson individua come il tratto distintivo della schiavitù31. Le classi dominanti hanno per loro natura il sogno di un dominio assoluto ed eterno, compito delle classi inferiori è rendergli presente, ponendo loro un argine, che questo sogno è distruttivo perché irreale, altrimenti subiranno le tendenze distruttive delle classi superiori. Finora nessuna società è riuscita a stare insieme, ad assicurare la cooperazione dei suoi membri senza uniformare molte volontà, ad una sola o a poche volontà, e da ciò deriva la necessità di affidare il comando a qualcuno, e questo comporta l’esistenza di un potere coercitivo e relative diseguaglianze di potere. Marx ed Engels ammettevano benissimo questa realtà di fatto quando si trattava di polemizzare con gli anarchici (Engels adduceva l’esempio del comandante di una nave: quando c’è una tempesta è vitale che ognuno si uniformi alla sua volontà), tuttavia vollero conservare l’obiettivo dell’«estinzione dello stato».
Ci saranno esponenti delle classi dominanti disposti a tollerare e anche ad incoraggiare e favorire forme di auto-organizzazione delle classi popolari (e con questo termine intendo sia le classi medie che inferiori), avendo bene stampato in mente l’avvertimento di Machiavelli che senza un popolo forte, attivo alla fine un stato è preda di «chiunque l’assalta»)?
Le classi inferiori devono difendere delle condizioni di vita dignitose e difendere l’autonomia della propria classe sociale, ma allo stesso tempo devono accettare il posto subordinato nella società. Non c’è nulla di disonorevole nello stare alla base della società. Inoltre, sembra che oggi la vita non abbia senso se non si fa qualcosa di «particolare», a mio parere invece non va disprezzata una «normalità» costituita da una vita in cui si da il proprio contributo lavorativo necessario al funzionamento della società, che lasci il tempo libero necessario per curare la propria famiglia e i propri interessi, oltre alla formazione militare che rende capaci di difendere se stessi, la famiglia e la patria. Una vita fondata su queste basi è del tutto sensata. Chi invece è chiamato a compiti particolari per attitudini e vocazione, deve avere la possibilità di farlo, anche se proviene dalle classi inferiori.
La teoria marxiana che voleva la classe lavoratrice capace di gestire l’intera società si è rivelata infondata, seppur diversi sono stati partiti operai di massa del novecento costituiti dai lavoratori manuali della grande industria, in quanto Marx per classe lavoratrice intendeva dall’«ingegnere all’ultimo manovale». Le «forze mentali della produzione», cioè i tecnici non si sono uniti alla classe operaia, ma se anche si fosse verificata la dinamica prevista da Marx secondo cui la proprietà si sarebbe trasformata in un gruppo parassitario, a cui si sarebbe opposto il lavoratore associato (i lavoratori manuali insieme alla forze mentali della produzione o general intellect) credo che non avrebbe configurato una «classe intermodale», cioè capace di gestire la transizione ad un nuovo sistema sociale, poiché per guidare la società non sono sufficienti le sole conoscenze di carattere tecnico, ma è necessaria quella formazione che da sempre hanno caratterizzato le classi dominanti, cioè oltre alla formazione fornita dalla pratica politica, quel tipo di formazione definita «umanistica» che si acquisisce con la conoscenza della storia, della filosofia, della giurisprudenza, delle arti. Inoltre, la politica è un’arte e come tale necessita di attitudini specifiche, in parte innate, non solo un determinato grado di intelligenza e di formazione, ma anche le attitudini psico-fisiche per reggere il conflitto, che seppur in questo campo non si svolge direttamente con le armi, spesso è ugualmente pericoloso. La politica a tempo pieno non è per tutti, e neanche tutti sono interessati ad un tale tipo di impegno. Ci sono diversi gradi, c’è chi ne fa una ragione di vita, ma la maggioranza si interessa alle questioni politiche quando sente le proprie condizioni di vita minacciate.
Le classi popolari non possono svolgere un’efficace lotta politica senza organizzazione, la quale presuppone una forma di divisione in classi interna tra chi dirige e chi è diretto. Ciò significava il principio, che Lenin trasse dal «rinnegato Kautsky», secondo cui agli «operai la coscienza può essere portata solo dall’esterno», in base al quale si organizzarono i partiti operai del secolo scorso che ebbero come modello principale la socialdemocrazia tedesca.
L’obiettivo della «fine della società di classe» va abbandonato perché si è dimostrata un’utopia individualistica (il giovane Marx con la sua hybris estremistica individualistica avrebbe voluto addirittura abolire la «divisione del lavoro»)32. L’essere umano è un essere sociale che vive in società organizzate, cioè costituite da gerarchie. Una volta stabilito tale punto fermo tutto da discutere è il rapporto tra le classi. Sicuramente le società occidentali odierne con le loro mostruose differenze di reddito necessitano di una radicale riorganizzazione. Di una radicale riorganizzazione ha bisogno anche la forma dello stato, che miri al suo rafforzamento attraverso una sua trasformazione democratica che assegni un ruolo alle classi medie e alle classi inferiori (non mi soffermo qui sul ruolo del «ceto medio semicolto» trattato in vari interventi, che è in realtà un’appendice dell’apparato statale odierno). Tale radicale trasformazione dello stato assolutistico, implica un’estensione del potere alle classi non dominanti, per dirla con Massimo Morigi, pur mantenendo una gerarchia di poteri.
Una volta stabilito il principio dell’autonomia delle classi popolari, ma all’interno di una società organizzata, le classi popolari devono ricercare l’alleanza con i membri delle classi dominanti, se ce ne sono, che non abbiano le tendenze auto-distruttive prevalenti in quelle attuali, e che abbiano l’intenzione di combattere la deriva attuale delle società occidentali. Soltanto se si realizzare tale sinergia sarà possibile nelle condizioni attuali invertire la deriva.
Va ritrovata un’unità sociale nella difesa dello stato. I recenti movimenti «sovranisti» intendono difendere la sovranità dello stato nei confronti della «globalizzazione», cioè nei confronti del tentativo statunitense di stabilire un dominio mondiale. Tuttavia la difesa di questa sovranità implica una decisa trasformazione dello stato che ne trasformi radicalmente le basi assolutistiche sulle quali è fondato. Senza questo intento il «sovranismo» non potrà essere che un altra forma di inganno, ancora un altro partito che una volta in parlamento fa esattamente il contrario di quanto aveva promesso per ottenere il voto.
Toni Negri è un «cattivo maestro», ma si impara anche dai maestri cattivi una volta riconosciuti come tali. Come scrisse Preve, è un pensatore da prendere sul serio, perché a suo modo geniale e innovativo. In Impero egli effettua una colossale mistificazione, presentando la «globalizzazione» statunitense quale erede del repubblicanesimo machiavelliano, ma confrontandosi con i suoi argomenti, frutto di una conoscenza sofisticata, si possono migliorare gli strumenti teorici necessari per combattere i conflitti attuali. Quello di Negri è stato il tentativo più significativo di trasformare il repubblicanesimo machiavelliano in una teoria politica per l’oggi, ma pervertendone il significato, trasformandolo in un’ideologia a servizio della globalizzazione. La sua antropologia del desiderio è esattamente il contrario della virtù machiavelliana, quale attaccamento alla patria, fortezza e temperanza, senso della giustizia, capacità militare e politica allo stesso tempo, e infine audacia, perché sarà necessaria molta audacia per affrontare l’Idra. Leviatano, il mostro marino, vinse Behemoth, il mostro terrestre, e con questi poi si congiunse e con l’ausilio della Tecnica diede vita all’Idra che vuole dominare tutto il globo.
Non c’è dubbio che la critica di Toni Negri della sovranità statale corrisponda alle finalità di destrutturazione degli stati a cui mira la globalizzazione (statunitense), ciò non toglie che sia sostanzialmente giusta. Difendersi dalla globalizzazione semplicemente affermando la sovranità dello stato è una lotta di retroguardia destinata alla sconfitta, perché questo tipo di sovranità svuota di ogni forma di partecipazione le classi medie e le classi inferiori. Abbiamo una contrapposizione tra stato-apparato (l’insieme dell’apparato di dominio che comprende anche i media) e la nazione (l’intera collettività). Lo stato-nazione si difende quindi ritrovando una forma di partecipazione ad esso delle classi non dominanti, il che comporta la messa in discussione dell’assolutismo di base su cui è costruito lo stato moderno. Ecco la critica dell’assolutismo su cui si fonda lo stato moderno, è evidente che essa coglie i nodi essenziali della questione:
«La teoria hobbesiana della sovranità era funzionale allo sviluppo della monarchia assoluta e, tuttavia, il suo schema trascendentale poteva essere ugualmente applicato alle altre forme di governo: all’oligarchia e alla democrazia. Nel momento in cui la borghesia stava diventando la classe emergente, sembrava che non vi fosse alcuna alternativa a questo schema di potere. Non fu dunque casuale che il repubblicanesimo democratico di Rousseau finì per assomigliare al modello hobbesiano. Il contratto sociale di Rousseau garantisce che l’accordo tra le volontà individuali viene sostenuto e sublimato nella costruzione di una volontà generale che nasce dall’alienazione delle singole volontà a favore della sovranità dello stato. In quanto modello di sovranità, l’«assoluto repubblicano» di Rousseau non è realmente diverso dall’hobbesiano «Dio in terra», e cioè dal monarca assoluto. «Queste clausole [del contratto], beninteso, si riducono tutte a una sola, cioè all’alienazione totale di ciascun associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità». Le altre condizioni poste da Rousseau per la definizione della sovranità in senso democratico popolare sono assolutamente irrilevanti rispetto all’assolutezza della fondazione trascendente. In particolare, la nozione rousseauviana della rappresentanza diretta è completamente distorta e, in ultima analisi, viene inghiottita dalla rappresentanza della totalità a cui è strutturalmente connessa – e tutto ciò, ancora una volta, risulta perfettamente compatibile con la concezione hobbesiana della rappresentanza. Hobbes e Rousseau non facevano altro che ripetere il paradosso che Bodin aveva già concettualizzato nella seconda metà del sedicesimo secolo. La sovranità appartiene, propriamente, soltanto alla monarchia, poiché uno solo è il sovrano. Se due, tre o più avessero il potere, non vi sarebbe sovranità, poiché il sovrano non può essere soggetto al potere di altri. Le forme politiche democratiche, plurali e popolari potranno anche essere proclamate, ma la sovranità moderna avrà sempre una sola configurazione politica: un unico potere trascendente»33.
Uno dei primi a rendersi conto che una società senza una cultura comune non poteva andare avanti fu Rousseau, il quale propose di creare in sostituzione una «religione della patria», ma poiché non vi può essere una tale comunanza in presenza di differenze sociali sostanziali, egli propose allo stesso tempo una religione dell’umanità e dell’eguaglianza, che aveva anche un suo peccato originale costituito dallà «proprietà». Se all’inizio religione della patria e religione dell’umanità andavano accompagnate nella stessa persona, come ancora in Filippo Buonarroti34 successivamente finiranno per divaricarsi per dar vita a nazionalismo e socialismo (successivamente: fascismo e comunismo), diventeranno le sorelle nemiche tanto acerrime proprio perché nate dallo stesso seme. Era già iniziato il processo della disgregazione europea. Ma il problema non fu principalmente ideologico, se l’Europa non riusci a creare una cultura comune in sostituzione del cristianesimo fu perché non riusci a svilupparsi come realtà unitaria.
La civiltà europea è giunta ad un punto morto. La sua storia iniziata con le crociate si è conclusa con conflitti insolubili, sfociati in due guerre mondiali, e infine la sottomissione agli Usa, ma non prima di aver stravolto la faccia del mondo. Chi pensa di ripartire da questa storia, dai suoi nazionalismi, magari ribattezzati rispettabilmente in «patriottismo», secondo me perde tempo. La stato nazionale va difeso, pena la disgregazione totale, ma in un’ottica rivolta al futuro, e per quanto riguarda l’Europa ciò vuol dire ricostruire le sue articolazioni nazionali intorno ad un nuovo centro, il quale sarà Russia, se è vera la profezia secondo cui Mosca è la Terza Roma. Ma questa non è prospettiva a breve termine, emergerà come orizzonte politico dopo lo scontro tra le grandi potenze che si preannuncia.
Non ritengo sia tutto da buttare della storia europea, ma neanche ci si deve nascondere il sostanziale fallimento della civiltà europea. Potremmo dire che avremmo preferito con Machiavelli uno sviluppo più classico più simile a quella di Roma, con un «progresso» meno accellerato, e più integrabile dalla psiche umana e dalle strutture sociale e non lo sviluppo abnorme, mostruoso e fuori controllo a cui siamo di fronte, tuttavia la storia non segue degli sviluppi «classici» perché attinge nella natura (nel senso di physis) che per l’essere umano è imperscrutabile nei suoi fondamenti ultimi, a cui l’essere umano può accostarsi ma mai dominare a suo piacimento. A cosa ci condurrà l’odierna situazione non lo sappiamo, di sicuro l’epoca «tranquilla», seguita alla II guerra mondiale (perché basata sulla deterrenza nucleare) durata pochi decenni sta definitivamente per concludersi. Non sappiamo cosà accadrà, di sicuro saranno conflitti enormi, proporzionati alla capacità distruttiva acquisita dell’essere umano, per affrontare i quali sarà necessaria molta, tantissima virtù per non soccombere alla fortuna.
La capacità esplicativa del paradigma machiavelliano la si può verificare utilizzandola per quanto riguarda il mondo uscito dalla II guerra mondiale. Per l’occidente, e per la stessa Italia, le cose sono andate meglio fin quando gli Usa avevano un antagonista nell’Urss, era proprio questo antagonismo a creare un ordine. Non appena tale antagonista sbiadisce, e questo avviene ben prima del «crollo del muro», comincia la decadenza del mondo occidentale del dopoguerra e nasce il «neo-liberismo».
Machiavelli ritorna d’attualità nella misura in cui si esaurisce il vantaggio tecnologico «occidentale» sul resto del mondo iniziato cinque secoli fa. Se la civiltà ortodossa, quella sinica e anche quell’indiana (sebbene meno protagonista rispetto alla prime due non corre però rischi esistenziali), hanno superato la prova della minaccia mortale costituita dall’espansionismo mondiale dell’occidente, diversamente è stato per la civiltà islamica. A causa del fatto che ha avuto la sventura di trovarsi sopra i maggiori deposito di petrolio mondiale e per debolezze intrinseche dovute alle divisioni confessionali, la civiltà islamica è l’unica rimasta sotto le grinfie dell’occidente. Il tentativo di conquista del dominio mondiale degli Usa dopo il crollo del muro ha colpito soprattutto in questo ambito distruggendo l’Iraq e poi la Libia, mentre l’Iran resta permanentemente nel mirino. Attraverso l’Arabia Saudita e il Qatar si è riusciti a manipolare i movimenti islamisti che utilizzano gli attentati terroristici tra i principali mezzi di lotta, in modo da indirizzarli principalmente contro la Russia. Dato lo sporco gioco occidentale e dato il fatto che i nostro s-governanti hanno avuto la felice idea di lasciar crescere delle enclaves di popolazioni di religione islamiche nelle città europee, con organizzazioni legate all’Arabia Saudita e al Qatar è da prevedere che gli attentati cresceranno, qualora diventassero fenomeno quotidiano con un rischio statistico significativo, potrebbe essere lo sviluppo di forme di milizia popolare. Nei recenti attentati in Europa, la presenza diffusa di cittadini armati, con armi adeguate ed addestrati ad usarle, avrebbe potuto determinare esiti differenti (cittadini nel senso autentico della parola, cioè membri di una comunità capaci di difendere se stessi e la collettività in cui vivono). Altrimenti, l’alternativa sarebbe, nel caso di crescita significativa degli attentati sarebbe la militarizzazione delle società, e la fine di quella libertà di movimento a cui siamo attaccati.
Riconsideriamo quindi il monito che risuona nei secoli lanciato da Machiavelli alle classi dominanti:
Per tanto, se tu vuoi fare uno popolo numeroso ed armato per poter fare un grande imperio, lo fai di qualità che tu non lo puoi poi maneggiare a tuo modo: se tu lo mantieni o piccolo o disarmato per poter maneggiarlo, se tu acquisti dominio, non lo puoi tenere, o ei diventa sì vile che tu sei preda di qualunque ti assalta35.
Se è vero che gli eserciti odierni hanno una ineliminabile componente di specializzazione, è anche vero che ad usare questi strumenti sono pur sempre degli uomini e in quanto tali devono avere delle motivazioni per combattere. Il culto del drone radiocomandato è un simbolo del nichilismo tecnologico in cui si sono infognate le società occidentali. Ma il drone non si guida da solo, neppure è in grado di combattere Igor il cattivo, protagonista della recente e scadentissima saga mediatica. Le società occidentali individualiste e disgregate non forniscono queste motivazioni. Man mano che si intensificherà lo scontro multi-polare Machiavelli tornerà d’attualità. L’«occidente» ha puntato tutto sulla superiorità tecnica, ma il divario tecnico è la cosa più facile da colmare, mentre è molto più difficile far risalire la china ad una società disgregata, divisa al suo interno. Il divario tecnico di cui ha goduto l’occidente è già praticamente superato, e nel prossimo scontro vinceranno le società più compatte che sapranno realizzare forme di inclusione del popolo, che sapranno trovare un popolo disposto e capace di difendere la propria nazione.
Il Progresso è un’idea scaduta, messa radicalmente in discussione da due guerre mondiali e dall’invenzione della bomba atomica. Il progresso tecnico accresce tanto le capacità costruttive quanto quelle distruttive dell’essere umano. Affidarsi al Progresso equivale ad affidarsi alla Divina Provvidenza, un concetto religioso di cui il Progresso fu una secolarizzazione. Per gli occidentali che di fronte alla superstizione del progresso hanno adottato più o meno consapevolmente l’attitudine di alcuni superstiziosi in Italia secondo cui «non è vero ma ci credo», cioè essi non credono più al Progresso, ma continuano a credere che la «civiltà occidentale» sia comunque al culmine della civiltà mondiale, forse la visione ciclica di Machiavelli ha qualcosa da dire: «…la virtú partorisce quiete, la quiete ozio, l’ozio disordine, il disordine rovina, e similmente dalla rovina nasce l’ordine, dall’ordine virtù, da questa gloria e buona fortuna»36. Non è forse l’aver pensato di essere il culmine della civiltà e di non avere più nemici una delle cause della disgregazione e decadenza delle oscietà occidentali?
La cultura americana (statunitense) ha inondato il mondo di ciarpame, ma rispetto alla cultura europea attuale (se ne esiste una visto che ormai si limita a seguire al traino quella statunitense) è possibile rovistando trovare qualcosa di utile, talvolta indispensabile. Prendiamo la questione della guerra, è da tempo ormai che la cultura europea è incapace di affrontare tale fondamentale realtà umana, mentre invece la cultura statunitense non ha bisogno di rimuoverla. C’è un’attenzione alla questione del conflitto assente nella produzione intellettuale delle nazioni europee. Ad es. non saprei indicare un testo di uno scrittore europeo contemporaneo che possa eguagliare per profondità e realismo il libro di James Hillman, Un terribile amore per la guerra, una lettura altamente consigliata che può offrire un valido aiuto per affrontare i tempi che verranno, in quanto affronta la guerra da un punto di vista filosofico e psicologico. Penso inoltre inoltre a tutta una corrente storiografica e sociologica che ha visto nella guerra il principale fattore di sviluppo dello stato moderno. Proprio il marxismo, che si dimostra in questo un frutto della decadenza europea, è stato uno dei principali promotori di questa vera e propria rimozione. Nato, il marxismo, in un momento in cui le nazioni europee si incartavano, per così dire, in conflitti regressivi, pensava di superare questa situazione rimuovendo del tutto il fattore dell’identità di gruppo, della nazione, della conflittualità tra gli esseri umani, che ha caratterizzato ogni epoca della storia umana, sostituendovi la sola conflittualità tra le classi sociali, la quale portata all’estremo avrebbe creato un mondo senza conflitti. Il marxismo ha contribuito di molto alla perdita di contatto con la realtà della cultura europea. Non che il conflitto tra le diverse classi non esiste, l’errore è isolarlo dagli altri conflitti, non metterlo in relazione ad es. a quello inter-nazionale, mentre invece è in questa relazione che acquisisce significati diversi, anche opposti (vedi in merito il mio Relatività dei conflitti. Per un nuovo paradigma nell’analisi politica).
Guardiamo con realismo alla questione del conflitto. Ciò che ha moderato il carattere sostanzialmente oligarchico e degli stati occidentali che ha creato uno spazio per le rivendicazioni salariali è stata la necessità che si è avuta del coinvolgimento popolare per condurre il conflitto con gli altri stati. Dopo la seconda guerra mondiale la presenza dell’alternativa di sistema costituita dall’Unione Sovietica aveva spinto a delle misure, soprattutto in Europa, atte a mantenere un certo consenso popolare, da ciò è sorto il cosiddetto stato sociale. Dopo che, l’Unione Sovietica cessò di essere una sfida, prima del crollo del muro, già negli anni settanta si aveva sentore del non funzionamento del sistema sovietico, ritornò il neo-liberismo. Esso è sostanzialmente una forma estrema di individualismo, come disse la Thachter «la società non esiste». Le città statunitensi, dopo il breve periodo di ordine del dopoguerra, ritornavano allo hobbesiano stato di natura. Frank M. Colman in un articolo degli anni settanta, riconducendo il sistema alla sue radici hobbesiane, coglieva benissimo la tendenza (neo)liberista (ri)nascente. Come ha scritto successivamente Colemanm, lo stato hobbesiano quale incarnazione del creazionismo biblico nullifica il mondo. Il nichilismo in cui si è conclusa la cultura «occidentale», e che di conseguenza ha infettato le culture di tutto il mondo, è frutto di un lungo percorso. Se non altro Hobbes, il suo primo e principale fautore, ebbe l’onestà di chiamarlo con il suo nome di mostro marino, Leviatano. Esso combattè con un mostro terrestre, Behemoth, che sconfisse. Da allora Leviatano si è ingrandito al punto di essere capace ora di inghiottire la Terra, ma pochi osano dichiarare la sua mostruosità.
L’ «occidente» deve prendere atto dell’esistenza di altre civiltà con cui deve convivere. Esse non possono essere sottomesse o distrutte. L’unico tentativo «serio» di impedire la rinascita delle altre civiltà è stato quello nazista. Figurarsi quindi se l’ «occidente» oggi sarebbe in grado di sottomettere la Cina o la Russia.
Bisogna ricercare un assetto che prenda atto realisticamente della competizione per le sfere d’influenza fra le potenze eredi delle grandi civiltà, compresa la possibilità di conflitti locali e a margine delle linee di faglia degli stati eredi delle grandi civiltà, senza però che questo degeneri nel conflitto di civiltà. Il timore, anzi l’orrore, per le conseguenze probabili di una collisione diretta tra civiltà è ciò che deve guidare in negativo le relazioni internazionali. Per l’«occidente» si richiederebbe una decisa inversione di rotta dall’imperialismo da cui è sorto il globalismo (cioè la tendenza al dominio mondiale) ad un territorialismo che curi l’ordine interno. La campagna elettorale di Trump è stata improntata a un «protezionismo» che sembrava riflettesse in una certa misura il desiderio di una inversione di tendenza, ma naturalmente ora eletto non sta mantenendo nessuna promessa. Dicono perché costretto dal «deep state» (cioè dal potere effettivo nascosto, il vero stato), ma temo che quei settori delle classi dominanti che hanno sostenuto Trump non hanno avuto fin dall’inizio l’intenzione di effettuare una seria inversione di marcia. Il «populismo dall’alto» non potrà mai funzionare, se non si incontra con «populismo dal basso». Mi chiedo quanto le classi dominanti possano abusare del popolo nella loro infinita arroganza, finché i cittadini non decidano che sia il tempo di dare loro una lezione. Tra l’altro negli Usa si è conservato uno dei principi fondamentali del repubblicanesimo, cioè la possibilità per il popolo di portare le armi. Di solito si vuole discreditare questo principio sacrosanto attribuendogli la responsabilità dell’alto tasso di violenza. Accusa infondata in quanto in Canada e in Svizzera, dove ugualmente la possibilità di portare liberamente le armi è sancita dalla costituzione, vi sono tassi di mortalità per le armi da fuoco simili a quelli europei, mentre in varie nazioni dell’America Latina dove non vi è questo diritto costituzionale i tassi di mortalità sono più alti di quelli statunitensi.
Un radicale cambiamento di indirizzo degli Usa dal globalismo alla cura dell’ordine interno non è possibile senza cambiamento radicale della sua struttura interna. Tale cambiamento sembra molto difficile nelle condizioni attuali, ma l’alternativa è il declino e il disfacimento interno, oppure la ricerca di una «soluzione tecnica» della crisi attraverso le micidiali armi attuali che comporterebbe una catastrofe mai vista nell’intera storia dell’umanità. Anche se non credo che comporterebbe la fine del genere umano, si tratterebbe comunque di una catastrofe di proporzioni inenarrabili.
Siamo ad una tappa decisiva, che impone un radicale cambiamento di indirizzo, di un percorso iniziato oltre tre millenni fa. Ciò che Jaspers chiama il periodo assiale andrebbe visto come un percorso in cui l’essere umano è passato dalla soggezione verso la natura al tentativo di conquistarla. Non credo che la volontà di non essere in balia della natura sia in sé sbagliata, sicuramente vanno capite bene le modalità e i rischi che essa comporta. Innanzitutto l’essere umano può conquistare uno spazio di preminenza all’interna della natura, ma non può pensare di mettersi al di sopra di essa perché da essa è generato. Come aveva ben capito Jaspers è proprio attraverso l’insensato proposito dell’essere umano che la natura ristabilisce la preminenza. «La soggezione dell’uomo alla natura è resa manifesta in maniera nuova dalla tecnica moderna. La natura minaccia di sopraffare in modo imprevisto l’uomo stesso, proprio mercé il dominio enormemente maggiore che questi ha su di essa. Attraverso la natura dell’uomo impegnato nel lavoro tecnico, la natura diventa davvero la tiranna dell’essere umano. C’e il pericolo che l’uomo sia soffocato dalla seconda natura, a cui egli da vita tecnicamente come suo prodotto, mentre può apparire relativamente libero rispetto alla natura indomata nella sua perpetua lotta fisica per l’esistenza.»
Heidegger nell’analisi della illimitata volontà di potenza a cui Nietzsche diede l’espressione più pregnante, e che non fu certo solo della Germania nazista, scrisse: «La volontà di potenza non è soltanto il modo in cui e il mezzo mediante il quale accade la posizione di valori, ma è, in quanto essenza della potenza, l’unico valore fondamentale in base al quale viene stimata qualsiasi cosa che deve avere valore o che non puo pretendere di averne. «Ogni accadere, ogni movimento, ogni divenire come uno stabilire rapporti di grado e di forza, come una lotta… . Chi è che in tale lotta soccombe è, in quanto soccombe, nel torto e non vero. Chi è che in questa lotta rimane a galla è, in quanto vince, nella ragione e nel vero. Per che cosa si lotti è, pensato e auspicato come fine con un contenuto particolare, sempre di importanza secondaria. Tutti i fini della lotta e le grida di battaglia sono sempre e solo strumenti di lotta. Per che cosa si lotti è già deciso in anticipo: è la potenza stessa che non ha bisogno di fini. Essa è senza-fini, così come l’insieme dell’ente privo-di-valore. Questa mancanza-di-fini fa parte dell’essenza metafisica della potenza. Se mai qui si puo parlare di un fine, questo fine è la mancanza di fini dell’incondizionato dominio dell’uomo sulla terra. L’uomo di questo dominio è il super-uomo (Uber-Mensch)»37.
Frank Coleman, nell’analizzare il rapporto tra Hobbes e l’Antico Testamento, ritiene che nella misura in cui «il capitalismo è ciò che genera la percezione di un difetto nella natura, è anche il capitalismo, assistito dalla scienza moderna, che mostra ad Hobbes la via d’uscita. Il modo in cui il capitalismo ci libera dalla presenza di un difetto nella natura è attraverso il progetto di derivazione biblica di dominio sulla terra. I poteri del Dio dell’Antico Testamento sono riattribuiti al capitale e alla scienza moderna che procede quindi alla produzione di un artefatto della società civile che fa da parallelo e da rinforzo all’artefatto costituito dallo stato. […] Non è tanto il ruolo politico assegnato al capitalismo e alla scienza in sostegno allo stato moderno che è di interesse, ma il concetto che di natura ad esso sottostante. L’idea di derivazione biblica della natura quale artefatto, lasciatemi sottolineare, soggiace allo stato leviatano, alla scienza moderna, e al capitalismo nella teoria hobbesiana»38.
Seppure l’Antico Testamento ha giocato un ruolo fondamentale, io credo esso vada collocato nella cornice più ampia del movimento del pensiero umano costituito dal periodo assiale. Non a caso l’Artefice, il Creatore, the Maker (secondo la lingua inglese) ha un suo antenato nel Demiurgo platonico, figura che nasce dal e allo stesso tempo intende superare il netto dualismo tra mondo delle idee e realtà sensibile. Il trascendentalismo dominante durante il periodo assiale, che si differenzia rispetto ad un periodo precedente dominato da religioni immanenti alla natura, è l’espressione della volontà dell’essere umano di porsi al di sopra della natura. Poiché ciò che trascende l’essere umano è la natura da cui esso è generato, spostare la trascendenza dalla natura allo spirito, determinando una netta contrapposizione tra materia e spirito, tra corpo e anima, significa porre la trascendenza nell’intelligenza, in ciò che l’uomo ritiene che lo ponga al sopra degli altri esseri viventi, restringendo il significato di natura che nell’accezione dei greci comprendeva l’intero cosmo, alle sole «creature» viventi.
Il peccato maggiore dei moderni, prima che due guerre mondiali e la Bomba spegnessero le illusioni, è stata la hybris. Prometeo fu trasformato in una figura positiva, mettendone in secondo piano la tragicità. Persino Goethe, il più equilibrato di tutti, non fu esente da questa distorsione. Eppure se Prometeo fu condannato ad un pena terribile non fu senza ragione. Non tanto per aver rubato il fuoco agli Dei, quanto per aver pensato in questo modo di rendere gli uomini simili ad essi. Il peccato della hybris consiste nell’illusione di poter diventare padroni della natura, dimenticando che siamo sempre soggetti ad essa. Massima è la hybris di Marx secondo il quale sarebbe stato possibile padroneggiare addirittura la Storia, prevederne gli esiti. La storia e la natura hanno le loro radici nell’Ignoto, non sono prevedibili e padroneggiabili nei loro fondamenti ultimi. Far fronte a tale condizione esistenziale è compito degli esseri umani, ma senza pensare di poter padroneggiare ciò da cui siamo stati generati. Engels, un pensatore originale scrisse che la natura «si vendica di ogni nostra vittoria. Ogni vittoria ha infatti in prima istanza le conseguenze sulle quali avevamo fatto assegnamento; ma in seconda e terza istanza ha effetti del tutto impreveduti, che troppo spesso annullano a loro volta le prime conseguenze (…). Ad ogni passo ci vien ricordato che noi non dominiamo la natura come un conquistatore domina un popolo straniero soggiogato (…). Tuttavia il nostro dominio sulla natura consiste nella capacità, che ci eleva al di sopra delle altre creature, di conoscere le sue leggi e di impiegarle nel modo più appropriato»39.
Quando leggiamo Machiavelli lo sentiamo come un moderno, qualcuno che parla di un mondo che è anche il nostro, ma riguardo al rapporto dell’uomo con la natura appare la diversità del «pagano» Machiavelli portavoce di una modernità diversa rispetto a quella che ha prevalso.
«Quanto alle cause che vengono dal cielo, sono quelle che spengono la umana generazione, e riducano a pochi gli abitatori di parte del mondo. E questo viene o per peste o per fame o per una inondazione d’acque: e la più importante è questa ultima, sì perché la è più universale, sì perché quegli che si salvono sono uomini tutti montanari e rozzi, i quali, non avendo notizia di alcuna antichità, non la possono lasciare a’ posteri. […]. E che queste inondazioni, peste e fami venghino, non credo sia da dubitarne; sì perché ne sono piene tutte le istorie, sì perché si vede questo effetto della oblivione delle cose, sì perché e’ pare ragionevole ch’e’ sia: perché la natura, come ne’ corpi semplici, quando e’ vi è ragunato assai materia superflua, muove per sé medesima molte volte, e fa una purgazione, la quale è salute di quel corpo; così interviene in questo corpo misto della umana generazione, che, quando tutte le provincie sono ripiene di abitatori, in modo che non possono vivervi, né possono andare altrove, per essere occupati e ripieni tutti i luoghi; e quando la astuzia e la malignità umana è venuta dove la può venire, conviene di necessità che il mondo si purghi per uno de’ tre modi; acciocché gli uomini, sendo divenuti pochi e battuti, vivino più comodamente, e diventino migliori»40.
Vediamo quindi come Machiavelli ripristina spontaneamente la trascendenza nella natura. La modernità dalla antica visione del mondo si rivela tutta in queste parole che dovrebbero essere da monito per noi viventi. Se gli esseri umani non riusciranno ad invertire la tendenza riparando ai mali prodotti da un percorso millenario, che non è condannare in sé, quale volontà dell’essere umano di non essere in completa balia della natura, ma solo nell’illusione di poter soggiogare la natura, dimenticando che essa stabilisce comunque la sua preminenza rispetto al singolo individuo.
Il Grande Falegname (per quelli del tempo della Bibbia) o il Grande Ingegnere Interstellare per quelli di oggi è un concetto antropomorfico. C’è bisogno di un concetto che indichi l’esistenza di ciò che trascende la capacità di comprensione umana o che l’essere umano può cogliere in minima parte senza poterla esaurire, possiamo chiamarlo Dio, Infinito, Natura. E’ da superare il concetto di Dio creatore della natura (che il settimo giorno si riposò), perché è una proiezione dell’illusione umana di dominare la natura.
Se non si metterà il massimo impegno a invertire una «crescita» che ormai somiglia più al diffondersi di una metastasi e ristabilire un equilibrio allora sarà la natura a farlo. Questo non vuol dire affatto porsi dalla parte della «de-crescita», quel semplicismo per cui basta mettere il segno negativo al valore della «crescita». Sapranno conquistare l’egemonia quei sistemi sociali che sapranno indicare ai popoli un diverso modello qualitativo di sviluppo.
Siamo oggi nel crepuscolo del Demiurgo. Si spera che la notte che incombe non sia illuminata da esplosioni nucleari.
Non il pacifismo, né il buonismo, questi due figli ipocriti della carità cristiana, entrambi arruolati dal globalismo, ma la virtù machiavelliana può ispirare uno spirito di antagonismo nei confronti dell’Idra le cui teste sono sparse in tutto il globo, l’Apparato di potere che rischia di devastare l’intero mondo nella sua agonia. Il pericolo maggiore è che l’Idra-Apparato voglia ricorrere alla Tecnica (nello specifico all’utilizzo delle armi atomiche su vasta scala), sulla quale ha fatto sempre affidamento prioritario, per impedire o ritardare la sua fine, perché non può ricorrere alla virtù che da tempo ha soffocato nei suoi sottoposti. Il compito prioritario degli «occidentali» sarebbe distruggere questo mostro che altrimenti li porterà alla rovina. Siamo sulla strada che porterà ad uno scontro generalizzato che ridefinirà i rapporti inter-nazionali, acquisiranno un ruolo di primo piano le società che faranno affidamento non solo sulla superiorità tecnica degli armamenti, ma sulla loro maggiore compatezza, sul maggiore attaccamento dei loro cittadini al proprio stato, al proprio sistema sociale, alla proprià civiltà. Gli occidentali questo attaccamento non l’hanno, troppo marce sono diventate le società occidentali, troppo piene di diseguaglianza e plateali ingiustizie, troppo pieni di menzogne i programmi dei partiti politici, inqualificabili sono i media occidentali si dedicano deliberatamente al rimbambimento dei loro spettatori e a suscitare tutti i più miseri particolarismi.
Prepariamoci psicologicamente e fisicamente, non esiste una netta distinzione, a tempi difficili. La cosa peggiore è la fuga dalle realtà degli «occidentali», ma per chi non vuole essere in balia degli eventi, per chi ritiene che la dignità dell’essere umano consista nel tentare almeno di far fronte ai colpi della Fortuna, Machiavelli è sicuramente un compagno di strada.
1Pocock, Il momento machiavelliano, ed. it. II vol. p. 389. Ho semplificato i riferimenti bibliografici, con gli attuali strumenti informatici è molto facile ritrovare i testi citati. Inoltre, poiché ho utilizzato la versione digitale di molti testi, ho inserito il numero di pagina solo quando era disponibile, non l’ho inserito nel caso di articoli e introduzioni. L’eventuale lettore interessato al contesto da cui sono tratte alcune citazioni non farà fatica a ritrovarlo. Vorrei infine ringraziare che ha allestito il sito http://gen.lib.rus.ec/, dove ho reperito tantissimi testi e senza il quale non avrei potuto portare a termine questo lavoro.
2 Marco Geuna, Introduzione a Skinner, La Libertà prima del liberalismo, p. XVII
3 M. Geuna, Introduzione a Philip Pettit, Il repubblicanesimo. Una teoria della libertà e del governo, p. 28
4 «Sempre ch’io ho potuto onorare la patria mia, eziandio con mio carico et pericolo, l’ho fatto volentieri: perché l’uomo non ha maggiore obbligo nella vita sua che con quella, dependendo prima da essa l’essere, e dipoi tutto quello che di buono la fortuna e la natura ci hanno conceduto; e tanto viene a essere maggiore in coloro che hanno sortito patria piú nobile. E veramente colui il quale con l’animo et con l’opera si fa nimico della sua patria, meritamente si può chiamare parricida, ancora che da quella fussi suto offeso». Machiavelli, Discorso intorno alla nostra lingua
5 M. Geuna, Introduzione a Q. Skinner, La libertà prima del liberalismo
6 Chabod, Scritti su Machiavelli, p. 77
7 «Questo esemplo, con molti altri che di sopra si sono addotti, mostrano quanta bontà e quanta religione fusse in quel popolo [romano], e quanto bene fusse da sperare di lui. E veramente, dove non è questa bontà, non si può sperare nulla di bene; come non si può sperare nelle provincie che in questi tempi si veggono corrotte: come è la Italia sopra tutte l’altre, ed ancora la Francia e la Spagna di tale corrozione ritengono parte». Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio
8« …tener ricco il pubblico, povero il privato, mantenere con sommo studio li esercizi militari, sono le vie a far grande una Repubblica» Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio
9William J. Connell, L’espansione come telos dello stato
10 «Se però è corretto definire Impero “una organizzazione tale che in essa l’unità non agisca in modo distruttivo e livellatore nel riguardo della molteplicità etnica e culturale da essa compresa”, a ragione si può affermare con de Benoist che l’Impero romano, sotto questo profilo è un esempio particolarmente illuminante: nell’Impero romano la tolleranza religiosa è la norma, esiste una doppia cancelleria imperiale, in Egitto si continua ad applicare il diritto indigeno spolverato di diritto greco e il diritto ebraico continua ad essere valido per gli ebrei. Ogni comunità cioè ha il diritto di organizzarsi in base alla propria tradizione, benché chi gode del diritto di cittadinanza romana (concessa con l’editto di Caracalla del 212 d. C. a tutti gli abitanti liberi dell’impero) possa sempre appellarsi alla giustizia imperiale. Insomma, il cittadino romano si trova a dipendere sia dalla città in cui è nato sia dall’amministrazione imperiale. E Maurice Sartre giunge a sostenere: “Se c’è un insegnamento che dobbiamo trarre dalla storia dell’Impero romano potrebbe essere proprio questo: la coesione di un insieme tanto disparato che si basa sul rispetto di strutture locali responsabili della gestione della vita quotidiana, guardiane delle tradizioni […] A conti fatti, il rispetto delle identità culturali è più importante, a lungo termine, del successo economico o degli imperativi strategici”, in quanto sono in gioco un modello di civiltà e un sistema di valori che si ritiene di dover difendere “contro chi vorrebbe metterli in discussione, all’esterno (i barbari) o all’interno (in particolar modo i cristiani)”». Fabio Falchi, L’impero come «grande spazio» . Vedi l’intero articolo per una distinzione tra il concetto di impero e l’imperialismo. Anche se personalmente preferisco utilizzare il termine territorialismo al posto di impero. (L’articolo si può consultare sullo spazio dell’autore in academia.edu).
11da War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe Victoria Tin-Bor Hui, un’apparentemente modesta ricercatrice accademica, ma dal pensiero affilato come la lama di una katana, ha elaborato un interessantissimo saggio comparativo tra la sviluppo della Europa moderna e quello della Cina antica. Putroppo, lo stato comatoso della cultura europea ha lasciato passare inosservato questo saggio che pur ha ricevuto una serie di premi in ambito accademico statunitense.
12 Victoria Tin-Bor Hui, op. cit. p. 39
13Victoria Tin-Bor Hui, op. cit. p. 28
14 Arte della guerra
15Victoria Tin Hui, op. cit. p. 140-1. La citazione di Machiavelli è da Il principe
16… giudico il mondo sempre essere stato ad uno medesimo modo, ed in quello essere stato tanto di buono quanto di cattivo; ma variare questo cattivo e questo buono di provincia in provincia, come si vede per quello si ha notizia di quegli regni antichi, che variano dall’uno all’altro per la variazione de’ costumi, ma il mondo restava quel medesimo: solo vi era questa differenza, che dove quello aveva prima allogata la sua virtú in Assiria, la collocò in Media, dipoi in Persia, tanto che la ne venne in Italia e a Roma. E se dopo lo Imperio romano non è seguíto Imperio che sia durato né dove il mondo abbia ritenuta la sua virtú insieme, si vede nondimeno essere sparsa in di molte nazioni dove si viveva virtuosamente; come era il regno de’ Franchi, il regno de’ Turchi, quel del Soldano, ed oggi i popoli della Magna, e prima quella setta Saracina che fece tante gran cose ed occupò tanto mondo, poiché la distrusse lo Imperio romano orientale. In tutte queste provincie adunque, poiché i Romani rovinorono, ed in tutte queste sétte è stata quella virtú, ed è ancora in alcuna parte di esse, che si desidera e che con vera laude si lauda.
- Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio
17 Pocock, Introduzione a James Harrington The Commonwealth of Oceana and A System of Politics
18 M. Geuna, Rousseau interprete di Machiavelli
19 Victoria Tin-Bor Hui, op. cit. p.. 194
20 Max Weber, Storia economica, p. 227-8
21Crawford Brough Macpherson, Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese: la teoria dell’individualismo possessivo da Hobbes a Locke
22Idem
23 Kant, Il conflitto delle facoltà
24Come sintetizza il titolo, From the state of princes to the person of the state, del capitolo finale del II vol. di Vision of Politics
25Diversi testi di Marco Geuna sono disponibili sul sito academia.edu
26Gli interventi di Massimo Morigi sul Repubblicanesimo Geopolitico sono stati pubblicati dal sito http://corrieredellacollera.com
27https://www.youtube.com/watch?v=VeOUHYC8zq8&t=533s
28http://www.cogitoergo.it/l%E2%80%99esercito-esaurito/
29E avvengaché quelli suoi re perdessono l’imperio, per le cagioni e modi discorsi; nondimeno quelli che li cacciarono, ordinandovi subito due Consoli che stessono nel luogo de’ Re, vennero a cacciare di Roma il nome, e non la potestà regia: talché, essendo in quella republica i Consoli e il Senato, veniva solo a essere mista di due qualità delle tre soprascritte, cioè di Principato e di Ottimati. Restavale solo a dare luogo al governo popolare: onde, sendo diventata la Nobilità romana insolente per le cagioni che di sotto si diranno si levò il Popolo contro di quella; talché, per non perdere il tutto, fu costretta concedere al Popolo la sua parte e, dall’altra parte, il Senato e i Consoli restassono con tanta autorità, che potessono tenere in quella republica il grado loro. E così nacque la creazione de’ Tribuni della plebe, dopo la quale creazione venne a essere più stabilito lo stato di quella republica, avendovi tutte le tre qualità di governo la parte sua. E tanto le fu favorevole la fortuna, che, benché si passasse dal governo de’ Re e delli Ottimati al Popolo, per quelli medesimi gradi e per quelle medesime cagioni che di sopra si sono discorse, nondimeno non si tolse mai, per dare autorità agli Ottimati, tutta l’autorità alle qualità regie; ne si diminuì l’autorità in tutto agli Ottimati, per darla al Popolo; ma rimanendo mista, fece una republica perfetta: alla quale perfezione venne per la disunione della Plebe e del Senato
30Polibio, Storie (Libro VI) L’eccellenza della costituzione romana
31Slavery and Social Death
32Sull’individualismo di Marx vedi Louis Dumont, Homo aequalis
33Michael Hardt (Autore), Antonio Negri (Autore), A. Pandolfi (a cura di), D. Didero (a cura di), Impero
34Vedi in merito il lavoro di James H. Billington, Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith
35 Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio
36 N. Machiavelli, Istorie fiorentine
37 Nietzsche
38The prosthetic God: Thomas Hobbes, the bible, and modernity
39Dialettica della natura
40Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio
http://www.gennaroscala.it/2017/06/21/il-paradigma-machiavelliano-per-la-definizione-di-una-teoria-politica-non-ideologica/
Il sito www.italiaeilmondo.com non fruisce di alcuna forma di finanziamento, nemmeno pubblicitaria. Tutte le spese sono a carico del redattore. Nel caso vogliate offrire un qualsiasi contributo, ecco le coordinate: postepay evolution a nome di Giuseppe Germinario nr 5333171135855704 oppure iban IT30D3608105138261529861559 oppure
Su PayPal è possibile disporre eventualmente un pagamento a cadenza periodica, anche di minima entità, a partire da 2 (due) euro (ho scoperto che pay pal prende una commissione di 0,38 centesimi)
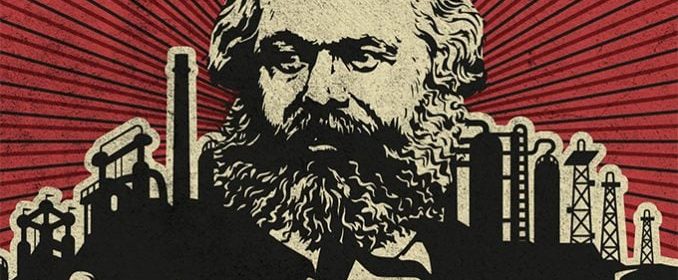


 questo socialismo patriottico in diverse esperienze politiche come quelle dei Paesi in via di industrializzazione, ad esempio l’Argentina peronista o l’Egitto nasseriano (strettamente imparentati ai fascismi europei), ma anche di Paesi ad industrializzazione avanzata, come la Francia gollista, fino a Paesi dichiaratamente socialisti quali la Cuba di Fidel Castro e Che Guevara che del “Patria o muerte” hanno fatto la propria insegna antimperialista ed antiamericana (una scelta che non può comprendersi in pieno obliterando, come sovente si fa, le origini falangiste “joseantoniane” di Castro e quelle peroniste di Guevara, per le quali rinviamo al nostro contributo rintracciabile qui https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-224-2/). Non solo, perché il patriottismo fu rivendicato anche da Palmiro Togliatti, in un articolo significativamente titolato “Il patriottismo dei comunisti” uscito su “Rinascita” nel luglio-agosto 1945, ossia a guerra civile ancora latente, nel quale il segretario del Pci scrisse: «È ridicolo pensare che la classe operaia possa staccarsi, scindersi dalla nazione. La classe operaia moderna è il nerbo delle nazioni. I comunisti, che sono il partito della classe operaia, non possono dunque staccarsi dalla loro nazione se non vogliono troncare le loro radici vitali. Il cosmopolitismo è una ideologia del tutto estranea alla classe operaia. Esso è invece l’ideologia caratteristica degli uomini della banca internazionale». Nello scrivere tali parole Togliatti, memore della lezione del fascismo che tentò di unire classe e nazione ossia socialismo e patriottismo, richiamava implicitamente il suo “Appello ai fratelli in camicia nera”, da lui firmato e pubblicato nel 1936 sulla rivista parigina “Lo Stato Operaio”, nel quale, all’interno di una strategia entrista nel momento del massimo consenso popolare al regime, invocava la “santa alleanza per la comune battaglia per il pane ed il lavoro” tra comunisti e fascisti di sinistra. Togliatti, nonostante fosse in esilio, aveva osservato che, dopo la delusione seguente ai compromessi nel decennio precedente tra il regime e i fiancheggiatori di destra, i fascisti di sinistra, ossia i veri fascisti, negli anni Trenta, con l’avvallo ufficioso dello stesso Mussolini (il quale giunse persino a sostenere la tesi della “corporazione proprietaria” di Ugo Spirito ossia la nazionalizzazione dei mezzi di produzione attraverso le corporazioni in una sorta di corporativismo comunista basato sull’“azionariato dei produttori”), stavano scalando le gerarchie fino al vertice. Si trattava, come ha spiegato Renzo De Felice, di quel “secondo fascismo” sempre più emergente, in quegli anni, nelle riviste e nelle organizzazioni giovanili del regime. Questo neofascismo prebellico si richiamava idealmente alle origini diciannoviste ossia socialiste del movimento fascista. Togliatti aveva ben colto queste spinte interne al regime favorite dalla svolta dirigista decisa per fronteggiare gli effetti della crisi del 1929 (istituzione dell’Iri, promulgazione della Legge Bancaria del 1936 con la nazionalizzazione della Banca centrale, rafforzamento degli strumenti di previdenza sociale ad iniziare dall’Inps, rivitalizzazione dei sindacati). Per gli stessi motivi per i quali prima della guerra aveva cercato di immettere elementi comunisti nel fascismo di sinistra, nel 1946 Togliatti, come ebbe a dichiarare in un’altra intervista manifestando toni di stima ed intenti pacificatori verso i “giovani idealisti” che avevano scelto di aderire a Salò, appoggiò l’amnistia onde cercare di attrarre i fascisti di sinistra nel Pci (vi riuscì solo in parte perché un’altra parte degli eredi dell’esperienza della Repubblica Sociale fondarono il Msi, che inizialmente non era affatto “destra nazionale” e lo diventò soltanto con la svolta moderata degli anni ’50). Insomma, Togliatti, tra il 1936 ed il 1946, riconobbe che Mussolini lo aveva preceduto, già dal 1914-1919, sulla strada della nazionalizzazione del socialismo, intuendo che socialismo e patriottismo non sono opposti ma piuttosto sinonimi. Non a caso, nel dopoguerra Togliatti additò la “via nazionale al socialismo” quale orientamento ideale e storico del suo Pci.
questo socialismo patriottico in diverse esperienze politiche come quelle dei Paesi in via di industrializzazione, ad esempio l’Argentina peronista o l’Egitto nasseriano (strettamente imparentati ai fascismi europei), ma anche di Paesi ad industrializzazione avanzata, come la Francia gollista, fino a Paesi dichiaratamente socialisti quali la Cuba di Fidel Castro e Che Guevara che del “Patria o muerte” hanno fatto la propria insegna antimperialista ed antiamericana (una scelta che non può comprendersi in pieno obliterando, come sovente si fa, le origini falangiste “joseantoniane” di Castro e quelle peroniste di Guevara, per le quali rinviamo al nostro contributo rintracciabile qui https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-224-2/). Non solo, perché il patriottismo fu rivendicato anche da Palmiro Togliatti, in un articolo significativamente titolato “Il patriottismo dei comunisti” uscito su “Rinascita” nel luglio-agosto 1945, ossia a guerra civile ancora latente, nel quale il segretario del Pci scrisse: «È ridicolo pensare che la classe operaia possa staccarsi, scindersi dalla nazione. La classe operaia moderna è il nerbo delle nazioni. I comunisti, che sono il partito della classe operaia, non possono dunque staccarsi dalla loro nazione se non vogliono troncare le loro radici vitali. Il cosmopolitismo è una ideologia del tutto estranea alla classe operaia. Esso è invece l’ideologia caratteristica degli uomini della banca internazionale». Nello scrivere tali parole Togliatti, memore della lezione del fascismo che tentò di unire classe e nazione ossia socialismo e patriottismo, richiamava implicitamente il suo “Appello ai fratelli in camicia nera”, da lui firmato e pubblicato nel 1936 sulla rivista parigina “Lo Stato Operaio”, nel quale, all’interno di una strategia entrista nel momento del massimo consenso popolare al regime, invocava la “santa alleanza per la comune battaglia per il pane ed il lavoro” tra comunisti e fascisti di sinistra. Togliatti, nonostante fosse in esilio, aveva osservato che, dopo la delusione seguente ai compromessi nel decennio precedente tra il regime e i fiancheggiatori di destra, i fascisti di sinistra, ossia i veri fascisti, negli anni Trenta, con l’avvallo ufficioso dello stesso Mussolini (il quale giunse persino a sostenere la tesi della “corporazione proprietaria” di Ugo Spirito ossia la nazionalizzazione dei mezzi di produzione attraverso le corporazioni in una sorta di corporativismo comunista basato sull’“azionariato dei produttori”), stavano scalando le gerarchie fino al vertice. Si trattava, come ha spiegato Renzo De Felice, di quel “secondo fascismo” sempre più emergente, in quegli anni, nelle riviste e nelle organizzazioni giovanili del regime. Questo neofascismo prebellico si richiamava idealmente alle origini diciannoviste ossia socialiste del movimento fascista. Togliatti aveva ben colto queste spinte interne al regime favorite dalla svolta dirigista decisa per fronteggiare gli effetti della crisi del 1929 (istituzione dell’Iri, promulgazione della Legge Bancaria del 1936 con la nazionalizzazione della Banca centrale, rafforzamento degli strumenti di previdenza sociale ad iniziare dall’Inps, rivitalizzazione dei sindacati). Per gli stessi motivi per i quali prima della guerra aveva cercato di immettere elementi comunisti nel fascismo di sinistra, nel 1946 Togliatti, come ebbe a dichiarare in un’altra intervista manifestando toni di stima ed intenti pacificatori verso i “giovani idealisti” che avevano scelto di aderire a Salò, appoggiò l’amnistia onde cercare di attrarre i fascisti di sinistra nel Pci (vi riuscì solo in parte perché un’altra parte degli eredi dell’esperienza della Repubblica Sociale fondarono il Msi, che inizialmente non era affatto “destra nazionale” e lo diventò soltanto con la svolta moderata degli anni ’50). Insomma, Togliatti, tra il 1936 ed il 1946, riconobbe che Mussolini lo aveva preceduto, già dal 1914-1919, sulla strada della nazionalizzazione del socialismo, intuendo che socialismo e patriottismo non sono opposti ma piuttosto sinonimi. Non a caso, nel dopoguerra Togliatti additò la “via nazionale al socialismo” quale orientamento ideale e storico del suo Pci.
 Diventa necessario prendere, o meglio riprendere, consapevolezza che il senso di comunità è connaturato all’uomo. Già Aristotele aveva compreso che l’uomo ha una natura sociale. Tommaso d’Aquino e l’intero medioevo hanno ribadito l’assunto in chiave cristiana. Ma tale veritativa evidenza, che non ha bisogno di dimostrazione come non ne ha bisogno il sole splendente in cielo, è presente in tutte le culture umane, ad ogni latitudine ed in ogni epoca storica. Soltanto nell’Occidente moderno, a partire dal XV-XVI secolo e poi con forza sempre maggiore dal XVIII fino al XXI secolo (motus in fine velocior), il solipsismo individualista, man mano che si imponeva la secolarizzazione, ha scalzato ogni solidarietà comunitaria sostituendo l’organicismo con il contrattualismo sociale. Questo rilievo storico ed antropologico, ancor prima che filosofico e teologico, diventa oggi un potente spartiacque tra nuove categorie politiche che attraversano quelle, ormai obsolete, di “destra” e “sinistra” come le abbiamo fin qui conosciute. Si tratta, pertanto, di comprenderlo sia a destra che a sinistra perché la auspicabile formazione di nuovi schieramenti potrebbe riservare sorprese, neanche tanto inedite (perché soluzioni già tentate nel corso del XX secolo), e riorientare il dibattito politico in modo che apparenti “nemici” di ieri possano scoprirsi insospettabili “amici” di oggi.
Diventa necessario prendere, o meglio riprendere, consapevolezza che il senso di comunità è connaturato all’uomo. Già Aristotele aveva compreso che l’uomo ha una natura sociale. Tommaso d’Aquino e l’intero medioevo hanno ribadito l’assunto in chiave cristiana. Ma tale veritativa evidenza, che non ha bisogno di dimostrazione come non ne ha bisogno il sole splendente in cielo, è presente in tutte le culture umane, ad ogni latitudine ed in ogni epoca storica. Soltanto nell’Occidente moderno, a partire dal XV-XVI secolo e poi con forza sempre maggiore dal XVIII fino al XXI secolo (motus in fine velocior), il solipsismo individualista, man mano che si imponeva la secolarizzazione, ha scalzato ogni solidarietà comunitaria sostituendo l’organicismo con il contrattualismo sociale. Questo rilievo storico ed antropologico, ancor prima che filosofico e teologico, diventa oggi un potente spartiacque tra nuove categorie politiche che attraversano quelle, ormai obsolete, di “destra” e “sinistra” come le abbiamo fin qui conosciute. Si tratta, pertanto, di comprenderlo sia a destra che a sinistra perché la auspicabile formazione di nuovi schieramenti potrebbe riservare sorprese, neanche tanto inedite (perché soluzioni già tentate nel corso del XX secolo), e riorientare il dibattito politico in modo che apparenti “nemici” di ieri possano scoprirsi insospettabili “amici” di oggi. umana viva e proprio per questo non priva di conflittualità interne pur restando in ultimo una unità essenzialmente inscindibile nonostante ogni tensione o lotta tra i suoi membri. Perché laddove i suoi membri non si riconoscessero più membra del medesimo corpo, parti della stessa comunità organica, verrebbe meno l’unità politica e con essa ogni possibilità di solidarietà umana sul piano orizzontale della natura (l’unità verticale nello Spirito, infatti, resta una possibilità che si dà sempre ai singoli anche nelle società sconsacrate). Le forme storiche mutano ma i principi tradizionali che rendono salda una comunità restano sempre gli stessi, rendendo palese la verità del conservatorismo inteso come conservazione dell’essenza principiale, di per sé imperitura, e non delle forme storicamente superate. In tal modo la Tradizione diventa l’unico vero “progetto per il futuro”. Un progetto che si pone oltre la destra e la sinistra proprio perché su di esso possono convergere e reciprocamente intendersi conservatori (non liberali) e socialisti (non marxisti), purché gli uni comprendano che la conservazione delle identità e della cultura nonché dei principi spirituali non significa affatto anche conservazione di una iniqua distribuzione della ricchezza comune e purché gli altri comprendano che senza quel mondo di relazioni e solidarietà che discendono esclusivamente dal comune sentire identitario nessuna redistribuzione della ricchezza avrà mai un solido, duraturo e stabile fondamento. Chi difende le identità tradizionali dei popoli non può farlo come paravento di assetti sociali che, per dirla con il catechismo di san Pio X, “gridano vendetta al cospetto di Dio”. Ma chi lotta per la giustizia sociale non può farlo nella negazione delle identità tradizionali dei popoli che della giustizia sociale sono la migliore garanzia.
umana viva e proprio per questo non priva di conflittualità interne pur restando in ultimo una unità essenzialmente inscindibile nonostante ogni tensione o lotta tra i suoi membri. Perché laddove i suoi membri non si riconoscessero più membra del medesimo corpo, parti della stessa comunità organica, verrebbe meno l’unità politica e con essa ogni possibilità di solidarietà umana sul piano orizzontale della natura (l’unità verticale nello Spirito, infatti, resta una possibilità che si dà sempre ai singoli anche nelle società sconsacrate). Le forme storiche mutano ma i principi tradizionali che rendono salda una comunità restano sempre gli stessi, rendendo palese la verità del conservatorismo inteso come conservazione dell’essenza principiale, di per sé imperitura, e non delle forme storicamente superate. In tal modo la Tradizione diventa l’unico vero “progetto per il futuro”. Un progetto che si pone oltre la destra e la sinistra proprio perché su di esso possono convergere e reciprocamente intendersi conservatori (non liberali) e socialisti (non marxisti), purché gli uni comprendano che la conservazione delle identità e della cultura nonché dei principi spirituali non significa affatto anche conservazione di una iniqua distribuzione della ricchezza comune e purché gli altri comprendano che senza quel mondo di relazioni e solidarietà che discendono esclusivamente dal comune sentire identitario nessuna redistribuzione della ricchezza avrà mai un solido, duraturo e stabile fondamento. Chi difende le identità tradizionali dei popoli non può farlo come paravento di assetti sociali che, per dirla con il catechismo di san Pio X, “gridano vendetta al cospetto di Dio”. Ma chi lotta per la giustizia sociale non può farlo nella negazione delle identità tradizionali dei popoli che della giustizia sociale sono la migliore garanzia. loro valore immanenti. La disuguaglianza crescente mina la fiducia, la coesione e l’empatia, dal momento che gli uomini che vivono in mondi completamente diversi e non incontrano più gli altri strati sociali si sentono sempre meno parte di una medesima comunità ed unità di destino. Già al suo esordio il capitalismo comportò la frammentazione delle comunità, la distruzione dei beni comuni e lo sradicamento degli uomini, che vennero strappati ai propri legami consueti e al ritmo di vita tradizionale e consegnati ai mercati e alle macchine, ai cui ritmi si dovettero da quel momento sottomettere. In effetti la critica di Karl Marx per il quale il capitalismo riduce la “dignità personale (ad) un semplice valore di scambio” lasciando “tra uomo e uomo (nessun) altro vincolo che il nudo interesse”, ovvero “lo spietato pagamenti in contanti”, non è soltanto la descrizione della realtà sociale del suo tempo quanto, invece, una linea di sviluppo che si è fatta palese soprattutto nel capitalismo globalizzato e finanziario del nostro secolo. Ma – ecco il punto – una economia che distrugge le tradizioni, i valori ed i vincoli di comunità, distrugge il collante che tiene insieme la società ed alla lunga diventa umanamente insostenibile. Senza una certa dose di vincoli e valori comunitari viene meno la stessa “res publica”, ossia la cosa pubblica “comune”. Senza il sentimento di appartenenza comunitaria nessuna democrazia riesce a sopravvivere. Lo sapevano già Platone e Aristotile. In un ordinamento liberale si perde di vista il nucleo fondamentale del vivere umano ossia la codecisione delle scelte strategiche della comunità e di conseguenza i gruppi di interesse più influenti finiscono per dominare sulla politica.
loro valore immanenti. La disuguaglianza crescente mina la fiducia, la coesione e l’empatia, dal momento che gli uomini che vivono in mondi completamente diversi e non incontrano più gli altri strati sociali si sentono sempre meno parte di una medesima comunità ed unità di destino. Già al suo esordio il capitalismo comportò la frammentazione delle comunità, la distruzione dei beni comuni e lo sradicamento degli uomini, che vennero strappati ai propri legami consueti e al ritmo di vita tradizionale e consegnati ai mercati e alle macchine, ai cui ritmi si dovettero da quel momento sottomettere. In effetti la critica di Karl Marx per il quale il capitalismo riduce la “dignità personale (ad) un semplice valore di scambio” lasciando “tra uomo e uomo (nessun) altro vincolo che il nudo interesse”, ovvero “lo spietato pagamenti in contanti”, non è soltanto la descrizione della realtà sociale del suo tempo quanto, invece, una linea di sviluppo che si è fatta palese soprattutto nel capitalismo globalizzato e finanziario del nostro secolo. Ma – ecco il punto – una economia che distrugge le tradizioni, i valori ed i vincoli di comunità, distrugge il collante che tiene insieme la società ed alla lunga diventa umanamente insostenibile. Senza una certa dose di vincoli e valori comunitari viene meno la stessa “res publica”, ossia la cosa pubblica “comune”. Senza il sentimento di appartenenza comunitaria nessuna democrazia riesce a sopravvivere. Lo sapevano già Platone e Aristotile. In un ordinamento liberale si perde di vista il nucleo fondamentale del vivere umano ossia la codecisione delle scelte strategiche della comunità e di conseguenza i gruppi di interesse più influenti finiscono per dominare sulla politica. secondo le possibilità di ciascuno, per sovvenzionare le attività pubbliche e sostenere i membri della società che si trovavano in una situazione meno favorevole. Le origini di questo progetto, come riconosce la stessa Wagenknecht, devono essere cercate innanzitutto nella Dottrina Sociale Cattolica ancor prima che nella socialdemocrazia. Ma anche, aggiungiamo noi, nella cultura della “Destra Sociale” che a partire dalla critica reazionaria all’individualismo rivoluzionario ha attraversato l’ottocento per incontrarsi con la “Sinistra Nazionale”, di derivazione risorgimentale mazziniana e sindacalista rivoluzionaria, nell’esperienza dei fascismi tra le due guerre. Persino la scuola economica vigente nella Germania postbellica, ossia l’ordoliberalismo, aveva posto alla base del suo ideale di economia sociale di mercato argomentazioni analoghe, benché più “liquide”, a quelle dell’organicismo di matrice cattolica o socialdemocratica. Fino al sopraggiungere della globalizzazione il senso di appartenenza, la solidarietà, la responsabilità condivisa nei confronti della comunità di appartenenza sono stati valori riconosciuti in gran parte delle nazioni europee, sicché porsi contro di essi equivaleva ad una posizione di immoralità sociale.
secondo le possibilità di ciascuno, per sovvenzionare le attività pubbliche e sostenere i membri della società che si trovavano in una situazione meno favorevole. Le origini di questo progetto, come riconosce la stessa Wagenknecht, devono essere cercate innanzitutto nella Dottrina Sociale Cattolica ancor prima che nella socialdemocrazia. Ma anche, aggiungiamo noi, nella cultura della “Destra Sociale” che a partire dalla critica reazionaria all’individualismo rivoluzionario ha attraversato l’ottocento per incontrarsi con la “Sinistra Nazionale”, di derivazione risorgimentale mazziniana e sindacalista rivoluzionaria, nell’esperienza dei fascismi tra le due guerre. Persino la scuola economica vigente nella Germania postbellica, ossia l’ordoliberalismo, aveva posto alla base del suo ideale di economia sociale di mercato argomentazioni analoghe, benché più “liquide”, a quelle dell’organicismo di matrice cattolica o socialdemocratica. Fino al sopraggiungere della globalizzazione il senso di appartenenza, la solidarietà, la responsabilità condivisa nei confronti della comunità di appartenenza sono stati valori riconosciuti in gran parte delle nazioni europee, sicché porsi contro di essi equivaleva ad una posizione di immoralità sociale.