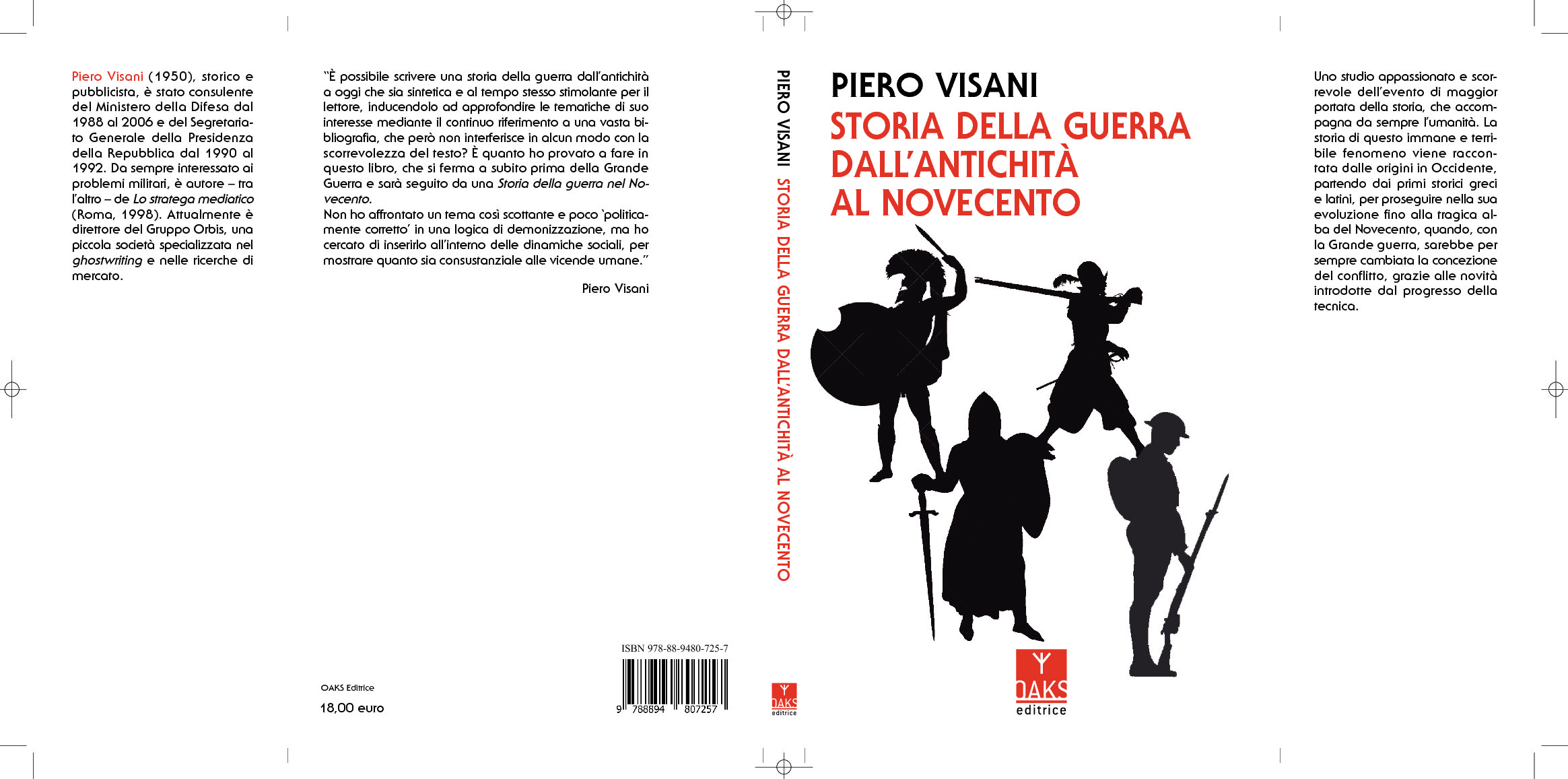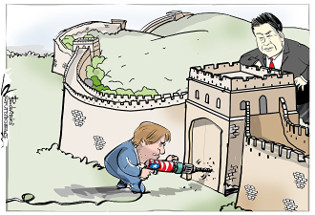meglio Callicle, di Teodoro Klitsche de la Grange

Seguendo le sollecitazioni di alcuni lettori si ripropone qui sotto un saggio di Teodoro Klitsche de La Grange già apparso sul sito ma con una veste grafica poco adatta alla lettura_ Giuseppe Germinario
MEGLIO CALLICLE
C’è molto da meditare, ancora oggi, in particolare per chi si occupi di studi politici e giuridici, sull’alternativa, nel Gorgia, tra le contrapposte tesi di Socrate e Callicle. Com’è noto, Socrate – il quale inizia, sul punto, a discutere con Polo – sostiene che è moralmente preferibile subire un torto piuttosto di farlo. Callicle (e Polo) al contrario, ritengono che subirlo non sia degno di un uomo libero. A ben vedere le opposte soluzioni conseguono dai diversi presupposti (e contesti) da cui partono i contraddittori, in certo modo confusi dall’abilità dialettica di Socrate. Infatti questi, procedendo da un’impostazione morale, considera l’azione in se, avulsa dalle conseguenze che dalla stessa possono derivare, e dal contesto in cui si producono gli effetti. Trattandosi però di violazioni anche di nomoi il campo in cui va a incidere il giudizio etico di Socrate non è quello, individuale, della coscienza, ma l’assetto giuridico e politico della comunità. In sostanza traspone le norme etiche in un contesto ad esse non proprio. Callicle – che pure contrappone natura e legge, o meglio leggi di natura e leggi positive – si tiene fermo al campo politico (e giuridico). La sua tesi è che non “da vero uomo, ma da schiavo, è subire ingiustizie senza essere capaci di ricambiare, e meglio è morire che vivere se, maltrattati ed offesi, non si è capaci di aiutare se stessi e chi ci sta a cuore” (1). E ciò per legge di natura “la stessa natura chiaramente rileva esser giusto che il migliore prevalga sul peggiore, il più capace sul meno capace. Che davvero sia così, che tale sia il criterio del giusto, che il più forte comandi e prevalga sul più debole, ovunque la natura lo mostra, tra gli animali e tra gli uomini, nei complessi cittadini e nelle famiglie” (2). Callicle cioè si attiene, nelle sue argomentazioni, alla “realtà effettuale”, al contrario di Socrate: le argomentazioni del primo derivano dalla descrizione e valutazione dei fatti (dall’essere); quelle del secondo sono prescrittive, partono dal dover essere. Peraltro Callicle, come notato (3), non trascura mai le “costanti” della politica: in particolare la relazione di comando e obbedienza, col corollario della classe politica, ovvero dei meno che governano sui più che sono governati. Socrate invece prescinde dal rapporto politico, al punto che gli esempi addotti a conforto delle sue tesi sono tutti estranei a questo. E Callicle lo nota, osservando “tu non hai in bocca che calzolai, cardatori, cuochi, medici; come se il nostro discorso avesse per argomento tale gente!” E chiarisce: “In primo luogo quando parlo dei più forti, non intendo calzolai o cuochi, ma quelle persone la cui intelligenza è volta agli affari dello Stato, che sanno come si debba amministrare la cosa pubblica, e che sono non intelligenti solamente, ma anche uomini di coraggio, capaci di portare a termine quello che pensano e che non indietreggiano nel loro compito per debolezza d’animo” (4). In definitiva (sintetizzando) per Callicle il problema va risolto tenendo conto dell’essenza del potere (politico): che non può sopportare ingiustizie (almeno non le può subire spesso), pena il suo stesso venir meno come garante e produttore dell’ordine. Invece Socrate conclude sostenendo che compito del politico è di fare degli ottimi cittadini: cioè, sostanzialmente, di occuparsi del loro perfezionamento civico e morale (5). Per analizzare la posizione di Callicle, più interessante sul piano della “realtà effettuale” occorre non solo esaminarla nel contesto proprio, ma ponendosi in angoli visuali diversi: cioè a seconda che la massima si indirizzi ai governanti o ai governati, e se il campo ne sia, specificamente, la politica o il diritto. 2. Che la posizione di Socrate fosse, dì fatto, incongrua a reggere e conservare la comunità e quella di Callicle sia stata – anche se in parte – ritenuta valida a tale fine, risulta dalle riflessioni dell’etica cristiana. Secondo la quale commettere torto è assai peggio che subirlo – anzi subirlo significa guadagnarsi un posto in Paradiso; tuttavia i teologi hanno temperato tale (nobile) posizione etica discriminando tra il dovere del cristiano (governato) e quello dell’uomo di governo cristiano. Lutero, in particolare, ha scritto pagine illuminanti, distinguendo tra la tutela del proprio interesse e di quello degli altri. Quand’è leso il proprio interesse I fedele deve subire dei torti: per quello degli altri è. parimenti, dovere del cristiano non permettere che torti si commettano e, comunque, che questi debbano essere sanzionati. Scrive Lutero “Se tu non hai bisogno che il tuo nemico sia punito, il tuo vicino che è debole, ne ha necessità e devi venirgli in aiuto perché abbia la pace e il suo nemico sia represso. E ciò non può verificarsi se potere e autorità non sono onorati e rispettati. Cristo non dice “Non devi servire l’autorità né essere sottomesso ma Non devi resistere al male” (6). Da cui consegue che “facendolo ti porrai interamente a disposizione di una funzione e di un’attività al servizio del prossimo, che non sono utili a te, né al tuo bene o al tuo onore, ma servono solo agli altri, e, espletandola non con l’idea di vendicarti o restituire male al male, ma per il bene del prossimo e per assicurare la difesa e la pace degli altri” (7) e prosegue “quando si tratta del prossimo e del di esso interesse, agisci secondo amore cristiano e non tollerare che gli sia fatta alcuna ingiustizia” (8). In particolare all’autorità compete di mantenere l’ordine e il diritto, perché istituita da Dio in vista di tale fine. “Se il potere e la spada sono un servizio divino, come ho provato sopra, tutto ciò che è necessario al potere per impiegare la forza, dev’essere anch’esso un servizio divino. Occorre che ci sia qualcuno per catturare i delinquenti, accusarli, punirli e metterli a morte, e per proteggere, discolpare, difendere e salvare gli uomini virtuosi”(9). Poco dissimile è la concezione di Calvino. Questi ritiene i magistrati “vicari di Dio”, “servitori della giustizia”; rifiutando la posizione degli anabattisti, ritiene che il loro ruolo è necessario e niente affatto contrario alla vocazione del critiano ed alla religione cristiana. Riguardo alla pena di morte, scrive: “Il est vrai que la Loi de Dieu défend d’occire; au contraire aussi, afin que les homicides ne demeurent impunis, le souverain Législateur met le glaive en la main de ses ministres, pour en user contre les homicides. Certes, il n’appartient pas aux fidèles d’affliger ni faire nuisance; mais aussi ce n’est pas faire nuisance, ni affliger, que de venger par le commandement de Dieu les afflictions des bons” per cui “C’est pourquoi, si les princes et autres supérieurs connaisent qu’il n’y a rien de plus agréable à Dieu que leur obéissance, s’ils veulent plaire à Dieu en piété, justice et intégrité, qu’ils s’emploient à la correction et punition des pervers” (10). Ne consegue che la massima morale valida per il cristiano, di porgere l’altra guancia, non vale per il governante, anche cristiano, il quale operando per l’interesse dei governati non deve subire né, soprattutto, tollerare che i governati subiscano torti. Sosteneva Troeltsch che da tale concezione protestante deriva l’alto senso del dovere che ha ispirato la burocrazia professionale tedesca (11); è sicuro comunque che, determina anche sul piano etico una netta distinzione, secondo la funzione, nei doveri e nel comportamento del cristiano. A conclusioni non molto diverse si arriva leggendo i teologi della controriforma. Scriveva S. Roberto Bellarmino, polemizzando in particolare con gli anabattisti, che le leggi “non servirebbero a nulla, se non ci dovesse essere alcuna sentenza; ma come si è già provato, non si devono togliere le leggi: dunque nemmeno le sentenze” (12). Quindi esercitare la giustizia e rivolgersi al giudice per la riparazione del torto è lecito, anzi in certi casi doveroso, perchè concorre a reprimere chi potrebbe commettere altre ingiustizie; e quanto all’autorità temporale, ed alla pena di morte è “compito di un buon principe, al quale è affidata la protezione del bene comune, impedire che le parti corrompano il tutto, per il quale esistono; di conseguenza se non può conservare integre tutte le parti, deve piuttosto recidere una parte che lasciar perire il bene comune; come i contadini recidono i rami e i tralci che danneggiano la vite o l’albero, e il medico amputa le membra, che potrebbero corrompere il corpo” (13). Passando al diritto internazionale, ed alla liceità della guerra – nel caso di risposta alle offese – Francisco Suarez afferma ” bellum defensivum non solum est licitum, sed interdum etiam praeceptum” e ciò per difendere l’esistenza e le ragioni della comunità; ma anche la stessa guerra offensiva può essere giusta e la ragione è” quia tale bellum saepe est reipublicae necessarium ad propulsandas iniurias et coercendos hostes, neque aliter possunt respublicae in pace conservari: Est ergo hoc iure naturae licitum, atque adeo etiam lege evangelica, quae in nulla re derogat iuri naturali, neque habet nova praecepta divina, praeterquam fidei et sacramentorum: Quod enim non vult haec mala, sed permittit, unde non prohibet quin iuste possint propulsari (14). Nel caso che il principe sia trascurato “in vindicanda et defendenda republica” allora può” tota respublica se vindicare, et privare ea auctoritate principem quia semper censetur apud se retinere eam potestatem, si princeps officio suo desit” (15) E tra le giuste ragioni di guerra di un principe cristiano, vi sono le riparazioni di un torto o la difesa degli innocenti (16). Pur sostenendo concezioni, su altre questioni, opposte, sul punto del dovere dell’autorità temporale di proteggere i sudditi, e sulla legittimità della relativa funzione, teologi cattolici e protestanti concordano, con poche sfumature di differenza. Come tutti condannano gli anabattisti, per il loro divieto al cristiano di assumere funzioni pubbliche. La distinzione quindi tra morale “pubblica” e “privata” (e relative “sfere”) è saldamente stabilita. Quel che è vietato al privato è concesso – anzi è dovere – dell’uomo pubblico. Ciò conferma il rapporto dell’etica cristiana con l’ordine: il bene morale è in riferimento all’ordine dell’esistenza e della vita, cui deve conformarsi il comportamento del credente. Ordine che non può sussistere (e durare) senza distinzioni di ruoli, di funzioni, e quindi di comportamenti: la distinzione tra chi comanda e chi obbedisce, tra funzione pubblica e attività privata, tra azioni vietate, premesse o comandate a seconda del ruolo sociale dell’autore, ed in funzione della conservazione della comunità, come essere ordinato. 3.0 Jhering, nel “Kampf um’s recht”, rivoluziona tale impostazione, rendendola più vicina, anche se in un ambito parzialmente diverso, a quella di Callicle. Cioè rende di nuovo universale – rivolto a tutti, governanti e governati – l’imperativo di non subire il torto, anzi ne fa il (principale) fatto fondante l’ordinamento comunitario. Il giurista tedesco prende le mosse dal concetto del Diritto che è un “concetto pratico, cioè dire, un concetto non puramente speculativo, ma tendente ad uno scopo. Se non che ogni concetto di tal natura è per propria essenza dualistico. Nel seno suo accoglie l’opposizione del fine e del mezzo. Parlare semplicemente del fine non basta: occorre indicare al tempo stesso anche il mezzo per giungere al fine” e continua “il mezzo, per vario e multiforme che possa essere all’apparenza, in sostanza riducesi sempre alla lotta contro l’ingiustizia. Il concetto del Diritto inchiude in sé le opposizioni della lotta e della pace: questa come termine finale; quella come mezzo del diritto. Le due cose sono date ugualmente nel concetto del Diritto e dallo stesso inseparabili” (17). Né si può opporre che la lotta, il conflitto sia proprio ciò che il diritto mira ad impedire perché “l’obiezione sarebbe giusta, ove si trattasse della lotta dell’iniquità contro il Diritto. Ma il fatto è che qui si tratta dell’opposto, della lotta del Diritto contro l’ingiustizia. Tolta simile lotta, tolta cioè la resistenza contro la violazione, il Diritto sarebbe ridotto ad una negazione intrinseca di sé. Sino a che il Diritto dev’esser considerato dal lato delle ingiuste aggressioni, che può subire – e ciò accadrà sino a che durerà il mondo
– il Diritto non può esimersi dal lottare. Per la qual cosa la lotta non è un che di straniero al
Diritto. Essa è invece intimamente legata con l’essenza sua: è, in una parola, un momento del suo concetto” (18). Da ciò, prosegue Jhering, deriva che l’essenza del diritto è attuazione pratica: “Una regola giuridica, che giammai non fu attuabile, ha perduto la capacità di esserlo, non può pretendere a cotal nome. Essa è una molla inetta, che non collabora nel meccanismo del Diritto, e che può esser tolta via, senza che alcuna alterazione ne segua”. Questo principio s’applica senza limitazione di sorta a tutte le parti del Diritto. Ma mentre l’attuazione del diritto pubblico e penale è “assicurata perché imposta come dovere ai rappresentanti del potere politico; quella invece del diritto privato prende la forma di un diritto delle persone, vale a dire, abbandonato completamente alla loro propria iniziativa, alla spontanea attività loro. Nel primo caso l’attuazione del Diritto dipende da ciò, che le autorità e gli ufficiali dello Stato compiono il dover loro; nel secondo invece da ciò, che le persone private faccian valere il loro diritto” (19). Ma se queste non se ne curano, non lottano cioè per realizzare il loro diritto “la regola giuridica rimane allora impotente. Onde può dirsi: la realtà, la forza pratica delle massime del diritto privato apparisce e s’afferma, allorché i diritti concreti vengon fatti valere. E così, mentre questi ricevon da un lato la vita loro dalla legge, fanno d’altro lato la vita della legge. La relazione del diritto obiettivo o astratto co’ diritti subbiettivi o concreti è pari alla circolazione del sangue, che parte dal cuore, ma al cuore fa ritorno” (20). A chi sostiene che, tutto sommato, a soffrire le conseguenze di un’azione nel tutelare il proprio diritto, è “l’investito del diritto”, Jhering controbatte che “Quando l’arbitrio e la licenza s’attestano temerarii ed audaci di levare il capo, è segno sicuro che quei che eran chiamati a difendere la legge hanno negletto il dover loro” (21). E nel diritto privato ciascuno è, “in obbligo di difendere la legge; ciascuno, entro la sua propria sfera, n’è custode ed esecutore”; per cui
“Affermando il diritto suo, nella sfera ristretta, che questo occupa, egli nulladimeno afferma e mantiene il Diritto. Epperò l’interesse e le conseguenze della sua maniera di agire trascendono di molto la persona sua” (22). L’interesse generale, ricollegato al comportamento attivo, non è quello, puramente ideale, della maestà della legge; ma quello reale e pratico, “che lo stabile ordinamento della vita socievole sia assicurato e conservato saldo ed integro” (23). Quando il diritto diventa punto o poco applicato, per indifferenza o pigrizia “La responsabilità di simili condizioni non ricade sulla parte del popolo, che trasgredisce la legge; ma su quella, che non ha il coraggio di farla rimanere inviolata e rispettata. Non bisogna lamentarsi dell’ingiustizia, che tenta usurpare il posto del Diritto; ma bensì del Diritto, che se n’acqueta e contenta. E fra le due massime: non fare alcun torto, e: non soffrire alcun torto, se dovessi scegliere per dare a ciascuna il grado che le spetta secondo la sua importanza pratica, direi, che quella di non sopportare alcun torto è la prima; e l’altra di non farne, la seconda” (24). In ciò Croce ravvedeva non solo un’inoppugnabile ragione pratica, di conservazione dell’ordinata vita sociale, ma anche l’espressione di un “alto concetto” e di un “sentimento morale”. Quello cioè di difendere il proprio diritto anche con sacrificio degli interessi individuali (25). In realtà è chiaro che, come sostenuto da Jhering, una società non può reggersi se il diritto viene totalmente, o largamente disapplicato. Il diritto non è una collezione di “grida” di manzoniana memoria (o, diremmo oggi, di norme – manifesto) ma vive della sua applicazione, di cui è strumento essenziale, anche se non esclusivo, la volontà e la determinazione individuale. Ciò è connaturale all’approccio problematico ed alla cultura del giurista, dato che in alcuni ordinamenti è prescritta addirittura l’abrogazione per desuetudine. Ma anche laddove questa non è prevista, un diritto poco o punto applicato è un diritto inesistente, che ha smarrito la funzione essenziale di formalizzazione dell’ordine e garanzia del medesimo. Di fronte al quale, non può non concordarsi con il giudizio di Jhering. 4.0 Diversa – almeno in parte – appare la questione ad affrontarla sotto l’angolo visuale, che è propriamente quello di Callicle, cioè della politica. Qui il problema consiste nel vedere come l’alternativa si presenta in un campo di rapporti specificamente politici. In primo luogo cioè, come si configuri in un ambito in cui il potere è fattore essenziale, ed è assicurato dal rapporto tra comando e obbedienza; la cui funzione precipua non è tanto la tutela d’interessi individuali, ma dell’esistenza collettiva. Ne consegue che se la teoria di Jhering vale per un individuo, che opera per interessi personali e fa scelte le cui conseguenze ricadono in primo luogo su di se, e solo di riflesso su tutti; qui, di converso, abbiamo decisioni che coinvolgono, immediatamente e direttamente, gli interessi di tutti. Per cui, spesso, subire un torto, per odioso che sia è preferibile a lottare per il proprio diritto, perché il costo della scelta sarebbe insopportabile. Il che è particolarmente chiaro e manifesto nei rapporti internazionali, dove abbiamo visto interi stati cessare d’esistere senza combattere (come gli Stati baltici e la Cecoslovacchia nel 1939), perché la lotta si manifestava impari, anzi
disperata, e molto costosa, sul piano umano prima che economico. E’ possibile tacciare quei governanti d’ “immoralità” o meglio di codardia, sotto il profilo considerato? O non piuttosto, avendo quelli la responsabilità di milioni di uomini, hanno applicato la regola machiavellica, di trarre “miglior partito dal meno malo”, salvando la vita dei concittadini, al prezzo dell’esistenza collettiva? In altri termini ciò che (anche) rende peculiare il problema politico (rispetto alla realtà morale o “giuridica”) è che in politica l’etica è sempre, in misura prevalente, un’etica della responsabilità: bisogna considerare come ogni scelta ricada sugli interessi di milioni di persone. Il che non succede, come chiarito, negli altri casi. Fatta tale premessa, e ponendoci nella prospettiva del governante, occorre distinguere tra due ipotesi: subire un torto o farlo subire. E’ chiaro come, a tale proposito, occorre appena considerare che il torto sia sofferto sul piano personale. Questo sarebbe irrilevante; tuttavia trattandosi di persone pubbliche, fatti del genere provocano una diminuzione di autorità (di “credibilità” si potrebbe dire), con le conseguenze relative; pertanto da evitare, per quanto possibile. Quando però a subire un’ingiustizia è la comunità o l’istituzione o il gruppo “rappresentato” la regola d’azione non può che essere quella di Callicle; anche se occorre tener conto, come sopra scritto, delle conseguenze e del costo della reazione. Questo, in primo luogo, perchè primaria funzione del potere politico è proteggere la comunità e i membri di questa da ogni offesa esterna ed interna. Se la comunità, nel suo insieme, subisce un’ingiustizia, è chiaro che ciò incrina l’efficacia della protezione, ovvero la principale “obbligazione” dei governanti. Il giudizio, tante volte ripetuto, che gli Stati stanno tra loro in perenne stato di natura, implica anche questo: che, in linea di principio, non può subirsi il torto. Tant’è che il diritto internazionale conosce l’istituto della rappresaglia, la quale è, per l’appunto, una reazione (o rimedio) lecito per la riparazione dell’illecito patito. Ma, tornando a ragionare sul piano puramente politico, si arriva a conclusioni uguali. La funzione del potere è, infatti, attraverso il monopolio della violenza legittima (nello Stato moderno), di stabilire e garantire l’ordine. Come scriveva Hauriou “ogni potere che voglia durare è obbligato a creare un ordine delle cose e un diritto positivo” (26). La relazione tra questo, l’ordine e il diritto è quindi una costante necessaria dell’esistenza collettiva. Ma il potere può essere tale solo se, concretamente, comanda e viene obbedito. Il dualismo tra potere di fatto e di diritto, nelle situazioni storiche, è destinato a durare poco; perchè, in periodi più lunghi, o il potere di fatto diviene potere di diritto – alla fin fine, perchè obbedito o quello di diritto torna ad esserlo anche di fatto, per la stessa ragione. Ogni situazione di conflitto tra poteri in una comunità, si risolve in tal modo; e il criterio della prevalenza è dato dalla capacità di farsi obbedire, cioè di (creare e) garantire l’ordine. Ad affrontare poi la questione sotto il profilo se il potere politico possa tollerare di far subire ingiustizie ai membri della comunità, la conclusione è ancora più semplice. Questo perchè è quasi nullo il rischio che un torto subito da un privato possa trasformarsi in un casus belli che metta in gioco l’esistenza collettiva. In questi casi tutto si risolve all’interno dell’unità politica.
Orbene se fine del potere è la protezione (o la sicurezza) delle vite e dei beni dei singoli cittadini, è chiaro che far subire un torto è un grave, gravissimo “sviamento” da tale funzione. E’ un “peccato” sotto il profilo dell’etica politica: e ciò non solo per i motivi esposti e sopra citati – da Lutero. Ma perchè, in un’epoca di secolarizzazione, in cui sono stati recisi i legami tra cielo e terra, la prima ragione di legittimazione del potere è la sua congruità alla funzione, come ci è capitato di sottolineare altrove. Cioè che riesca ad adempiere efficacemente i propri compiti. Ma allorquando non abbia successo nella sua primaria incombenza, non c’è alcuna ragione perchè possa pretendere Peraltro laddove, come nello Stato moderno, il potere pubblico ha ottenuto il “monopolio della violenza legittima”, si è anche caricato, più che in altre forme politiche, della responsabilità della protezione, proprio perchè la reazione al torto e/o la sua “esecuzione” non può più essere “amministrata” dal privato. Questo accadeva in altri ordinamenti, come l’antico diritto romano o l’Europa feudale, in cui alcune – diffuse – forme di autoamministrazione ed autoesecuzione della sanzione erano ammesse. Ma laddove queste siano state totalmente eliminate – anzi sanzionate penalmente – una repressione pigra, occasionale e svogliata è, nei fatti, un incentivo alla prepotenza ed ai soprusi: alle violazioni, cioè, di quel diritto di cui lo Stato si pretende sia arbitro. Una sorta d’ “intelligenza”, complicità o “solidarietà” con chi viola la legge e non con chi l’osserva. D’altra parte, è appena il caso di ripetere – tanti l’hanno già detto – che lo Stato moderno non ha il monopolio del diritto ovvero non è l’unica fonte di produzione normativa – atteso che questo è, in buona parte, prodotto di altri enti od istituzioni sociali, non solo pubbliche – e in parte è generato, spontaneamente dai (costanti) comportamenti comunitari. Ciò di cui lo Stato ha il monopolio è dell’applicazione e soprattutto esecuzione del diritto (come compito primario all’interno della funzione di garanzia dell’ordine, anch’essa “monopolizzata”). Il cui aspetto principale è che non sia consentito far subire ingiustizie, anzi siano approntati tutti gli strumenti perchè chi le ha patite ottenga soddisfazione. C’è un’altra considerazione che rende all’ambito politico e giuridico la tesi di Callicle e del tutto incongrua quella di Socrate. Se è vero infatti che il sovrano dell’età moderna è “legibus solutus”, in quanto fonte della legge, la conseguenza che ne discende è quella espressa nella massima del diritto pubblico inglese “the king can do no wrong”: il re non può commettere torto, per definizione perchè è la sua volontà a determinare il giusto e l’ingiusto. Certo, si potrebbe rispondere, come uomo è soggetto alla legge morale; ma come gevernante (non come “cardatore, cuoco”, ecc.) è suo dovere non seguirla, come immediata conseguenza dell’autonomia della politica della morale. In sintesi non è obbligato ad osservare la legge positiva perchè ne è la fonte; non è tenuto a precetti morali, in particolare quando non tornino utili – e ancor più se sono dannosi – agli interessi dell’unità politica. Non è così per la massima di Callicle: subire e far subire un torto alla comunità (e alla persona pubblica del sovrano) è sempre un vulnus alla funzione di protezione e governo di questi. Al punto che Suarez nel passo sopra citato, legittima “tota respublica” a privare della sua autorità il principe “si princeps officio suo desit”.
L’affermazione del teologo gesuita è sorprendente – a non approfondirne il pensiero – tenuto conto che non ammette, se non in tal caso, un “diritto di rivoluzione” (o meglio, di “supplenza”) della comunità verso il sovrano legittimo. Ciò che è interdetto in linea generale, viene permesso ai sudditi proprio nel caso eccezionale si debba evitare di subire – o riparare un illecito ai danni della comunità (27). D’altra parte anche se più “avanzata”, questa posizione ha molti punti di contatto con quella di Hobbes, secondo il quale l’obbligo di obbedienza cessa per i sudditi quando il sovrano non è più in grado di dare loro protezione: in quanto “ogni cittadino ha la libertà di proteggersi da se, con i mezzi, che il suo criterio gli suggerirà” (28). Anche qui, con la dovuta differenza, è la funzione del sovrano, ordinatrice e protettrice, e l’efficacia di questa a determinare la sorte del rapporto comando – obbedienza; come d’altra parte giudicava anche Spinoza, nel cui pensiero il diritto naturale “è determinato dalla sola potenza di ciascuno” e “colui che detiene il pieno potere si dice che ha il supremo diritto su tutti: diritto, che avrà soltanto finchè
conserverà questa potenza di fare quello che vuole “se perderà questo (il sommo potere N.d.R.) perderà anche il diritto illimitato d’imperio” (29). E’ il caso di ricordare che secondo Spinoza era impossibile commettere torto, da parte delle “supreme autorità alle quali tutto è lecito di diritto” (30). Anche nel Trattato Politico ritiene “non si può in alcun modo dire che lo Stato sia soggetto alle leggi o che possa delinquere. Infatti le regole e i motivi di soggezione e di ossequio, che lo Stato deve a propria garanzia conservare, non sono del diritto civile, ma del diritto naturale”(31). E, concludendo questa breve casistica, e ritornando alla questione tra Socrate e Callicle, se dovessimo chiederci se sia peggior governante chi commette ingiustizia o chi la fa subire, la risposta è che, tra le due poco attraenti alternative, è sicuramente preferibile avere un governante che commetta ingiustizie piuttosto di uno che le faccia subire. E ciò non solo per l’ovvia considerazione che mentre il primo “pecca” una volta il secondo lo fa almeno due: perchè consentire che si subisca un torto significa commettere un (altro) torto. Con la conseguenza che in questi casi il cittadino si trova come il povero Pinocchio il quale, oltre a subire il furto dal Gatto e dalla Volpe, passò pure la notte in guardina per ordine del giudice, cui si era rivolto per avere giustizia. E neppure per il motivo, di etica della politica o, più in generale dell’etica dell’uomo pubblico, che così si contravviene alla propria funzione specifica, quella che legittima l’esercizio di posizioni di potere. Ma soprattutto perchè, seguendo un ragionamento di Hobbes, è assai peggio dover subire torti dai tanti governati che dai pochi che governano. Non solo per la quantità: ma perchè la prima alternativa, nel caso estremo, si trasforma nello stato di natura, cioè in una situazione da guerra civile. Cioè proprio quello che il potere politico ha, come scopo, di evitare. 5.0 Avevamo iniziato col chiederci quale fosse la soluzione migliore tra quelle sostenute da Socrate e Callicle – per un’etica del comportamento pubblico. La conclusione è, ovviamente, che è preferibile quella del sofista. Una società in cui la reazione all’illecito non è sanzionata e praticata, tende a confondere diritto e torto, permesso e vietato, e, più sfumatamente, comando e obbedienza, pubblico e privato: cioè una società in cui i termini di riferimento diventano indifferenti e intercambiabili, dove l’astuzia e la prepotenza, trovando pochi o punti ostacoli, hanno il destro per spadroneggiare. Se questo è chiaro per il diritto, non lo è da meno per gli aspetti più specificatamente politici, che, come Callicle notava, la tesi di Socrate trascura (e confonde). Come sopra scritto, dove il comando non si esercita, per ignavia dei governanti o dei governati, alla lunga non c’è ragione di obbedire. Ma del pari viene confusa la distinzione tra pubblico e privato, anch’essa ritenuta da Freund uno dei presupposti essenziali del politico. Si può tralasciare o perdonare la lesione dei propri interessi privati, ma non quando vengono in gioco le condizioni di esistenza della comunità. in questo senso l’obiezione di Callicle a Socrate, di aver confuso pubblico e privato, gli statisti con i cardatori, è magistrale. A un tempo, con ciò il sofista individuava la regola di comportamento dell’uomo pubblico, non nell’interesse dello stesso, ma in quello della società. E’ sostanzialmente tributaria dell’etica della responsabilità; e, in particolare per il governante, non è detto che sia più facile da percorrere; anzi, in genere, è di gran lunga la più aspra e difficile. A governare facendo discorsi edificanti, lottizzando cariche e prebende e non disturbando (o solleticando) tutti “i poteri forti”, sono capaci se non tutti, molti. In fondo non si chiede a costoro altro che le doti di don Abbondio, tra le quali, come riconosciuto dallo stesso, non c’era il coraggio. L’esercizio della funzione pubblica, anche a livelli non “apicali” esige invece doti di coraggio e spesso di abnegazione non indifferenti, nonché la capacità di assumersi responsabilità e rischi. Se la politica non fosse – com’è – comando e obbedienza; se non fosse, secondo un noto detto di Napoleone, il destino; se non ponesse in gioco l’ordinata esistenza collettiva e individuale probabilmente tali caratteristiche avrebbero un’importanza marginale. Se, per esempio, fosse un’arte per elevare moralmente i cittadini, le doti ricordate non avrebbero senso, o ne avrebbero molto poco. Più che assumersi rischi, una tale concezione richiede di far buone prediche. Invece ciò che fa l’uomo pubblico è il coraggio prima che l’intelligenza o la dirittura morale. O meglio queste, senza il primo, servono poco. Se infatti il potere politico ha una funzione ordinatrice, e cioè finalizzata alla creazione e al mantenimento dell’ordine, comandare e sanzionare son essenziali: non foss’altro perchè, come scrivevano, tra i tanti, Machiavelli e Lutero, i cittadini virtuosi devono essere difesi dai molti che virtuosi non sono. In questo contesto appaiono del tutto impropri i continui richiami moralistici, che vengono fatti oggi, in Italia, da politici e funzionari. Che chi ha il potere e il dovere d’intervenire, riesca per lo più soltanto a fare delle prediche, appare immorale sotto il profilo dell’etica della politica, oltrechè contrario alla funzione dello Stato moderno. Meglio opererebbe ad attivarsi per incrementare la percentuale, per esempio, del “prodotto finito” dell’azienda-giustizia penale, e cioè l’esecuzione della pena, che, oggi in Italia, si realizza invece solo in un caso su (oltre) duecento denuncie presentate. Per cui lo Stato diventa così non un’organizzazione per la protezione dei diritti, ma per far subire le violazioni di questi.
Anche perchè chi, in presenza di situazioni di fatto così disastrate si mostra animato da buone intenzioni, e magari lo è, spesso è personalmente onesto, cioè non commette ingiustizie “in proprio”. Ma è del tutto inidoneo alla funzione rivestita, e, il più delle volte un atteggiamento del genere è la maschera nobile di concreti timori, pavidità, incapacità.
Quello che Jhering chiamava la “politica della vigliaccheria”. Per cui sotto le nobili parole di Socrate si nascondono, quasi sempre, le paure di don Abbondio. Teodoro Klitsche de la Grange NOTE 1) GORGIA 483 a-b, trad it. Bari 1997, p. 89; 2) GORGIA 483 d, op cit., p, 91; E qualcosa di non dissimile scrive Tucidide nel noto episodio dell’ambasciata ateniese al popolo di Melo, tutto improntato ad uno stretto realismo politico, per cui gli ambasciatori d’Atene ritengono “le nostre opinioni sugli Dei, la nostra sicura scienza degli uomini ci insegnano che da sempre, per invincibile impulso naturale, ove essi, uomini o Dei, sono più forti, dominano. Non siamo noi ad aver stabilito questa legge, non siamo noi che questa legge imposta abbiamo applicata per primi”. (La guerra del Peloponneso, lib. V, cap. 105): individuando così una delle “regolarità” della politica. 3) J. FREUND, L’essence du politique, Paris, 1965 p. 146 ss; 4) GORGIA 491 d, op. cit., p. 109; 5) GORGIA, 515 a.-c., op. cit. p.167; 6) LUTERO, “Sull’autorita Temporale”, Oevreus, tome I V0 , p. 23; 7) Op. cit. p. 23 8) Op. cit. p. 24 9) Op. cit. p. 29; 10) Calvino, L’institution chrétienne, liv IV, cap. XX, in particolare p. 459, Editios K2rigma U.S.A. 1978; 11) T. E. Troeltsch, Il protestatismo nella formazione del mondo moderno, rist., Firenze 1974, p. 57. Come noto, uno dei punti da superare, per amettere la liceità della guerra e della repressione dei delitti, erano i noti passi del Vangelo, predicanti l’amore universale. Il Cardinale Bellarmino li interpreta distinguendo tra “pubblico” e “privato”: “Infine vengono citate quelle parole. S. Matt., c. 5: Se ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche la sinistra… ; amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi odia, e quelle, in S. Matteo al c. 26 Si osservi che queste stesse prove furono portate una volta contro i cristiani da Giuliano l’apostata, come ci viene riferito da S. Gregorio Nazianzeno. Quanto alla loro confutazione, diciamo in primo luogo che tutte queste cose sia comandi, sia consigli, vengono dati ad uomini privati: infatti il Signore o l’apostolo s. Paolo non comanda al giudice di non dare a colui che commise un’ingiustizia a danno di terzi, la giusta punizione, bensì comanda a ciascuno di sopportare di buon animo le offese ricevute; la guerra non è una vendetta privata, bensì fa parte della pubblica giustizia; e come l’amore verso i propri nemici, al quale siamo tutti tenuti, non ritiene il giudice o il carnefice dell’adempimento delle proprie funzioni, così non trattiene i soldati e i generali dall’adempimento delle loro. Inoltre diciamo che anche per i privati stessi, questi non sono sempre comandi, ma ora sono comandi ed ora consigli. Son sempre comandi quanto alla disposizione dell’animo, così che si sia pronti a porgere l’altra guancia e a dare anche il mantello a colui che ci portò via la tunica, piuttosto che offendere Dio; ma agire poi così di fatto, è comando nel caso che l’onore di Dio lo richieda necessariamente, altrimenti è soltanto consiglio; anzi alcune volte non è neanche questo, come quando porgendo l’altra guancia non ne viene utilità, se non che l’altro torni a peccare” (S. Roberto Bellarmino “Scritti politici, Torino 1950, p.255). 12) S. Roberto Bellarmino in Scritti politici, Torino 1950
- 248; 13) Op. cit. p. 250. D’altra parte com’è noto nella Confessione Augustana è detto: “Per ciò che riguarda la vita civile (le Chiese riformate) insegnano che le istituzioni civili legittime sono buone opere di Dio e che ai cristiani è lecito ricoprire cariche pubbliche, esercitare la funzione di giudice, pronunziare le sentenze in base alle leggi imperiali e alle altre norme vigenti, stabilire le pene in conformità alle leggi, far guerra per giusti motivi, militare negli eserciti, stipulare contratti secondo le leggi, avere delle proprietà, prestare giuramento su richiesta dei magistrati, ammogliarsi o prendere marito. Condannano gli Anabattisti che vietano questi doveri civili ai cristiani” (La Confessione Augustana del 1530, Torino 1980, p. 127). 14) SUAREZ De charitate, disp. 13: De Bello. In “Ausgewalthe texte zun volkerrecht”, Tubigen 1965, p. 122 15) Op. cit., p. 126; 16) Op. cit., p. 158; 17) Op. cit., trad. it., Bari 1935, p. 11 18) Op. cit. p. 12; 19) Op. cit., p. 67; 20) Op. cit., p. 67; 21) Op. cit., p. 68; 22) Op. cit., p. 69; 23) Op. cit., p. 69; 24) Op. cit., p. 71; 25) “Avvertenza” (prefazione) al “Kampf um’s recht”, trad. it. cit., 26) Prècis de droit constitutionel, Paris 1929, p. 16. 27) Un’altra eccezione invero Suarez ammette per il tiranno laddove sostiene che “bellum reipublicae contra principem (l’usurpatore n.d.a.), etiamsi sit aggressivum non est intrinsece malum”; devono però ricorrere le condizioni “justi belli”. In particolare deve distinguersi se il tiranno è tale” quoad dominium et potestatem” ovvero “quoad regimen”, per cui diverse sono le ipotesi in cui la apparente “seditio” può essere invece “bellum justum” (v. Suarez op. cit. p. 202). Nel pensiero di Suarez, plasmato da concetti e argomenti giuridici, in definitiva il criterio ultimo di discrimine tra lecito e illecito è quello della legittima difesa “omnibus competit jus defensionis”. D’altra parte, anche nella trattazione dello jus belli e del diritto naturale, la differenza evidente tra i teologi della controriforma e i filosofi del diritto naturale successivi è che per i primi lo jus belli è strettamente collegato e funzionalizzato al ripristino del diritto leso: evidente nella guerra difensiva, la riparazione del torto (e con ciò il ripristino dell’ordine) serve a giustificare i casi di guerra aggressiva. Sul punto vedi anche Francisco de Vitoria (Relectio de indis, trad. it., Bari 1996, pp. 84, 111, 112), che collega in particolare il “bellum justum” alla “justa causa” o allo “justum titulum”. Juan de Mariana, la cui posizione è particolare, perché, com’è noto, giustifica il tirannicidio (in ciò più deciso del confratello Suarez), considera questa extrema ratio giustificata (nel caso di tirannide “quoad regimen”) dal fatto che il tiranno “arrivi al punto di mandare in rovina lo stato, di impadronirsi con la forza delle proprietà pubbliche e private, di disprezzare le pubbliche leggi e le credenze religiose, mostrando apertamente di riporre tutta la sua prodezza nella superbia, nell’audacia, nell’empietà verso il cielo”. Con questo anche l’uccisione del principe ingiusto è vista come mezzo per il ripristino della giustizia e del diritto (v. Juan de Mariana De Rege ed regis institutione, trad. it., Napoli 1996, p. 52). E la guerra (giusta), anche civile, è così un mezzo del diritto e della giustizia e un “succedaneo” del giudice, del “terzo decisore”. Mentre per i secondi la possibilità di guerra, senza particolari giustificazioni, è conseguenza diretta dello “stato di natura” e del diritto naturale, applicato agli Stati, che tra di loro, sono “in stato di natura”. 28) v. Th. Hobbes, Leviathan, trad. it., Bari 1974, p. 298. 29) v. Trattato Teologico . politico, p. 382 – 383, Torino 1980. 30) T.T.P., cit. p. 385. 31) Op. cit. Torino 1958 p. 206.






 Caro Carlo,
Caro Carlo, Caro Teodoro,
Caro Teodoro,