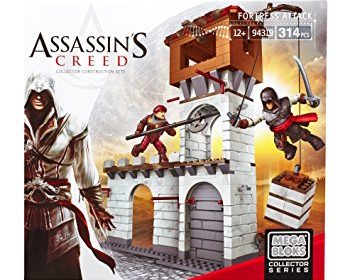I DUE PROTAGONISTI
I DUE PROTAGONISTI
Di Donald Trump temo che continueremo ancora per mesi se non anni a sorbirci soprattutto i resoconti dettagliati dei suoi difetti o sedicenti tali; dalla maldestra improvvisazione alla ruvidità di modi, dall’affettata eleganza alla volubilità di giudizi, alla rozza ignoranza. Con il nobile intento di salvaguardare l’umanità da questo flagello, i campioni dell’informazione democratica, in particolare il NYT (New York Times) e il WP (Washington Post), dimentichi delle restanti cose del mondo, stanno da tempo concentrando la totalità degli sforzi in questa missione piegando ad essa fatti, realtà e soprattutto deontologia professionale. Con la stessa dedizione, ma con evidente minore fatica, gli innumerevoli corifei dell’informazione europea, pervasi da certezze assolute, non fanno altro che spandere a cuor leggero veline e veleni propinati dai capostipiti. Eppure almeno una caratteristica del Presidente Americano dovrebbe accomunare il giudizio dei pochi fautori e dei tanti detrattori del suo prominente impegno: la capacità di scatenare l’aperto spirito bellicoso anche nelle personalità più prudenti e discrete; tra queste, senza dubbio il Cancelliere tedesco.
Di Angela Merkel, nella vicenda delle intercettazioni americane delle sue conversazioni telefoniche, abbiamo apprezzato la capacità di accettare dal versante amico le peggiori intrusioni e umiliazioni senza alcun pregiudizio dei rapporti, in particolare quelli con Obama e senza apparenti sussulti di orgoglio; nella vicenda del milione di profughi siriani, invece il suo spirito di accoglienza talmente ecumenico da equivocare sulle profferte amorose del branco senza autorizzazione delle interessate, salvo cercare di rifilare con discrezione gran parte degli ospiti ai paesi vicini una volta constatata la loro difficoltà di inserimento e la loro preparazione professionale evidentemente non all’altezza delle aspettative; nella vicenda delle contraffazioni dei dati di emissione degli scarichi delle auto tedesche, abbiamo apprezzato la difesa pur tardiva dello spirito puritano a scapito forse dell’immagine di efficienza del sistema industriale e dei sistemi di controllo tedeschi. Il meglio della sua valenza di amministratrice, almeno sino a pochi mesi fa, è emerso nella vicenda del collasso della Grecia quando con mirabile quadratura è riuscita a conciliare l’aura puritana del rigore contabile con il trasferimento sui bilanci pubblici degli stati europei di gran parte delle esposizioni bancarie tedesche verso quel paese, con il consolidamento dei profitti finanziari delle stesse sul debito restante, con l’acquisizione di buona parte della rete logistica greca e, ciliegina sulla torta, con la vendita a caro prezzo all’esercito ellenico di residuati bellici presenti nei depositi della Bundeswehr. Si sa che le trattative politiche riservano come corollario quasi sempre il lato oscuro della meschinità. Nella graduatoria degli inperturbabili la statista tedesca non detiene certo l’esclusiva, di sicuro è in posizione di ascesa. Tra gli innumerevoli esempi, gli allora Generale Wesley Clark e Segretaria di Stato Madeleine Albright si concessero come bottino della missione umanitaria in Jugoslavja una partecipazione azionaria delle società minerarie del Kosovo; la stessa pletora di funzionari, accademici ed economisti americani e tedeschi accorsi al capezzale della moritura URSS e della nascitura Russia di Boris Eltsin ottenne di scambiare le proprie disinteressate consulenze con una partecipazione attiva al saccheggio di quel paese; per non parlare delle cointeressenze in Ucraina. Anghela, come un re Mida dei nobili principi, è riuscita a trasformare anche la meschinità in rigore risanatorio, sempre però con un profilo dimesso e discreto; da pudico comportamento collaterale a qualità volta al bene pubblico.
UN CONFRONTO PREMATURO
Durante il G7/G20 avviene inopinatamente la sua metamorfosi e la consacrazione da Maria Maddalena del cenacolo europeo ad angelo giustiziere dell’attentatore all’ordine mondiale.
Sono bastati pochi mesi dal gelido saluto al non ancora insediato Presidente Americano, alla imbarazzata visita a Washington per finire con la contrapposizione al G7 per passare da una immagine di capo di governo in verità un po’ dimesso, tutt’al più abile ad agire nell’ombra, a quella di statista orgoglioso in grado di contrapporsi apertamente al neopresidente e, aspetto ben più rilevante, di trasformare la Germania da paese in grado di approfittare in maniera surrettizia delle opportunità della globalizzazione a nazione paladina di questa virtù o in alternativa, secondo le interpretazioni, in grado di contrapporsi, assieme alla Cina, alla prepotenza e all’unilateralismo americano.
Da allora è tutto un fiorire di letteratura e di tesi sul destino manifesto di un paese, inesorabilmente portato a scontrarsi con la nazione egemone; quello che divide i sostenitori riguarda il probabile esito finale dello scontro, ma confronto comunque dovrà essere.
La redazione di Limes, autrice di una per altro pregevole monografia sull’argomento, è la portabandiera più autorevole di questa tesi.
Sono sufficienti pochi atti politici pubblici, concentrati in poche settimane, in aggiunta magari al proposito proclamato di costruzione di un sistema diplomatico e di difesa europei autonomo dagli USA, per promuovere l’attendibilità di una svolta politica così straordinaria?
Già la dinamica e la successione dei recenti eventi da adito a parecchi dubbi.
Intanto il tampinamento postpresidenziale di Obama e l’accoglienza trionfale a lui riservata a Berlino, all’esponente quindi che, assieme a Hillary Clinton, suo successore designato, ha cercato ostinatamente di arginare la tendenza al multipolarismo e di destrutturare gli stati viziati da proprie ambizioni autonome, svelano i legami inestricabili di dipendenza e compromissione con il vecchio establishment nonché le aspettative di ripristino dello “statu quo ante” del cancelliere tedesco. Il veemente appello alla crociata in difesa dell’accordo sul clima di Parigi e del libero mercato globalizzato sventolato al G7 di Taormina, ha mostrato per altro subito la corda al G20 di appena due mesi dopo lasciando in mano alla Merkel un vessillo ridotto ad un cerino consunto con alle spalle truppe scarse e poco convinte a difenderlo. Si potrebbe interpretare come un modo spregiudicato di condurre una danza del quale si possiede il filo conduttore della musica. Più che una condottiera dotata di forza propria in realtà si è rivelata lo strumento di uno schema più grande e complesso giocato per lo più Oltreatlantico. Lo stesso pulpito si è rivelato poco attendibile vista la recente propensione della Germania a limitare le acquisizioni cinesi in Europa rivelando così una evidenza chiara ancora a pochi eletti: il confronto sul libero mercato è una battaglia per determinare regole commerciali più favorevoli ad una o l’altra delle formazioni socieconomiche e ai loro centri dominanti all’interno di logiche geopolitiche operanti all’interno ma non riducibili ad un mero o assolutamente prevalente confronto economico. Una riduttivismo invece che ancora prevale oppure tende a riaffiorare surrettiziamente in gran parte delle tesi, anche nella monografia di Limes.
UN APPROCCIO EVENEMENZIALE
L’approccio evenemenziale presente in gran parte degli studi e soprattutto nella divulgazione mediatica tende a focalizzare e spettacolarizzare un particolare duello a discapito degli altri e dello sguardo d’insieme. Il tentativo stesso di Trump di reimpostare in maniera bilaterale i rapporti e le relazioni tra gli stati può indurre ad accentuare tale interpretazione particolaristica. Un tentativo che se inteso come strategia può trascinare alla rovina gli Stati Uniti e favorire uno sviluppo caotico e gravido di incognite del multipolarismo, ma con qualche possibilità in più, per le potenze intermedie, di assumere una propria peculiare fisionomia. In realtà l’adozione del modello di relazioni bilaterali è del tutto irrealistico e fuorviante perché prescinde dal naturale gioco di alleanze che si dipana nel conflitto politico e il cui successo presuppone proprio ciò che l’attuale svolta politica sta sentenziando inappellabilmente: l’inesistenza di un centro dominante indiscusso. Esso conduce in pratica alla stessa sterilità di chiavi interpretative del concetto di globalizzazione fondato sul movimento atomistico dei singoli agenti sul mercato e sul declino inesorabile del ruolo degli stati nazionali. Se adottato altrimenti come espediente tattico, come da probabile intendimento di Trump, può servire ad una destrutturazione del sistema attuale di relazioni in vista di una ricostruzione più controllata delle sfere di influenza, ma a determinate condizioni: che gli attori in grado di condurre il gioco siano limitati, che riconoscano una reciproca legittimazione e che abbiano un’idea sufficientemente precisa della delimitazione delle sfere di influenza. In un modo o nell’altro si tratta di un processo ormai irreversibile rispetto al quale la classe dirigente dominante tedesca sembra molto più temere le incognite ed apprezzare le attuali rendite di posizione che cogliere le incerte opportunità.
Profetizzare, come prevede la redazione di Limes, uno scontro aperto tra Stati Uniti e Germania pare quantomeno prematuro se non azzardato. E infatti, ad eccezione dei contributi esterni in realtà molto più cauti, gli articoli dei redattori suffragano la tesi sulla base di stereotipi ormai consunti.
Da una parte cerca di fondare l’ineluttabilità del conflitto sulla base dell’incompatibilità tra le due culture. In realtà la storia offre innumerevoli esempi di conflitti atroci e di durature alleanze tra paesi e centri strategici dalle culture difficilmente compatibili. Gli stessi Stati Uniti hanno combattuto almeno tre guerre aperte con il paese a loro culturalmente più affine, il Regno Unito. Negli Stati Uniti, lo rivela la stessa rivista, la componente più numerosa è appunto quella di origine tedesca e la sua cultura ha impregnato pervasivamente la formazione politica e sociale americana, pur affermando in esse una scarsa capacità lobbistica. Paradossalmente, secondo i redattori, una stessa identità culturale avrebbe quindi contribuito decisivamente a determinare la costruzione di una nazione e della sua classe dirigente e nel contempo l’ineluttabile conflitto con il paese di origine di quel ceppo, costituitosi in stato nazionale. Una tesi, quindi, fuorviante, versione edulcorata del più famoso ed altisonante conflitto di civiltà teorizzato da Huntington.
Dall’altra cerca di spiegare la dinamica inesorabile di questo conflitto attraverso il confronto asimmetrico tra il peso e la forza economica crescente del paese europeo e la pervasività e la forza politica di quello americano. Una dinamica che tenta di spiegare non solo le modalità del conflitto tra i due paesi ma anche la natura del dilemma che dovranno risolvere le classi dirigenti degli altri paesi, in particolare quello dell’Italia, di fronte alla alternativa posta della alleanza strategica con uno o l’altro dei contendenti. Un confronto quindi tra il peso militare, la capacità diplomatica e la pervasività dei servizi di intelligence da una parte e la solidità finanziaria, la capacità produttiva e la potenza commerciale dall’altra.
Una chiave esplicativa più sofisticata della prima, ma altrettanto fuorviante e non priva di evidenti punti oscuri e vere e proprie omissioni.
 LA RIMOZIONE DI UN EVENTO EPOCALE
LA RIMOZIONE DI UN EVENTO EPOCALE
Entrambi i limiti interpretativi pagano lo scotto di una rimozione o, nel migliore dei casi, di una valutazione del tutto parziale delle implicazioni di un evento politico epocale cruciale: la sconfitta militare, l’occupazione territoriale, la distruzione di un regime istituzionale, per altro odioso, la riduzione e lo smembramento territoriale della Germania.
La dimensione catastrofica di quella resa consentì ai due vincitori, l’URSS e gli USA, di decidere delle sorti di quel paese. Per quel che ci riguarda più direttamente, in quanto forza di occupazione gli Stati Uniti determinarono il carattere federale oltre che parlamentare del regime nella sua parte sud-occidentale, il suo carattere antisovietico, la limitazione drastica delle forze armate, in particolare quelle terrestri e l’infiltrazione e l’organizzazione delle principali istituzioni e sistemi.
Il carattere di occupazione di quella presenza non ancora risolto definitivamente nemmeno dagli accordi che hanno sancito negli anni ‘90 l’unificazione tedesca.
Una modalità di dominio non risolvibile con il controllo di una parte limitata delle élites dominanti del paese sconfitto e con azioni complottistiche tese a determinare direttamente le azioni dei vertici politici; piuttosto una azione altamente sofisticata e persuasiva tesa soprattutto ad orientare ed indurre, addirittura a creare delle dinamiche inerziali capace di attirare e integrare progressivamente in un sistema occidentale le varie formazioni sociali e i vari stati nazionali caduti nella rete dei liberatori. Un sistema fortemente attrattivo, capace nel rispetto delle gerarchie fondamentali, di offrire sviluppo ed una relativa libertà di azione, ma proprio per questo ancora più pervasivo. In questa trama la Germania Federale ha assunto un ruolo importante, superiore alle stesse aspettative delle élites tedesche emerse dalla sconfitta militare, in parte per merito proprio, soprattutto per scelta del vincitore. Accantonate rapidamente le tentazioni, vellicate soprattutto da Francia e Regno Unito, di ridurre il paese ad una condizione preindustriale, senza nulla cedere sulla capacità di controllo, si optò per un rapido sviluppo che stabilizzasse un paese alleato ai confini cruciali della propria zona di influenza, contribuisse economicamente e produttivamente al sostegno della macchina bellica e neutralizzasse le residue ambizioni egemoniche di Francia e Gran Bretagna. Il pegno da pagare in termini di sovranità fu estremamente pesante con un sistema di controllo e infiltrazione particolarmente intricato e insindacabile, per altro sancito, che riguardava non solo l’intelligence e le forze armate, ma anche il sistema politico, amministrativo e comprendente anche, un aspetto del tutto ignorato dai redattori di Limes come da gran parte dei giornalisti e studiosi, gli organi di informazione e le strutture economiche.
In settant’anni le cose possono cambiare; ma non è questo, sostanzialmente, il caso della Germania.
Le tentazioni e qualche timido e sporadico tentativo di affrancamento non sono certo mancati. Durante la guerra fredda il tentativo più coerente fu portato avanti negli anni ‘70 con l’ “oestpolitik”. Si trattò in realtà di una “interpretazione” troppo estensiva del processo di distensione, più che altro un riconoscimento meno precario delle rispettive zone di influenza, inaugurato dalle due superpotenze. Per ricondurre alla mansuetudine nell’ovile della pecorella inquieta, agli americani fu allora sufficiente assecondare i timori francesi di un rigurgito delle ambizioni tedesche e la loro conseguente improvvisa conversione all’ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Europea e innescare una politica di riarmo missilistico. Con la crisi e la caduta del blocco sovietico si presentò un contesto apparentemente più favorevole a vellicare ambizioni più audaci.
SUSSULTI DI EGEMONIA
Il tentativo più organico e strutturato avvenne nella seconda metà degli anni ‘80 quando, percepita la crisi imminente del blocco sovietico e forte dei legami più o meno circospetti stretti con quella parte della loro classe dirigente legata al commercio e al finanziamento del debito estero, una parte dell’establishment tedesco tentò per alcuni anni di organizzare e sostenere il sistema bancario dei paesi dell’Est-Europa per favorire la ristrutturazione economica e salvaguardare buona parte di quella classe dirigente. Fu l’atto e il momento che suscitò, nei confronti dell’élite tedesca, le stesse premure dedicate a quella italiana. Il luogo di raccolta degli accoliti fu diverso; con gli uni si scelse il Panfilo di Sua Maestà, al largo di Roma; con gli altri un più modesto albergo bavarese. Anche il numero di convitati differiva; ben più numeroso sulla prestigiosa imbarcazione, limitato a meno di dieci persone nel gasthof. Non si è trattato, probabilmente, di un mero omaggio alla italica convivialità rispetto alla proverbiale essenzialità teutonica; deve aver influito la diversa funzione che i comprimari, inglesi nell’una e francesi nell’altra, hanno assunto nell’iniziativa; soprattutto, è stata la perdurante e progressiva frammentazione politica ed istituzionale dell’Italia rispetto alla Germania a determinare le diverse caratteristiche dell’iniziativa, i diversi sviluppi e gli esiti opposti pur in una comune riconfigurazione della subordinazione politica all’alleato d’oltreatlantico.
Il tentativo più intraprendente fu posto in atto durante la guerra civile in Jugoslavia conclusasi, al momento, con la frammentazione di quel paese e con una conflittualità latente pronta a riemergere. L’iniziale spinta propulsiva alla divisione fu data soprattutto dalla Germania sino ad essere rapidamente assorbita pur con qualche attrito significativo da quella americana. L’evento bellico rappresenta comunque una svolta significativa che vede il gruppo dirigente egemone in Germania passare da una politica di cooptazione e sostegno delle vecchie classi dirigenti riformate dei paesi del blocco sovietico ad una di progressiva aperta ostilità verso la Russia e tesa a favorire la liquidazione delle stesse nei paesi dell’Europa Orientale e nei Balcani. Una scelta indubbiamente vantaggiosa nell’immediato perché ha consentito di riprendere e perseguire una politica di influenza ed integrazione economica esattamente lungo i corridoi tracciati dai colonizzatori tedeschi nel corso dei secoli sino alla metà del ‘800 senza dover contestare i legami di subordinazione con lo stato egemone americano e indebolendo vistosamente la posizione politica ed economica dei due altri grandi paesi fondatori della UE, la Francia e l’Italia. Una scelta deleteria dal punto di vista strategico nel caso la Germania dovesse aspirare ad una maggiore e decisiva autonomia politica che richiedesse un avvicinamento duraturo e stabile alla Russia di Putin proprio perché troverebbe nei più importanti paesi dell’Europa Orientale e della penisola scandinava i più fieri oppositori a tale svolta con scarse possibilità di un loro ricambio con centri politici più duttili.
I messaggeri in quell’albergo bavarese devono evidentemente essere stati particolarmente persuasivi anche se assecondati dalle circostanze propizie della morte violenta dei due nuovi paladini della ostpolitik, Herrhausen di Deutsche Bank e Rohwedder di Treuhandanstalt.
Da questi due eventi a cavallo della riunificazione si è dipanata la condizione di un paese ormai al centro di attenzioni e sospetti, ma incapace di una politica assertiva capace di aggregare forze e in grado tutt’al più di neutralizzare e fiaccare le forze di potenziali rivali nel campo “amico” europeo.
Negli ultimi venti anni i pochi atti politici autonomi di quella classe dirigente sono consistiti nella non partecipazione ufficiale alle avventure militari, in particolare Libia ed Iraq, salvo garantire efficacemente, ma in modo discreto, i propri servizi logistici e di intelligence come avvenuto in Libia. Per il resto si è rifugiata in annunci velleitari, quali la creazione di una forza militare congiunta e integrata con i francesi, miseramente fallita o nel perseguimento classico di una politica di influenza a rimorchio nel vicinato, come avvenuto in Ucraina, con grave pregiudizio delle relazioni con i russi o nel supporto opportunistico e lucrativo alla destabilizzazione specie nel Grande Medio Oriente. La Germania, infatti, lemme lemme risulta costantemente tra i primi fornitori ufficiali di armi e munizioni dei Sauditi, impegnati in Yemen, dei Giordani e della pletora di governi a supporto delle primavere.
I LIMITI STRUTTURALI
Una fondata e non frettolosa elezione della Germania a protagonista geopolitico e antagonista naturale degli Stati Uniti non può prescindere da una analisi della condizione strutturale del paese.
La particolare struttura federale già dibattuta nelle università americane a partire dagli anni ‘30 e imposta nel regime di occupazione assegna importanti competenze di politica estera ai laender in cooperazione e spesso in conflitto tra loro e con lo stato centrale, indebolendone di fatto coerenza e incisività. Un esempio significativo si può trarre dal ruolo decisivo assunto dal Governo Bavarese nella fomentazione della guerra civile in Jugoslavja e nella capacità di trascinare altre regioni di stati confinanti su questo indirizzo in opposizione alle direttive dei rispettivi stati nazionali. Una organizzazione istituzionale che riesce comunque a mantenere una propria operatività grazie al ruolo unificante delle grandi associazioni verticali entro le quali si compongono gli interessi lobbistici e gli indirizzi di buona parte dei centri decisionali.
A garantire, più che la coerenza, l’incisività di una struttura così articolata fa difetto però l’estrema permeabilità delle strutture di intelligence e degli apparati coercitivi e di controllo, il retaggio più pesante della disfatta militare e del conseguente regime di occupazione. La vicenda delle intercettazioni americane ai danni della Cancelliera ha semplicemente rivelato il livello di integrazione ed infiltrazione dei servizi tedeschi con quelli americani; la susseguente rimozione del responsabile, più che la volontà una riorganizzazione e una depurazione delle strutture, ha rivelato la stizza di un capo politico per la pubblicità imbarazzante di quei segnali di attenzione. Per il carattere di riservatezza insito, i Servizi di Sicurezza sono particolarmente vulnerabili; la permeabilità, comunque, investe un po’ tutti gli apparati coercitivi e sanzionatori dello stato germanico, compreso quello militare ancora particolarmente debole.
Una chiosa a parte merita il sistema di informazione, quasi del tutto allineato all’ortodossia atlantica. Con l’eccezione di alcune testate nazionali a tiratura limitata ed alcune testate locali il livello di controllo del sistema mediatico è impressionante. Una capacità di indirizzo delle testate e di legame diretto con singoli giornalisti. È del resto notoria la meticolosità con cui i vari centri strategici americani curano le relazioni con i media istituzionali. Le campagne giornalistiche e la manipolazione dell’opinione pubblica sono sempre stati strumenti propedeutici al conflitto politico, al condizionamento dei centri e all’eliminazione degli avversari, anche se la diffusione dei network on line ha in parte facilitato la possibilità di centri politici alternativi e ridefinito le modalità di manipolazione dell’informazione. In Germania, nella fattispecie, colpisce il fatto che la componente più orientata ad una politica autonoma con la Russia, un tempo significativa, trovi sempre meno spazio mediatico e non riesca ormai da anni a creare una opinione pubblica favorevole a sostegno delle proprie scelte.
La chiave di lettura determinante per individuare il peso reale della Germania e la sua collocazione nelle dinamiche geopolitiche riguarda però il ruolo dell’economia nello stabilire il peso strategico e la condizione conflittuale di un paese.
Chi attribuisce alla Germania un ruolo di protagonista assoluto, di competitore e di antagonista di prim’ordine tende ad attribuire più o meno esplicitamente all’economia, nel migliore dei casi ai rapporti sociali economici, il ruolo preponderante e sovradeterminante gli altri ambiti delle attività umane, compresa quella politica, solitamente assumendo il seguente canovaccio.
UNO SCHEMA INTERPRETATIVO LIMITANTE E FUORVIANTE
La capacità di potenza si esprimerebbe soprattutto attraverso il peso economico; il campo preponderante di esercizio della competizione sarebbe il mercato; l’esercizio della potenza si realizzerebbe soprattutto attraverso la capacità commerciale; la sua misura si pondererebbe attraverso i dati macroeconomici del PIL, del saldo commerciale, degli attivi finanziari, nel migliore dei casi anche della presenza preponderante nel settore dei beni di consumo di massa più evoluti e durevoli. Scelte politiche non corrispondenti alla condizione economica sono considerate illogiche, sbagliate o semplicemente degli accidenti della storia destinati a rientrare o a determinare la sconfitta dei soggetti promotori.
Uno schema fuorviante sia in termini generali che affrontando una analisi della condizione della particolare economia tedesca.
Si può partire dalla constatazione che i mercati tengono conto e tendono a conformarsi progressivamente alle sfere di influenza politiche in via di formazione proprio perché gli attori economici privilegiano le condizioni di maggiore stabilità; le stesse grandi aziende, ormai da alcuni anni, tendono a riassumere il controllo diretto della verticale delle filiere produttive seguendo le condizioni di sicurezza politica. In una fase nella quale la leva economica, sotto forma di condizioni di finanziamento ed investimento e di apertura del mercato, di controllo tecnologico, addirittura dei prezzi in numerosi settori specie strategici, viene utilizzata non solo per condizionare, ma come strumento diretto di sanzione e conflitto, la funzione della politica emerge dalla maschera della competizione puramente economica tra gli attori.
Ma il politico, nella sua accezione di essenza, di caratteristica intrinseca, trova il modo di agire in maniera ancora più “subdola” nell’ambito economico; un esempio può essere l’invenzione, l’adozione, l’applicazione su base industriale e la padronanza delle tecnologie.
In Cina, ad esempio, il tentativo imponente di assumere la creazione e la padronanza delle tecnologie, uno dei fondamenti utili a garantire l’autonomia, l’autorevolezza e l’indipendenza delle decisioni della classe dirigente di un paese, passa anche attraverso lo scontro tra i sostenitori dei grandi colossi industriali, eredi delle imprese statali del periodo “socialista”, di fatto ancora sotto controllo politico diretto, e l’ampio settore di medie e piccole aziende, presenti nel sudest del paese molto più dipendenti dalle tecnologie e dai moduli organizzativi occidentali. Nel recente passato è sufficiente rispolverare alcuni casi, l’Olivetti in Italia e il sistema di motore a reazione Arrow in Canada tra i tanti, per constatare che la capacità tecnologica ed organizzativa di una azienda possono determinare gli standard di un mercato solo all’interno di contesti conformati politicamente.
Il mercato, infatti, rappresenta un’area, un campo di azione governato da un insieme di regole di natura politica, frutto di imposizioni e mediazioni, entro il quale agiscono gli attori economici; la rottura e la modifica di queste ultime comporta inevitabilmente ed intrinsecamente atti politici.
L’immagine che ancora si offre del mercato è invece troppo spesso fuorviante e semplicistica.
Il mercato globale viene rappresentato come una rete con un centro regolatorio indefinito e indefinibile; il suo innegabile sviluppo è però artificiosamente amplificato dalla frammentazione politica degli stati che ha trasformato in commercio estero gran parte degli scambi interni degli stati nazionali antecedenti il crollo del blocco sovietico; la sua rappresentazione glissa sull’esistenza e il rafforzamento al suo interno di aree, settori e blocchi attraverso i quali, tra l’altro si veicolano le influenze politiche.
La stessa raffigurazione degli organismi internazionali preposti alla regolazione di esso nasconde il fatto che tali regole non sono affatto neutrali e soddisfacenti in egual misura i vari attori, ma anche, più prosaicamente, che ammettono innumerevoli deroghe, omissioni, clausole particolari e comportamenti discriminatori che lasciano sospettare il peso politico differente dei paesi nella conduzione.
Gli esempi più clamorosi riguardano probabilmente il diverso trattamento riservato a Russia e Cina nei tempi di adesione agli organismi nonché nelle modalità e nella qualità dei trasferimenti di tecnologia occidentale; come pure il diverso trattamento riservato alle cosiddette Tigri Asiatiche e alla Corea del Sud rispetto ad alcuni paesi del Sud-America.
UNA RAPPRESENTAZIONE PIU’ ESAUSTIVA
Questo schema consente, probabilmente, una valutazione più realistica e meno enfatica del peso economico sia intrinseco che rispetto agli altri ambiti dell’azione politica nel determinare la forza geopolitica della Germania e, soprattutto, nel determinare i passi e le condizioni necessari a garantire la sua emersione come attore politico più autonomo.
 La Germania, a partire dalla fine degli anni ‘80, al pari di tutti i paesi, ha avviato un processo di profonda trasformazione economica concomitante e favorito dalla sua nuova collocazione geopolitica determinata dall’unificazione seguendo però proprie peculiarità.
La Germania, a partire dalla fine degli anni ‘80, al pari di tutti i paesi, ha avviato un processo di profonda trasformazione economica concomitante e favorito dalla sua nuova collocazione geopolitica determinata dall’unificazione seguendo però proprie peculiarità.
Ha salvaguardato ed accentuato il carattere dualistico del suo sistema finanziario trasformando, dopo l’uccisione di Herrhausen, la Deutschbank nella quinta banca di investimento al mondo dedita a servizi di consulenza e alla gestione dei nuovi e più speculativi prodotti finanziari e tutelando dalle intromissioni comunitarie il sistema di banche territoriali a tutela dei sistemi locali economici e sociali.
La difesa ostinata della sua politica restrittiva in ambito europeo non serve soltanto a indebolire i suoi concorrenti economici prossimi, l’Italia e la Francia, ma a difenderla dalle loro debolezze e, sinché possibile, dalle implicazioni più rischiose della sua esposizione nei circuiti finanziari dominati dal sistema angloamericano.
Ha governato con lungimiranza il processo di precarizzazione di larghi settori dell’economia industriale e dei servizi, analogo a quello di altri paesi, compensando parzialmente con il welfare pubblico la regressione socioeconomica di vaste aree sociali.
Ha saputo tutelare e sviluppare alcuni settori di produzione di beni di consumi di massa tradizionali ma relativamente più complessi (automobile, agroalimentare, meccanica) mantenendo il pieno controllo della catena produttiva e di valore e decentrando sapientemente la componentistica nei paesi dell’hinterland più affine non garantendo più la quasi esclusiva del settore all’Italia.
 L’attivo commerciale imponente che ne deriva è il frutto non solo di queste politiche, ma anche di un misconosciuto basso livello di investimenti sia pubblici, in particolare delle infrastrutture del paese, che, con sorpresa, privati rispetto ai più importanti paesi dello scacchiere mondiale. Un livello, specie in quelli pubblici che, protrattosi nel tempo analogamente alla condizione dell’Italia, rischia di pregiudicare le stesse capacità tecniche e tecnologiche di ricostruzione. Un attento esame del campione di immagine tedesco, la Volkswagen, rivela sorprendentemente i punti deboli, sopperiti sino ad ora da una indubbia capacità commerciale, del suo settore privato.
L’attivo commerciale imponente che ne deriva è il frutto non solo di queste politiche, ma anche di un misconosciuto basso livello di investimenti sia pubblici, in particolare delle infrastrutture del paese, che, con sorpresa, privati rispetto ai più importanti paesi dello scacchiere mondiale. Un livello, specie in quelli pubblici che, protrattosi nel tempo analogamente alla condizione dell’Italia, rischia di pregiudicare le stesse capacità tecniche e tecnologiche di ricostruzione. Un attento esame del campione di immagine tedesco, la Volkswagen, rivela sorprendentemente i punti deboli, sopperiti sino ad ora da una indubbia capacità commerciale, del suo settore privato.
L’economia tedesca, tra l’altro, è pervasa, più degli altri paesi europei dagli investimenti statunitensi in importanti settori così come dipende maggiormente dalle esportazioni in America.
La Germania è senz’altro presente in maniera significativa in alcuni settori importanti come quello dei beni industriali, della meccatronica, della chimica, del software applicato; ma è quasi del tutto assente, al pari degli altri paesi europei, nel settore del controllo e della gestione on line dei dati, fondamentale per il controllo dei flussi e dei comandi operativi nell’industria 4.0.
E’ in difficoltà in altri ambiti strategici, tra i quali l’avionica, l’aeronautica, il gps (Galileo) oggetto di ingenti investimenti soprattutto pubblici, frutto soprattutto di ricerche nell’ambito militare francese, ma pregiudicati dai dissidi di gestione tra i paesi cooperanti o dalle limitazioni nell’uso in ambito militare, frutto a loro volta delle imposizioni e delle premure americane.
Il progetto AIRBUS, gestito da Germania, Francia e Spagna, conosce così una fase di crisi acuta ed improvvisa, alimentata anche dai dissidi di gestione, la quale sta rinfocolando le ambizioni di una direzione avulsa dal controllo azionario e le voci di una possibile acquisizione da parte dell’americana General Electric; il progetto Galileo, invece, dopo anni di faticosa gestazione, avversato dalla stessa Commissione Europea al pari di Airbus, vede intaccato il proprio primato tecnologico dalla inibizione della possibilità di applicazione nell’ambito militare.
Sono solo due degli episodi, questi ultimi, rivelatori della dipendenza politica di quel paese in tutti gli ambiti, a partire ancora una volta da quelli prioritari istituzionali e mediatici.
Ci sarebbe anche da aggiungere le considerazioni sugli effetti della politica comunitaria tesa ad impedire sistematicamente la formazione di colossi industriali paragonabili con quelli americani e ultimamente cinesi, ma solo per constatare che la stessa Unione Europea è propedeutica al mantenimento di questa subordinazione dei paesi dell’intero continente.
LE INTENZIONI E LE POSSIBILITA’ DI AFFRANCAMENTO
Ogni atto politico, compresi quelli di politica economica, della classe dirigente germanica va valutato, quindi, secondo l’intenzione e la capacità di affrancamento da tale situazione.
A tutt’oggi non risultano passi decisivi in questa direzione.
Intanto l’aspirazione ad ottenere un vero e proprio trattato di pace apertamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da Francia e Gran Bretagna risulta ancora inevasa a distanza di settant’anni, con tutto quello che implica nei diritti e nella discrezionalità di forze militari ancora di occupazione; dal punto di vista istituzionale del ripristino del controllo effettivo su settori chiave dell’apparato statale lo sforzo appare più di immagine che effettivo; da quello invece del sistema di informazione e di formazione dell’opinione pubblica la situazione risulta ancora peggiorata visto il progressivo declino e l’incapacità persuasiva della residua classe dirigente ancora legata alla Oestpolitik.
La stessa crisi del Partito Socialdemocratico non fa che accentuare questa parabola; le lamentele e le rimostranze recenti della classe imprenditoriale tedesca riguardante l’esposizione eccessiva della Merkel contro la Presidenza di Trump sono per di più legate ai rischi di sanzioni commerciali legate al surplus commerciale.
Le tentazioni per una politica più autonoma ed indipendente certamente non mancano. Più che per forza propria potranno trovare ulteriore alimento dalle evidenti forzature che la politica estera americana, attualmente in fibrillazione, sta operando. Queste ultime, in particolare, ultimamente si stanno esercitando sugli ostacoli alla costruzione vitale del secondo gasdotto Northstream tra Russia e Germania in grado di rafforzare il ruolo di hub europeo e di controllore essenziale delle forniture nel continente e sulle pressioni per un aumento dei bilanci di spesa militare. Un loro significativo incremento potrebbe indurre al rafforzamento di un proprio complesso industriale militare propedeutico alla nascita di una struttura di difesa autonoma; una eventualità, però, in controtendenza con le attuali pulsioni autodistruttive operanti sia in Germania che nella stessa Francia.
Lo stesso progetto di cooperazione militare rafforzata portato avanti ultimamente e strombazzato dalla Germania presenta numerosi aspetti di ambiguità:
-
nasce sulle ceneri dell’ipotesi di integrazione delle forze armate tedesche e francesi fallita ad inizio secolo;
-
punta all’integrazione di paesi (Olanda, Romania, Rep. Ceka) appartenenti all’area di influenza tedesca ma particolarmente legati, in funzione antirussa, all’establishment statunitense;
-
si tratta ancora di forze limitate tese, probabilmente, più a compensare la debolezza delle forze operative tedesche e il timore di affrontare le conseguenze esterne di un più pesante riarmo diretto;
-
il debole coinvolgimento della Francia e l’assenza dell’Italia lascia intravedere una funzione di contenimento di questi paesi piuttosto che di affrancamento dalla tutela americana;
-
negli ultimi anni, il carattere antirusso della politica estera tedesca si è ulteriormente accentuato e rischia di diventare irreversibile, non ostante le relazioni economiche non corrispondano esattamente ai proclami sanzionatori; questo comporta dei riflessi diretti nelle opzioni militari.
 CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
In realtà l’attuale classe dirigente tedesca, rispetto al quale non risultano emergere forze alternative credibili, tende inesorabilmente a cacciarsi in una situazione analoga a quella che la hanno trascinata nelle due ultime rovinose guerre mondiali.
Non ha la forza e le caratteristiche per diventare, da sola, l’artefice di un polo politico comparabile con quelli in via di formazione, in competizione con gli Stati Uniti; per ambire a tale condizione dovrebbe puntare razionalmente a stringere un sodalizio meno squilibrato e su basi più paritarie in via prioritaria con la Francia e l’Italia e su questo costruire un rapporto costruttivo con la Russia. Questo implica una ridefinizione dei rapporti e un’azione verso la maggior parte dei paesi dell’Europa Orientale e quelli scandinavi che agevoli un ricambio di quelle classi dirigenti così oltranziste, impegnate ad affermare la propria identità e rafforzare la loro circoscritta influenza regionale a scapito della Russia, scegliendo la via apparentemente più comoda ed immediata: una alleanza politica sempre più stretta con gli Stati Uniti attualmente praticabile soprattutto grazie alla garanzia del retroterra tedesco, ma resa certamente più fragile da una sua defezione. Non si può dire certo che gli ingombranti vicini, Italia e Francia, concedano più di tanto qualche chance a questa eventualità. Una svolta quindi tanto più improbabile per l’azione ricorrente di Francia e Italia di “utilizzo” del potente d’oltreatlantico per regolare le controversie di vicinato in un processo di integrazione atlantista che sta coinvolgendo pesantemente, ormai anche la Francia, anche se non ancora, probabilmente, in maniera irreversibile. Si tratterebbe di rimettere in discussione le modalità di costruzione di un sistema di relazioni costruito negli ultimi trenta anni, laddove la posizione di vassallo privilegiato ha consentito di costruire una formazione sociale sufficientemente solida da garantire un largo consenso e discreti margini di azione.
Più che una subordinazione riottosa sembra per tanto, quello della Germania, un sodalizio consenziente per quanto prono. Una condizione che difficilmente può essere superata senza la formazione di poli alternativi che impediscano di continuare a lucrare sui saldi commerciali e senza un significativo indebolimento della potenza egemone ancora in gran parte da compiersi. L’alternativa, in mancanza di un recupero del controllo pieno delle leve di potere, potrebbe essere una fuga velleitaria in avanti, magari vellicata dalla stessa potenza egemone, propedeutica ad una terza pesante lezione storica.
E L’ITALIA?
In tale contesto inquadrare la collocazione dell’Italia come un paese dibattuto nella scelta tra il contendente tedesco e quello americano con una propensione iniziale per quella teutonica, appare una indicazione fuorviante; del tutto fuori luogo se, come statuisce la redazione di Limes, a questo dilemma corrisponde la formazione sul suolo italico di due blocchi in tenzone tra loro; quello economico sensibile alle sirene germaniche, quello istituzionale, degli apparati di sicurezza legato a quelle americane. Una contrapposizione che non offre una sintesi credibile semplicemente perché uno dei pilastri e ambiti del contenzioso, quello economico, non è assolutamente una prerogativa assoluta e nemmeno prevalente della Germania. La struttura economica italiana, negli ultimi trenta anni ha subito una drammatica perdita di controllo dei propri assetti strategici più importanti, superiore alla stesa distruzione dell’apparato produttivo. La gran parte di quelle attività sono finite in mano americana e poi francese, più che tedesca. È sufficiente scorrere i destini dell’industria aeronautica, dei generatori, della ceramica, della siderurgia specializzata, della meccanica, oltre che dei marchi alimentari, della moda e soprattutto della rete di telecomunicazioni per rivelare una penetrazione ben più articolata e preoccupante. I commensali del banchetto sono numerosi. È sufficiente orientare i propri padiglioni verso la voce dei corifei, tra i tanti Calenda, tutti impegnati ad identificare la globalizzazione con il mercato americano, per individuare le priorità stabilite dalla maggior parte della classe dirigente. L’impegno tedesco si è concentrato, piuttosto, sulla gestione del drenaggio del risparmio, sull’acquisizione di alcuni poli logistici necessari ai flussi dell’industria tedesca, sul controllo parziale ma indiretto della componentistica e sul ridimensionamento della capacità produttiva di un importante competitore.
DIFFICILMENTE
In realtà, sino a quando l’attuale classe dirigente tedesca riuscirà a mantenere in qualche maniera il controllo della costruzione europea per conto terzi, difficilmente la propensione tutta italica a costituire fazioni autodistruttive per conto di podestà stranieri potrà essere soddisfatta e la disputa occuperà inevitabilmente temi più rarefatti, come difficilmente il sodalizio tedesco-americano potrà incrinarsi significativamente, specie in una fase di restaurazione della politica americana ormai vincente.
Difficilmente, però, l’approccio offerto dalla redazione potrà offrire un contributo ad uno sforzo consapevole e proficuo di individuazione di un interesse nazionale capace di raccogliere il consenso delle parti più dinamiche e dignitose della comunità; come pure diventa alquanto arduo individuare, in Europa, nei vari paesi, le forze suscettibili di essere coinvolte.
Quanto alla Germania, se resurrezione dovrà essere, richiederà la realizzazione di numerose condizioni; i timidi vagiti richiederanno tempo per arrivare ad espressioni più articolate e razionali. La stessa formazione sociale tedesca inizia a conoscere importanti crepe nella sua proverbiale coesione con la erosione dei punti di garanzia e stabilità, ma anche di immobilismo. Si sta cominciando dal ruolo dei sindacati; ben presto toccherà anche il sistema periferico di promozione ed assistenza sociale. Bisognerà vedere se gli eventi, ormai incalzanti, concederanno il tempo necessario a compiere le svolte.




 I DUE PROTAGONISTI
I DUE PROTAGONISTI LA RIMOZIONE DI UN EVENTO EPOCALE
LA RIMOZIONE DI UN EVENTO EPOCALE La Germania, a partire dalla fine degli anni ‘80, al pari di tutti i paesi, ha avviato un processo di profonda trasformazione economica concomitante e favorito dalla sua nuova collocazione geopolitica determinata dall’unificazione seguendo però proprie peculiarità.
La Germania, a partire dalla fine degli anni ‘80, al pari di tutti i paesi, ha avviato un processo di profonda trasformazione economica concomitante e favorito dalla sua nuova collocazione geopolitica determinata dall’unificazione seguendo però proprie peculiarità. L’attivo commerciale imponente che ne deriva è il frutto non solo di queste politiche, ma anche di un misconosciuto basso livello di investimenti sia pubblici, in particolare delle infrastrutture del paese, che, con sorpresa, privati rispetto ai più importanti paesi dello scacchiere mondiale. Un livello, specie in quelli pubblici che, protrattosi nel tempo analogamente alla condizione dell’Italia, rischia di pregiudicare le stesse capacità tecniche e tecnologiche di ricostruzione. Un attento esame del campione di immagine tedesco, la Volkswagen, rivela sorprendentemente i punti deboli, sopperiti sino ad ora da una indubbia capacità commerciale, del suo settore privato.
L’attivo commerciale imponente che ne deriva è il frutto non solo di queste politiche, ma anche di un misconosciuto basso livello di investimenti sia pubblici, in particolare delle infrastrutture del paese, che, con sorpresa, privati rispetto ai più importanti paesi dello scacchiere mondiale. Un livello, specie in quelli pubblici che, protrattosi nel tempo analogamente alla condizione dell’Italia, rischia di pregiudicare le stesse capacità tecniche e tecnologiche di ricostruzione. Un attento esame del campione di immagine tedesco, la Volkswagen, rivela sorprendentemente i punti deboli, sopperiti sino ad ora da una indubbia capacità commerciale, del suo settore privato.







 È inoltre opportuno chiarire che nonostante i proclami per la creazione di un nuovo Airbus Navale, in grado di accelerare l’integrazione della Difesa Europea, Macron non metterà a sistema Europa tutti i suoi cantieri, ma solo quelli in difficoltà di Saint Nazaire, tenendo per la Francia i cantieri navali a più alto contenuto tecnologico, ovvero quelli in grado di costruire le unità militari più sofisticate fra cui i sottomarini, esattamente come già accaduto con l’Airbus Aeronautico. Anche in il quel caso la Francia tenne separati da Airbus, in mani esclusivamente francesi, gli stabilimenti della Dassault, da cui provengono gli ottimi caccia multiruolo Rafale (foto), con cui la Francia ha fatto, spesso con successo, concorrenza al consorzio europeo Eurofighter.
È inoltre opportuno chiarire che nonostante i proclami per la creazione di un nuovo Airbus Navale, in grado di accelerare l’integrazione della Difesa Europea, Macron non metterà a sistema Europa tutti i suoi cantieri, ma solo quelli in difficoltà di Saint Nazaire, tenendo per la Francia i cantieri navali a più alto contenuto tecnologico, ovvero quelli in grado di costruire le unità militari più sofisticate fra cui i sottomarini, esattamente come già accaduto con l’Airbus Aeronautico. Anche in il quel caso la Francia tenne separati da Airbus, in mani esclusivamente francesi, gli stabilimenti della Dassault, da cui provengono gli ottimi caccia multiruolo Rafale (foto), con cui la Francia ha fatto, spesso con successo, concorrenza al consorzio europeo Eurofighter. Ai meno ingenui tutta l’operazione appariva sin dall’inizio come il salvataggio di Saint Nazaire e non un’acquisizione per eliminare un pericoloso concorrente nel segmento delle grandi navi passeggeri, come veniva raccontato al pubblico italiano. Sarebbe stato assai più vantaggioso per Fincantieri lasciare che i cantieri di Saint Nazaire fallissero, senza accollare alla nostra finanza pubblica anche questo fardello. Anche la giustificazione addotta in merito alla mancanza di spazi per costruire navi passeggeri da 200.000 tonnellate non ha senso, visto che Fincantieri possiede a Palermo (foto) un bacino in muratura in grado di contenere navi di grandissimo tonnellaggio (300.000 tons.) molto superiore a quello richiesto per le nuove pur grandi navi passeggeri. Sarebbe bastato investire risorse nel cantiere siciliano invece che all’estero, per disporre di uno stabilimento in grado di reggere la concorrenza sulle navi passeggeri di grande taglia , sempre più richieste dagli armatori internazionali.
Ai meno ingenui tutta l’operazione appariva sin dall’inizio come il salvataggio di Saint Nazaire e non un’acquisizione per eliminare un pericoloso concorrente nel segmento delle grandi navi passeggeri, come veniva raccontato al pubblico italiano. Sarebbe stato assai più vantaggioso per Fincantieri lasciare che i cantieri di Saint Nazaire fallissero, senza accollare alla nostra finanza pubblica anche questo fardello. Anche la giustificazione addotta in merito alla mancanza di spazi per costruire navi passeggeri da 200.000 tonnellate non ha senso, visto che Fincantieri possiede a Palermo (foto) un bacino in muratura in grado di contenere navi di grandissimo tonnellaggio (300.000 tons.) molto superiore a quello richiesto per le nuove pur grandi navi passeggeri. Sarebbe bastato investire risorse nel cantiere siciliano invece che all’estero, per disporre di uno stabilimento in grado di reggere la concorrenza sulle navi passeggeri di grande taglia , sempre più richieste dagli armatori internazionali.