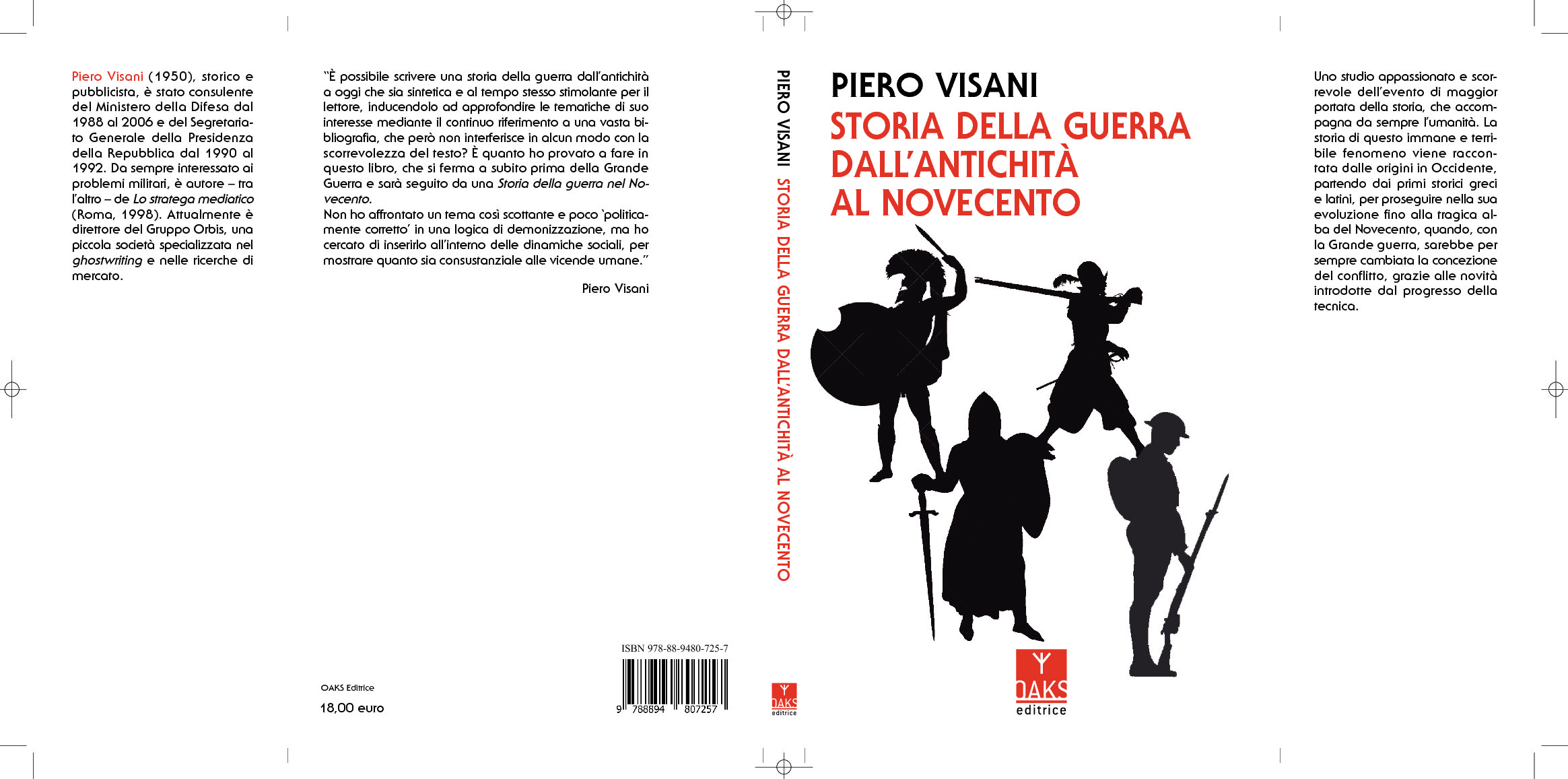Il sistema di costruzione e di controllo dominante della narrazione mediatica ha subito pesanti crepe nella capacità di imporre la propria rappresentazione. Lo stridore sempre più acuto con la realtà delle cose ha posto le basi di questa caduta di credibilità. La nascita di nuovi network ha offerto i luoghi di espressione di nuove possibilità di chiavi interpretative. Internet e la comunicazione telematica sono il veicolo principale e il campo di battaglia eletto per la ripresa del controllo. Il problema è che gli arbitri sono parte in causa del gioco politico. Non sono certo i centri decisionali di paesi come in Italia a poter condizionare tale gioco e tali decisioni. Né, per altro, nessuno dei paesi europei sembrano porsi il problema se non su alcuni aspetti parziali, come il progetto Galileo. Le capacità di condizionamento degli arbitri risiedono nei paesi sedi dei poteri di controllo sui server, guarda caso gli Stati Uniti. Anche a costo dello smascheramento della loro condizione, hanno iniziato in maniera concertata ha oscurare alcuni siti di larga informazione, infowars è l’ultima clamorosa vittima designata; in maniera più sofisticata stanno piegando gli algoritmi che determinano i risultati delle ricerche in base alle necessità politiche dominanti. La persecuzione politica efficace con i metodi più tradizionali avverrà dopo, se avrà pieno successo la prima fase. In Italia dobbiamo accontentarci di emuli, un po’ in ritardo e un po’ artigianali, di tali propositi. Qualche indagine giudiziaria apparentemente estemporanea; qualche gruppo organizzato nel segnalare agli arbitri giocatori, tra la tanta pattumiera, soprattutto le voci scomode. La presa sempre più ferrea sui sistemi tradizionali di comunicazione assecondata dalla persistente infatuazione berlusconiana verso Renzi, culminata con l’estromissione di Belpietro e Mario Giordano da Rete4 e il conseguente affidamento della rete agli accoliti di Matteo Renzi nonché la conduzione sempre più sfacciata de La7 sono per ora il piatto forte su cui si stanno concentrando i tentativi di ripristino, in attesa che sia definito lo scontro in ambito RAI, con la vergognosa vicenda del veto alla Presidenza di Marcello Foa. Segno ulteriore di quanto il penoso e miserabile declino di Berlusconi stia costando al paese. In questo contesto trova spazio l’ambizione e la fregola dei nuovi Savonarola che trovano posti accoglienti e ben remunerati nelle ormai pletoriche autorità di controllo per dare sfogo ai propri propositi moralistici e “politicamente corretti”. Buona lettura. Giuseppe Germinario
IL RECINTO IDEOLOGICO FILO-IMMIGRAZIONISTA: LAVORI IN CORSO.
tratto da http://www.progettoeurexit.it/il-recinto-ideologico-filo-immigrazionista-lavori-in-corso/
Commento alla delibera N. 403/18/CONS dell’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni)
Il 25 luglio scorso, con delibera n. 403/18/CONS, l’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) ha emesso la delibera avente ad oggetto “AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO IN MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL’HATE SPEECH E ALL’ISTIGAZIONE ALL’ODIO”.
Tale provvedimento è passato inosservato sui media mainstream, ma il suo contenuto è di fondamentale importanza per le implicazioni in esso contenute sulla regolamentazione dell’informazione nel nostro Paese. Ritengo dunque importante esporne il significato, analizzando i suoi passaggi più importanti.
Innanzitutto, la delibera concerne tutto il mondo delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, quindi l’intero sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, del quale viene richiamato il Testo Unico (D.Lgs. 177/2005).
Essa richiama, come presupposti del proprio intervento, fonti di diritto internazionale e sovranazionale, fra le quali:
- l’art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”;
- l’art. 1 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale delle Nazioni Unite del 1965, ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654: “l’espressione «discriminazione razziale» sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”;
- l’art. 4 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione, che prevede che “gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della presente Convenzione”. Tra queste misure lo stesso art. 4 prevede esplicitamente quelle finalizzate a “non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale”;
- la Raccomandazione di politica generale n. 15 della ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza del Consiglio d’Europa), relativa alla lotta contro il discorso dell’odio adottata l’8 dicembre 2015, che stimola gli Stati ad agire concretamente affinché ogni forma di discriminazione etnica sia contrastata ed eliminata, coerentemente con il diritto internazionale che tutela i diritti umani;
- l’art. 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 e in particolare il comma 1, secondo il quale “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”;
- la direttiva n. 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione Europea, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; l’art. 3-ter della direttiva n. 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, secondo il quale “Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”.
Inoltre, vengono richiamate norme nazionali come:
- l’art. 3 della Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;
- l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 : “L’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici”;
- l’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120: “I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”;
- la delibera n. 424/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante “Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento”, avente valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3, 32, comma 5, e dell’art. 34 del Testo unico, secondo il quale i programmi radio-televisivi nella diffusione di notizie devono “uniformarsi a criteri-verità, limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull’odio o sulla discriminazione, che incitino alla violenza fisica o verbale ovvero offendano la dignità̀ umana e la sensibilità degli utenti contribuendo in tal modo a creare un clima culturale e sociale caratterizzato da pregiudizi oppure interferendo con l’armonico sviluppo psichico e morale dei minori”, nonché devono “rivolgere particolare attenzione alla modalità di diffusione di notizie e di immagini sugli argomenti di attualità trattati avendo cura di procedere ad una veritiera e oggettiva rappresentazione dei flussi migratori, mirando a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dell’hate speech, contrastando il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni mediatiche”;
- la delibera n. 46/18/CONS, del 6 febbraio 2018, recante “Richiamo al rispetto della dignità umana e alla prevenzione dell’incitamento all’odio” con la quale l‘Autorità stessa ha richiamato “i fornitori di servizi media audiovisivi a garantire nei programmi di informazione e comunicazione il rispetto della dignità umana e a prevenire forme dirette o indirette di incitamento all’odio, basato su etnia, sesso, religione o nazionalità” alla luce dei dati di monitoraggio sul pluralismo politico/istituzionale relativi al periodo 29 gennaio-4 febbraio 2018 dai quali la trattazione di casi di cronaca relativi a reati commessi da immigrati appariva “orientata, in maniera strumentale, ad evidenziare un nesso di causalità tra immigrazione, criminalità e situazioni di disagio sociale e ad alimentare forme di pregiudizio razziale nei confronti dei cittadini stranieri immigrati in Italia, contravvenendo ai principi di non discriminazione e di tutela delle diversità etniche e culturali che i fornitori di servizi media audiovisivi sono tenuti ad osservare nell’esercizio dell’attività di diffusione radiotelevisiva”;
- il “Testo unico dei doveri del giornalista”, approvato dal Consiglio Nazionale dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 che stabilisce che “il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia; […] applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network”;
- l’art. 9 del “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, allegato al “Testo unico dei doveri del giornalista” sopra citato, che stabilisce che “nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali;
- la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.
Mi scuso per la prolissità del testo, dovuta all’elencazione delle fonti di cui sopra, ma la corretta comprensione della portata della delibera in esame non può prescindere dal quadro normativo richiamato.
Alla luce delle suddette norme e raccomandazioni, l’Autorità Garante esprime le proprie considerazioni, ovvero:
- che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, “i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira – devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, nonché con l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e con la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale” (e fin qui, nulla di nuovo);
- che “la crescente centralità, nel dibattito pubblico nazionale ed internazionale, delle politiche di governo dei flussi migratori provenienti da paesi in stato di guerra o di emergenza economico-sociale, sembra generare posizioni polarizzate e divisive in merito alla figura dello straniero e alla sua rappresentazione mediatica, favorendo generalizzazioni e stereotipi che minano la coesione sociale, nonché offendono la dignità della persona migrante o in ogni caso di categorie di persone oggetto di discorsi d’odio e di discriminazione su base etnica o religiosa” : qui parte il primo “affondo” alle politiche del Governo, evidentemente ritenute responsabili del generarsi delle “posizioni polarizzate e divisive” in merito alla “figura dello straniero” (con l’utilizzo del termine generico di “straniero” per indicare la categoria specifica del “migrante”, in via del tutto impropria), nonché foriere di “generalizzazioni e stereotipi” che (nell’ambito ristretto di cui si tratta, ovvero riguardo agli immigrati) “minano la coesione sociale”, “offendono la dignità della persona migrante (concetto nuovo e del tutto indefinito nelle sue caratteristiche) o comunque di “categorie di persone” (ancora più indefinito!) oggetto di “discorsi d’odio e di discriminazione su base etnica o religiosa”.
Mi fermo a commentare questa seconda considerazione, in quanto determinante e profondamente significativa. Con essa, il Garante espone la propria visione politica del contesto sociale attuale: egli ritiene dunque che il Governo in carica stia adottando politiche migratorie che creano divisioni e alimentano un clima di odio e pregiudizio. Né più né meno, ciò di cui le opposizioni di “sinistra” accusano quotidianamente, tramite tutti i media, il Ministro Matteo Salvini. Va sottolineato dunque, che l’interpretazione in chiave discriminatoria e disegualitaria delle politiche di controllo dell’immigrazione clandestina e lotta al traffico di esseri umani, poste in essere con decisione ed efficacia da questo Governo dopo anni di inerzia da parte dei Governi precedenti (in assoluta linearità rispetto a quelle intraprese dai Governi europei che ci sono stati regolarmente posti come esempi da emulare, ed a fronte della conclamata insostenibilità degli oneri economici, organizzativi e sociali che il fenomeno migratorio da cui il nostro continente è stato investito negli ultimi anni ha comportato e continua a comportare per l’Italia in misura enormemente maggiore rispetto agli altri Paesi europei, a causa della sua posizione geografica di “porta d’ingresso” nel Mediterraneo) è frutto di una visione distorta del fenomeno, dovuta all’orientamento politico di appartenenza e ampiamente veicolata dai media.
Ciò è vero, quantomeno, alla luce del fatto che metà del Paese (almeno) invece ha subito le precedenti politiche di accoglienza illimitata e incontrollata con disappunto e legittima preoccupazione, viste le evidenti (e indiscusse) ricadute negative in termini occupazionali, sociali, assistenziali e salariali sulla cittadinanza.
La coabitazione forzata fra cittadini colpiti dalla più grave crisi economica dal dopoguerra ed immigrati clandestini che vanno ad aumentare l’esercito di disoccupati e sottooccupati o lavoratori in nero (per non parlare degli addetti ad attività illecite) nel nostro già fragile sistema economico, non poteva altre che portare ad una reazione repulsiva da parte della popolazione autoctona. Non aver capito e previsto tale fenomeno, è la prima responsabilità dei governi di sinistra oggi relegati all’opposizione dall’elettorato, stanco di assistere ad un afflusso imponente e fuori controllo di immigrati clandestini.
Il modo per combattere le conseguenze di tale fenomeno, in termini di atteggiamento xenofobo o intollerante da parte della cittadinanza, avrebbe dovuto essere quello di rassicurare gli Italiani tramite maggiori controlli sugli ingressi irregolari, sulla gestione dei soggetti accolti nelle varie strutture di identificazione, con una ferrea applicazione delle norme di legge riguardanti rimpatri per i non aventi diritto all’asilo e alle espulsioni per i delinquenti. Invece, i cittadini hanno avuto di fronte un sistema colabrodo che non ha saputo minimamente garantire il rispetto della legalità e della sicurezza sul territorio, e i casi di cronaca con protagonisti immigrati irregolari si sono moltiplicati, alimentando la paura e il disagio sociale.
Le cause dei riportati fenomeni di discriminazione, odio o semplice insofferenza sono dunque da attribuire alle gestioni fallimentari perpetrate negli ultimi anni ed alle conseguenti ripercussioni sulla vita dei cittadini, anziché sull’informazione mediatica che ha – doverosamente – riportato i casi di cronaca coinvolgenti i “migranti”, come ha fatto per tutti gli altri.
L’assunto di partenza della delibera in esame, dunque, poggia su un’interpretazione delle cause della rilevata “crisi sociale” del tutto discutibile e di parte.
Le successive considerazioni espresse dal garante riguardano la necessaria correttezza ed obiettività, completezza ed imparzialità, nella diffusione di notizie, da parte dei fornitori di servizi dei media, “in ragione della pervasività del mezzo radiotelevisivo e dell’importante contributo che l’informazione radiotelevisiva svolge in ordine alla formazione di un’opinione pubblica sulla corretta rappresentazione dello straniero”, ed il contrasto alle strategie di disinformazione alimentate da notizie inesatte, tendenziose o non veritiere.
Su tale punto non si può non essere d’accordo, ma andrebbe rilevato che la disinformazione, con le modalità ivi censurate, viene molto più spesso effettuata dai mass media in altri ambiti (economia, politica, esteri) o nell’ambito in oggetto, ma in senso inverso a quello qui attenzionato: basta pensare al recentissimo caso dell’atleta di colore colpita da un uovo lanciato da un’autovettura, oggetto di un altisonante tam-tam mediatico con “allarme razzismo”, quando poi si è accertato che l’odio razziale aveva nulla a che fare con quell’episodio.
Il richiamo ai principi fondanti del giornalismo andrebbe pertanto esteso a tutte le tematiche materia di informazione, non solo a quella limitata ai “migranti”. Tale delimitazione appare, di per sè, come un intervento selettivo a beneficio di una categoria che già i cittadini percepiscono come “privilegiata” per il trattamento che riceve da parte dello Stato, sotto diversi aspetti, rispetto a quella dei residenti autoctoni.
Anche nell’accentuazione del dovere del fornitore del servizio di media di “assicurare la diffusione di notizie complete ed imparziali, che non siano idonee ad alimentare pregiudizi o convinzioni basate su discriminazioni derivanti da ragioni etniche, o di appartenenza religiosa o di sesso” si avverte una preoccupazione del Garante di assicurare la correttezza e imparzialità dell’informazione soltanto con riferimento a categorie selezionate di soggetti, come se gli altri fossero meno meritevoli di tutela.
Viene poi spiegato il significato del termine inglese “hate speech”, inspiegabilmente scelto dal Garante per individuare l’oggetto dell’intervento di contrasto, quando poi lo stesso necessita di traduzione e spiegazione nella lingua italiana. Esso viene individuato nell’ “utilizzo strategico di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o fomentare l’odio, la discriminazione e la violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche”.
Si denomina così il contenuto del divieto sancito nella prima parte dell’art. 604-bis del nostro Codice penale, secondo il quale “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Va da sè che, essendo previsto da una specifica norma penale, l’”hate speech” configura un reato nel nostro ordinamento, pertanto il contrasto allo stesso, qualsiasi sia il mezzo attraverso cui esso si manifesti, è già previsto da nostro sistema giuridico, con sanzioni penali (le più severe fra tutti i tipi di sanzioni giuridiche).
Ma anche qui, quando la fattispecie interessa i “migranti”, pare che alla stessa sia riconosciuta maggiore attenzione, e difatti il Garante richiama una norma internazionale che attribuisce la qualifica di “materiale razzista e xenofobo” a “qualsiasi materiale scritto, qualsiasi immagine o altra rappresentazione di idee o di teorie che incitino o incoraggino l’odio, la discriminazione o la violenza, contro una persona o un gruppo di persone, in ragione della razza, del colore, dell’ascendenza o dell’origine nazionale o etnica, o della religione, se questi fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti”.
Tale norma appare evidentemente indefinita nei suoi margini di applicazione, in quanto la dicitura “qualsiasi” e la locuzione “che incitino o incoraggino l’odio” possono ricomprendere anche immagini o comportamenti di per sè neutri ma che, da un punto di vista puramente soggettivo, possono essere percepiti anche in senso psicologicamente favorevole al sentimento dell’odio o di atteggiamenti discriminatori. L’applicazione di tale criterio per individuare materiale “razzista o xenofobo” può portare a considerare tale tutta una serie di dati, immagini o informazioni che i media dovrebbero poter utilizzare nella fornitura dei loro servizi senza per ciò soltanto incorrere in sanzioni.
Poiché invece il Garante pone un collegamento automatico, quasi necessario, fra i suddetti dati o comportamenti e gli “hate crimes”, altro termine inglese per indicare “i crimini generati dall’odio, prevalentemente basati su razzismo e xenofobia”, affermando che “in Italia, secondo gli ultimi dati diffusi nell’anno 2016 dall’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)”, gli stessi, “prevalentemente basati su razzismo e xenofobia, sono quasi raddoppiati nell’arco di un triennio”, e considerando così confermati “i timori di una possibile correlazione tra la crescente diffusione dei discorsi d’odio (hate speech) sui diversi media e l’incremento di aggressioni concrete e violente (hate harm), ancorché isolate, nei confronti di categorie di persone oggetto di azioni mirate”, egli ritiene che l’intervento regolamentare sia necessario e impellente, giustificandolo vieppiù con la presunta incidenza su tali fenomeni della “ribalta assunta, sui diversi media, dal dibattito pubblico nazionale ed internazionale sul governo delle politiche migratorie di soccorso umanitario, di accoglienza e di integrazione” (marcando ancora una volta la connotazione politica delle proprie argomentazioni).
È importante, a questo punto, ricordare come le Autorità indipendenti, categoria di cui fa parte l’AGCOM autrice delle delibera qui esaminata, secondo la più autorevole dottrina e la costante giurisprudenza, non devono avere, nella loro azione, alcuna connotazione politica (v. ad es. Caianiello V., Le Autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Rass. giur. en. el., 1997, p. 5.): le Autorità amministrative indipendenti, difatti, sono state concepite ed istituite per dare alle domande della società una risposta tecnica e indipendente e, quindi, non politica (per un’analisi più approfondita della figura delle A.A.I., vedi qui).
L’intento dell’Autorità garante, dunque, in continuità con la già invasiva delibera precedente della stessa Autorità n. 424/16/CONS, del 16 settembre 2016, appare chiaramente quello di voler irregimentare l’informazione massmediatica – nella consapevolezza della sua incontrollabile amplificazione tramite i social network – definendo in maniera puntuale e rigorosa i limiti ed i criteri che essa dovrà rispettare per non essere catalogata come “razzista e xenofoba” e per tale ragione, censurata e soggetta a sanzioni. Ciò va ben oltre il lodevole ed indiscutibile intento di garantire il rispetto dei diritti umani contro le discriminazioni di ogni tipo: il risultato di tali interventi consisterà in qualcosa di molto più grave, cioè un vera e propria censura verso ogni tipo di rappresentazione dei fatti e delle opinioni non sufficientemente “protettiva” verso eventuali possibili letture in senso biasimevole o discriminatorio verso i “migranti”.
È paradossale, peraltro, che nel predisporre tali strumenti di fatto distorsivi e mortificanti per la libertà, la completezza e l’obiettività dell’informazione, si richiamino norme tese a tutelare proprio tali valori, come l’art. 21 della Costituzione.
La conclusione è inquietante: il Garante afferma la necessità di fornire una regolamentazione di dettaglio del precetto contenuto nell’articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, il quale prescrive unicamente che “I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità” (prescrizioni già munite di tutela giuridica penalistica, tramite il disposto del richiamato art. 604-bis del codice penale) e si accinge a farlo attraverso un intervento che inciderà pesantemente (e vedremo se, ed in che misura, entro i limiti consentiti) sulle libertà democratiche fondamentali garantite dalla nostra Costituzione, come la libertà di informazione e di espressione!
Sarà fondamentale, dunque, al momento della pubblicazione di tale atto, una disamina attenta dello stesso da parte dei soggetti legittimati ed interessati (non ultimo, lo stesso Ordine dei Giornalisti), per segnalarne immediatamente eventuali profili ingiustificatamente lesivi delle suddette libertà democratiche costituzionalmente garantite, scongiurando così che, per vie amministrative, sciolte da ogni valutazione politica e giudiziaria, si trasformi la nostra Repubblica democratica in un sistema di governo etero-gestito, tramite un subdolo controllo totalitario dell’informazione e delle comunicazioni, al fine di nascondere alla pubblica opinione ogni fatto o ragionamento che possa orientarne il pensiero ed il libero giudizio in maniera difforme dalla volontà di chi promuove un travaso irreversibile dei popoli africani verso l’Europa.
Francesca Donato