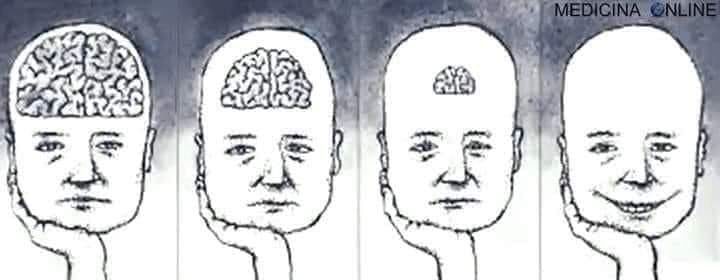La prima parte di un articolo tratto da “Le Grand Continent” su Trump e il prosieguo dello scontro politico negli Stati Uniti. Ho detto prosieguo, non ho parlato di eredità. Per il resto affidatevi agli ormai innumerevoli scritti e podcast del sito_Giuseppe Germinario
Trump è solo un sintomo di tendenze più profonde è probabilmente la frase che sentiamo più spesso su questo straordinario presidente. È corretto, se capiamo anche che è un sintomo di uno stadio avanzato, ma di cosa? Non è un presidente “normale”, al di là anche del carattere e dei suoi eccessi, nel senso dell’arrivo attraverso di lui dell’estrema destra alla Casa Bianca. Ma rappresenta effettivamente il risultato logico.di due sviluppi americani: quello del connubio tra politica e “spettacolo” mediatico, e quello del Partito Repubblicano per 40 anni, prodotto di una strategia teorizzata in particolare da Newt Gingrich per rilevare il Congresso negli anni ’80, e i cui segni distintivi sono un discorso sempre più disinibito “anti-sistema e anti-élite”.
La presidenza Trump rappresenta anche un momento specifico per la politica estera americana, di cui cristallizza una doppia crisi: crisi interna, perché la politica estera non è più sostenuta dal popolo americano, e in particolare dalle classi medie e popolari; crisi esterna, che è allo stesso tempo crisi di mezzi, credibilità e legittimità della politica estera, legata al relativo declino del potere e della capacità di influenza degli Stati Uniti. Questa crisi è germogliata dalla fine della Guerra Fredda, e qui va ricordato che lo slogan America First , che risale alla fine degli anni ’30, era già riapparso nel 1992 con la candidatura di Pat Buchanan, considerato il padre spirituale. Trumpismo. Ma Trump, dopo Bush e Obama, sta in qualche modo portando a compimento il processo. E la prima cosa da riconoscere è che ha provocato negli Stati Uniti il più ampio dibattito sugli obiettivi, i mezzi e le finalità della politica estera degli ultimi decenni – dove Obama, di cui anche ambizione, non era riuscita. Nel 2016 ci siamo chiesti se la “moderazione strategica” di Obama, il suo desiderio di disimpegnarsi e rinnovare la leadership americana fosse un’eccezione, un semplice riequilibrio dopo l’eccessiva espansione degli anni di Bush, o una nuova tendenza nella politica estera americana: con Trump che segue Obama, abbiamo la conferma che c’è una forte tendenza al lavoro.
La prima cosa che dobbiamo riconoscere in Trump è che ha provocato negli Stati Uniti il più ampio dibattito sugli obiettivi, i mezzi e le finalità della politica estera degli ultimi decenni – dove Obama, di cui era anche ambizione, non era riuscita.
MAYA KANDEL
Ciò solleva la questione della natura e della portata della rottura di Trump in politica estera, e in particolare del suo punto di riferimento: fine del periodo aperto dalla fine della Guerra Fredda, messa in discussione delle basi della Pax Americana. post-1945, o addirittura indietro nel diciannovesimo secolo politico e … il dibattito non è ancora risolto, e per tutto il suo mandato, le grandi linee guida sono state oggetto di intense lotte all’interno del amministrazione come tra la Casa Bianca e il Congresso. Analisi del processo decisionalefa luce su questa lotta costante tra il presidente populista e il “sistema”, definito come il gruppo formato dagli alti funzionari della pubblica amministrazione e dalle nomine politiche (più di 8.000), e più in generale dall’insieme della burocrazia e da altri istituzioni che partecipano alla politica estera, in primo luogo il Congresso. Tieni presente che la macchina della politica estera degli Stati Uniti è una nave di linea enorme e un cambio di direzione richiede tempo. Oltre a ciò, è anche necessario interessarsi alla battaglia delle idee, perché se Trump non è un intellettuale, è circondato da ideologi che hanno teorizzato per lui e hanno partecipato alla definizione di una nuova visione del mondo, ancora in gestazione.

Questa domanda è cruciale anche perché la ridefinizione del rapporto americano con il mondo è stata al centro della campagna di Trump nel 2016 e rimane centrale nelle preoccupazioni della sua base elettorale, sia che si tratti dell’apertura delle frontiere al mondo. immigrazione e commercio, questione delle alleanze o modalità dell’azione internazionale del Paese. Con l’idea che la politica estera non fosse più al servizio degli americani, che gli alleati come avversari stessero “approfittando” dell’America, con un fortissimo rifiuto dell’istituzione della politica estera, dei Democratici repubblicani e in particolare della neoconservatori, considerati colpevoli delle guerre costose e “infinite” (e infruttuose).
La ridefinizione del rapporto americano con il mondo è stata al centro della campagna di Trump nel 2016 e rimane al centro delle preoccupazioni della sua base elettorale, sia che si tratti dell’apertura delle frontiere all’immigrazione e al commercio, la questione delle alleanze, ovvero le modalità dell’azione internazionale del Paese.
MAYA KANDEL
L’idea di ridefinire una politica estera veramente al servizio degli americani, in particolare della classe media e operaia, di riconciliare la politica estera e quella interna, è presente anche su entrambi i lati dello spettro politico americano, e soprattutto ai suoi estremi, una base trumpista. come base progressista dei Democratici. L’evoluzione del contesto internazionale sotto il doppio effetto della globalizzazione e dei social network fa sì che la distinzione tra soggetti esterni ed interni appaia sempre più artificiosa: le grandi questioni internazionali sono largamente presenti nel dibattito pubblico, e gli argomenti sono di sempre più intrecciati. Si legge spesso, come nel 2016, che la politica estera non conta nelle elezioni: ma anche affrontata dal punto di vista della politica interna, questioni come la Cina, la Russia, il commercio o il clima rimangono soggetti internazionali, oggetto di politica estera. Infine, la polarizzazione si è estesa alla politica estera, comprese le questioni regionali, rendendo definitivamente obsoleto il classico adagio americano secondo cui “la politica si ferma in riva al mare” (la politica si ferma in riva al mare ), un detto rivelatore pronunciato dal senatore Vandenberg all’alba della Guerra Fredda: questo è anche ciò che oggi viene messo in discussione, e lo testimonia la polarizzazione della politica estera.
Ciò che colpisce di più alla fine del primo mandato di Trump, quando si guarda all’opinione americana, non è solo l’estrema polarizzazione, ma anche l’estrema stabilità del suo sostegno: qualunque cosa faccia o dica, Trump mantiene un base del 40% di parere favorevole; la sua popolarità tra l’elettorato repubblicano ha raggiunto il 90%, anche se nel 2020 risente della gestione della pandemia. Questa base elettorale del Trumpismo non scomparirà, anche se perde le elezioni. Ci costringe a mettere in discussione ciò che dice del Trumpismo, della sua visione del mondo in particolare e del suo peso nelle future ridefinizioni del Partito Repubblicano.
L’evoluzione del contesto internazionale sotto il duplice effetto della globalizzazione e dei social network fa sì che la distinzione tra soggetti esterni ed interni appaia sempre più artificiosa: le grandi questioni internazionali sono largamente presenti nel dibattito pubblico, e gli argomenti sono di sempre più intrecciati.
MAYA KANDEL
Trump e la fine del periodo post-guerra fredda
La presidenza di Donald Trump segna la fine dell’era post-Guerra Fredda. La politica estera americana di questo periodo potrebbe essere riassunta da un doppio paradigma. Il primo è quello della globalizzazione, che caratterizza un’evoluzione globale ma che designa anche la linea guida della dottrina Clinton di “estensione delle democrazie di mercato”, e più in generale la globalizzazione dell’ordine internazionale creato e sostenuto dagli Stati Uniti. all’indomani della seconda guerra mondiale, le cui istituzioni, norme e principi sembravano quindi poter essere estesi a tutto il globo con la caduta dell’Unione Sovietica e del blocco omonimo. Il secondo, dall’11 settembre 2001, è quella della “guerra mondiale al terrore” di Bush, portata avanti anche se con mezzi più discreti da Obama.

Trump voleva rivoluzionare la politica estera americana e questo desiderio di ridefinire il rapporto dell’America con il mondo era al centro delle sue promesse elettorali. Quattro anni dopo, sembra che il cambio di paradigma sia effettivamente avvenuto: la competizione strategica e più precisamente la rivalità “sistemica” con la Cina.ha sostituito la lotta al terrorismo come obiettivo principale della politica estera; la pagina sull’estensione delle democrazie di mercato è voltata. La sua presidenza ha sancito il rifiuto del principio guida della politica estera americana del dopoguerra fredda, secondo cui l’inclusione dei rivali nel sistema internazionale li renderebbe “partner responsabili” degli Stati Uniti: i documenti strategici degli Stati Uniti. L’amministrazione si apre sull’osservazione del fallimento di questa politica. Mettendo in discussione il multilateralismo e le sue istituzioni, l’America di Trump sembra trasformarsi in un “partner irresponsabile” che rifiuta questo ordine internazionale che aveva finora garantito,
L’era Trump sancisce il rifiuto del principio guida della politica estera americana del dopoguerra fredda, secondo cui l’inclusione dei rivali nel sistema internazionale li renderebbe “partner responsabili” degli Stati Uniti: i documenti strategici dell’amministrazione Trump aperta all’osservazione del fallimento di questa politica.
MAYA KANDEL
Tuttavia, resta difficile definire il “trumpismo” in politica estera: mettere in discussione i principi guida della politica estera non significa tornare all’isolazionismo degli anni Trenta, o alla politica estera essenzialmente commerciale del XIX secolo. secolo. La difficoltà nell’interpretare la politica estera di Trump deriva dalle molteplici contraddizioni di questa politica su più temi, legati al caotico processo decisionale, oggetto di continue lotte, ma anche alla personalità del presidente; soprattutto il trumpismo, che qui caratterizza la mutazione del Partito Repubblicano sotto l’influenza della base elettorale di Trump, è ancora in gestazione, oggetto di lotte interne che si intensificheranno dopo le elezioni e di un vivace dibattito di idee, che non può prescindere dall’evoluzione demografica dell’America.
Trump non è un ideologo o un intellettuale ma ha istinti e ossessioni, e ha governato per la sua base elettorale, che fa luce sulle motivazioni interne di molte decisioni di politica estera, soprattutto in Medio Oriente. Soprattutto altri hanno teorizzato per lui, se sono ancora alla Casa Bianca dopo quattro anni, come Stephen Miller, Pete Navarro o Matt Pottinger, o sono stati solo un compagno di viaggio, come Steve Bannon o John Bolton. La longevità di Miller, Navarro e Pottinger dà già indicazioni sull’eredità: nazionalismo “giudeo-cristiano”, governance anti-global e anti-multilateralismo ( anti-immigration); politica commerciale anti-libero e anti-cinese; adottare una posizione dura contro la Cina. La dichiarata “ nuova guerra fredda ” contro la Cina è stata avallata ai massimi livelli nell’ottobre 2018 con il discorso del vicepresidente Mike Pence: ma per farlo ci sono voluti la pandemia e l’approssimarsi delle elezioni per Trump. si è ripreso nel marzo 2020, approvando il consenso.
Ci sono voluti la pandemia e l’approssimarsi delle elezioni affinché Trump si radunasse nel marzo 2020 sulla dottrina della “nuova guerra fredda”, approvando il consenso.
MAYA KANDEL
Mirare e premiare i gruppi identificati ha portato ad alcune decisioni soprattutto su Israele, a causa del patto fatto tra Trump e gli evangelici nel 2016, ovvero il clima, con la scelta del “primato energetico” visualizzato come obiettivo strategico, sempre determinato in buona parte da un accordo concluso nel 2016 con i maggiori gruppi petroliferi. Alcune scelte di politica industriale e commerciale hanno soddisfatto anche le aspettative degli elettori chiave che hanno vinto Trump nella Rust Belt (Michigan, Pennsylvania), una regione più colpita dalle delocalizzazioni ma anche dall’abbandono del carbone. L’agenda anti-Obama risponde a un’ossessione personale di Trump, ma anche al movimento del Tea Party (di cui l’elezione di Trump è anche l’espressione di maggior successo), e ha portato alla distruzione metodica dell’eredità La politica estera di Obama (uscita dall’accordo di Parigi, accordo sul nucleare iraniano, apertura a Cuba e ovviamente denuncia immediata del TPP). Mentre alcuni elementi avrebbero potuto trovare il loro posto in un’amministrazione repubblicana più classica (Iran, clima), altri costituiscono una rottura e sono stati oggetto di un’aspra lotta, non sempre netta, tra la Casa Bianca e il Congresso in particolare. Ciò spiega la natura schizofrenica, anche la duplice politica estera che ha colpito principalmente l’Europa, o gli strumenti di politica estera: è stato il Congresso e in particolare il Senato repubblicano a difendere la NATO, ha aumentato la spesa degli Stati Uniti per la deterrenza sul fianco orientale dell’Europa, ha rafforzato la sua posizione nei confronti della Russia e ha protetto il bilancio della diplomazia dai ripetuti attacchi della Casa Bianca. altri costituiscono una rottura e sono stati oggetto di un’aspra lotta, non sempre netta, tra la Casa Bianca e il Congresso in particolare. Questo spiega la natura schizofrenica, anche la doppia politica estera che riguardava principalmente l’Europa, o gli strumenti di politica estera: era il Congresso e in particolare il Senato repubblicano a difendere la NATO, ha aumentato la spesa degli Stati Uniti per la deterrenza sul fianco orientale dell’Europa, ha rafforzato la sua posizione nei confronti della Russia e ha protetto il bilancio della diplomazia dai ripetuti attacchi della Casa Bianca. altri costituiscono una rottura e sono stati oggetto di un’aspra lotta, non sempre netta, in particolare tra la Casa Bianca e il Congresso. Questo spiega la natura schizofrenica, anche la doppia politica estera che riguardava principalmente l’Europa, o gli strumenti di politica estera: era il Congresso e in particolare il Senato repubblicano a difendere la NATO, ha aumentato la spesa degli Stati Uniti per la deterrenza sul fianco orientale dell’Europa, ha rafforzato la sua posizione nei confronti della Russia e ha protetto il bilancio della diplomazia dai ripetuti attacchi della Casa Bianca.
Queste contraddizioni illustrano la sostenibilità di diverse correnti di politica estera all’interno del Partito Repubblicano, anche se il partito si è schierato con Trump (hanno gli stessi elettori), segno di tensioni persistenti all’interno della nuova alleanza portata da Trump tra isolazionisti. e nazionalisti, a scapito degli interventisti assimilati ai neoconservatori e respinti dagli elettori trumpisti. Uno degli aspetti più commentati da accademici ed esperti è stata la “distruzione dell’ordine liberale internazionale”: illustra l’ascesa e il controllo della corrente sovranista sul Partito Repubblicano, simboleggiata da Bolton, un effimero compagno di viaggio. Trumpismo, che ha saputo usare Trump per portare avanti la sua personale crociata contro il governo mondiale.America Firstin una parola sarebbe nazionalismo (o nazional-populismo per evocare la circolazione transatlantica e l’importanza del contesto). Troviamo qui l’influenza di Bannon e Miller, ma anche del Claremont Institute, think tank sulla West Coast e fornitore ufficiale di idee al Trumpismo, che si è mobilitato molto presto alla candidatura di Trump, con Michael Anton, appunto. sulla politica estera. Altri si sono mobilitati, con obiettivi meno chiari (sintesi difficile) come l’Hudson, dove Pence ha tenuto il discorso di apertura delle ostilità sulla Cina nell’ottobre 2018 – ma ci sono voluti meno la pandemia e un’improvvisa scadenza elettorale ben avviato affinché Trump si mobiliti dietro il consenso tra agenzie della sua stessa amministrazione. Una “nuova guerra fredda” contro la Cina permette anche di mobilitare gli internazionalisti, compresi i primi e ancora neoconservatori. Tuttavia, sul piano della politica estera appunto, la sintesi intellettuale non è completata – e il dibattito non è risolto: permane una forte tensione tra la tentazione isolazionista, favorevole a un trinceramento degli Stati Uniti dietro i loro confini, e tendenza egemonica in cui la supremazia militare rimane essenziale.
Uno degli aspetti più commentati da accademici ed esperti è stata la “distruzione dell’ordine liberale internazionale”: illustra l’ascesa e la morsa della corrente sovranista sul partito repubblicano, simboleggiata da Bolton, un effimero compagno di viaggio. Trumpismo, che ha saputo usare Trump per portare avanti la sua personale crociata contro il governo mondiale.
MAYA KANDEL
Una nuova sintesi repubblicana: il ritorno degli isolazionisti
Il politologo americano Colin Dueck, specializzato nello studio della politica estera del Partito Repubblicano, ha dimostrato che ci sono tre principali correnti di politica estera all’interno del Partito Repubblicano. La prima corrente, dominante nelle élite del partito dal 1945, è la corrente internazionalista. Tutti i presidenti repubblicani, da Eisenhower a Trump, erano internazionalisti, favorevoli a un’attivista politica estera americana, che difendevano l’ordine internazionale stabilito dopo la seconda guerra mondiale e si affidavano soprattutto alle istituzioni internazionali e ad un sistema di alleanze tra Stati Uniti al centro e in posizione di leadership. Questa corrente è composta da realisti e neoconservatori, questi ultimi che hanno ottenuto l’ascesa con la presidenza Reagan.
La seconda corrente può essere definita isolazionista e ha dominato il Partito Repubblicano in particolare negli anni ’20 e ’30. È particolarmente contrario alle alleanze vincolanti e agli interventi militari non difensivi (si pensi, ad esempio, alla mancata ratifica del Trattato di Versailles nel 1919 e alla non partecipazione degli Stati Uniti alla Società delle Nazioni). Di ispirazione libertaria, è stata ancorata nel DNA americano sin dall’inizio ma è stata emarginata durante la Guerra Fredda a causa dell’imperativo di combattere il comunismo. È riemerso con forza alla fine della Guerra Fredda, con una pausa dopo gli attacchi del 2001, ed è rappresentato tra gli altri da Rand Paul (e suo padre Ron prima di lui), oggi uno dei convinti sostenitori di Trump. al Senato.
Questa corrente nazionalista ben rappresenta il punto di vista della politica estera del Tea Party, a favore di un alto livello di spesa militare e di un atteggiamento più aggressivo contro il terrorismo, come Trump.
MAYA KANDEL
Infine, la terza corrente è soprattutto nazionalista, e fino a quando Trump è rimasto poco rappresentato a livello di élite e nei think tank , un vuoto che il Claremont Institute è venuto a colmare, cui si sono aggiunti altri che si sono uniti al Trumpismo abbracciando la lotta contro la sfida cinese alla supremazia americana (Hudson). Questa corrente nazionalista ben rappresenta il punto di vista della politica estera del Tea Party, favorevole ad un alto livello di spesa militare e ad un atteggiamento più aggressivo contro il terrorismo, come Trump. I nazionalisti non sono né pacifisti né isolazionisti, ma sono davvero ostili agli interventi umanitari o di costruzione della nazione , agli aiuti esteri, alle istituzioni internazionali in generale e allel’idea di governance globale : sono feroci difensori della sovranità americana.
Storicamente, i nazionalisti sono stati la spina dorsale del Partito Repubblicano sulle questioni internazionali, un gruppo il cui sostegno era indispensabile per qualsiasi intervento militare importante e duraturo. La loro alleanza con gli internazionalisti ha sostenuto l’attivismo americano durante la Guerra Fredda, così come nell’immediato periodo successivo all’11 settembre 2001. In tutto questo periodo, gli internazionalisti hanno dominato ei non interventisti sono stati emarginati. Ma Trump ha favorito l’emergere di una nuova alleanza tra non interventisti e nazionalisti, questa volta marginalizzando gli internazionalisti, identificati con i neoconservatori e quindi con le élite di partito in politica estera. È questa alleanza che non ha precedenti dagli anni ’30. Dopo quattro anni del presidente Trump, sembra aver prodotto una nuova postura se non una dottrina, articolata attorno a una politica estera soprattutto economico-legale (sanzioni), e una nuova guerra fredda almeno in campo commerciale e tecnologico con la Cina . L’ultimo libro di Colin Dueck è intitolato altroveAge of Iron: sul nazionalismo conservatore .
Trump ha favorito l’emergere di una nuova alleanza tra non interventisti e nazionalisti, questa volta emarginando internazionalisti, identificati con neoconservatori e quindi con élite di partito in politica estera.
MAYA KANDEL
Una politica estera “jacksoniana”: sovranità e bilateralismo
Molti osservatori insistono giustamente sugli elementi di continuità tra la politica estera di Trump e quella del suo predecessore democratico, Barack Obama, in particolare il duplice desiderio di disimpegnarsi dal Medio Oriente e di orientarsi verso l’Asia. A questo potremmo aggiungere il rifiuto di essere il “poliziotto del mondo”, cioè il garante dell’ordine internazionale, per Obama perché gli Stati Uniti non avrebbero più i mezzi, per Trump perché che non sarebbe più nel loro interesse: in entrambi i casi gli alleati sono chiamati a fare di più, gli avversari trovano nuove opportunità. Ma questi elementi non dovrebbero mascherare la vera rottura, il rifiuto del principio guida della politica estera americana del dopoguerra fredda, secondo cui l’inclusione dei rivali nell’architettura internazionale (istituzioni e regole) dovrebbe renderli “partner responsabili” degli Stati Uniti nella difesa della sicurezza e della prosperità globali (Cina all’OMC, Russia al G7). Ildocumenti strategici dell’amministrazione Trump aperti sull’osservazione del fallimento di questo approccio. La sua amministrazione ritiene che questa architettura internazionale non sia più adatta all’attuale sistema internazionale e intende aggiornare i suoi elementi principali per adattarli al nuovo contesto, quello della rivalità americano-cinese: si tratta infatti di reinventare le istituzioni, alleanze e determinate regole, in particolare a livello commerciale e tecnologico.

Il “trumpismo” in politica estera è stato chiamato Jacksonian: nella tipologiadefinito dallo storico Walter Russell Mead, Jacksonism, in riferimento ad Andrew Jackson, un presidente populista e nazionalista che ha ampliato il voto popolare e accelerato la “pulizia etnica” dei nativi americani, descrive una politica estera basata su una ristretta ridefinizione degli interessi americani , sollevando soprattutto l’imperativo della sovranità, necessaria per preservare la libertà d’azione americana: la politica estera jacksoniana rifiuta ogni missione universale a favore della sola realpolitik. Il Jacksonismo della “dottrina Trump” si è tradotto in un assalto generalizzato al “globalismo” rispondendo soprattutto alle motivazioni interne della base elettorale trumpiana, rappresentati da americani che si considerano i perdenti della globalizzazione a vantaggio di una “élite globalizzata” vista come il nemico, anche come anti-americano. Si è manifestato attraverso gli attacchi sistematici contro le alleanze e le istituzioni internazionali – dalla NATO all’ONU, al G7 e all’OMC , il cui meccanismo di risoluzione delle controversie è stato reso de facto inoperante da Washington, o oggi contro l’OMS; o anche attraverso il ritiro definitivo dell’UNESCO o della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il tutto riflette questo assalto generalizzato a ciò che Trump e la sua base chiamano “globalismo” e al quale si oppongono al nazionalismo dell’America First line .
Il Jacksonismo della “dottrina Trump” si è risolto in un assalto generalizzato al “globalismo” rispondendo soprattutto alle motivazioni interne della base elettorale trumpiana, rappresentata dagli americani che si considerano i perdenti della globalizzazione a favore della una “élite globalizzata” considerata come il nemico, anche come anti-americano.
MAYA KANDEL
Gli americani erano soliti chiamarsi “multilateralisti quando possiamo, unilateralisti quando dobbiamo”. L’attuale rifiuto del multilateralismo riflette anche il relativo declino del potere americano, dovuto all’ascesa della Cina, molto visibile all’interno delle organizzazioni internazionali. Gli Stati Uniti erano multilateralisti, o perché erano abbastanza potenti perché la loro volontà si imponesse, o perché potevano permettersi un risultato meno ottimale, ma alla fine giustificato dall’imperativo superiore. per mantenere la stabilità egemonica. Questo margine di manovra è ormai scomparso e gli Stati Uniti sono unilateralisti soprattutto perché non sono più così potenti relativamente. Sono anche piuttosto “bilaterali”, per usare l’ analisi di David Haglund, gestione ottimale di un potere che ancora domina qualsiasi rapporto bilaterale.
Questa scelta è inseparabile dall’evoluzione ideologica del Partito Repubblicano in un partito sovranista, uno dei cui slogan è l’opposizione viscerale al governo mondiale in nome dell’indipendenza nazionale, della libertà di azione e legittimità unica della Costituzione degli Stati Uniti. Dagli anni ’90, in uno sviluppo quindi in gran parte antecedente a Trump, il Partito Repubblicano ha progressivamente adottato un’opposizione sistematica all’ONU ma anche più in generale alla diplomazia, al multilateralismo e ad ogni forma di accordo internazionale, opponendosi alla ratifica di quasi tutti i trattati. Pertanto, anche trattati come quello delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o il trattato sui diritti delle persone disabili ( Disability Treaty), tuttavia un’iniziativa americana, non poteva essere ratificata dal Senato americano.
Dagli anni ’90, in uno sviluppo quindi in gran parte antecedente a Trump, il Partito Repubblicano ha progressivamente adottato un’opposizione sistematica all’ONU ma anche più in generale alla diplomazia, al multilateralismo e ad ogni forma di accordo internazionale, opponendosi alla ratifica di quasi tutti i trattati.
MAYA KANDEL
Dobbiamo tornare a un articolo pubblicato nel 2000 da John Bolton (allora vicepresidente del think tank American Enterprise Institute), che ha respinto il progetto di “governance mondiale” simbolo della “globalizzazione felice” degli anni ’90, rappresentato negli Stati Uniti dalla dottrina Clinton dell’espansione delle democrazie di mercato e dall’intervento umanitario sotto l’egida della ONU (o almeno NATO). Questo progetto multilateralista assimilato ai Democratici è denunciato dal Partito Repubblicano del dopo Guerra Fredda come una minaccia per la sovranità e la libertà di azione degli Stati Uniti. È in nome della difesa dell’identità americana che la governance mondiale e ciò che ne consegue – diritto internazionale, multilateralismo – sono qui considerati anti-americani. Questa frattura è ora ampiamente familiare, soprattutto perché si è diffusa in tutto il mondo, contrapponendo i nazional-populisti ai “globalisti”,
Il trumpismo è nazionalismo
Il movimento conservatore, colonna portante intellettuale del Partito Repubblicano, ha cercato, dopo tre anni di presidenza Trump e l’avvicinarsi di una nuova scadenza elettorale, di “teorizzare gli istinti” di questo presidente straordinario, in accordo con la nuova base campagna elettorale, al fine di trattenere questi nuovi elettori che hanno portato al potere Trump e il Partito Repubblicano, sia il Presidente che il Congresso. Questa ” teorizzazione inversa ” del trumpismo in “conservatorismo nazionale” getta luce sull’evoluzione di questo nazional-populismo in stile americano, le cui risonanze sono numerose con i populismi europei e in particolare con la teorizzazione orbaniana della democrazia cristiana “illiberale”.. Ma questo revival nazionalista americano ha anche le sue specificità, legate alla storia degli Stati Uniti, alla costruzione della sua identità e del suo rapporto con il mondo. Il rifiuto della recente politica estera americana occupa infatti un posto centrale: ma la questione del ruolo degli Stati Uniti nel mondo è anche il punto più confuso di questo nuovo movimento, diviso tra poli ancora opposti – ma che potrebbe unirsi dietro lo scontro con la Cina. Soprattutto, è solo uno dei movimenti di idee che stanno combattendo per la base elettorale di Trump – e l’eredità del Trumpismo.
La questione del ruolo degli Stati Uniti nel mondo è anche il punto più confuso di questo nuovo movimento, diviso tra poli ancora opposti – ma che potrebbe unirsi dietro il confronto con la Cina.
MAYA KANDEL
Tra i conservatori nazionali troviamo una visione del mondo che mescola la lettura civilizzazionista di Samuel Huntington , il prisma dei “nazionalisti contro i globalisti” ripreso da Trump nei testi scritti da Stephen Miller, ma anche l’ossessione sovranista di lunga data di alcuni. Settori repubblicani e intellettuali come quelli del Claremont Institute, il cui principio fondante, ricordiamolo, è che è necessario “ripristinare i principi di fondazione del Paese”: la Costituzione americana è considerata come unica fonte di legittimità e di diritto, il che spiega anche perché l’Unione Europea figura a tal punto da eresia, nemico da distruggere. La politica estera di Mike Pompeo, vicino a Claremont, va quindi spesso intesa nelle sue due dimensioni, interna ed esterna, nel quadro di un doppio confronto, interno e globale: contro un’élite internazionalista favorevole alla governance mondiale e multilateralismo (“globalista”), ma anche multiculturalismo interno (“cosmopolita”); e contro chi vuole la fine dell’Occidente (Cina e Islam politico). Ma dove Pompeo (come Yoram Hazony, autore di The Virtue of Nationalism ) parla di ridefinire le alleanze in conformità con questi principi e di incoraggiare i nazionalisti di tutti i paesi, altri, come Tucker Carlson, vicino a Trump e conduttore di Fox News , il cui spettacolo è il secondo più visto a livello nazionale, difendere un autentico isolazionismo che vede nella politica estera la difesa dell’interesse americano ridefinito al minimo : sicurezza territoriale, protezione delle frontiere, difesa delle aziende americane dalla concorrenza cinese; con questo in mente, non dobbiamo solo lasciare il Medio Oriente ma anche la Corea del Sud e l’Europa, l’idea di fare la guerra per difendere Taiwan non viene presa sul serio e la NATO è obsoleta (e “Perché non dovremmo essere amici della Russia”). In uno scambio con il presidente Trump, Tucker Carlson si è chiesto perché avrebbe dovuto mandare suo figlio a morire per il Montenegro, in occasione dell’ingresso di quel paese nella NATO; La risposta rivelatrice di Trump: “Mi pongo la stessa domanda”.
In uno scambio con il presidente Trump, Tucker Carlson si è chiesto perché avrebbe dovuto mandare suo figlio a morire per il Montenegro, in occasione dell’ingresso di quel paese nella NATO; La risposta rivelatrice di Trump: “Mi pongo la stessa domanda”.
MAYA KANDEL
Un “blocco nazionalista”, base elettorale del Trumpismo
Un fl u nel 2019 think tank di sinistra Center for American Progress sullo sviluppo dell’opinione americana sulla politica estera ha indicato l’esistenza di un “blocco nazionalista” secondo l’opinione: un terzo degli elettori , il gruppo più numeroso individuato dallo studio, potrebbe essere definito un blocco nazionalista, definito dal desiderio di ritirarsi dal mondo e dall’adesione alle posizioni di Trump su immigrazione e commercio. Uno dei marker più importanti è stata la dimensione generazionale, evidenziata anche da altri studi., dimostrando che la maggior parte degli internazionalisti sono nella popolazione che invecchia, mentre la maggioranza degli under 40 pensa che gli Stati Uniti dovrebbero “stare alla larga dagli affari mondiali”. Senza giustificarli, i cambiamenti demografici fanno luce su queste posizioni segnate dalla paura. Secondo uno studiodal Pew Research Center nel 2017, la popolazione statunitense nata all’estero ha raggiunto i 44,4 milioni; la percentuale di immigrati residenti negli Stati Uniti era del 13,6% della popolazione, appena sotto il record del 1890 al 14,8%. Dal 1990 al 2007, la popolazione di immigrati clandestini è triplicata, raggiungendo i 12,2 milioni nel 2007. Attualmente è stimata in 10,5 milioni. Queste cifre sono vicine al livello storico più alto del 1890 e del 1910, due momenti che preludono alle febbri del nazionalismo, all’approvazione delle leggi sulle quote (1923 e 1924) e al periodo più isolazionista della politica estera americana (1920 e 1930).

Ci sono fondamentali che non cambieranno con o senza Trump: l’osservazione di un ordine internazionale che non serve più gli interessi americani e che necessita di essere riformato (dinamite, secondo Trump); la necessità di rinnovare il legame con la politica interna; il rifiuto degli interventi militari a meno che l’interesse nazionale non sia direttamente minacciato; una rivalutazione delle alleanze e degli alleati. Ma la politica estera è al centro del conservatorismo nazionale, mentre costituisce la grande debolezza di questo movimento, a causa della confusione che vi regna, e le questioni esistenziali che il suo sviluppo pone al Paese. Perché gli Stati Uniti sono sempre stati definiti dall’eccezionalità, dalla convinzione di avere un ruolo unico da svolgere nel mondo: e il disimpegno dal mondo presuppone anche una rinuncia, quella di una posizione egemonica internazionale. Non è certo che il Paese e le sue élite siano pronte: rifiutando l’eccezionalismo, gli Stati Uniti diventerebbero un Paese come un altro, una “potenza normale”. Questo punto interroga profondamente l’identità americana, la cui crisi èlegato a quello della politica estera e illumina il momento attuale negli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti sono sempre stati definiti dall’eccezionalità, dalla convinzione di avere un ruolo unico da svolgere al mondo: e il disimpegno dal mondo presuppone anche una rinuncia, quella di una posizione egemonica sulla scena internazionale.
MAYA KANDEL
Potere normale o potere egemonico: la questione dell’eccezionalismo
Per il Claremont Institute, come per i nazionalisti e gli isolazionisti che intendono tornare alle origini del Paese, è opportuno riallacciarsi a George Washington e al suo rifiuto delle “alleanze vincolanti”; oltre a ciò, si tratterebbe di tornare alla politica estera americana del I secolo, fondata sulla necessità di potere economico e quindi su una politica commerciale aggressiva, con l’obiettivo di difendere la base manifatturiera americana e l’occupazione, ma anche su un imperialismo economico a McKinley che mette il potere dello stato per il salvataggio di imprese americane, all’interno e all’estero – questo “imperialismo privato” strettamente americano, simboleggiata dalla politica asiatica nel XIX ° secolo , di United Fruitin America Latina fino alla seconda guerra mondiale – fino alle sanzioni extraterritoriali di oggi.
Ma non tutti vedono la politica internazionale come una semplice “competizione geoeconomica”. Così, il senatore Josh Hawley, il più giovane eletto al Senato, figura in ascesa e fedele trumpista – almeno finora – ha denunciato in un discorsorecente “l’ideologia globalista dominante in molti paesi europei, in particolare Germania e Francia di Emmanuel Macron”, ideologia designata come “progressismo transnazionale”, visione “post-sovranista” o “universalismo progressista”. Ribadendo che l’obiettivo della politica estera americana non è più quello di trasformare il mondo, ha sottolineato la fondazione del paese, “costruito e sviluppato dai lavoratori, le classi medie”, sostenendo un “ordine internazionale rispettoso del nostro carattere nazionale, che deve essere una nazione prima di tutto commerciale ”. Ora, “una nazione commerciale che necessita di accesso ai mercati in tutte le regioni del mondo”, ha concluso Hawley indicando che ciò era possibile solo “se nessuna regione è controllata o sviluppata da un’altra potenza”,
Questa enfasi geopolitica che evoca le teorie di McKinder sta facendo un netto ritorno nei testi dei think tank conservatori americani, molto interessati al “controllo dell’Eurasia”.
MAYA KANDEL
Questa frase richiama il documento strategico del 1992, il primo documento del Pentagono dopo la fine della guerra fredda di Dick Cheney e Paul Wolfowitz (due uomini che si troveranno nell’amministrazione di George W. Bush nel 2001), che ribadiva uno dei fondamenti dell’atteggiamento americano nei confronti del mondo, “per impedire l’emergere di una superpotenza rivale” in grado di dominare una regione del mondo. Questa enfasi geopolitica che evoca le teorie di McKinder sta facendo un marcato ritorno nei testi dei think tank conservatori americani, molto preoccupati per il “controllo dell’Eurasia”. Hawley ha concluso il suo discorso di fondazione con una strategia di contenimento, questa volta contro la Cina, la cui “volontà di dominare costituisce la più grave minaccia alla sicurezza per gli Stati Uniti in questo secolo”. Questo discorso è vicino a quello di Tom Cotton o Nikki Haley, altre figure emblematiche della giovane guardia repubblicana e contendenti alla successione di Trump. Questo approccio sta per imporsi da parte repubblicana e potrebbe riunire le diverse correnti descritte da Dueck. Consente inoltre di invocare l’eccezionalità, in un contesto sempre più marcato di confronto dei modelli con la Cina.
Gli Stati Uniti, potenza insulare: fine della centralità delle relazioni transatlantiche
Walter Russell Mead era al momento della pubblicazione della strategia di difesa nazionale di Amministrazione nel 2018 Trump illuminante parallelo con il dibattito politico del Regno Unito agli inizi del XX ° secolo. Alla fine del XIX E secolo in Gran Bretagna, il dibattito strategico opposti, da una parte i partigiani di una strategia di “continentale” dando priorità alle alleanze e ad una stretta collaborazione con gli Stati europei principali, e del un altro i difensori di una strategia marittima ( la politica dell’acqua blu ), che voleva allontanarsi dall’Europa per abbracciare una strategia globale, utilizzando la posizione geografica e l’impero per massimizzare il potere britannico.
Negli Stati Uniti contemporanei, si dice che i “continentalisti” siano i sostenitori dello status quo , un’estensione della politica estera post-1945.
MAYA KANDEL
Negli Stati Uniti contemporanei, si dice che i “continentalisti” siano i sostenitori dello status quo , un’estensione della politica estera post-1945: vedono ancora il mondo atlantico, con la sua fitta rete istituzionale sviluppata all’interno degli alleati della Guerra Fredda, come il modello su cui si può e si deve costruire una società pacifica globale, e quindi difendere sempre una politica americana basata soprattutto sulla collaborazione occidentale. Ma l’amministrazione Trump sembra aver fatto la scelta di una “strategia marittima”, nel senso della blue water policy del dibattito britannico: come ai tempi della Pax Britannica, i sostenitori di questa strategia intendono accumulare potere e ricchezza promuovendo i loro interessi in tutto il mondo, vedendo in questo una ricetta migliore per il successo che nelle complicazioni europee e transatlantiche. Ricordiamo, per usare la metafora di Mead, che per gli inglesi dell’epoca una Gran Bretagna forte poteva allora intervenire se necessario in Europa per mantenere o ristabilire un equilibrio di potere, e garantire così una dominazione britannica globale. Questa visione informa molte decisioni della squadra al potere a Washington. L’amministrazione Trump, ad esempio, vede l’accordo di Parigi soprattutto come un ostacolo allo sfruttamento da parte degli Stati Uniti del proprio potenziale energetico. Sopprattuto, gli Stati Uniti si vedono in una competizione geopolitica globale con la Cina che non può essere vinta invocando il multilateralismo e il diritto internazionale. La “dottrina Trump” esprimerebbe queste scelte: Asia prima dell’Europa, “realismo” piuttosto che internazionalismo liberale, prosperità americana prima del multilateralismo e cooperazione internazionale.
Questa visione ha il pregio di avvicinare sia il focus del Pentagono, già da diversi anni, sulla sfida cinese, sia alcuni istinti dello stesso presidente. Un tale approccio non volta le spalle al campo occidentale e non rifiuta le relazioni transatlantiche, ma presuppone che sia il potere americano, e non le istituzioni transatlantiche, a consentire queste stesse istituzioni, e quindi l’Occidente. esistere. Le fasi della politica estera americana e le principali rotture sono sempre legate agli sviluppi nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa e più precisamente agli equilibri transatlantici. Si tratta quindi di un profondo cambiamento di status per le relazioni transatlantiche e forse, per quanto ci riguarda, la principale differenza tra la visione del mondo trumpista e la riflessione avviata da un campo democratico anche in piena riorganizzazione. Ma questo è solo uno dei campi di interrogazione aperti da Trump sulla politica estera. Fondamentale, per la base elettorale trumpista come per i progressisti del Partito Democratico, è anche l’idea di ridefinire una politica estera veramente al servizio degli americani, soprattutto delle classi medie e popolari, di conciliare politica estera e interna. Ma si tradurrebbe diversamente in una presidenza Biden, di cui restano da precisare i contorni e in particolare il posto di sinistra, anche se è presente anche la volontà di reinventare la politica estera e di trasformare il rapporto americano con il mondo. Fondamentale, per la base elettorale trumpista come per i progressisti del Partito Democratico, è anche l’idea di ridefinire una politica estera realmente al servizio degli americani, soprattutto della classe media e operaia, di conciliare politica estera e interna. Ma si tradurrebbe diversamente in una presidenza Biden, di cui restano da precisare i contorni e in particolare il posto della sinistra, anche se è presente anche la volontà di reinventare la politica estera e di trasformare il rapporto americano con il mondo. Fondamentale, per la base elettorale trumpista come per i progressisti del Partito Democratico, è anche l’idea di ridefinire una politica estera veramente al servizio degli americani, soprattutto delle classi medie e popolari, di conciliare politica estera e interna. Ma si tradurrebbe diversamente in una presidenza Biden, di cui restano da precisare i contorni e in particolare il posto di sinistra, anche se è presente anche la volontà di reinventare la politica estera e trasformare il rapporto americano con il mondo.
https://legrandcontinent.eu/fr/2020/10/23/la-doctrine-trump-1/