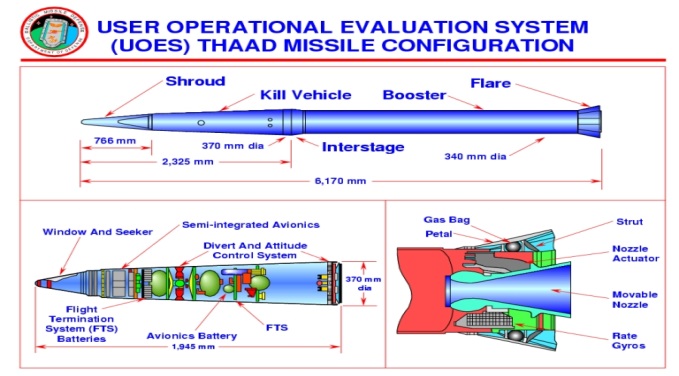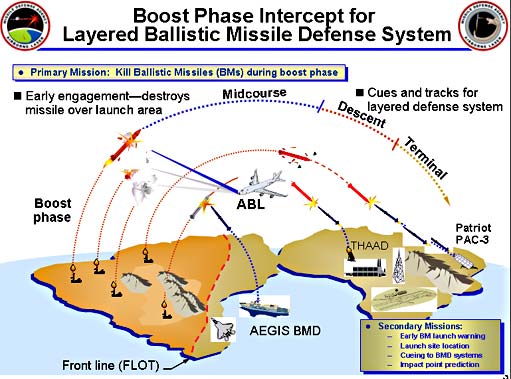Il progetto messianico degli USA e la deriva del nostro Paese, a cura di Luigi Longo_ 3a parte

Passo al terzo punto dopo aver ripresentato il prologo
A Giuseppe Germinario, responsabile del blog “ItaliaeilMondo”.
Chiedo la pubblicazione dei seguenti tre interventi che riguardano:
1.Gli scenari che si aprono con la fine della brevissima apertura multipolare di Trump segnata dall’aggressione alla Siria. Un multipolarismo tattico, appunto, non strategico, perché gli USA amano dominare il mondo in maniera unilaterale per adempiere il loro Progetto Messianico ( << di avere una missione speciale da compiere e di essere pertanto l’unica nazione indispensabile del mondo >>). Questo significa prendere l’iniziativa di riallineare l’architettura del potere globale, nonostante l’epoca del grande giocatore (allo stesso tempo più ricco e militarmente più potente) stia ormai per finire.
E’ uno scritto di Paul Craig Roberts, Trump si è arreso, il prossimo sarà Putin?, www.libreidee.org, 9 aprile 2017.
2.Il ruolo importante che assume il territorio italiano nelle strategie USA nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. L’Italia è stato lo spazio di coordinamento USA per l’aggressione alla Siria: Napoli ( Comandi: quartiere generale Napoli-Capodichino e Napoli Lago Patria), Gaeta (base Sesta Flotta), Sigonella ( base aeronavale), Niscemi (Sistema Muos).
E’ uno scritto di Manlio Dinucci, Dall’Italia l’attacco USA alla Siria, www.voltairenet.org, 11 aprile 2017.
- Il ruolo del G7; dello scritto mi interessa far rilevare le trasformazioni delle città italiane (aree urbane e rurali) in hotspot (centri decisi dalla UE per la detenzione, identificazione ed espulsione manu militari dei richiedenti asilo), in centri disumani di immigrati e in città strategiche per i comandi USA-NATO.
E’ uno scritto di Antonio Mazzeo, Il vertice G7 di Taormina, in www.sbilanciamoci.org, 10 aprile 2017.
Grazie Cordialità
Luigi Longo
Terzo. Nella fase multipolare le città e i territori si militarizzano sempre di più.
Antonio Mazzeo, Il vertice G7 di Taormina.
La Sicilia ha assunto un ruolo chiave nelle strategie di guerra mondiali a partire dall’installazione a Niscemi del terminale terrestre del Muos, il nuovo sistema di telecomunicazione satellitare delle forze armate Usa.
Un territorio duramente segnato dal dissesto idrogeologico, le frane dopo ogni temporale, la progressiva erosione delle coste. Si presenta così il comprensorio ionico compreso tra le città di Messina e Catania, per lungo tempo una perla del turismo per le sue straordinarie bellezze paesaggistiche e il patrimonio storico-culturale, da alcuni anni vittima della crisi di un modello economico insostenibile e dell’incapacità o inettitudine delle classi politiche e di governo locali. Gli investimenti per la messa in sicurezza dei territori o per il rilancio di attività socio-culturali ed economiche ecocompatibili sono inesistenti, così per uscire illusoriamente dalla crisi, il governo Renzi prima, quello Gentiloni poi, hanno pensato bene di “rilanciare” internazionalmente l’immagine di Taormina elevandola a sede del prossimo G7, il vertice dei capi di stato delle sette maggiori potenze economiche, politiche e militari occidentali (Usa, Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia). Il 26 e 27 maggio 2017 il comune siciliano ospiterà più di mille delegati, tremila persone fra security, intelligence e fornitori, 2.500 giornalisti, 6.400 tra poliziotti, carabinieri e appartenenti alle forze armate. L’ennesimo “grande evento” che come ormai accade puntualmente in Italia non potrà non avere devastanti impatti socio-ambientali, con ricadute pari a zero in termini occupazionali, mentre di contro enormi flussi di denaro pubblico andranno alle aziende private dei soliti noti.
In vista del G7 di Taormina, il governo ha stanziato 45 milioni di euro “per l’attuazione degli interventi relativi all’organizzazione e allo svolgimento del vertice”: di questi, 30 andranno per la gestione diretta dell’evento e “solo” 15 milioni per le opere infrastrutturali nella località ospitante. Ancora una volta le modalità per la scelta delle opere prioritarie e della gestione dei bandi di gara sarà quella “emergenziale”, così da poter bypassare le procedure previste dalle normative di legge in materia di appalti e prevenzione dell’infiltrazione mafiosa. Il prefetto Riccardo Carpino è stato nominato commissario straordinario per l’evento con delega alle infrastrutture e solo da poco più di un mese è stata messa in moto la macchina organizzativa vera e propria con l’affidamento dei primi lotti di gara. A Taormina si è dato il via agli interventi che più preoccupano per i loro effetti ambientali e paesaggistici, due grandi eliporti per i decolli e gli atterraggi delle delegazioni dei capi di stato (lavori affidati all’Aeronautica militare) e l’allestimento “scenico” del teatro Greco. Affidati pure i lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria” di alcune strade interne al territorio comunale (in verità appena 991mila euro nonostante il grave degrado in cui versa la rete viaria locale), mentre a giorni andrà in gara il lotto per “l’abbellimento floreale” e il “miglioramento del decoro e dell’arredo urbano”, come suggerito dalla sottosegreteria Boschi nel corso della sua recente visita in Sicilia. Di ben altro spessore la tranche riservata ai “servizi” del G7 (pasti, alberghi, servizi, trasporti, ecc.), oltre 25 milioni di euro che la Consip – come denunciato in due speciali de L’Espresso e della Gazzetta del Sud – sono già stati divisi “in gran parte tra imprese e imprenditori extra-collaudati da anni di rapporti con la politica”. Come riporta il giornalista Sebastiano Caspanello, tra i vincitori dei lotti di gara “ci sono il catering ufficiale di Eataly, già saggiato nelle cene di raccolte fondi del Pd, e l’agenzia di comunicazione che ha gestito budget milionari all’Expo; ci sono l’azienda monopolistica dei grandi eventi (il G8 di Genova e L’Aquila) e con consolidate amicizie nei salotti della Capitale e il gruppo di società organizzatrici di meeting, con più di un volto noto gravitante nell’orbita del famoso giglio magico”.
Intanto cresce in tutta l’isola la mobilitazione dei soggetti e delle realtà che si oppongono al modello economico dominante e alle politiche di guerra e di devastazione dell’ambiente perpetuate dai governi G7. La parola d’ordine è di ritrovarsi tutti a Taormina il 26 e 27 maggio per manifestare contro i “Sette Grandi” e contro il “pensiero unico” che legittima alcune transnazionali a decidere sulla vita e sulla morte di 8 miliardi di abitanti della terra. “Il vertice G7 formalizza annualmente le misure di austerità neoliberiste da applicare internazionalmente o gli interventi di guerra planetaria sempre più spesso subappaltate all’organizzazione della NATO”, si legge in un appello condiviso durante le due giornate di mobilitazione internazionale Fora u G7, tenutosi a Palermo a fine febbraio.
Secondo le prime indiscrezioni, il summit di Taormina affronterà alcuni dei conflitti più sanguinosi scatenati nell’area mediterranea e mediorientale (in primis Siria, Libia, Yemen, ma con un occhio anche ai conflitti in corso nel continente africano) e l’immancabile “lotta al terrorismo (islamico)”. Altro tema caldo sarà quello delle relazioni-pressing sulla Russia dove si confronteranno due visioni opposte: da una parte chi chiede d’intensificare l’accerchiamento militare contro Mosca e suoi principali alleati nell’Est Europa e nel Caucaso (Germania e altri paesi chiave Ue); dall’altra chi vorrebbe riagganciare al G7 la potenza guidata da Putin (le lobby politiche energetiche dominanti in Italia e alcuni settori della nuova amministrazione Trump). Il G7 di Taormina sarà importante anche per comprendere chi e come avrà la guida dei comandi NATO, mentre è probabile che i nuovi piani di riamo nucleare globale e di rafforzamento delle componenti di guerra più moderne (droni, unità navali e terrestri del tutto automatizzate, cyber war, ecc.) saranno “socializzati” a tutti i paesi G7 e ai loro più stretti alleati.
In agenda poi il tema delle “emergenze” prodotte dalle migrazioni mondiali, in vista di un rafforzamento delle alleanze politico-militari per contrastare la fuga di milioni di persone dalle guerre e dai crimini socio-ambientali. Scelte scellerate che avranno innanzitutto ricadute dirette sulla vita e le libertà dei cittadini dei paesi membri del G7: dalla ipermilitarizzazione di punti strategici interni (aree metropolitane di interesse finanziario e culturale, porti, aeroporti, punti di confini) ad una sempre maggiore restrizione dei diritti di espressione e utilizzo di social network, media-strumenti informatici (è in atto una vera e propria campagna globale che enfatizza la cosiddetta cyber security, nuova frontiera del capitale finanziario e del complesso militare-industriale).
La decisione di svolgere in Sicilia il G7 non è del resto casuale. L’Isola ha assunto ormai un ruolo chiave nelle strategie di guerra mondiali: l’installazione a Niscemi del terminale terrestre del MUOS, il nuovo sistema di telecomunicazione satellitare delle forze armate USA; la trasformazione della grande base di Sigonella in uno dei maggiori centri per la operazioni dei droni USA, NATO e UE; l’uso costante degli scali aerei di Trapani-Birgi e Pantelleria per i bombardamenti e le attività di spionaggio top secret in Nord Africa; i devastanti processi di militarizzazione che hanno investito Augusta (hub navale Usa e NATO), Lampedusa, ecc., testimoniano la portata altamente distruttiva delle infrastrutture belliche realizzate e ampliate in Sicilia negli ultimi anni. A ciò si aggiunge il ruolo di vera e propria fortezza assunto dalla Sicilia per conto dell’Unione europea e della famigerata agenzia di controllo delle frontiere esterne Frontex nelle politiche di contrasto delle migrazioni, con l’uso dei porti e degli aeroporti da parte dei mezzi militari Ue-NATO impegnati a far la guerra ai migranti nel Mediterraneo o la trasformazione di sempre maggiori aree urbane ed extraurbane in hotspot e centri-lager dove detenere in condizioni disumane chi è scampato ai naufragi e ai bombardamenti (a Trapani-Milo, Lampedusa, Pozzallo e presto anche a Messina e Mineo). “Pseudo modalità di accoglienza che rispondono esclusivamente a logiche di controllo sicuritario e che contribuiscono a dilapidare sempre più ingenti risorse pubbliche, alimentando gli affari di grandi e piccoli operatori economici (che sempre più spesso si intrecciano con i circuiti dell’economia criminale) e la precarietà per i lavoratori”, denunciano i No G7 siciliani.