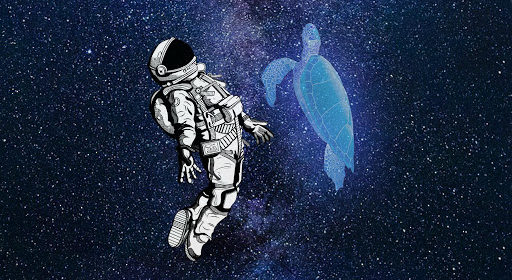Per millenni, la geopolitica ha fatto parte delle due dimensioni che determinano la superficie terrestre. Le battaglie navali avvenivano nelle immediate vicinanze delle coste, assimilate così al prolungarsi dei conflitti il cui esito si svolgeva spesso sulla terraferma. A partire dal XVII ° secolo, la navigazione oceano permette un’azione in profondità e rivela una certa sorpresa strategica da iniziative ai teatri lontani, almeno difesi. Ma queste azioni sono raramente provano decisivo e non è stato fino al XX ° secolo per il controllo di 3 edimensione diventa capitale. Gli spazi pionieri per eccellenza, l’oceano e lo spazio sono soprattutto aree di controllo, il che giustifica l’interesse delle grandi potenze.
-
Limiti tecnici e umani
Il primo limite che gli uomini incontrano nel conquistare questi spazi è ovviamente tecnico, di fronte alla sfida dell’immensità. Ampiezza relativa degli spazi oceanici, con navi la cui velocità e capacità di trasportare cibo è limitata. Nel 1492, Colombo navigò per trentasei giorni senza toccare terra per andare dalle Canarie alle Bahamas, Magellan quasi cento giorni nel 1521 per attraversare il Pacifico. Ancora oggi, ci vuole più di un mese di navigazione (non-stop) per collegare l’Europa e l’Asia orientale o attraversare il Pacifico. Immensità assoluta, e persino infinità dello spazio esterno: anche la Luna, la stella a noi più vicina, si trova a una distanza equivalente a nove o dieci volte la circonferenza della Terra – le missioni Apollo impiegavano settanta ore per raggiungerla e un aereo di linea impiegava dai sedici ai diciotto giorni – e Marte, il nostro “vicino”, il unico pianeta che sembra ragionevolmente alla portata dell’uomo, è circa 200 volte più lontano! Un viaggio con equipaggio su Marte riprodurrebbe le condizioni delle esplorazioni marittime dei tempi moderni, aggravando il vincolo dell’esiguità, e quindi la pressione psicologica, che pone qualsiasi esperienza di questo tipo sul filo del rasoio, come marinai dell’era atomica.
Questi limiti spiegano perché la progressiva esplorazione di questi spazi può ancora essere considerata imperfetta: meno di vent’anni fa abbiamo un record del primo calamaro gigante vivente e abbiamo esplorato appena il 5% delle profondità oceaniche, come non sappiamo. 96% dell’universo (se questa stima ha senso per una nozione “infinita”) perché, nell’abisso come nello spazio, l’intervento umano diretto è difficile e molto puntuale, addirittura impossibile, sia per ragioni simili (mancanza di ossigeno) o opposte (assenza di gravità in un caso, pressione estrema nell’altro). Per scoprire questi spazi, senza nemmeno parlare di farli propri, è quindi necessario padroneggiare tecnologie complesse: cantieristica navale, cartografia, navigazione astronomica di ieri, costruzioni aerospaziali, automazione e digitalizzazione, la rete satellitare oggi. Si tratta di tecnologie d’élite, non solo perché richiedono un’incredibile quantità di competenze, intellettuali oltre che manuali, per implementarle, ma perché richiedono anche notevoli mezzi finanziari e molto tempo: l’ANS[1] Suffren , consegnato alla Marina francese nel 2020, è il risultato del programma Barracuda lanciato nel 2006, l’ultima unità del quale (la Duquesne ) dovrebbe entrare in servizio nel 2029 e rimanere nella flotta fino al 2060 circa.
Da leggere anche: Alle tue armi! La SNA Suffren
Queste tecnologie sono tanto meno accessibili a tutti in quanto sono generalmente oggetto di sorveglianza, di una politica di segretezza per mantenere un vantaggio essenziale da una prospettiva di potere o semplicemente commerciale. Carte nautiche, i trattati di navigazione sono stati tenuti segreti e nel XVI ° secolo, che gli algoritmi di oggi. Fu solo con l’esplorazione dell’Atlantico di Halley nel 1698-1699 che la conoscenza divenne un fattore di prestigio e da quel momento in poi fu mostrata (almeno in Europa) piuttosto che nascosta. Le imprese tecnologiche o le esplorazioni avventurose verranno ora pubblicizzate, anche se i dettagli delle tecniche per realizzarle rimangono sotto sorveglianza.

Dal mare allo spazio
La logica ultima di questa copertura mediatica era la conquista dello spazio, oggetto di una rivalità tra le due superpotenze del dopoguerra. Nel mondo bipolarizzato della Guerra Fredda, il progresso tecnologico è stato sia una vetrina del suo know-how, e quindi del suo avanzamento sull’altro modello, sia un sostituto di un conflitto diretto che non poteva aver luogo a causa di deterrenza nucleare. La corsa allo spazio aveva inoltre a che fare con il progresso dell’arma atomica, perché la tecnologia del razzo (motorizzazione, potenza, guida, controllo automatizzato) era la stessa, su scala più ampia, di quella usata per il missili intercontinentali, vettori invulnerabili della bomba.
È quindi comprensibile che gli americani fossero preoccupati per l’avanzata presa dai sovietici nelle prime fasi di questa corsa: primo satellite artificiale (Sputnik, 1957), prima essere vivente poi primo uomo nello spazio ( Gagarin, 1961). Il candidato democratico nel 1960, John F. Kennedy, ha utilizzato il tema del “gap missilistico” durante la sua campagna per screditare il suo avversario Richard Nixon, vicepresidente uscente. Sotto Johnson (1963-1968), la tendenza sarà invertita e Nixon, ora presidente, avrà la soddisfazione di assistere al primo sbarco sulla luna per il suo primo anno in carica (1969). E lo spazio testimonierà anche il cambiamento nelle relazioni tra i due grandi quando la logica del confronto succederà a quella della distensione: nel luglio 1975, nel mezzo della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa a Helsinki (CSCE), il lo stivaggio di una cabina Apollo e di una navicella Soyuz ha dimostrato la capacità dei due grandi di cooperare in uno spazio da cui partono una serie di accordi internazionali, conclusi da un decennio,
-
Spazi di controllo
Ciò è comunque vero per il dispiegamento permanente di sistemi d’arma o per uso militare (trattato del 1967, trattato ABM [2] del 1972). Eppure le prime mete della ” dimensione 3 E ” erano bene, e rimangono, militari: è l’osservazione e la conoscenza delle forze e dei movimenti del nemico. Aeroplani o dirigibili furono incorporati negli eserciti per questo scopo, prima di sviluppare capacità decisive di attacco al suolo alla fine della prima guerra mondiale; Dal 1916 e dalla battaglia di Verdun, la prima battaglia per la superiorità aerea, la padronanza dello spazio aereo “sovrastante” è una condizione sine qua non vittoria, a terra come in mare, come i satelliti, sono diventati la principale fonte di questo bene essenziale per i leader: l’informazione, nel suo doppio aspetto di raccolta (osservazione) e trasmissione (comunicazioni).
Uno spazio essenziale per la capacità di azione
In modo che il 3 °dimensione è la chiave per la libertà di intraprendere azioni su larga scala in geopolitica: è grazie alla sua maestria che un potere può avere informazioni sufficientemente precise, statiche e dinamiche (satelliti di osservazione e geolocalizzazione) , per decidere e condurre un’azione su qualsiasi scala. Dall’azione furtiva (squadre di commando) o addirittura invisibile, nel cyberspazio, come la contaminazione da parte di Stuxnet che probabilmente ha preso di mira il programma nucleare iraniano, all’azione senza risposta basata su missili tele o homing e / o droni lanciati da aerei o forze navali operanti in aree internazionali, inclusa la semplice esibizione di forza dissuasiva che costituisce il dispiegamento di una significativa forza aerea navale in prossimità di aree critiche.
La libertà di attuare tali mezzi e la loro efficacia sono tanto più sottolineate dalle difficoltà che le truppe di terra incontrano oggi, in particolare nei conflitti asimmetrici: per ottenere risultati, devono dispiegare in massa, che richiede logistiche disabilitanti e aumenta il rischio di tensioni con le popolazioni locali, senza una reale garanzia di efficacia contro un nemico che sfrutta anche le possibilità offerte dalla 3a dimensione in termini di comunicazione criptata, capacità tracciamento, ecc.
La questione dell’autonomia, quindi la sovranità è quindi molto direttamente correlata ai mezzi per agire in questa 3 e dimensione strategica, se non altro per avere un’indipendenza nell’informazione – ecco cosa che ha spinto Russia, Cina, ma anche Giappone o Unione Europea, a sviluppare ad esempio un proprio sistema di geolocalizzazione. L’affermazione del potere oggi passa attraverso le tecnologie balistiche – lo vediamo con la Corea del Nord – e attraverso programmi spaziali autonomi o in collaborazione limitata – come l’Agenzia spaziale europea, creata nel 1975, o la cooperazione israeliana. -indiano dagli anni 2000.
Leggi anche: L’ideologia juche nordcoreana, oltre il comunismo
Ma non dobbiamo dimenticare l’aspetto marittimo di questa terza dimensione, vale a dire la profondità. Il 99% delle comunicazioni istantanee di cui godono i nostri computer e telefoni passa attraverso cavi che si trovano sul fondo dell’oceano e la rete in continua espansione ora include più di 300 cavi che si avvicinano a un milione di miglia. E i sottomarini, in particolare a propulsione atomica che beneficiano di una totale autonomia [3], sono anche gli strumenti ideali per la raccolta di informazioni, siano esse tattiche (illuminazione di una forza navale) o strategiche e, naturalmente, per gli attacchi: con missili, sia da crociera che balistici , testata nucleare o meno, il 95% delle aree abitate del globo sono vulnerabili a un attacco innescato dal mare, in particolare le più grandi metropoli, la maggior parte delle quali si trova entro 200 km dalla costa. Viceversa, a causa della loro furtività e della loro mobilità, i sottomarini atomici sono piattaforme quasi impercettibili, e quindi quasi invulnerabili, salvo un incidente o un incredibile colpo di fortuna da parte del “cacciatore”. Questo è ciò che rende gli SSBN (sottomarini missilistici nucleari) i vettori essenziali della deterrenza nucleare,
-
La tentazione della territorializzazione
Grazie alle profondità, il mare ha mantenuto il ruolo di spazio di sorpresa che ha sempre avuto, dalle incursioni vichinghe agli sbarchi alleati della seconda guerra mondiale e persino in Corea. Oggi, il rilevamento aereo, e ancor di più via satellite, impedisce a una flotta di superficie di nascondersi, ma i sottomarini mantengono questa capacità. Anche se la precisione dei satelliti è raffinata, il che consente loro di contribuire, ad esempio, a comprendere gli effetti del riscaldamento globale sugli oceani (temperatura, livello, correnti, ecc.), Non rilevano ancora i sottomarini oltre poche decine di metri di profondità.
Logicamente, la capacità di osservazione ha portato a un maggiore desiderio di controllo e regolazione. Questo è il XVII ° secolo, che l’idea di proprietà, o per lo meno il controllo legale delle aree marittime prendendo forma, con la prima estensione della sovranità di uno Stato per le acque costiere (1604) e con il dibattito avviato dal gli olandesi sulla libertà dei mari, difesi dal giurista Grotius (1583-1645) nel suo Mare liberum (1609). Questo lavoro, bandito in Inghilterra, ha suscitato una risposta da John Selden (1584-1654) attraverso il suo Mare clausum, completato già nel 1618, ma pubblicato una ventina di anni dopo. I principi ei metodi poi conservati per definire e tracciare le Camere del Re, la prima forma di acque territoriali, sono abbastanza vicini a quelli approvati quasi quattro secoli dopo a Montego Bay per la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in particolare nozioni di linee di base o passaggi innocui.
Questo perché il diritto marittimo è soprattutto consuetudinario. La progressiva estensione delle acque sotto la giurisdizione nazionale avviene casualmente da casi pratici, ma accompagna anche le capacità di sorveglianza degli Stati: il limite di 3 miglia nautiche (circa 5 km) delle acque territoriali è stato per lungo tempo la norma perché corrispondeva al capacità pratiche di azione di uno Stato, e sono gli Stati Uniti che la estenderanno fino a 12 miglia nautiche per combattere contro le “barche del peccato”, queste navi casinò ancorate al limite di 3 miglia nautiche, quindi in vista della costa, al tempo del divieto di alcol (1917-1933) – questo diventerà il nuovo standard del mare territoriale alla conferenza di Ginevra nel 1958. La creazione della Zona Economica Esclusiva (ZEE) da parte di la convenzione del 1982, portando fino a 200 miglia (370 km) i diritti e le responsabilità dei residenti nella regolazione di determinate attività, corrispondeva a un compromesso tra gli Stati “poveri”, desiderosi di un’estensione del loro mare territoriale fino a questo limite, e le competenze navi marittime che desiderano mantenere la massima libertà di navigazione e di azione possibile. Si noti che lo spazio aereo riproduce fedelmente lo stato delle terre o dei mari sottostanti: lo spazio aereo nazionale si estende quindi anche al di sopra del mare territoriale.
ZEE e piattaforma continentale
La ZEE può anche essere estesa dalla piattaforma continentale fino a un massimo di 350 miglia (650 km) se questa estensione è giustificata da argomenti geologici e convalidata da una commissione specializzata delle Nazioni Unite. Questo è ciò che consente alla Francia, che ha la seconda ZEE più grande al mondo dietro gli Stati Uniti, di avere il primo dominio sub-marittimo dalla convalida delle estensioni nel 2015, con 11,6 milioni di km², in in attesa di ulteriori decisioni. Le aree che non rientrano nella ZEE o nelle piattaforme continentali (circa il 60% degli oceani) costituiscono l’alto mare, dove prevale il principio di libertà. Tuttavia, ciò non significa che sia una zona illegale, perché sono state concluse convenzioni specifiche per la regolamentazione della pesca, regionale (tonno, merluzzo) o globale (caccia alle balene,
Fino ad oggi, oltre alle risorse ittiche, sono principalmente le riserve di idrocarburi ad essere sfruttate, a profondità sempre maggiori – dell’ordine di 3.000 m di colonna d’acqua, a cui si aggiunge la profondità di foratura. La maggior parte delle nuove riserve scoperte, a parte il gas di scisto e il petrolio, sono ora in mare e lo sfruttamento offshore fornisce circa un terzo della produzione mondiale, grazie a giacimenti che si trovano in ZEE generalmente riconosciute, anche se la scoperta di tali ricchezze a volte riattiva controversie dormienti finché non c’erano quasi poste in gioco, ad esempio i giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale.
Sfruttare le risorse del mare
Lo sfruttamento delle risorse minerarie in mare, solitamente situate a profondità molto elevate, è solo all’inizio: la società australiana Nautilus Minerals ha lanciato nel 2019 il progetto Solwara 1 al largo della Nuova Guinea per la produzione di rame e oro – ma l’enorme dimensione dei depositi suggerisce che la corsa arriverà presto. Un rapporto congiunto CNRS e Ifremer pubblicato nel 2014 ha stimato che la zona di Clarion-Clipperton (15% dell’Oceano Pacifico), grazie al suo “campo” di noduli polimetallici, conteneva 6.000 volte più tallio, 3 volte più cobalto e più manganese e nichel di tutte le risorse individuate al di fuori degli oceani. Anche le risorse genetiche marine (codici del DNA degli organismi marini) sono oggetto di molte fantasie – e semplificazioni,

Il problema però non è cambiato: si tratta ancora di garantire la più ampia libertà di accesso possibile a queste risorse, ma bisogna scegliere tra una libertà incantatoria, l’apertura all’accesso al saccheggio, secondo una concezione simile a quella di pirati di tutti i tempi, e non solo in mare, e libertà reale, che presuppone regole eque e autorità per farle rispettare. L’ONU ha anche avviato nel 2018 negoziati per completare la Convenzione sull’alto mare del 1982. Il senso della storia cresce in effetti con l’aumento della presenza dell’uomo nel 3 ° dimensione, che sia una presenza legale o una presenza fisica, con il proliferare di installazioni sostenibili in alto mare: piattaforme petrolifere, parchi eolici … Il problema sorgerà senza dubbio presto nello spazio esterno, che è indistinguibile non per il momento di un’estensione infinita dello spazio aereo.
Da leggere anche: Cina, Stati Uniti, UE: chi vincerà la guerra?
Realisticamente, con un interesse strategico ed economico del 3 e rafforzato per dimensioni e capacità di intervento umano aumentato, il gioco del potere è sicuro di dispiegarlo, a volte a discapito della legge. L’appropriazione da parte della Cina di isolotti o scogliere nel Mar Cinese Meridionale per aumentare il suo mare territoriale e la sua ZEE, a dispetto delle rivendicazioni concorrenti e di un parere della Corte internazionale di giustizia dell’agosto 2016, annuncia conflitti a venire. E la possibilità di attraccare satelliti già in orbita apre anche la strada a una “guerra spaziale” che non ucciderà le persone, ma giocherà comunque un ruolo decisivo nella difesa della sua sovranità.
Cronologia: padronanza del mare e dello spazio in 21 date
- 1405-1433: le 7 spedizioni di Zheng He
- 1519-1522: prima circumnavigazione (Magellano – Elcano)
- 1604: istituzione delle Camere dal re Giacomo I ° d’Inghilterra
- 1843: prima nave in acciaio azionata da un’elica ( Gran Bretagna )
- 1851: primo cavo sottomarino (Calais-Douvres)
- 1869: apertura del Canale di Suez
- 1905: primi voli controllati dei fratelli Wright
- 1911: primo esempio di bombardamento aereo (Tripolitania)
- 1914: siluramento di 3 incrociatori britannici da parte del sottomarino U9
- 1929: definizione universale di miglio nautico
- 1939: primo volo di un aereo a turbogetto autonomo
- 1954: lancio del Nautilus , il primo sottomarino atomico della storia
- 1957: lancio del primo satellite artificiale, Sputnik I.
- 1960: il Bathyscaphe Trieste raggiunge il fondo della Fossa delle Marianne (- 11.000 m)
- 1967: trattato sull’uso pacifico dello spazio cosmico
- 1969: sbarco sulla luna della missione Apollo XI (21 luglio)
- 1970: risoluzione 2749 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
- 1975: Apollo – Missione Soyuz
- 1982: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay)
- 2010: rilevamento del worm Stuxnet, il primo caso identificato di attacco informatico
- 2020: primo ormeggio dei satelliti in orbita geostazionaria
[1] SNA: sottomarino da attacco nucleare. Sottomarino a propulsione atomica dedicato ad attaccare forze navali o obiettivi terrestri con armi non nucleari (missili, siluri).
[2] Missili antibalistici: armi destinate all’intercettazione di missili intercontinentali.
[3] Non hanno infatti bisogno di fare rifornimento e riciclano l’aria e l’acqua, potendo rimanere in immersione totale finché dura la loro scorta di cibo e l’equipaggio resiste al confinamento.
https://www.revueconflits.com/ocean-espace-geopolitique-pierre-royer/


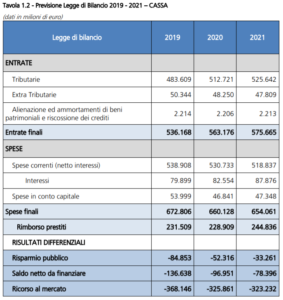



 (Credito fotografico: Hurriyet Daily News)
(Credito fotografico: Hurriyet Daily News) (Credito fotografico: NATO)
(Credito fotografico: NATO) (Credito fotografico: Getty Images su www.express.co.uk)
(Credito fotografico: Getty Images su www.express.co.uk)