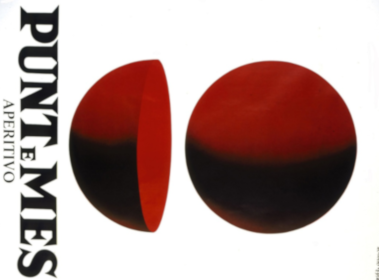Le armi della guerra economica
La presente sezione sarà dedicata all’analisi dettagliata delle armi utilizzate
dagli Stati nella guerra economica per vincerla e affermare la loro potenza. Le
prime che prenderemo in considerazione sono le armi di tipo indiretto, che
agiscono nelle retrovie e contribuiscono a plasmare il dispositivo di una “guerra
coperta”.
All’interno di questo insieme molto particolare di strumenti di guerra
economica, quello che più agisce a monte di tutti è sicuramente la formazione, che
contraddistingue soprattutto i Paesi sviluppati e ha contribuito in larga misura ai
loro successi economici. Basti pensare, a questo proposito, all’importanza data
dall’Unione Europea a questo fattore, tanto che due degli otto obiettivi della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
riguardano proprio l’istruzione (riduzione dei tassi di abbandono scolastico
precoce al di sotto del 10% e aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione
universitaria). Andando poi a verificare la correlazione di formazione e sviluppo
economico, esempi di Paesi come la Germania, il cui sistema di istruzione e
formazione è riconosciuto come uno dei migliori al mondo, o il Giappone, dove il
tasso di conclusione degli studi secondari si aggira intorno al 95%, confermano
quanto finora affermato, soprattutto se si considera le modalità con cui questi due
Paesi sono presenti sui mercati internazionali. Naturalmente qui non si tratta solo
della formazione di base, per quanto questa sia importante nel porre le basi e dare
l’impronta di un certo modo di progredire anche in ambito economico, ma ci si
riferisce in maniera particolare alla formazione continua, che dà a coloro che la
ricevono le necessarie doti di flessibilità e polivalenza che permettono di essere
costantemente aggiornati e mai impreparati ai cambiamenti. A questo proposito,
un altro buon esempio sono le scuole di commercio francesi, delle quali le più
prestigiose si classificano ai primi posti in ambito europeo e il cui successo si deve
in gran parte a un modello nazionale che prevede una formazione biennale di base
ad alto contenuto generalista, quindi non solo scientifico ma anche umanistico,
propedeutico alla successiva specializzazione. Una caratteristica peculiare delle
élite che si formano in questo tipo di scuole moderne è la loro propensione
internazionale, aspetto ben distinto dal carattere marcatamente sciovinista della
preparazione militare dei secoli passati di cui tali scuole, se si segue il filo
conduttore della guerra economica come versione attuale degli antichi scontri
bellici, dovrebbero essere la naturale continuazione.
A complemento del discorso sulla formazione iniziale, è necessario parlare
del ruolo svolto dalla formazione specialistica e dalla ricerca, cruciali ai fini
dell’affermazione della potenza economica. Non è un caso, lo ribadiamo, che
l’Unione Europea abbia affermato fin dall’inizio del millennio di voler diventare la
prima “economia della conoscenza” e che, ad esempio, la sola Francia conti
160.000 ricercatori, un numero più che raddoppiato nel giro di settant’anni. Il
sapere è infatti diventato l’arma suprema della guerra economica e il potenziale
della ricerca risulta essere il motore delle trasformazioni del nostro tempo. È per
questo che Paesi emergenti come la Cina e l’India, che hanno compreso
perfettamente quale sfida cruciale si giochi intorno alla produzione di sapere, sia
esso di base o applicato, non rimangono indietro in questa sorta di “corsa alla
conoscenza”: se da Pechino arrivano forti e chiare le dichiarazioni di uomini di
punta come il Primo Ministro Wen Jiabao, che nel 2005 si spingeva a proclamare il
XXI come “il secolo asiatico delle alte tecnologie”; nel subcontinente indiano ogni
anno prestigiosi istituti tecnologici costruiti negli anni Sessanta sul modello del
MIT sfornano un esercito di 170.000 diplomati. Nell’ambito della ricerca è poi
fondamentale la cooperazione fra università, scuole e settore privato, il quale si
aspetta precisi e puntuali ritorni dal lavoro dei ricercatori; cooperazione che al
giorno d’oggi si presenta sotto forma di “cluster” o “poli di competitività”, spazi
dove convivono luoghi di ricerca, scuole d’ingegneria e imprese di alta tecnologia e
che sono incubatori di una potenza economica straordinariamente innovativa e
all’avanguardia. A questo proposito, lo Stato francese si è fatto promotore, dal
2005, di questo tipo di realtà che rappresentano un elemento fortemente attrattivo
per il territorio in cui sono insediati, realizzando attività di alta formazione
assolutamente all’avanguardia. Ad ogni modo, si registrano ancora divari enormi
nelle politiche effettive in favore della ricerca attuate dai diversi Paesi, anche
all’interno del gruppo delle nazioni leader: è quasi scontato, purtroppo, riferire a
questo proposito il caso dell’Italia dove, pur riconoscendo a parole l’importanza
capitale di una ricerca solida, anche finanziata dal settore privato, per poter dotare
le imprese di tecnologie a elevate prestazioni e consentire loro, di conseguenza, di
essere concorrenziali sui mercati internazionali, il numero di ricercatori impiegati
nelle aziende è cinque volte inferiore a quello di Stati Uniti, Giappone e Svezia. Per
non parlare poi della fuga di cervelli, che decidono di lasciare l’Italia per trovare
migliori opportunità di lavoro e stipendi più alti oltreché la valorizzazione di
merito e competenze a scapito di raccomandazioni, burocrazia e scarso turnover.
Per ogni “cervello che fugge”, però, c’è senz’altro un Paese pronto e ben felice di
accoglierlo e ve ne sono alcuni che fanno dell’attrazione del personale altamente
qualificato e specializzato una vera e propria arma di guerra economica: è il caso
degli Stati Uniti, che a più riprese nel corso del XX secolo sono stati un porto
d’approdo delle menti migliori dei quattro angoli del globo, a cominciare dalle élite
ebraiche in fuga dall’Europa nazifascista, proseguendo con le decine di fisici e
matematici ex sovietici arrivati negli anni Novanta e, infine, arrivando fino ai giorni
nostri, in cui le università statunitensi sono popolate di ingegneri ed economisti
indiani e cinesi. Se si considera il fatto che tre quarti di loro si stabiliscono
definitivamente negli Stati Uniti una volta terminati i loro studi, si può dedurre
facilmente il vantaggio che ne deriva per l’economia americana.
Direttamente collegata con la ricerca è l’innovazione, motore propulsivo di
fondamentale importanza per le imprese e su cui lo Stato ha tutto l’interesse di
investire. L’esempio dei brevetti mostra quanto la collaborazione fra questi due
attori possa rivelarsi fruttuosa. La classifica mondiale delle potenze in termini di
deposito di brevetti certifica il primato cinese, il cui ufficio brevetti dal 2013 è
ormai il primo al mondo con un quarto del totale delle richieste, seguito a ruota
dagli Stati Uniti, mentre il ruolo dell’Europa perde progressivamente di rilevanza a
discapito di una massiccia presenza asiatica, dato che le altre prime posizioni sono
occupate da Giappone, Corea e India. La maggior parte dei brevetti depositati in
tutto il mondo è a opera di imprese del settore privato (Matsushita, Philips,
Siemens, Huawei, Bosch, Toyota, Microsoft, solo per citarne alcune) che però senza
l’azione dello Stato – soprattutto in epoche passate (ci riferiamo qui al ruolo
decisivo in termini di ricerca e sviluppo dei comandi militari americani, o del MITI
giapponese) – non avrebbero mai potuto raggiungere i risultati odierni. È pur
sempre opera dello Stato perfino la predisposizione di un ambiente normativo
favorevole e sufficientemente tutelato in questo settore, per cui la ricerca dei
brevetti può essere considerata a tutti gli effetti un affare nazionale, una garanzia
di produttività, insomma: un’arma decisiva per gli scontri commerciali fra nazioni.
Passando dall’ampio campo della gestione della conoscenza nelle sue
diverse forme quale strumento di guerra economica a quello della competitività,
possiamo affermare che su questo terreno lo Stato può giocare a pieno tutte le sue
carte. È nel suo massimo interesse, d’altronde, far sì che le sue imprese siano
dotate il più possibile della capacità di affrontare la concorrenza sui mercati
esterni e interni. In un momento storico come quello che si sta attraversando, in
cui i travolgimenti nell’ambito delle posizioni di potenza sono di notevole portata,
vediamo come a fronte dell’avanzamento imponente di alcuni Stati sui mercati
internazionali (negli scambi a livello globale, la percentuale cinese è passata dal
2% al 9% nel giro di poco più di vent’anni) altri, storicamente ben piazzati,
indietreggiano (è il caso della Francia, che nello stesso arco di tempo è passata dal
6% a circa il 4%), mentre altri ancora mantengono le proprie posizioni (la
Germania è esempio di notevole continuità, dal momento che mantiene saldamente
il primo posto con una quota che si aggira intorno al 10%). Il ruolo dello Stato è qui
quello di coordinatore, di fornitore di strumenti di lettura, comprensione e
interpretazione del terreno degli scambi internazionali, possibile grazie alle
conoscenze nei più disparati ambiti che almeno una parte dei suoi funzionari
dovrebbe avere degli altri Stati. Prendendo l’esempio della Francia, questo ruolo
viene svolto in gran parte dal Segretariato di Stato per il Commercio estero,
impegnato in questi anni di crisi economica soprattutto a contenere l’erosione
della quota francese sui mercati mondiali la quale, seppur imputabile a
cambiamenti per lo più inevitabili e che coinvolgono tutti i grandi Paesi occidentali,
resta tuttavia preoccupante per la bilancia economica nazionale. A questo scopo, è
stata recentemente riformata l’Agenzia nazionale di promozione dell’esportazione,
Ubifrance, incaricata di promuovere le esportazioni grazie all’apporto delle proprie
competenze ed expertise nei confronti delle imprese francesi. In Italia, l’organismo
con funzioni praticamente sovrapponibili a quelle di Ubifrance è l’Agenzia ICE, che
ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e
commerciali italiani con l’estero, in particolare delle piccole e medie imprese, e che
opera per incentivare l’internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la
commercializzazione dei beni e servizi nazionali sui mercati internazionali. Anche
il ruolo attivo dello Stato nella negoziazione di grossi contratti di produzione
rientra nella più generale promozione della competitività e concretizza quella
cooperazione con le imprese spesso invocata ma sempre di difficile attuazione: il
partenariato fra gli Stati Uniti e le imprese di armamenti e del settore
dell’aeronautica è un buon esempio di questo aspetto.
La competitività è un indice applicabile alle imprese; l’attrattività invece è
una caratteristica propria dei territori: attirare investimenti esteri diretti significa
produrre occupazione nazionale e beneficiare di un ritorno fiscale. Politica fiscale,
gestione del territorio e cultura ne sono le componenti. Per quanto riguarda la
politica fiscale, abbiamo già visto in precedenza come questo sia un nodo dolente
dell’attrattività italiana, anche se altri Stati europei, in particolare il Belgio e la
Francia, hanno tassi d’imposta sulle società non molto distanti. Al contrario, il caso
dell’Irlanda è esemplificativo del fatto che una politica fiscale “leggera” nei
confronti delle imprese funge fortemente da incentivo agli investimenti diretti
esteri: con una tassazione che si aggira intorno al 15%, peraltro fortemente
osteggiata dall’UE, la “tigre celtica” è riuscita così ad attirare soprattutto imprese
straniere nel settore delle alte tecnologie e informatico (da Adobe a eBay, passando
per Yahoo!), sostenendo in gran parte la propria crescita economica. La Cina
invece, in questo ambito, ha sviluppato una politica di istituzione di aree
economiche speciali nelle province di Guangdong, Fujian e Hainan e di sviluppo di
regimi fiscali particolarmente attraenti da applicare proprio in queste aree alle
imprese straniere che scelgono di insediarvisi. Per quanto riguarda la gestione del
territorio, si intende qui il livello di sviluppo delle infrastrutture necessarie alle
imprese per rifornirsi di materie prime, per portare ai quattro angoli del mondo i
risultati della produzione e per comunicare fra di loro: collegamenti aerei, ferrovie
ad alta velocità, strade e porti, connessioni internet ad alta velocità e copertura per
la telefonia mobile, che ha ormai quasi ovunque soppiantato la rete di telefonia
fissa e in intere parti del mondo, ad esempio nell’Africa subsahariana, dove ne
rende addirittura inutile l’estensione. Per quanto riguarda, infine, la cultura, si
tratta dell’elemento più impalpabile ma non per questo meno sfruttabile del soft
power, come lo definisce Joseph Nye. A differenza di molti altri elementi analizzati,
questo è indubbiamente una caratteristica che l’Italia possiede pienamente e da cui
può trarre profitto, come ripetutamente si è prodigato a ripetere e promuovere il
suo attuale Primo Ministro e come ha saputo dimostrare in occasione di Expo
2015, dove l’“Italian way of life” fondato su un benessere alleato del gusto e della
bellezza non ha mancato di attrarre una vasta platea di potenziali investitori.
L’ultima arma strategica che prendiamo in considerazione qui, nell’ambito
della guerra coperta, è l’intelligence economica, che l’Alto Responsabile presso il
Segretariato Generale della Difesa francese Alain Juillet definisce come una
modalità di governance focalizzata sul controllo dell’informazione strategica e che
mira alla competitività e la sicurezza sia dell’economia che delle imprese. Altri due
grandi esperti di guerra economica, Christian Harbulot ed Éric Delbecque, hanno
proposto le loro definizioni di intelligence economica. Il primo l’ha definita come la
costante ricerca e interpretazione delle informazioni accessibili a tutti, con
l’intento di decifrare le intenzioni degli attori e intuire le capacità. Il secondo
invece l’ha individuata nella cultura di lotta economica, ossia nella competenza –
intesa come l’insieme di metodi e di strumenti di sorveglianza, di sicurezza e di
influenza–enella politica pubblica, che mira ad accrescere la potenza tramite
l’elaborazione e l’attuazione di strategie geo-economiche, oltre che tramite azioni
in favore del controllo collettivo dell’informazione strategica. L’intelligence viene
qui naturalmente intesa nella sua accezione originaria di derivazione
anglosassone, ossia come raccolta di informazioni per sapersi muovere meglio sul
terreno, qualunque esso sia, e non tanto negli aspetti esacerbati dello spionaggio e
degli agenti segreti tipici dell’epoca della Guerra Fredda, in cui ciò che si
privilegiava era una cultura dell’informazione ad appannaggio di pochi, oscuri
esperti e incurante dell’illegalità dei mezzi utilizzati (trasferimenti di tecnologia,
furti di materiale informatico, licenziamenti di quadri strategici, ecc.). Analizzando
più nel dettaglio in cosa consista l’intelligence economica, ossia le applicazioni
concrete di quella che a volte viene definita impropriamente “guerra
dell’informazione”, possiamo distinguere tre campi d’azione: la veglia, la
protezione dell’informazione e la realizzazione di lobby. La prima, in particolare, si
concretizza nella sorveglianza dell’ambiente economico di riferimento in modo da
individuare con una certa prontezza eventuali minacce da cui difendersi o
occasioni da cogliere; si divide nelle sette tipologie di veglia concorrenziale,
commerciale, tecnologica, geografica, geopolitica, legislativa e societaria. Tutto ciò
a favore di una crescita di influenza, e quindi di potenza, di quegli Stati in grado di
mettere in campo un tale dispositivo. Il punto di vista che qui si propone, infatti,
privilegia la capacità dello Stato di usare quest’arma strategica, piuttosto che
quella delle singole imprese che la usano allo scopo di ampliare il proprio giro
d’affari e di aumentare i profitti. Contemporaneamente strumento offensivo e
difensivo, come quando viene usato per prevedere un’alleanza fra concorrenti o
praticare la disinformazione, l’intelligence economica è il fiore all’occhiello delle
politiche di guerra economica, vista l’importanza assunta dall’informazione nelle
economie moderne. È su questo terreno, peraltro, che si rende maggiormente
necessaria una stretta collaborazione fra Stato e imprese, sul modello sviluppato in
Giappone nell’immediato dopoguerra, quando la fondazione della Japan External
Trade Organization si affiancò al lavoro del già citato MITI. L’intensificazione dei
legami commerciali con gli altri Stati veniva perciò supportata dagli ampi poteri
assegnati a quest’ultimo, in una realtà non solo economica ma anche culturale dove
la partecipazione allo sforzo di rendere grande la propria nazione attraverso i
primati in termini di innovazione tecnologica e proiezione commerciale è un
dovere morale di ogni singolo cittadino. Non a caso, dell’intero budget nazionale
destinato a ricerca e sviluppo, una cifra compresa fra il 10 e il 15% viene destinata
in Giappone all’informazione scientifica e tecnica. Qualcosa di analogo avviene
anche negli Stati Uniti, anche se ancora formalmente mascherato da un discorso
ufficiale di competizione leale. L’amministrazione americana ha infatti messo in
piedi un servizio di “contro-intelligence”, derivato da un ampliamento delle
prerogative della CIA che in questo modo svolge un ruolo attivo nello spionaggio
industriale, per fornire alle proprie imprese informazioni segrete relative ai loro
concorrenti stranieri.
Dopo aver analizzato ampiamente le armi utilizzate nella guerra economica
coperta (formazione dei quadri dirigenziali, politiche di competitività e di
attrattività, dispositivi di intelligence economica), conviene ora passare in rassegna
le diverse armi offensive a disposizione degli Stati.
Nel corso del presente contributo si sono già citate le sanzioni quale forma
di guerra economica condotta con finalità politico-strategiche. Una modalità che
risulta ancora più soffocante per l’avversario è quella del boicottaggio, quando non
del blocco alle vendite: ne sono esempi l’arma alimentare usata dal presidente
Carter nel 1979 per bloccare le vendite di cereali all’URSS in occasione
dell’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Armata Rossa, l’attuale minaccia di
chiusura dei rubinetti del gas da parte della Russia nei confronti dell’Europa, o
ancora il boicottaggio a danno dei prodotti francesi in Cina nel 2008 causato dal
sostegno dato da Parigi al Tibet, questione peraltro scoppiata alla vigilia dei giochi
olimpici di Pechino anche in molti altri Paesi occidentali in seguito alla repressione
cinese della ribellione dei monaci tibetani. Un’altra misura che potrebbe essere
interpretata come ritorsione è il contingentamento delle importazioni: vietato
nell’Unione Europea, è invece ampiamente usato dagli Stati Uniti nei settori più
disparati, che vanno dal formaggio alle automobili, misura quest’ultima volta a
tutelare le grandi società produttrici americane a detrimento dei prodotti
giapponesi, con Tokyo che ha preferito negoziare in questo senso piuttosto che
correre il rischio di essere soggetto a restrizioni ancora più sfavorevoli. Vi sono poi
i picchi tariffari, ovvero dazi doganali superiori al 100%, spesso applicati sui
prodotti agricoli provenienti da determinati Paesi (si vedano ad esempio le
condizioni di adesione all’OMC imposte all’Afghanistan nel 2014, alla fine dei
negoziati).
A queste armi dirette si affiancano, come si vede ora, altrettante armi
offensive indirette della guerra economica aperta. Innanzitutto la cosiddetta
“diplomazia degli affari” che, pur essendo una pratica dalla lunga tradizione, è stata
perfezionata dall’amministrazione Clinton: essa consiste in una sorta di assalto
massiccio delle imprese sui mercati esteri, supportata da un’attenta preparazione
del terreno (liberalizzazione degli scambi con il Paese interessato), da
un’approfondita conoscenza del campo dello scontro (informazione industriale e
commerciale) e da una sapiente regia statale (nel caso degli Stati Uniti degli anni
Novanta, l’Advocacy Center informalmente chiamato “War room”, incaricato di
sorvegliare costantemente i mercati industriali mondiali). Se si affronta più nel
dettaglio il primo di questi elementi, la liberalizzazione degli scambi, vediamo
come e quanto sia stato usato soprattutto dagli Stati Uniti come una vera e propria
arma. I trattati di libero scambio da essi conclusi, infatti, hanno sempre rivelato la
loro potenza offensiva in quanto strumenti di relazione diseguale tra uno Stato
forte, da un lato, e uno Stato debole, dall’altro, asimmetria che ha sempre
penalizzato quest’ultima controparte, naturalmente. È il caso, ad esempio, delle
relazioni commerciali mantenute con gli Stati dell’America centrale (la cui quasi
totalità dei Paesi ha concluso simili accordi con Washington): nient’altro che
un’evoluzione post-Guerra Fredda dell’idea di manifest destiny, della dottrina
Monroe e del corollario Roosvelt. Questi accordi sono spesso molto più
intransigenti degli standard dell’OMC ai quali tutti appartengono: la supremazia
statunitense si afferma gioco forza per l’importanza rivestita nella bilancia
commerciale di questi Stati, di cui sono il primo partner commerciale, e permette
di imporre unilateralmente norme sbilanciate in loro favore, ad esempio sui
brevetti (allungamento della durata di protezione dei brevetti, oppure
allargamento delle condizioni di brevettabilità, che permettono di porre dei
brevetti su prodotti già commercializzati) e, di conseguenza, di conservare la
leadership. Gli Stati Uniti, dunque, non schiacciano il loro avversario economico
con la forza, ma si accontentano in qualche modo di definire regole del gioco
favorevoli ai propri interessi.
L’ultima evoluzione in termini di armi offensive nella guerra economica
sono i fondi sovrani che hanno fatto la loro irruzione sullo scenario finanziario
mondiale negli ultimi vent’anni e che, per la portata del loro impatto sull’economia
internazionale, ci si potrebbe arrischiare a paragonare a vere e proprie armi di
distruzione di massa. Si tratta di fondi d’investimento internazionale del risparmio
nazionale che, essendo difficilmente depositabile nei circuiti bancari classici per
l’eccezionalità del loro importo (le stime indicano una cifra di più di 16.000
miliardi di dollari solo per i Paesi dell’Asia orientale), viene direttamente
controllato dagli Stati o dalle banche centrali. Sono stati pensati in origine come
strumenti finanziari destinati a valorizzare un capitale rilevante dello Stato e
destinato alle generazioni future (è questo il caso del fondo sovrano norvegese). La
maggior parte di questi fondi è stata costituita da Stati esportatori di petrolio, da
un lato, e da Paesi dell’Asia orientale la cui bilancia corrente registra saldi
dell’ordine del 6,5% del PIL, dall’altro, per investire le loro ingenti eccedenze
commerciali e si sono configurati come potente mezzo di intervento negli equilibri
economici mondiali soprattutto in seguito alla crisi dei subprime, quando un certo
numero di essi è entrato nel capitale di gruppi prestigiosi (Citigroup, Merrill Lynch,
Morgan Stanley) allo scopo di salvarli con iniezioni di liquidità. Esemplificativo è il
caso di Citigroup: primo gruppo finanziario mondiale fino al 2007, di fronte ai
problemi di liquidità derivati dalle speculazioni dei subprime ha fatto appello a
diversi fondi fra cui quelli di Singapore, del Kuwait e di Abu Dhabi. Il salvataggio c’è
effettivamente stato, ma a condizioni dettate naturalmente dai nuovi investitori:
garanzia di rendimenti elevati delle azioni (dal 9 all’11% annuo), prezzi minimi
garantiti anche in caso di crollo dei valori e decisioni prese non più nella sede della
casa madre negli Stati Uniti, bensì nel palazzo di uno degli emiri proprietari del
fondo sovrano, elemento territoriale puramente simbolico ma molto eloquente di
qual è lo Stato che ora ne detiene il controllo. Risulta quindi evidente come un tale
massiccio intervento non sia affatto neutro e che, di conseguenza, sia a tutti gli
effetti una forma di controllo da parte degli Stati di cui tali fondi sono emanazione.
Il sospetto è che, anche grazie a politiche e gestioni non esattamente trasparenti,
essi servano interessi politici e geopolitici dei Paesi emergenti e vengano perciò
percepiti come una minaccia economica importante dai Paesi occidentali. Basti
pensare che il fondo di Abu Dhabi da solo avrebbe potuto acquisire, prima della
crisi, le prime nove imprese quotate nel più importante indice della piazza parigina
e che la China Investment Company, fondata nel 2007, si posiziona già al 6° posto
mondiale per quantità di capitale. La miglior prova del fatto che sono percepiti
come una minaccia è la recente adozione di misure destinate a ostacolarne la
capacità di acquisizione. Questo dispositivo ha una certa tradizione negli Stati
Uniti, dove il Committee on Foreign Investments può consigliare al Presidente di
rifiutare un investimento straniero che minaccerebbe un’impresa americana
giudicata strategica.
Accanto alle armi, vi sono i dispositivi di protezione e di difesa.
Naturalmente, attacco e difesa sono strumenti che concorrono insieme a definire
una stessa strategia e perciò il loro uso ha pari importanza all’interno della guerra
economica. Libero scambio sì, dunque, ma a patto di poter adeguatamente tutelare
il tessuto industriale interno e le ricadute che la sua tenuta ha in ambito politico e
sociale; se dunque le varie teorie elaborate dagli specialisti non soddisfano questo
principio pragmatico, gli Stati non si fanno alcuna remora a ignorarle e ad agire nel
senso protettivo appena indicato. È il motivo per cui non bisognerà meravigliarsi
che certi mezzi di difesa presentati qui siano già stati annoverati nella categoria
delle armi appena presentate: gli stessi strumenti della guerra economica possono
rivelarsi contemporaneamente armi potenti e scudi resistenti in funzione del
contesto. I dispositivi di protezione e di difesa che vedremo sono: la moneta,
l’unfairtrade, le barriere doganali e tariffarie, le quote d’importazione, le
sovvenzioni alle esportazioni, il patriottismo economico sotto forma di consumo
patriottico e il soft power normativo.
Per quanto riguarda la moneta, la svalutazione è un potente mezzo di
stimolo alle esportazioni in periodo di recessione, come hanno dimostrato le azioni
della Bank of England fra il 2008 e il 2009 in favore della sterlina nei confronti
dell’euro e la svalutazione di yen e yuan. La moneta svolge così il doppio ruolo di
strumento difensivo, poiché diminuisce la competitività dell’avversario, e di arma,
in quanto consente una più facile penetrazione dei mercati esteri.
La questione dell’unfairtrade si richiama a una legge statunitense del 1962,
la cosiddetta “301”, che aveva lo scopo di sanzionare Stati e imprese appartenenti
al proprio blocco che si rendessero colpevoli di comportamento sleale ovvero,
concretamente, commerciassero con l’URSS o con Cuba, e autorizzava il Presidente
in persona a rispondere agli atti “ingiustificabili”, “immotivati” o “discriminatori” di
questo tipo. Se ciò è facile da comprendere in un contesto di Guerra Fredda, in cui
le alleanze politico-strategiche regolavano abbastanza rigidamente le relazioni
internazionali, risulta forse meno accettabile in un contesto di distensione e
multilateralismo come quello odierno, eppure si tratta di atteggiamenti tutt’altro
che desueti. Negli anni Novanta il Presidente Clinton, che in più occasioni si è
dimostrato come un forte sostenitore della logica di guerra economica, ha
rinnovato la cosiddetta “super-301” emanata nel 1984 allo scopo di individuare gli
ostacoli alle importazioni americane e combatterli con misure di ritorsione. Il caso,
citato in precedenza in merito al boicottaggio, delle misure di tutela delle grandi
case automobilistiche a scapito dei prodotti giapponesi, accettate da Tokyo per non
correre il rischio di essere soggetto a restrizioni ancora più sfavorevoli, nacque
proprio a causa della minaccia americana di ricorrere alla “super-301”, con
sovrattasse anche del 100%. L’istituzione dell’OMC e del relativo organismo di
regolazione delle controversie, sorta di arena giuridica dove si affrontano le
potenze per far valere i loro diritti, dovrebbe prevenire il ricorso a questo tipo di
misure. Il funzionamento dell’Organo di Conciliazione si basa su norme precise e su
una serie di scadenze predefinite per l’esame di ciascun caso. La procedura dura in
totale al massimo un anno e tre mesi (solo un anno in assenza di appello): le
decisioni iniziali sono prese da un gruppo speciale, previa consultazione di
entrambe le parti cui viene anche presentato il rapporto finale (entro sei mesi), e
approvate o rifiutate dall’insieme dei membri dell’OMC. Tuttavia l’obiettivo
dell’organismo, più che essere l’emissione di un giudizio, sarebbe di conciliare, per
l’appunto, le controversie e arrivare a una negoziazione consensuale della
risoluzione da parte delle due parti in causa; un’eccezione a questa funzione
particolare, che peraltro normalmente si realizza nei fatti, è stata la cosiddetta
“guerra delle banane” che ha contrapposto i Paesi ACP a quelli dell’America Latina.
Negli ultimi tempi, l’Organo di Conciliazione ha registrato un aumento del numero
di ricorsi, segno per i suoi funzionari della fiducia che gli Stati riporrebbero nelle
sue procedure e decisioni. Tuttavia, in un contesto di competizione sempre
maggiore, esso potrebbe anche essere uno fra i tanti mezzi di cui gli Stati si
servono per vincere le battaglie economiche che li oppongono e, per questo, un
rivelatore particolarmente paradigmatico della situazione di guerra economica al
tempo della globalizzazione.
Per quanto riguarda le barriere doganali o tariffarie, si tratta dei mezzi
difensivi più antichi di cui gli Stati dispongono per tutelarsi contro le strategie
offensive sviluppate dai loro avversari. Sono un tipo di misura attuata soprattutto
dai Paesi in via di sviluppo, che la adottano per proteggersi dalle importazioni
provenienti dalle nazioni industrializzate (l’economista tedesco propone la
definizione, in questo caso, di “protezionismo educativo”). Dal canto loro, i Paesi
occidentali si servono delle tariffe doganali per proteggere l’occupazione
industriale, il che, se da un lato ha costi elevati in termini economici, dall’altro è
politicamente molto favorito in ragione della sua influenza sugli equilibri sociali.
D’altra parte, è doveroso ricordare come dalla fine della Seconda Guerra Mondiale
le tariffe doganali siano costantemente scese, passando dal 44% degli anni Trenta
del Novecento all’attuale valore inferiore al 5%.
Già si è parlato del contingentamento delle importazioni, con cui sono
strettamente imparentate le quote di importazione, la forma più importante di
barriera non tariffaria. Delimitando direttamente la quantità di prodotti di un certo
tipo che possono essere importati, esse vengono usate per proteggere determinati
settori nazionali oppure per equilibrare la bilancia dei pagamenti. Anche in questo
caso, sono gli Stati Uniti a fornirci un buon esempio con la loro quota
d’importazione sulle importazioni di zucchero: a fronte di una limitazione ben
definita della quantità di zucchero importato e di una conseguente maggiorazione
del prezzo sul prodotto finale venduto al consumatore, il settore zuccheriero
statunitense, piccolo in termini di numeri di occupati, non conosce crisi. Le quote
derivano appunto da una scelta politica, quella di conservare l’occupazione in
determinati settori: la razionalità economica liberale imporrebbe la soppressione
delle quote per abbassare il prezzo del prodotto finale e diversificare il consumo,
ma in guerra economica qualunque teoria non funzionale al mantenimento di una
logica di potenza e di indipendenza risulta sostanzialmente inapplicabile.
Questa sorta di “nuovo protezionismo” si manifesta, oltre che nelle
importazioni, anche nelle esportazioni, sotto forma di sovvenzioni pubbliche a una
determinata impresa o settore di produzione. Conosciute anche con il nome di
dumping, sono ufficialmente illegali (si veda ad esempio quanto stabilito dal
regolamento CE n. 1225/2009 del Consiglio dell’UE), ma spesso vengono attuate in
maniera indiretta. In questo senso, rivestono particolare importanza le
sovvenzioni agricole: sia l’Unione Europea che gli Stati Uniti erogano consistenti
aiuti di Stato ai rispettivi agricoltori, a detrimento di tutti quei Paesi, soprattutto
africani, la cui economia si regge sul settore primario ma che, non detenendo alcun
potere sullo scacchiere economico internazionale, sono fortemente penalizzati e
non riescono neppure ad accedere al mercato mondiale delle derrate alimentari.
C’è da dire che, almeno formalmente, sia l’UE che gli USA si sono impegnati a
rivedere PAC e varie Farm Bill ma, non essendo stati fissati dei tempi per farlo, la
partita non è ancora neppure aperta.
Quando si parla di patriottismo economico si fa riferimento a un famoso
discorso del 2005 dell’allora Primo Ministro francese Dominique de Villepin, nel
quale si affermava la necessità da parte dello Stato di difendere le imprese
nazionali strategiche, soprattutto in settori di punta o comunque considerati parte
del patrimonio industriale nazionale. In realtà, tale concetto sarebbe nato già negli
anni Novanta, sempre in territorio francese, in concomitanza con la fase successiva
alla fine della Guerra Fredda di massima espansione della globalizzazione, che
rappresentava una potenziale minaccia per le imprese dalla capitalizzazione
fragile. La definizione usata da Villepin si rifarebbe invece a un rapporto
presentato nel 2003 dal deputato Bernard Carayon su “Intelligence economica,
competitività e coesione sociale”, dalla fortuna altalenante (condiviso da politici e
imprenditori, ma ritenuto insufficiente nelle sue analisi da molti economisti). In
esso viene ampiamente esposta e dimostrata l’esigenza di dare una connotazione
maggiormente patriottica alla politica economica francese, definendo a tal
proposito tutta una serie di obiettivi da raggiungere: definizione di interessi
comuni fra Stato e settore privato, la tutela di questi interessi come misura di
legittima difesa dall’assunzione di controllo da parte di capitali stranieri, la
successiva conquista di porzioni di mercato mondiale promuovendo l’eccellenza di
determinati settori e aumentandone la competitività. È proprio seguendo le idee
presenti in questo rapporto che è emanato il decreto del 31 dicembre 2005, voluto
da Villepin, sulla protezione della produzione di settori quali la difesa, le tecnologie
dell’informazione, la sicurezza privata e i sistemi di intercettazione delle
informazioni. D’altra parte, la Francia non è la sola a fare ricorso a questo
strumento di difesa nella guerra economica: l’Unione Europea stessa, con
l’istituzione nel 2004 della forma giuridica della “società europea”, persegue
chiaramente l’obiettivo di consolidare la dimensione europea di queste imprese a
discapito di possibili assunzioni di controllo da parte di entità straniere nei loro
confronti. Per non parlare poi degli Stati Uniti, dove il Committee on Foreign
Investment ha diritto di veto sulle operazioni d’acquisto di imprese americane da
parte di società straniere, o ancora della Germania, dove nel 2010 il governo della
cancelliera Merkel ha impedito l’acquisizione di Opel da parte di Fiat-Chrysler.
Per quanto riguarda il soft power normativo, l’esempio principe che merita
di essere preso in considerazione è quello delle negoziazioni commerciali
multilaterali. L’OMC è quindi diventata teatro di scontri contrapposti per
promuovere e ampliare sempre più il libero scambio, da un lato, e proteggere il
vantaggio tecnologico dei Paesi industrializzati, dall’altro. È ovvio che ad esserne
svantaggiati risultano soprattutto i Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo,
perché la mancata liberalizzazione di determinati brevetti in campo medico, ad
esempio, impedisce a questi Stati di produrre medicinali a basso costo. Un’OMC
ostaggio dei Paesi occidentali, che ha portato fra le altre cose al fallimento nel 2011
del Doha Round dopo dieci anni di negoziati, non è altro che una misura di difesa
contro quei Paesi emergenti – India in testa con il suo potenziale di produzione
nelle biotecnologie – che potrebbero così aspirare non solo all’indipendenza
economica in determinati settori, ma anche a imporsi come leader sui mercati
internazionali. Altro terreno su cui si disputa un’importante partita intorno al soft
power è senza dubbio il Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli
Investimenti (TTIP): non un semplice accordo commerciale di libero scambio per
la libera circolazione di merci e servizi, ma anche un accordo di tipo normativo,
volto a rimuovere le molte differenze in regolamenti tecnici, norme e procedure di
omologazione, standard applicati ai prodotti e regole di sicurezza e sanitarie
presenti fra Unione Europea e Stati Uniti, che hanno ancora alcune carte da
giocarsi in merito. Questo partenariato, qualora e quando entrasse in vigore,
creerebbe l’area di libero scambio più grande del pianeta, equivalente a circa la
metà del PIL e un terzo degli scambi commerciali globali: tutto il mondo ne
gioverebbe e sarebbe ipotizzabile imboccare nuovamente la strada del
multilateralismo nella liberalizzazione commerciale, che attraversa un momento di
stallo nonostante la volontà di unificare il commercio mondiale. La
frammentazione giuridica attuale, infatti, favorisce la costruzione del teatro della
guerra economica, con la regola del più forte (del più potente) a prevalere su
qualsiasi altra logica razionale.
Infine, fra gli strumenti difensivi citati in apertura di questa sezione vi è il
consumo patriottico, che consiste semplicemente nel privilegiare l’acquisto di
prodotti nazionali, piuttosto che stranieri, nei più disparati settori. Esso può essere
incentivato dallo Stato oppure no, ma in entrambi i casi fornisce una difesa efficace
contro gli attacchi della guerra economica. Il primo caso è rappresentato dagli Stati
Uniti, dove una misura protezionistica adottata in piena Grande Depressione, il
Buy American Act promosso da Roosevelt e approvato nel 1933 come una delle
misure volte a risollevare il Paese dalla recessione economica, è ancora in vigore a
giustificare una politica che accorda ufficialmente la preferenza alle imprese
americane. In questo quadro si inserisce, ad esempio, il conflitto fra Boeing e
Airbus per la fornitura di una commessa all’aviazione statunitense: l’impresa
europea era stata selezionata per le sue migliori prestazioni, ma il Pentagono ha
comunque deliberato di annullare l’offerta e di rimetterla alla decisione della
prima amministrazione Obama all’indomani del suo insediamento, favorendo così
implicitamente Boeing in questa partita. In Giappone, invece, le modalità di
consumo patriottico sono completamente diverse: lo Stato non ne ha alcuna
responsabilità, ma sono di fatto i consumatori a preferire per la stragrande
maggioranza i prodotti nazionali. Ne sono un esempio il mercato dell’automobile,
detenuto per il 95% da marchi nipponici, o il recente blocco della
commercializzazione di prodotti elettronici targati Samsung nel Paese del Sol
Levante, dovuto a una penetrazione difficilissima del mercato giapponese che
lasciava all’azienda coreana un misero 1% dell’intero mercato dell’elettronica.
Conclusioni
Questo contributo era iniziato con gli auspici dei grandi pensatori
dell’Ottocento circa la realizzazione di uno scenario di pace perpetua dove il libero
scambio delle merci e delle idee avrebbe sostituito gli scontri militari fra nazioni
per la supremazia politica ed economica. Nonostante le apparenti promesse del
multilateralismo degli anni Novanta e una globalizzazione che teoricamente
poneva le basi perché questo progetto si avverasse, le lotte a tutto campo per il
controllo dei mercati e delle risorse continuano a infuriare.
http://italiaeilmondo.com/2019/11/26/una-nuova-tipologia-di-guerra-la-guerra-economica_2a-parte-di-giuseppe-gagliano/
http://italiaeilmondo.com/2019/11/22/una-nuova-tipologia-di-guerra-la-guerra-economica_1a-parte-di-giuseppe-gagliano/






 (Credito fotografico: NATO)
(Credito fotografico: NATO) (Credito fotografico: NATO)
(Credito fotografico: NATO)