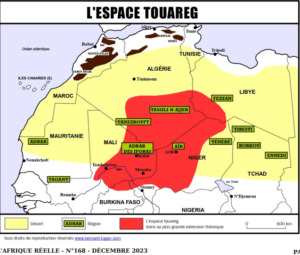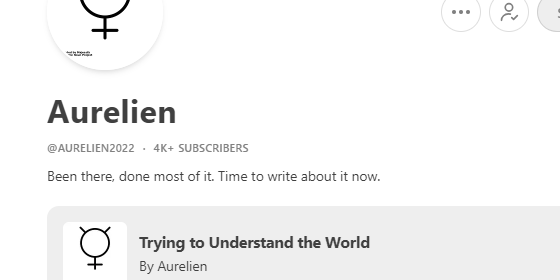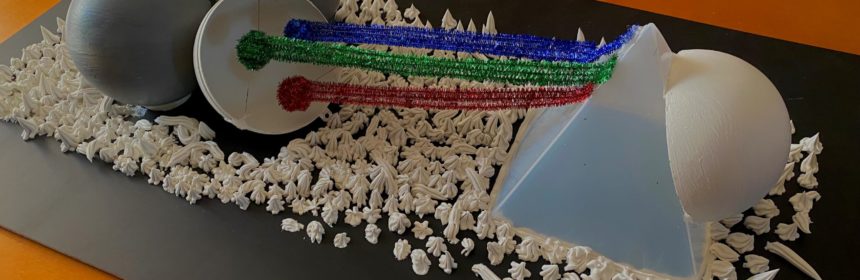Riceviamo e pubblichiamo_Giuseppe Germinario
Nichilismo del lavoro nella società capitalista
FINI MOTIVANTI IL LAVORO
Il lavoro è azione su ciò che ci è esterno, imprimendo su esso una forza per modificarlo. Sul mondo agiscono forze oggettive: gravità, elettromagnetismo, ecc. Il lavoro è invece una forza messa in atto dalla nostra soggettività: è pensiero fatto azione. A differenza degli animali, il cui lavoro è finalizzato soltanto a soddisfare stimoli che fanno capo all’istinto di conservazione e riproduzione, l’uomo lavora anche sotto la spinta di pulsioni che non hanno strettamente a che fare con i due istinti testé menzionati .
Ad es. c’è chi lavora per far carriera, onde accrescere la propria autostima e/o gratificarsi esercitando un potere sugli altri; altri lavorano per non essere costretti, stando con le mani in mano, a prendere atto di una situazione esistenziale non propriamente felice.
C’è anche chi poi fa del proprio lavoro una sorta di rituale ossessivo, con cui mettere ordine nella propria vita. A mo’ di esempio mi vien da pensare a chi pulisce giornalmente la casa perché, essendo incapace di mettere ordine nel proprio essere, lo vuole mettere almeno nelle cose che possiede, illudendosi che all’ordine nell’avere corrisponda metaforicamente quello nell’essere. L’uomo contemporaneo ha perso l’accesso all’interiorità, a ciò che egli è indipendentemente da ciò che possiede. Nella nostra società il lavoro è quindi la manifestazione del prevalere dell’avere sull’essere.
LAVORARE PER AVERE
L’uomo odierno si pone nei confronti dell’essere non più con l’attitudine di chi cerca di attribuirgli un significato positivo, ma con quella di manipolarlo al fine di piegarlo al proprio servizio, illudendosi così che esso non ci causi dolore e infelicità. Per manipolare l’essere ci vuole però la potenza; con essa crediamo di assoggettare l’essere per renderlo un nostro avere.
Nella società odierna il lavoro è finalizzato quasi esclusivamente ad accrescere la potenza e di conseguenza l’avere. Esso rappresenta perciò una modalità essenzialmente predatoria e sopraffattrice di rapportarsi con l’esterno. Ad es. se l’essere in noi va in un bosco per godere della bellezza della natura e per sentirsi in sintonia con la sua forza vitale, l’avere in noi ci va per vedere cosa c’è da predare: trasformare gli alberi in legname, far piani di disboscamento per far posto a lucrose piantagioni, ecc.
L’ESSERE AMBISCE ALL’UNITÀ COL TUTTO
L’essere si rapporta alla natura con lo scopo di creare un legame con essa, onde far nascere un sentimento di unità col tutto. L’essere infatti – come ci ricordano gli antichi filosofi – è uno, per cui la sua modalità di azione è finalizzata a produrre unità.
Chi sperimenta in sé il sentimento di unità col tutto avverte che la sua piccola vita individuale viene arricchita dalla vita del tutto cui è legato. La potenza che sente in sè coincide con la volontà di essere legato al tutto. È una Potenza quindi ben diversa da quella che ha per scopo il dominio sul tutto. Questa è fondata sulla logica del “divide et impera”, quindi sulla rottura dei legami; quella sul la volontà di legame col tutto.
Di più, la prima crea divisione all’interno dell’essere, frantumandolo in parti che, in quanto separate, percepiscono le altre come oggetti (objecta, poste fuori da sé). È una potenza che trae la sua forza dall’oggettivazione dell’essere un essere ridotto a materiale a servizio della potenza.
La seconda invece è fondata sulla volontà che l’essere sia uno, quindi che sia soggetto, in quanto niente è al di fuori di esso (objectum). Non è quindi una potenza – quella data dagli oggetti – ma una potenza di natura immateriale, che non ci viene quindi dall’esteriorità degli oggetti, ma che è in noi, la Potenza insita nella nostra soggettività.
Si è potenti non separandoci dall’essere oggettivandolo, ma unendoci ad esso soggettivizzandolo. Oggettivando l’essere lo tra- sformiamo in materia, per cui esso diventa per noi un avere. È invece soggettivizzandolo, cioè creando legami onde superare l’alterità dell’oggetto, che l’essere conserva la sua autentica natura, quella di essere uno.
Chi vive secondo l’essere sente che la potenza datagli dal lega- me con il tutto è interna a lui; che non è separabile dal suo essere, come può esserlo ciò che è materiale. Egli sente che la potenza è il suo stesso essere, che è una cosa sola con lui. La natura del suo legame col tutto è il prodotto del fatto che egli si identifica totalmente col tutto, per cui egli sente che non c’è da una parte lui e dal- l’altra il tutto, col legame a fungere da trait d’union fra loro. Egli sperimenta il suo essere come il legame stesso, come ciò che crea unità.
Finché egli proverà in sé un tale sentimento dell’essere, niente e nessuno potrà spezzare tale legame, a meno che non sia egli stes- so a volerlo, scindendo il suo legame di identità assoluta col tutto e scegliendo di riconoscere una parte del tutto come esterna.
LAVORARE PER AVERE È UN’ESPERIENZA SEPARANTE
La nostra civiltà, avendo scelto di rapportarsi all’essere secondo la modalità dell’avere, ha rimosso la percezione che il legame è con- sustanziale all’essere. Ne consegue che, per evitare la disgregazione dell’essere, il legame diventa cosa da creare; infatti, per chi vive secondo l’avere, originario non è il legame, bensì la separazione. Per lui l’essere è molteplicità, per cui i legami sono da creare con la forza, costringendo l’altro a piegarsi alla volontà di chi vuole legarlo a lui.
Di qui l’ossessione della nostra civiltà di dover lavorare incessantemente per accrescere la potenza. Essa diviene necessaria per tenere unito l’essere, in quanto da noi percepito come disgregato.
Il problema però è che, per ottenere potenza, si deve dividere l’essere ancor più di quanto sia già diviso. Di conseguenza il lavoro, invece di creare ordine, legami che appianino i conflitti fra gli opposti, crea ancor più divisione, facendo degradare i legami a un qualcosa di prodotto dalla sola forza e non da una libera volontà. Si tratta di legami costretti, creati dalla necessità.
Lavoriamo per creare un mondo di schiavi talmente disumanizza- ti da assomigliare quasi a dei robot (ciò d’altra parte è in linea con chi ritiene che anche la vita sia un fatto meccanico) e siamo con- vinti che questo sia l’unico modo per salvare l’essere: privarlo del- la libertà e quindi della coscienza. Ma questo significa distruggere la vita, riducendo l’essere allo stato minerale, dove maggiore è l’in- coscienza. Mi sembra che l’umanità attuale – fra guerre, inquina- mento, programmi di distruzione più o meno controllati – stia pericolosamente avvicinandosi a questa meta così “progredita”.
PENSIERO AL SERVIZIO DELL’AVERE
La nostra è la civiltà dell’agire, del fare, della trasformazione incessante dell’essere. Con ciò esprimiamo molto più eloquente- mente che con le parole quale sia il nostro concetto dell’essere e il modo con cui intendiamo relazionarci con esso: vogliamo negarne la stabilità e unità, per consegnarlo a un divenire assoluto che lo renda talmente plastico da permetterne una manipolabilità totale.
Anche il pensiero viene posto di conseguenza al servizio del fare, al fine di trasformare l’essere, rompendo i legami che ne assicura- no l’unità. È messo al bando pertanto il pensiero filosofico che pen- sa l’essere come unità, sostituendolo col pensiero analitico-sepa- rante della tecnica. Si pensa per accrescere la separazione, l’instabilità e quindi il divenire. Si vuole che l’essere sia sempre più fratto, separato dai suoi legami, affinché divenga più facile impossessarsene. E tale è la fretta che abbiamo, la fretta di incrementare il nostro avere, che finiamo per volere secondo le modalità di sessantottina memoria del ‘tutto e subito’; vogliamo un mondo a portata di mano del nostro desiderio, perché ci hanno messo in testa che i desideri devono essere gratificati subito, altrimenti diventiamo
esseri frustrati, in quanto al nostro essere verrebbe negata la possibilità di avere ciò che desidera. Il desiderio inappagato, poi, produrrebbe uno stato di tensione nell’essere, ritenuto innaturale dal- la psicologia mainstream.
PER IL PENSIERO ANTIDIALETTICO L’IMMOBILITÀ CREA STABILITÀ; PER QUELLO DIALETTICO LA STABILITÀ È PRODOTTA DAL MOTO
Per la nostra civiltà, l’essere si trova nelle condizioni ideali quando è in uno stato di quiete , riposo; quando cessa di desiderare per- ché ha già tutto. In tale stato l’ essere è immobile, quindi impossibilitato a divergere da se stesso. Ci illudiamo stoltamente di poter così sottrarre l’essere all’azione del divenire che modificandolo annullerebbe l’identità dell’essere con se stesso. Il venir meno di tale identità per noi starebbe a significare che l’essere, divergendo da sè, diventa non essere.
Solo un pensiero antidialettico può pensare che la stabilità si raggiunga con l’immobilità!
Ciò però è assolutamente falso. Paradossalmente a dircelo però non è la filosofia ma una disciplina come la fisica. Purtroppo la filo- sofia ormai si è scordata del suo compito di insegnare all’uomo che non esiste solo la logica del principio di non contraddizione, ma anche quella del principio di contraddizione o, in altre parole, la logica dell’unione degli opposti o dialettica. Paradossalmente – ripeto – è la fisica moderna che ora ha preso le difese della dialettica. Tanto per fare un esempio ad hoc, la meccanica quantistica è arrivata alla conclusione che il principio fondamentale della natura è che tutto è in movimento, e che è esso movimento a produrre stabilità. Ma senza scomodare la fisica, basterebbe osservare che la dialettica viene confermata anche a livello delle piccole cose. Ecco un esempio terra terra: una bicicletta è in uno stato di equilibrio, quindi di stabilità, solo se è in movimento.
A livello psicologico la stessa legge la ritroviamo nel fatto che
l’individuo è in grado di superare la conflittualità interiore raggiungendo così uno stato di stabilità solo quando, e nella misura in cui, ha in sé una tensione tale da pro-gettarlo oltre la determinazione del presente, mettendolo così in marcia verso l’oltreità del futuro.
OGGI SI LAVORA PER EVADERE DALL’INTERIORITÀ
Per la nostra civiltà, purtroppo, l’essere dev’essere pensato solo come avere: non si è l’essere, ma lo si ha; lo si possiede, per cui abbiamo l’essere nella misura in cui riusciamo ad afferrarlo salda- mente nelle nostre mani. Di conseguenza la progettualità dell’uomo contemporaneo, onde agguantare con maggior sicurezza e presa l’essere, si prefigge scopi molto vicini nel tempo, scopi a portata di mano. Se non lo sono, ci penserà la tecnica ad avvicinarli per ras- sicurarci circa la nostra capacità di avere.
Più i nostri scopi sono vicini però, minore è la tensione del nostro essere verso di loro. La nostra progettualità – capacità di andare aldilà (pro – gettare ) – diminuisce. Se essa – come diceva Heidegger – è ciò che costituisce la nostra essenza, allora il ridurre la sua tensione, volendo ottenere tutto e subito, implica anche una riduzione della nostra essenza. Diventiamo così sempre più statici, inanimati, sempre più oggetti e sempre meno soggetti.
Mi vien da pensare quindi che la frenesia di azione, di lavoro del- la nostra società esprima la volontà di fuggire dalla nostra soggettività. Si lavora per diventare sempre più oggettivi; il nostro lavoro assomiglia sempre più a quello delle macchine. Di qui l’alienazione del lavoro.
Attraverso il divenire incessante prodotto dal lavoro rompiamo la caratteristica fondamentale del nostro essere, l’unità, per cui diventiamo non essere, altro dall’essere, cioè alienati. Lavoriamo, quindi accrescere il divenire, perché esso è ormai diventato ciò con cui ci identifichiamo, soppiantando la stabilità, modello di riferimento per l’uomo di civiltà non ancora contagiate dal morbo del progresso tecnologico.
Identifichiamo il nostro essere col trasformare frenetico e quindi col distruggere l’unità per creare molteplicità, alterità negante la nostra identità. Identificandoci col divenire, non siamo più noi stessi, ma altro da noi; non più soggetti, ma oggetti (objecti: ciò che sta in opposizione a noi stessi).
Ecco allora che, per corroborare la nostra identità oggettuale, produciamo sempre più oggetti, che però non facciamo altro che alienarci ancor di più, in quanto l’oggetto è, per definizione, ciò che sta fuori di noi.
Questo poi rientra nella strategia dell’oligarchia dominante che, con il periodo del consumo facile – almeno negli USA, Europa occidentale e Giappone – ci ha, come dice Latouche, colonizzato il nostro immaginario, attuando una sorta di rivoluzione antropologi- ca, il cui impatto sulla società è stato devastante.
Infatti la gente è diventata sempre più dipendente dall’esterno – cioè da ciò che possiede – per ricevere motivazioni esistenziali e gratificazioni morali. Da qui il bisogno di accrescere incessante- mente il potere sull’esterno per porlo al nostro servizio.
Questo lo chiamiamo progresso, civilizzazione; riteniamo che sia un lavoro volto a perfezionare un mondo sentito come imperfetto per il solo fatto che non è completamente prono alla volontà umana.
GIÀ DAL MONDO ANTICO SI AFFERMA L’IDEA CHE IL MONDO SIA IMPERFETTO
Per gli antichi Greci il mondo era perfetto in sé e per questo chiamato cosmos, cioè perfezione. L’idea della sua imperfezione la dobbiamo al pensiero giudeo-cristiano, per il quale il mondo è imperfetto a causa della caduta di Adamo, caduta che richiede quindi una redenzione.
Se tale pensiero fu accolto e fatto proprio dalla civiltà greco-latina, c’è da ritenere che in essa fosse già traballante il sentimento della perfezione del creato. Ciò – a mio avviso –spiega l’emergere di personalità come Alessandro Magno prima, Giulio Cesare poi, che incarnarono il bisogno di riplasmare il mondo secondo un ordine stabilito dalla loro volontà di potenza.
È singolare che ad un certo punto della storia, nell’umanità del bacino del mediterraneo – e specialmente nella sua parte più occidentale – si sia radicato in maniera così forte il sentimento dell’imperfezione del mondo.
Ora, dato che la visione che abbiamo del mondo esterno rispecchia il sentimento che abbiamo verso la nostra vita, anche la concezione dell’imperfezione del mondo viene a essere conseguenza del sentimento di imperfezione che abbiamo verso la nostra stessa vita, come se fosse mancante di qualcosa.
Ma perché mai – vien da chiedersi – si cominciò a sentire la mancanza come negatività?
Essa, in realtà, è la molla che ci spinge ad agire, in quanto ci sottrae all’immobilismo cui ci ridurrebbe la perfezione. La mancanza nel presente è perciò la condizione perché ci sia un fare ulteriore, e quindi un futuro.
Avvertire la mancanza come negatività è da imputare a una sorta di rifiuto del futuro, derivante da un sentimento di sfiducia nei con- fronti della vita; sfiducia che ci porta, quindi, a volere ora ciò che temiamo che il futuro non ci possa dare dopo.
Il rifiuto del futuro non significa però un rifiuto del fare, anzi! Proprio perché rifiutato coscientemente, il futuro ci condizionerà senza che ce ne rendiamo conto, quindi a partire dall’inconscio.
Mentre l’accettazione del futuro ci porterebbe a un fare equilibrato –un fare che non ricerca una realizzazione immediata – il rifiuto del futuro ci porta invece a voler realizzare i nostri desideri nel presente. Ciò, conseguentemente, ci porta a un fare compulsivo, perché dettato dal bisogno di realizzare i propri scopi immediata- mente, nel presente cioè.
NELLA SOCIETÀ TECNOLOGICA SI LAVORA PER TRASFORMARE LA VITA IN OGGETTO
Lo stato di carenza, di bisogno dell’uomo moderno, è diventato ormai tale da spingerlo ad un attivismo frenetico per tentare di por- vi rimedio. Questa constatazione mi porta a dire che ormai cifra del- l’uomo moderno, più che il pensiero (come diceva Cartesio), è l’a- zione. Ormai l’uomo è perché agisce; in altre parole il suo essere è talmente fragile da indurlo a pensare che solo un costante apporto di energia dato dal fare può salvarlo dall’annichilimento.
D’altra parte già il pensiero – per come era inteso da Cartesio e da chi, prima e dopo di lui, condividevano la metafora del mondo- macchina – è una sorta di fare, in quanto finalizzato a modificare l’esistente e non tanto a interrogarsi sul significato dello stesso. È quindi un pensiero finalizzato all’azione, un pensiero strumentale – come lo definiva la scuola di Francoforte – che, al pari di una macchina qualsiasi, ha lo scopo di accrescere la potenza.
Essa, però, si accresce con la strategia del ‘divide et impera’ cioè rompendo i legami fra gli enti. Di conseguenza nella nostra società il lavoro si configura sempre più come un passaggio del vivente (l’essere come espressione di una rete di legami molto complessa e strutturata: l’essere come unità) al non vivente (l’essere come molteplicità, divisione, chiusura rispetto a ciò che gli è esterno); passaggio che comporta la reificazione della natura, la sua trasforma- zione in mero oggetto.
Non solo ad esempio gli alberi diventano legname, gli animali carne e/o pellame; ma anche la vita umana diventa mera forza-lavo- ro o, a seconda delle esigenze del mercato, carne da piacere, carne da cannone, carne fornitrice di organi da espianto, ecc. L’essere nella sua totalità viene oggettivato: il suo interno viene completa- mente svuotato per essere posto al di fuori di esso (objectum). Ecco allora che di conseguenza noi sentiamo di essere solo in virtù della capacità di afferrarlo per attaccarci a esso.
PER RECUPERARE OCCORRE IL DISTACCO DAL FARE FINE A SE STESSO
Per la grande tradizione filosofica l’autenticità dell’essere si manifesta nel distacco; per la nostra civiltà invece nell’attaccamento. Per essere, ci attacchiamo a ciò che ci è esterno e quindi oggetto rispetto a noi. Chiediamo all’oggetto di farci essere; senza di lui sentiamo infatti di non essere. È difficile pensare ad una follia più grande di questa!
Secondo Dante – e con lui ancora tutto il pensiero medievale – l’essere era salvato dalla dissoluzione grazie a ‘l’amor che move il sole e l’altre stelle’. In seguito, a partire dal 1600, si impone una concezione meccanicista dell’essere e il mito scientista di galileiana memoria che il mondo sarebbe scritto in caratteri matematici. Si cominciò a pensare che non era più l’amore, ma la potenza a salva- re l’essere dalle insidie del non essere.
Da allora il lavoro non ebbe più solo lo scopo di provvedere a soddisfare i bisogni fondamentali dell’uomo e, tutt’al più, di rende- re la vita più comoda, grazie alla produzione di comfort di ogni genere; o, ancora, di essere espressione di creatività, volta alla produzione del bello, e come bisogno di esternare in forme materiali sentimenti e passioni che agitano la nostra psiche.
Da allora il lavoro fu finalizzato ad accrescere la potenza, onde assolvere al compito metafisico di salvare l’essere dal nulla. Di qui l’ossessione di accrescere indefinitamente la produttività del lavoro e con essa la potenza, nell’illusione così di rendere sicura e dura- tura la nostra presa sull’essere. Il lavoro è diventato la risposta sul piano dell’azione materiale alla rimozione della capacità di sentire che l’essere non ha alcun bisogno di essere salvato dalla disgregazione, perché è da sempre e per sempre integro.
Il fare scomposto e frenetico dell’uomo contemporaneo è oggi il sintomo più eloquente della malattia nichilista del nostro tempo, derivante dalla perdita della percezione dell’unità e quindi integrità intrinseca all’essere.
Non c’è lavoro che basti per rimediare a tale perdita. Anzi più si lavora, più si cerca soluzione nella direzione sbagliata, cioè quella del fare che genera potenza. Infatti la potenza, lungi dal produrre unità, richiede e crea disgregazione, cioè divenire dell’essere, divenire che è poi negazione dell’identità dell’essere e della sua integrità. Solo ponendo un freno all’attivismo demenziale del nostro tempo possiamo rallentare il divenire – divenire che è trapasso dall’identità all’alterità, dall’essere al non essere, dall’uno al molteplice
– condizione questa imprescindibile, affinché possa riemergere nella nostra coscienza il sentimento che niente e nessuno potrà mai spezzare il nostro eterno legame con l’essere o, meglio, annullare il nostro eterno essere identici all’essere.
ILLUSIONE CHE LA TECNOLOGIA CI LIBERI DALLA NECESSITÀ
Secondo la nostra civiltà, la volontà dell’essere deve realizzarsi all’istante: non bisogna frapporle ostacolo alcuno, altrimenti l’essere vive in uno stato di necessità che, ostacolando la sua libertà di volere, nega l’essenza stessa dell’essere, cioè la sua volontà.
Ora solo una modalità di sentire antidialettica ritiene la contrapposizione degli opposti – in tal caso necessità e libertà – come assolutamente inconciliabile, tale per cui ogni rapporto fra loro compor- ta soltanto una negazione reciproca, una diminuzione di essere. Una volontà quindi sarebbe veramente libera solo quando ottiene tutto e subito ciò che desidera. Tutto ciò che limita il ‘tutto e subito’ è percepito come necessità negante la volontà dell’essere. Una volontà che ottiene tutto e subito ciò che desidera è una volontà onnipotente, una volontà non ostacolata da alcuna necessità limitante la sua libertà.
L’incredibile progresso tecnologico realizzato dalla nostra civiltà è – a mio avviso – stato possibile solo dal desiderio antidialettico di accrescere illimitatamente la libertà, rimuovendo con la potenza tecnica la necessità. Più la necessità tende a zero, più la libertà tende all’infinito, tende ad annullare i limiti che de-finendola le danno forma e quindi la possibilità di riconoscersi.
Per intendere meglio la dialettica libertà/volontà e necessità, ricorriamo alla coppia di opposti luce e buio. La luce è visibile solo al buio; sarebbe assurdo che io usassi la luce per vedere la luce. La luce si manifesta solo quando svolge la sua funzione di illuminare. È evidente che si può illuminare solo il buio e non certo la luce.
Altrettanto ne è della libertà. Essa si manifesta solo quando svolge l’azione di liberare dalla necessità. Senza la necessità non siamo certo in grado di sentirci liberi e quindi neppure consapevoli di ave- re una volontà. È la necessità che fa sì che la volontà prenda coscienza di compiere l’atto del volere, presa di coscienza che richiede sforzo, fatica, sacrificio. Ed è poi attraverso tale atto che l’essere acquista coscienza di sé, realizza cioè di essere in quanto la sua azione è voluta. Ben diversamente invece le cose stanno con la macchina: essa non ha coscienza di essere perché priva di volontà. La rimozione della necessità, cui punta la nostra civiltà della potenza, diventa in tale prospettiva anche rimozione dell’essere. Senza la necessità, infatti, la volontà non ha più nulla da volere, allo stesso modo che la luce senza il buio non ha più nulla da illuminare. La volontà diventa perfetta nel senso che ha già compiuto totalmente (perfectum) la sua azione di volere. Non vuole più nulla, in quanto ha già tutto. L’assenza di distanza fra ciò che vuole e ciò che ha comporta che la volontà coincida completamente con l’avere.
Tale coincidenza comporta dunque anche la coincidenza fra avere ed essere.
L’ESSERE COME POSSESSO
La nostra civiltà però non si rende conto che l’essere lo si è, non lo si ha. Non possiedo il mio essere come possiedo una macchina, una casa, un oggetto qualsiasi. Non capire questo implica ridurre il proprio essere ad oggetto, a cosa, per cui ci rapportiamo ad esso come ad un qualcosa di esterno a noi (objectum), un qualcosa che possediamo, ma non siamo; un qualcosa cui siamo attaccati grazie alla potenza della nostra presa su di esso.
Stando così le cose, si capisce allora l’ossessione della nostra civiltà per la potenza: crediamo – e ancor più sentiamo – che abbiamo un essere solo fin tanto che riusciamo, grazie alla forza della nostra presa, a tenerlo stretto a noi.
Da qui ne consegue anche che ci rapportiamo in modo antilibertario col nostro stesso essere, perché abbiamo paura che ci scappi di mano. Diventiamo i tiranni, i carcerieri di noi stessi. La parte di noi che ritiene di avere l’essere, invece di esserlo, schiavizza la totalità del nostro essere per non perdere la presa su di esso.
Il fatto però è che più rafforziamo la presa sul nostro essere, nel- l’illusione di acquisirne possesso totale, più ci radichiamo nell’idea che l’essere è avere, che l’essere è quindi attaccato a noi grazie alla nostra presa. Ma per quanto forte essa sia, non potrà mai superare la separazione iniziale onde far sì che l’essere sia nostro una volta per tutte. E questo perché, se l’unità non è originaria, per non spezzarsi abbisogna costantemente di una forza esterna che la mantenga nel suo stato.
Sarà pertanto un’unità mediata, ottenuta cioè grazie alla media- zione di una forza; un’unità prodotta, non originaria, un’unità che viene dopo (pro-dotta) come conseguenza dell’azione di un mezzo (medium): la forza esterna.
Ora, il fatto che la nostra unità con l’essere sia mediata comporta che la causa di questa unità non sia in noi ma fuori di noi; sia cioè nella forza esterna. Il nostro essere dipende quindi dall’esterno. Di qui il senso di precarietà esistenziale e l’ossessione di accrescere il dominio sull’esterno propri della civiltà della potenza.
ILLUSIONE CHE L’ESSERE SI CREI COL LAVORO
Tale sentimento di alienazione dell’essere è a mio giudizio la causa prima e principale dell’ossessione della nostra civiltà per il fare; un fare che, al pari del lavoro di Sisifo, non può mai arrestarsi perchè esso è finalizzato al perseguimento di uno scopo errato in par- tenza cioè realizzare la certezza del possesso dell’essere. Per quanto si lavori per accrescere la potenza della nostra presa, non potremo mai avere il dominio assoluto sull’essere, perché l’essere è libertà. Non c’è da fare nessuno sforzo per essere; anzi bisogna al contrario ritirare la nostra presa su di esso, perché è solo lasciandolo libero che gli permettiamo di rivelarsi a noi nella sua libertà. Riprendendo il parallelismo con la luce e il buio dove la luce è l’essere e il buio è il non essere, la nostra civiltà volendo anche l’es- sere (la luce) testimonia così di non coincidere con l’essere, di non essere l’essere (la luce), ma di identificarsi col buio.
Ora che fa la nostra civiltà per manifestare l’essere (la luce)? Lavora accanitamente per produrre l’essere (la luce), onde uscire dal non essere (il buio). Se noi fossimo non essere (buio), avrebbe senso produrre la luce; noi però siamo già l’essere (la luce), per cui è assurdo che produciamo della luce per manifestare la luce che già siamo. Anzi più luce produciamo, meno appare la luce del nostro essere.
Al contrario è smettendo di produrre luce cioè di produrre essere, come se fosse un oggetto che dominiamo e utilizziamo per i nostri scopi, che dal buio del non essere emergerà in tutto il suo splendore la luce del nostro essere.
La nostra civiltà, avendo rimosso la natura dialettica della vita, non si rende conto che è il buio del non essere che permette alla luce dell’essere di brillare. Siamo talmente terrorizzati dal buio del non essere che pensiamo di dover lottare come dei forsennati contro di esso, per non esserne annichiliti, quando invece tale buio è la condizione necessaria perché possiamo scorgere la luce del nostro essere.
Non abbiamo capito che non è la potenza ad aprirci l’accesso all’essere, ma il coraggio e la forza di stare nel buio, sostenuti dal- la fede che più il buio si fa denso, più luminosa apparirà la luce dell’essere.
L’ETICA È CONNESSA ALL’ESSERE, NEGATA DALL’AVERE
Non c’è dubbio che la volontà della nostra società di risolvere l’es- sere in avere è anche la causa della perdita nell’uomo contemporaneo del senso della dignità, dell’onore, del senso stesso della vita.
Per l’avere ha senso solo ciò che si può possedere, solo ciò che possiamo far nostro, sottraendolo alla proprietà comunitaria. L’avere è quindi in contrapposizione con l’etica in quanto, avendo essa per scopo il perseguimento del bene comune, promuove la condivisione dei beni. L’individuo etico è quello che identifica il suo bene con quello della totalità. Egli trascende così la sua individualità, la sua separatezza, riconoscendosi come totalità. Concepisce l’unità in ter- mini unificanti: cioè l’unità si ottiene unendo. Sembrerebbe una cosa lapalissiana, ma non è così. Con ciò si vuol dire che secondo l’etica l’unità non è il risultato di un fare, non è un prodotto, una conseguenza di una causa esterna ad essa. Che l’unità si ottiene unendo significa che l’unità è causa di se stessa; essa è nello stesso tempo causa ed effetto. L’unità non è solo prodotto – un qualcosa che vien fuori dopo (prodotto), ma è anche causa di sé in quanto compie l’atto di unire.
Ne consegue anche che l’individuo etico si sente uno, un’unità sia come causa che come prodotto; cioè sente che egli è la causa della produzione del suo essere, del fatto che il suo essere è condotto fuori (prodotto) nella dimensione dell’esistenza. Egli può ben dire di essere causa di se stesso, caratteristica questa che la filosofia ha sempre riconosciuto all’essere nella formula “esse est causa sui”.
L’INDIVIDUO CENTRATO SULL’AVERE SI REALIZZA SPEZZANDO I LEGAMI
L’individuo centrato sull’avere, invece, concepisce l’unità in ter- mini separanti: si arriva all’unità dividendosi dalla totalità. Si sente uno perché ha scelto di rompere in modo più o meno drastico i legami col tutto. La sua è un’unità fondata sul narcisismo individualistico asociale.
Ora, è evidente però che, se l’unità è intesa solamente come il prodotto di un’azione separante, le si disconosce la sua funzione causante, si nega cioè che sia l’unità stessa a essere causa dell’es- sere. Ne consegue che l’individualità fondata su un’unità intesa come prodotto divenga essa stessa un prodotto; divenga quindi un oggetto, un qualcosa privo di originalità, in quanto originato da altro da sé.
Declinato a livello del singolo, ciò equivale dire che uno si sen- te individuo solo dopo che una causa lo ha prodotto, cioè dopo che lo ha condotto all’essere. Così facendo però, non si riconosce come causa di sè, ma come causato (prodotto cioè), come oggetto: ciò che sta fuori (objectum) dalla causa , in quanto è di questa conseguenza, un qualcosa che viene dopo che la causa ha svolto la sua azione. Ma in tale dopo c’è solo ciò che è inanimato e come tale può essere facilmente posseduto; c’è quindi l’essere una volta che è stato ridotto ad avere.
Secondo la logica dell’avere l’unità è quindi un prodotto e tale prodotto è l’individualità. All’opposto, secondo la logica dell’essere, l’unità è causa, forza che unisce ciò che è separato, quindi forza che produce condivisione, ovvero unità con ciò che è diviso (condivisione).
GIUSTIFICAZIONE METAFISICA DELL’AVERE
Credo che non si possa comprendere la bramosia smodata di ave- re della nostra epoca se non la si inquadra all’interno di una visione metafisica. Intendo con ciò dire che una tale bramosia non derivi da pulsioni coscienti, ma da pulsioni le cui radici affondano negli abissi della nostra psiche, là dove l’essere e il nulla – Eros e Thanatos, direbbe Freud – si disputano la nostra esistenza.
Chi identifica l’essere con l’avere non cerca l’avere per il semplice gusto che può ricavare da ciò che possiede; egli vuole avere per essere. La sua volontà di avere è volontà di potenza. La potenza gli è necessaria per tenere stretto a sé l’essere.
Ora, siccome l’essere – al pari dell’amore – è libertà, pretendere di avere l’essere afferrandolo saldamente comporta che quello che si stringe a sé non sia certo l’essere, ma un oggetto che dell’essere è solo un vano simulacro.
Di ciò è consapevole anche la nostra civiltà dell’avere. A rivelarglielo è la profonda infelicità da cui è avvinta l’umanità odierna. Tuttavia essa non è sufficiente a farci capire che la soluzione è lasciare la presa sull’essere. Al contrario, reagiamo perseverando nell’errore: vogliamo accrescere ancor più la potenza con cui ci afferriamo come dei disperati all’essere. L’avere diventa per noi come l’aria da respirare; diventa pertanto il solo e unico progetto della nostra vita che pertanto progetteremo in modo da renderci l’essere a portata di mano per poterlo così più facilmente afferrare.
ILLUSIONE CHE IL PASSATO CONSENTA IL POSSESSO DELL’ESSERE
Vogliamo un essere vicino sia nel tempo che nello spazio. Tale desiderio però comprime le dimensioni spazio-temporali entro cui l’essere si manifesta, per cui finiamo per negare all’essere la possibilità di dispiegare la sua potenziale vitalità.
Per quanto si riferisce al tempo, volere l’essere a portata di mano comporta il circoscriverlo nel presente, negandogli così la stabilità del passato e la mobilità del futuro, caratteristiche queste che osta- colano la brama di possesso di chi vorrebbe catturare l’essere per servirsene per i suoi scopi.
Nella dimensione temporale del passato l’essere è indisponibile alla nostra volontà predatrice perché la necessità, legandolo indissolubilmente a ciò che è già stato, nega la strategia del ‘divide et impera’ di chi vorrebbe separarlo dal legame col suo passato per appropriarsene.
Il passato – a ben vedere – è la massima espressione della finitezza dell’essere; in esso trova realizzazione compiuta l’ipotesi atomista dell’assoluta indivisibilità dell’essere, in quanto nel passato non è concesso all’essere di uscire dalla sua de-terminazione. Il passato è quindi il massimo vincolo che si oppone a tutto ciò che voglia staccare l’essere dall’identità con se stesso. Ciò che è passa- to non può essere diversificato; non può divenire diverso, per cui non può che coincidere completamente con se stesso.
Almeno così ci appare, anche se la fisica moderna, mettendo in discussione l’immodificabilità della freccia del tempo, non esclude che il tempo possa scorrere anche da quello che per noi è il futuro verso quello che per noi è il passato.
Ciò vuol dire che nel passato l’essere ha una presa assoluta su se stesso; lì è completamente se stesso (nel senso che è immodificabile); lì esercita una presa assoluta su di sé, tale per cui nessuna forza è superiore a quella con cui l’essere tiene integra la sua identità.
In una società come la nostra, dove la potenza rappresenta l’alfa e l’omega dei nostri desideri, è inevitabile che il passato eserciti un’attrazione formidabile, in quanto ne invidiamo la sua potenza assoluta, di fronte alla quale anche il divenire è impotente.
Ma è anche vero però che esso rappresenta per noi un ostacolo insormontabile per la nostra volontà di potenza, perché non le sarebbe concesso di modificare l’essere, una volta che fosse finito nel passato. La nostra reazione di attrazione e ripulsa verso il pas- sato non si esplica ovviamente verso un passato inteso in senso assoluto, poiché, per definizione, con l’assoluto non è possibile alcuna relazione.
Si esplica invece verso il passato inteso in senso relativo, cioè il passato inteso in senso non materiale, ma psicologico; il passato quale sentimento della lontananza, della perdita, della separazione, ma anche della stabilità, della durata, della certezza – quindi anche il passato quale manifestazione della verità: in comune con essa infatti ha l’assolutezza, l’immodificabilità che li rende unici ed eterni.
In pratica noi vorremmo strappare l’essere alla signoria del passato, per esercitare su di esso un uguale potere: vogliamo avere sull’essere la stessa presa assoluta che ha il passato, onde dominarlo per i nostri scopi. Tale presa è la necessità.
Nel passato essa è assoluta. Noi vorremmo esercitare sull’essere una necessità parimenti assoluta, illudendoci così di rendere asso- luta anche la nostra libertà, grazie alla potenza ottenuta col dominio assoluto dell’essere.
RIPROPOSIZIONE DELLA NECESSITÀ NEL PRESENTE
Come già detto, noi vogliamo circoscrivere l’essere nel presente, perché è solo nell’attualità del presente che è possibile agire sull’essere, attuando i nostri progetti su di esso.
Ma questo comporta negare all’essere il passato e il futuro. Pren- diamo in considerazione dapprima il nostro modo di relazionarci col passato. Di esso rifiutiamo il dominio che la necessità vi esercita, non certo però per liberare l’essere dal dominio della necessità.
La libertà, valore tanto conclamato dalla nostra civiltà, ha per noi il solo scopo di spodestare il passato dal dominio sull’essere, per sostituirsi a lui. Ora il fatto che vogliamo esercitare un dominio assolutamente necessitante sull’essere sta a indicare che vogliamo che la necessità non agisca più sull’essere nella dimensione del passato, ma in quella del presente.
Mentre però nel passato, dimensione temporale del finito, anche la necessità agisce in modo finito, nel presente invece – dimensione dell’atto (il presente è attuale) – la necessità è costantemente in azione. Essa agisce continuamente sull’essere senza mai passare, senza mai finire, per cui la tirannia che essa esercita sull’essere è infinita.
Il nostro modo di relazionarci col passato è quello di riportarlo (in latino “referre”, da cui anche relazionare) nel presente – si intende di riportare nel presente la necessità, qualità propria del passato – di renderlo attuale. In tal modo però ci troveremo a vivere un presente colorato dal passato: un presente già finito ancor prima di cominciare; un presente dove già tutto è finito, per cui non c’è più spazio per niente di nuovo e dove caso mai il nuovo altro non è che reiterazione di ciò che è già stato, di riproposizione dell’uguale, in quanto il passato non può essere diverso da ciò che è stato.
NELLA GABBIA DELL’ETERNO PRESENTE ANCHE IL LAVORO DIVIENE OBSOLETO
A pensarci bene, quanto la nostra vita è la conferma di ciò! Pensiamo ad es. al lavoro al quale, nolenti o volenti, siamo costretti a dedicare la maggior parte delle nostre energie e tempo. Ogni giorno è sempre la stessa routine: gli stessi atti, le stesse preoccupazioni, lo stesso ambiente.
E questo quando va bene, perché al giorno d’oggi il capitalismo, deposta la maschera democratica con la quale si presentava in Europa, sta mostrando anche da noi il suo volto feroce che, per quanto riguarda il lavoro, si palesa come ipersfruttamento e precarietà.
Se la routine del lavoro ci nega di progettare un futuro, di gettar- ci oltre (pro-gettare) la ‘stessità’ di un presente che, ripetendosi sempre uguale, non passa mai; l’odierna precarietà lavorativa ci toglie addirittura la routine del lavoro e quindi la possibilità di agi- re, seppure entro il carcere del presente. Si è condannati a stare in un presente a-progettuale senza nemmeno che ci sia concesso di muoverci al suo interno grazie all’azione del lavoro; un lavoro magari compulsivo e ripetitivo fin che si vuole, ma che, pur non dischiudendoci la dimensione del nuovo, ci dà almeno lo sfogo fisi- co del moto col quale tentare di sfuggire all’immobilismo assoluto, condizione psicologica di uno stato dell’anima dove il presente è stato completamente colonizzato dal passato.
La routine del lavoro aveva sottratto la meta al nostro agire; ora la precarietà ci sta quasi privando perfino dell’agire. Ormai l’uguale, l’identico, in un tempo ridotto come l’uomo di marcusiana memoria ‘a una dimensione’ (l’eterno presente), non ha neppure più bisogno dei servigi del movimento – seppure del movimento asservito, in quanto costretti a rieditare solo lo stesso lavoro routinario; la produzione industriale che – a differenza dell’artigiano – riproduce in serie l’uguale; la standardizzazione del gusto, del desiderio, del pensiero.
L’uguale quasi non ha bisogno di un moto che lo ribadisca, che lo riaffermi. Il suo dominio è diventato così incontrastato, per cui anche la sua riproduzione quantitativa attraverso il lavoro sta diventando obsoleta. Domina perché non ha più nessuno che lo contrasti dal punto di vista qualitativo in quanto – come dice Latouche – ci ha colonizzato l’immaginario.
UN PASSATO CHE NON PASSA NECESSITA IL PRESENTE OGGETTIVANDO L’ESSERE
Vogliamo la potenza assoluta, quella che esercita sull’essere la stessa forza necessitante che su di esso esercita il passato. Il risultato è che ci siamo trasformati in passato. Come il passato siamo diventati totalmente uguali a noi stessi; abbiamo escluso dalla nostra vita ogni apertura al diverso, al divenire. Ci illudiamo così che, eliminando il divenire, il nostro essere duri in eterno.
Il passato però è il regno del finito per cui l’eternità che vogliamo garantire al nostro essere, ricorrendo alla forza necessitante che ha il passato, sarà quella di un eterno finito, di un eterno passato. Il nostro essere diverrà la vittima della potenza della necessità; avremo un essere assolutamente necessitato, privo di qualsiasi libertà. La forza con cui eserciteremo la presa su di lui lo trasformerà ipso facto in oggetto.
La potenza, come insegnano molti miti, la si paga perdendo l’a- nima, diventando inanimati come lo sono gli oggetti.
La logica della vita non può essere solo una logica di potenza; altrimenti non c’è più spazio per dei soggetti, ma solo per degli oggetti. È una logica questa che – come dice Anders – fa dell’uomo ‘un essere antiquato’ poiché, in quanto a potenza, sarà sempre inferiore a quella delle macchine.
La logica della vita è quella che Hegel sintetizzò nella formula “Lasciare che il finito finisca”. Bisogna lasciare che il passato passi affinché non invada la sfera del presente, facendolo così finire nel momento stesso del nascere.
In altre parole bisogna che la necessità del passato termini con esso. Lasciamo al passato la forza assoluta che ha la necessità; altri- menti una volontà di potenza malata che voglia trasportare tale for- za nel presente, al cospetto dell’essere (presente) cioè, farà del presente un passato, dell’essere un non essere.
In un certo qual modo noi abbiamo, chi più e chi meno, un sentore del pericolo che costituisce l’azione della potenza sull’essere; avvertiamo che essa lo rende sempre più necessitato e per converso meno libero. Privato della libertà, l’essere diventa infatti finito, quindi diventa passato.
La chiusura che la forza necessitante esercita su di lui è analoga a quella che esercita il passato. Confinato nel passato, l’essere per- de la libertà, diventando così oggetto, un qualcosa che è posto fuori (ob-jectum) dal presente, dall’attualità e quindi dalla capacità di essere attuoso.
Certo, la nostra civiltà della potenza si illude di essere lei a esercitare la forza necessitante sull’esterno e di non esserne vittima. Il fatto è che più oggettiviamo il mondo per poter esercitare più facilmente il nostro potere su di esso, più ci relazioniamo con un mondo di oggetti; un mondo che, essendo privo di libertà, appartiene – per quanto detto – al passato.
Ma relazionandoci col passato, diventiamo noi stessi passato. Come è finito il passato, così saranno finiti i legami con quel mondo: finiti nel senso di incapaci di estendersi, ma anche di destinati a finire.
Senza legami perdiamo la percezione di ciò che ci tiene insieme, che fa di noi qualcosa di unico; ci disgreghiamo diventando molteplicità, numero, una quantità che ha preso il posto della qualità.
VOLONTÀ DI POTENZA E VOLONTÀ DI LIBERTÀ
Più o meno conscia di questo pericolo, la nostra civiltà reagisce con un’ossessiva smania di libertà e quindi di futuro.
Infatti, se il passato è la dimensione della necessità, il futuro lo è della libertà, la dimensione di ciò che, non essendo ancora rin- chiuso dentro i confini del de-terminato, può andare oltre il terminato, il finito. Il futuro è quindi anche la dimensione in cui è possibile il progetto, l’andare oltre, al di là del finito (pro-gettare).
Possiamo dire quindi che, come la volontà di potenza ci ha indotti a trasportare il passato nel presente, così la volontà di libertà il futuro nel presente.
Portare il passato nel presente risponde alla volontà di immobilizzare l’essere, necessitarlo, onde renderlo disponibile alla nostra potenza manipolatrice.
Alla minaccia che il nostro essere rimanga impigliato nella rete della necessità, reagiamo con una volontà ossessiva, perché dettata dalla paura, di libertà; cosa che, dal punto di vista della temporalità, corrisponde al voler portare il futuro nel presente.
Ma è illusorio credere che in tal modo possiamo sfuggire alla morsa della necessità. Portando il futuro verso il presente accorciamo la distanza fra volontà desiderativa del presente e sua realizza- zione futura. La volontà, così, si sente tanto più libera quanto più la sua meta è a portata di mano.
Una tale volontà è quindi in realtà una volontà di potenza. E tale è la nostra identificazione con la potenza, che ci sentiamo liberi solo nella misura in cui abbiamo a nostra disposizione la potenza. Pensiamo che anche la libertà, al pari di tutto ciò che è, sia cosa da possedere. Non capiamo che possedendola la riduciamo a oggetto, trasformandola così nel suo opposto, la necessità.
Inoltre, voler portare il futuro nel presente fa sì che esso divenga, per ciò stesso, passato, in quanto facciamo muovere il futuro all’indietro (nel passato cioè) invece che in avanti (come dovrebbe essere il moto del futuro). Facendo indietreggiare il futuro ne accorciamo vieppiù la progettualità, cioè la sua distanza dal presente.
Tale modo di procedere è proprio di una volontà che si sente tan- to più libera quanto più ristretta è la distanza verso cui si progetta. Ma chi in noi si progetta verso scopi immediati? Ciò che in noi manca di pazienza, di fede – intesa come apertura fiduciosa verso ciò che è lontano (futuro) e quindi non soggetto al nostro potere – ciò che teme il lontano, quindi ciò che teme l’altro da noi; infatti l’altro è ciò che essendo lontano non ci appartiene, non è parte di noi (appartiene); ciò che non accetta che il futuro sia diverso dal presente, perché ciò incrinerebbe la nostra identità, quella concepita, sulla scorta della logica della potenza, come qualcosa di statico che rimarrebbe perciò uguale a sé. Ciò che quindi ci suggerisce comportamenti fondati sulla logica del principio d’identità, logica pro- pria della tecno-scienza, dunque comportamenti automatici, irriflessi, aventi scopi di realizzazione immediata. Questa componente del nostro essere è quella fondata sull’istinto, sull’impulso; è la parte meccanica della psiche, quella che non agisce per realizzare un progetto, ma come conseguenza necessaria di una forza da cui siamo comandati.
Per la nostra civiltà, dunque, saremmo liberi solo quando ci abbandoniamo all’impulso, all’istinto, perché solo in essi la nostra volontà cessa di essere progettuale per divenire una volontà a realizzazione immediata, istantanea; saremmo liberi quando il volere si realizza subito, perché così abbiamo la sensazione che la nostra volontà, non distando dal suo scopo, coincida con se stessa. E in questo riproporsi uguale della volontà, ci illudiamo di rendere sta- bile anche l’identità del nostro essere.
LA CIVILTÀ TECNOLOGICA RIPRODUCE L’UGUALE
In relazione al lavoro, l’inversione verso il presente della natura- le posteriorità del futuro dà luogo al fenomeno della trasformazione della produzione in riproduzione: il produrre (portare in avanti, verso il futuro dunque) viene sostituito dal riprodurre (portare indietro ciò che sta in avanti).
Ora, il riprodurre è un ripetere, un rifare ciò che è già stato fatto; è quindi il ricreare l’uguale proprio della produzione tecnologica dell’industria, a differenza della produzione a bassa tecnologia del- l’artigianato del passato, nel quale all’unicità irripetibile del produttore era ancora permesso di lasciare una traccia in ciò che creava.
Nella nostra civiltà tecnologica invece anche il lavoro soggiace alla logica del principio d’identità, logica propria della matematica e quindi anche della tecnica. Si lavora per riprodurre l’uguale di ciò che già è, l’uguale di un modello già presente. Col lavoro si mette in moto ciò che è, l’essere presente appunto, non per andare avanti verso ciò che non è (il futuro), ma per ricreare ciò che è, per ricreare il presente, nell’illusione di renderlo così eterno.
Che cos’è dunque questo ossessivo darsi da fare dell’uomo con- temporaneo; questa sua mancanza di tempo libero, perché preso da mille impegni; questa mostruosa sovrapproduzione, che altro non è poi che trasformazione di ciò che è vivo o che è utile al vivente in oggetto al servizio della volontà di potenza dell’uomo?
A me altro non sembra che un gigantesco e smisurato rito apotropaico, onde costringere l’essere a sostare presso di noi (a essere presente cioè). La sua infinita riproduzione ha il compito sia di impedire che il passato lo faccia finire una volta per tutte, sia che il futuro lo allontani più in là della nostra presa. Per questo – come già detto – la nostra è l’epoca della riproduzione e non della produzione: l’epoca della creazione dell’uguale.
Certo anche il riprodurre, al pari del produrre, è un movimento che, come tale, può dare all’essere l’illusione di non essere inanimato come lo sono le cose, di non essere oggettivato.
C’è una bella differenza però fra il moto in avanti verso il nuovo del produrre e quello all’indietro verso l’uguale del riprodurre. È un moto questo che, ritornando su ciò che già è, impedisce all’essere di passare, imprigionandolo in un presente immobile, finito, un presente che è quindi un passato.
La nostra civiltà tecnologica conosce solo la quantità, per cui non ha cognizione neppure della qualità del moto. Il moto dell’essere progettuale (in avanti) e riproduttivo (all’indietro) per essa non fan- no differenza. Ma questo è vero però solo quando il moto lo subiamo, come lo subiscono gli oggetti. Per un oggetto, infatti, è indifferente la direzione del moto – l’essere gettato avanti (pro-dotto) o indietro (riprodotto) – perché, non avendo in sé la possibilità di cambiare, non ha nozione né di cosa era, né di cosa sarà.
La negazione della qualità del moto comporta di necessità che la nostra civiltà si metta in moto solo per produrre la quantità. In tal senso la macchinizzazione del lavoro, ancor prima di rispondere a motivi di ordine economico, è dettata dalla scelta filosofica della nostra civiltà di ridurre l’essere a quantità. La macchina, infatti, produce sempre e solo l’uguale, quindi una produzione avente per scopo unicamente la quantità. E l’uguale non può che essere un oggetto e non certo un soggetto, in quanto quest’ultimo è contraddistinto, appunto, dalla diversità propria dell’originalità.
Il lavoro nella nostra società produce l’uguale non solo attraverso la produzione seriale, ma anche per aver assunto un carattere sempre più routinario, che deborda poi anche nella nostra stessa vita, che, ripresentandosi sempre uguale, assume così la caratteristica di un oggetto.
La negazione della qualità del moto implica che il divenire assuma un carattere quantitativo dove l’unica cosa a divenire sarà la quantità; il che sta a significare che il progetto lungo cui si snoderà il divenire sarà quello dell’oggettivazione dell’essere, della sua riduzione a oggetto, in altre parole, della sua decoscientizzazione.
In un divenire quantitativo l’unica produzione possibile è la riproduzione dell’uguale, cioè di un modello preesistente. Non quindi produzione di essere, ma di pre-essere – quella del modello preesistente – produzione di ciò che sta prima dell’essere (pre-esistente), dunque del passato.
L’ORIGINALITÀ NON STA NELLA RIPRODUZIONE DELL’ORIGINALE, MA NEL FAR SI’ CHE IL NOSTRO ESSERE SI RIORIGINI A OGNI ISTANTE
Riprodurre un modello non è certo produrre qualcosa di origina- le. È vero che originalità deriva da origine, da ciò che sta all’inizio, che sta al principio; ma è anche vero che ogni originalità è creazio- ne del nuovo, di ciò che prima non c’era.
Ovviamente la riproduzione non crea originalità. Essa, riproducendo il modello originale, ripropone dell’origine soltanto la sua posizione iniziale, il suo essere passato; ma questo è tutto. La riproduzione infatti non ha niente a che fare con la forza creativa dell’origine, cioè di ciò che stando prima (principio) è causa di ciò che segue.
Ciò che segue, se è riproduzione di ciò che precede, sta nel futuro solo da un punto di vista quantitativo, cioè per il fatto che un moto l’ha allontanato.
Non sta però in un futuro qualitativo, un futuro inteso come dimensione nella quale può accadere il nuovo. In altre parole il moto in se stesso non ci porta in un futuro qualitativo.
La nostra civiltà, nella sua dabbenaggine, crede che il moto all’indietro del lavoro riproduttivo, essendo un andare verso l’origi- ne, sia anche un modo per ridestare la forza di produrre in modo originale e quindi di produrre il nuovo. Non ha capito che il nuovo, l’originale non può essere prodotto come una qualsiasi merce.
L’originalità, infatti, è ciò che produce, non ciò che è prodotto; è forza che produce, nel senso che è causa della produzione, mentre il prodotto è un causato, ciò che subisce passivamente l’azione di una causa che gli è esterna. L’attività produttiva comporta un andare avanti (pro – durre), un andare verso il futuro.
La nostra civiltà si vanta della sua grande capacità produttiva e, di riflesso, della sua capacità di creare futuro onde dischiudere anche alla nostra vita la dimensione del futuro. Ma, se per creare futuro bastasse solo produrre, allora anche una macchina col suo
lavoro creerebbe futuro, creerebbe ciò che non c’è ancora, ciò che sta dopo; sarebbe un’entità progettuale, che avrebbe delle aspettative dal futuro come ce le hanno i viventi.
È evidente però che la macchina, essendo priva di originalità, non tanto produce quanto riproduce, produce ciò che già c’è. La macchina crea sì il futuro, ma solo dal punto di vista quantitativo: un futuro dove il nuovo è semplice copia del passato.
In questo futuro pertanto, il nuovo è tale solo a livello quantitativo: l’unica cosa che cambia è solo l’accresciuta quantità delle copie.
Il futuro, inteso in termini puramente quantitativi, cioè cronologici, fa sì che il nuovo sia un qualcosa di separato da noi, in quanto risiede in un futuro che è altrove rispetto al nostro presente. Rispetto a noi è quindi un nuovo oggettivato.
Credere di avere accesso al nuovo grazie agli oggetti è dunque un’illusione, perché tale nuovo rimarrà sempre attaccato all’oggetto, quindi fuori di noi (objectum), fuori dalla nostra soggettività, che rimarrà così incapace di rinnovarsi, sempre uguale a se stessa. Ed è così perché in un futuro inteso cronologicamente come separato dal presente, il nuovo apparterrà solo all’oggetto.
Il futuro diverrà la dimensione dell’oggettività, un futuro creato da una progettualità avente per fine la trasformazione dell’essere in oggetto. La soggettività, di conseguenza, si troverà confinata nel passato, nella dimensione dell’immobilità dove vige la logica dell’identità intesa come riproposizione dell’uguale: la logica propria della tecnica. Lì la nostra vita dovrà adattarsi a divenire un qualcosa di meccanico, un’entità biologica decoscientizzata, un oggetto insomma.
La follia della riduzione del soggetto a oggetto ci porterà poi a ritenere paradossalmente che, per recuperare parte della nostra soggettività, dovremo oggettivare ancor di più il nostro essere. L’insana logica sottesa a questo pensiero è che, se il futuro è diventato la dimensione dell’oggettività, l’unico modo rimastoci di progettare – processo attraverso il quale esprimo la volontà e quindi la mia soggettività – rimane quello di trasformare ancor più la mia soggettività in cosa oggettiva. In altre parole, quanto più agisco come una macchina, tanto più affermerei la mia soggettività. Questa logica folle è poi la stessa che guida gli scienziati a ipotizzare di poter costruire macchine coscienti. Se non è nichilismo questo!
IL NUOVO COME STATO DELL’ESSERE IN CUI IL FUTURO È UNITO AL PRESENTE
Come detto, per la nostra civiltà il futuro si dà solo in termini quantitativi, è cioè la dimensione temporale in cui si ha solo accrescimento della quantità. Questo spiega perché siamo ossessionati dal bisogno di produrre sempre di più: non si tratta semplicemente del bisogno di avere sempre di più, ma anche di un bisogno più metafisico e cioè che il lavoro – ovviamente quello finalizzato a pro- durre quantità – è rimasto l’unico mezzo per sporgerci nel futuro. Pur di avere ancora un futuro, siamo disposti ad assumere lo status di macchine. Ma quale futuro? Solo quello quantitativo, adatto a ciò che in noi è quantità, adatto cioè alla volontà che vuole esercitare il dominio sul mondo materiale, il mondo della quantità.
Ma noi, fortunatamente, siamo anche qualità; siamo un’unità che, per quanto inconscia ci possa essere, non accetta di essere riduci- bile alla molteplicità della quantità. Siamo un’unità che non può pertanto accettare unicamente un futuro quantitativo, perché in esso la crescita quantitativa, comportando anche una crescita della molteplicità, inficia la possibilità di far emergere alla coscienza l’unità del nostro essere, la nostra individualità.
Essa sente il futuro come unitario, cioè un futuro dove la frattura temporale in istanti separati è superata; dove il nuovo, proprio del futuro, non è dopo, in un futuro separato da noi, ma è qui nel presente. È in noi, quindi non dobbiamo cercarlo fuori di noi.
Il nuovo è uno stato dell’essere nel quale l’essere avverte in sé una tensione che lo spinge oltre (pro – getta) il finito entro il quale è momentaneamente confinato. È quello stato nel quale l’essere sen- te di avere un’anima – nel senso di una forza che lo anima e che lo rende causa sui, produttore e non prodotto, soggetto e non oggetto.
È in virtù di tale tensione che è in grado di trascendere il finito del passato, in cui l’essere diventa non essere, per affermare se stesso.
L’essere non è ciò che ha avuto origine, ma ciò che dà origine in ogni momento a se stesso. La sua origine pertanto non si situa nel passato, ma è costantemente presente; ed è ciò che rende l’essere originale, mai copia di se stesso, mai riproduzione, ma sempre nuovo.
Il nuovo si manifesta allorché diventiamo originali, allorché cessiamo di essere copie, prodotti, per diventare produttori. In quanto produttori, poi, scegliamo di orientare la nostra vita verso l’essere; l’essere infatti è “causa di se stesso” cioè produttore. Scegliendo di essere produttori, inoltre, facciamo sì che in noi il presente si fon- di col futuro; cioè che ciò che siamo al presente si fondi col nuovo del futuro. Questo fa sì che per il produttore il presente non sia chiuso in se stesso, ma aperto alla novità, all’originalità del futuro, un presente quindi originale, sempre diverso dalle sue precedenti determinazioni.
Potrebbe sembrare che l’originalità neghi l’unità della coscienza perché la rende sempre diversa e quindi molteplice. Ma ciò è vero solo per una coscienza statica che vuole riprodursi sempre uguale. La coscienza di un produttore – di uno che scelga di essere causa di se stesso – è invece dinamica, una coscienza che fonde la determinazione del presente con l’indeterminazione del futuro, fonde quindi l’unità del finito con la molteplicità dell’infinito. È una coscienza dialettica: permane nell’unità proprio perché si diversifica.
Quello che permane in lei è ciò che Bergson chiamava “slancio vitale”, quell’essenza creatrice che la rende costantemente origina- le; permane il suo essere sempre nuova. Non permane il determina- to, il finito, ma la nostra essenza infinita.
L’infinito, diversamente dal finito, non separa il tempo nelle determinazioni del passato e del futuro. Al contrario, per il fatto di essere aperto, l’infinito supera le divisioni tra futuro e passato, per- mettendoci così di cogliere l’unità del nostro essere; un’unità dove, non essendoci più separazione tra passato e futuro, ci è permesso al fine di vivere veramente nel presente, cioè di vivere una vita dove il superamento della discontinuità temporale fa sì che l’essere ritrovi la sua essenza che è l’unità. L’essere si dà solo nel presente ovviamente, e lo ribadiamo ancora una volta; in un presente reso dinamico dallo “slancio vitale” che, superando le fratture del fini- to, è in grado di costruire l’unità. È infatti nel presente che l’esse- re ci sta davanti (presente), nel luogo cioè della manifestazione.
NEL LAVORO E NEI DESIDERI DE- FINITI VIENE MENO L’ORIGINALITÁ
Il moto riproduttivo consiste in un andare all’indietro, verso il passato, il finito, verso ciò che è de – terminato, chiuso entro i con- fini invalicabili della necessità, il cui significato etimologico vale appunto ‘non andare avanti’. È il moto proprio della produzione in serie del finito, della produzione di ciò che è necessitato, che non è libero, della produzione di oggetti.
Il lavoro, per come è concepito nella nostra epoca, porta di conseguenza ad accrescere continuamente il dominio del passato sul- l’essere, rendendolo sempre più finito e necessitato.
Non è solo con l’attività lavorativa però che perseguiamo questo obiettivo. Ormai, perfino i nostri desideri sono di natura ri – produttiva. Desideriamo, cioè, quasi esclusivamente ciò che non ci spinge lontano verso il nuovo, ma ciò che ci allontana quel tanto che basta per attivare l’effetto molla, onde ritornare indietro verso ciò che già siamo e così ribadirlo con maggior forza. Desideriamo il già noto, il già vissuto, la ripetizione dello stesso.
Si tratta quindi di desideri finiti, delimitati, di desideri, pertanto, di natura seriale, nel senso che sono sempre uguali a se stessi.
Si manifestano come ripetizione di un modello, per cui mancano di originalità: ciò che desideriamo non ha la capacità di originare in noi il nuovo, e quindi di mettere in moto la tensione progettuale del nostro essere,, onde proiettarci fuori dall’identità assoluta con noi stessi.
Il mondo dell’identità assoluta è quello della matematica, della tecnica. È il mondo adialettico dove vige il principio di non contraddizione, per cui un ente è sempre e solo se stesso. È il mondo del passato dove più nulla può cambiare, per cui è condannato a essere sempre uguale a sé.
Desiderare l’identità con se stessi implica quindi desiderare ciò che è immobile, inerte, privo della capacità di progettare, di divenire altro. Concretamente ciò si manifesta nell’abnorme materialismo della nostra epoca capace di desiderare solo il finito della materia. Si desidera ciò che è materiale, per esorcizzare con la finitezza della materia la lontananza del futuro. Al massimo possiamo accettare dei desideri che tendano il nostro essere solo entro il breve spazio di tempo richiesto per attuare il nostro ‘carpe diem’. Trascorso questo, sentiamo irrefrenabile il bisogno di tornare indietro da ciò da cui ci siamo allontanati. Non vogliamo diventare altro, ma rimanere ciò che già siamo: rimanere finiti, delimitati.
Ciò implica che i nostri desideri saranno improntati al finito, quindi a soddisfare la parte materiale del nostro essere, che si manifesta sia come attaccamento al corpo e ai piaceri ad esso lega- ti, sia – in modo più generale – come identificazione con la chiusura del finito.
PSICOLOGICAMENTE DIVENTIAMO DE-FINITI, CHIUSI
Tale identificazione si manifesta da un punto di vista psicologico come egoismo, egocentrismo; come rimozione della nostra natura progettuale, cioè di quella parte del nostro essere il cui fine è di gettarci oltre (pro – gettare) la statica identità col nostro ego, per farci sentire che il nostro essere si estende ben oltre la chiusura entro cui
vorremmo contenerlo. Oltre di essa c’è quella zona che, chi si identifica con la sua finitezza, chiama l’altro, il diverso dal suo essere e, di conseguenza, il non essere.
Sartre può affermare che “l’inferno sono gli altri” solo perché anche lui – sulla scorta del sentire della nostra civiltà – percepisce l’essere come rinchiuso identitariamente in se stesso, per cui ciò che sta oltre – gli altri appunto – costituiscono nient’altro che la minaccia del non essere verso l’essere.
In tale contesto anche il futuro dev’essere allora esorcizzato dal- l’alterità: dunque non un futuro dischiuso da un fare produttivo, un fare che ci fa andare avanti (pro – durre) allontanandoci dall’identità con noi stessi; ma il futuro del fare riproduttivo, cioè di un fare ripetitivo che ci porta indietro (ri – petere) per evitare così l’alterità. Lo sporgersi in avanti nel futuro diventa dunque un mezzo, il cui scopo, lungi dall’essere quello di portarci verso l’ignoto, è invece quello di riportarci verso il noto, il passato.
Il futuro perde così la sua funzione qualitativa di essere la dimensione in cui il nuovo può accadere e con essa perde anche la progettualità e la ricerca di uno scopo evolutivo. All’essere è concesso di sporgersi nel futuro solo per ribadire la sua identità tornando sui suoi passi. Ma così l’essere non fa altro che accrescere sempre più la coincidenza con se stesso e quindi diventare sempre più statico, immobile.
Ora, quanto più neghiamo al moto in avanti la possibilità di far- ci uscire dagli angusti confini del finito, tanto più esso diventerà frenetico, assillante. Lo stesso futuro sarà affetto dal bisogno identitario di riprodurre se stesso, col che negherà la sua natura qualitativa di produttore del nuovo, proponendosi solo come quantità riproduttiva di se stesso. Incarcerato nella gabbia del presente, del quale è condannato a riproporne incessantemente il modello, l’es- sere è ridotto al rango di oggetto seriale. La nostra civiltà, nella sua follia, si illude di poterlo riprodurre come si fa con le merci.
Ma ciò non può funzionare. L’essere non si lascia finire nell’identità assoluta con se stesso dell’oggetto. Credo che la prova più evi- dente di ciò sia data dal fatto che, quanto più ci affanniamo a immobilizzare l’essere per renderlo docile oggetto al nostro servizio, tanto più esso cercherà di sfuggirvi in tutti i modi.
E se non ci riuscirà col movimento di una progettualità tesa ver- so un futuro qualitativo, cercherà di porvi rimedio col movimento riproduttivo di un futuro quantitativo, quello a corto raggio della riproduzione dell’identico e del ‘carpe diem’.
Ma questo futuro, proprio perché di corto raggio, non può riuscire nell’intento di liberare il nostro essere dalla prigione in cui lo condanna la produzione dell’identità con se stesso.
LA VOLONTÀ DI POTENZA DISTRUGGE L’ESSERE
La volontà di accrescere a dismisura la potenza ci spinge a immobilizzare l’essere, negandogli la libertà e riducendolo così a oggetto; per compensazione l’essere che noi siamo e quello esterno a noi si ribellerà in tutti i modi ai nostri tentativi di oggettivarlo.
La nostra civiltà si illude di salvare l’essere dalla distruzione, accrescendone stabilità e durata con la potenza. Tale progetto però non può che essere destinato al fallimento perché la potenza, immobilizzando l’essere, gli nega la sua natura progettuale, e quindi la libertà di creare se stesso, di essere ‘causa sui’.
Ma questo è distruggere l’essere, altro che salvarlo! Pensiamo forse di salvarlo riducendolo ad oggetto? Sì, purtroppo! La nostra civiltà pensa che il solo modo per garantire l’eternità all’essere sia quello quantitativo di riprodurre un’altra copia dell’essere, una volta che quella precedente sia andata distrutta.
L’essere, però, non è un oggetto; e pertanto – nonostante il fanatismo ideologico della civiltà della tecnica, che vorrebbe convincer- lo di ciò – ce lo fa capire immettendo in noi una grande inquietudine e un bisogno irrefrenabile di cambiamento.
Nietzsche ben se ne avvide di ciò quando proclamò che “Dio è morto”. Intese con ciò affermare che era morto il principio della stabilità, dell’ordine, che l’essere non aveva più alcun vincolo necessitante per cui era finalmente libero. Senza entrare in merito al pensiero di Nietzsche, ritengo comunque che la libertà che abbiamo conseguito con la “morte di Dio” sia una libertà fittizia, una libertà che è l’altra faccia della medaglia della volontà di potenza.
A mio avviso questa è la libertà cui anela chi crede che il suo carceriere sia fuori di lui e non si rende conto invece di essere egli stesso tale. Non si rende conto che, volendo la potenza, si incarcera con le sue stesse mani. Il mito di Faust lo dice chiaramente a chi ha orecchie per intendere: se vuoi il potere, devi cedere in cambio la tua anima.
ll sito www.italiaeilmondo.com non fruisce di alcuna forma di finanziamento, nemmeno pubblicitaria. Tutte le spese sono a carico del redattore. Nel caso vogliate offrire un qualsiasi contributo, ecco le coordinate: postepay evolution a nome di Giuseppe Germinario nr 5333171135855704 oppure iban IT30D3608105138261529861559 oppure PayPal.Me/italiaeilmondo Su PayPal, ma anche con il bonifico su PostePay, è possibile disporre eventualmente un pagamento a cadenza periodica, anche di minima entità, a partire da 2 (due) euro (pay pal prende una commissione di 0,52 centesimi)