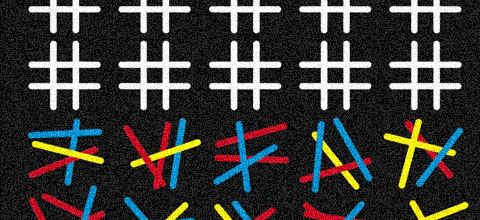– Daniela Caruso – **
Dopo la morte di Deng Xiaoping fu Jiang Zemin ad assumere la guida della Cina. Il suo riformismo trasformò il Partito Comunista Cinese in un partito aperto che inglobava il nuovo ceto emerso dallo sviluppo economico. Tuttavia la crescita poneva anche alcune sfide sul piano etico e Jiang si rese promotore di un nuovo orientamento ideologico che spingeva contro la corruzione e l’individualismo richiamando i quadri ad una maggiore moralità. In politica estera continuò con la promozione del multipolarismo di Deng, ma il suo lavoro più intenso si focalizzò verso le politiche regionali e di vicinato.
1. L’eredità di Deng
L’approccio pragmatico adottato dalla leadership cinese nell’introdurre il processo di riforme ha richiesto un impegno costante non solo nel sostenere i programmi dal punto di vista pratico ma anche nell’affrontare nuove sfide, riparare i fallimenti e rinvigorirne lo slancio davanti alle battute d’ arresto. L’emergere di tensioni e contraddizioni sociali tra coloro che ancora non riuscivano a beneficiare dei programmi di sviluppo, ma anche tra una “vecchia guardia” interna non del tutto favorevole al nuovo corso, avrebbero potuto destabilizzare il paese e rallentare i processi di riforma. Tali preoccupazioni necessitavano di costante attenzione e richiedevano una mediazione capace di ottenere e mantenere il consenso sui contenuti delle riforme; era necessario cioè tenere in vita processi di conciliazione tra i diversi orientamenti politici e gli interessi istituzionali. I riformatori cinesi tentarono trasformare gradualmente la dottrina ortodossa in un capitale di pensiero più elastico cercando però di mantenere gli essenziali valori del socialismo [1].
Deng era stato evidentemente determinato ad esplorare un percorso nuovo ed unico; a tal fine, c’era la necessità di un’ideologia socialista elastica e reinterpretabile che legittimasse le nuove esigenze del paese. In secondo luogo, discostandosi dal convenzionale approccio leninista, si compiva un passo importante nello stabilire la sua leadership. In terzo luogo, c’è da notare anche che questa nuova formula rifletteva un forte senso di nazionalismo [2]. Per placare lo scetticismo Deng aveva esortato il paese a proteggersi dalle influenze delle ideologie di matrice esterna; il “socialismo con caratteristiche cinesi” avrebbe dovuto rafforzare l’identità nazionale e ideologica rendendola indipendente sia dal modello comunista sovietico che dal modello capitalista occidentale. Il fatto che tale concetto di socialismo non fosse declinato attraverso una teorizzazione elaborata e più complessa non è casuale: una teoria generale, se pur non generica, avrebbe costituito un cornice entro la quale garantire una certa flessibilità di utilizzo, in grado di mediare tra l’ottenimento del consenso e l’introduzione di sempre nuove riforme. A tale proposito un economista riformista avrebbe commentato: “il concetto è così flessibile che abbiamo abbastanza spazio per manovrare al suo interno [3].” Tra l’altro a Deng va anche ascritto il merito di aver introdotto un concetto di “democrazia economica” declinata su due livelli: il decentramento dei processi di sviluppo ed una più ampia partecipazione della burocrazie ai percorsi decisionali, essendo essa in gran parte responsabile del successo iniziale delle riforme. Sul versante opposto si era assicurato il sostegno del partito legittimando il processo di riforma con il rispetto imprescindibile dei Quattro Principi [4] mai messi in discussione. Riuscì quindi a legare il programma riformista al consenso del partito, mantenendo l’equilibrio tra necessità politica e legittimazione ideologica contribuendo nel mantenimento della stabilità interna necessaria ai processi di cambiamento. La mediazione tra ideologia, politica ed economia, rappresentò la vera rivoluzione di una cultura politica che fino ad allora era stata conforme ai concetti di burocrazia elitaria così come ad una ideologia indiscussamente rigida. I programmi riformisti avevano avuto una lungimiranza sostanziale nel coinvolgere anche la burocrazia: Deng sapeva infatti che era stata proprio la resistenza dei vecchi burocrati a rendere tortuoso il percorso delle riforme in Europa Orientale e in Unione Sovietica. In Cina, invece, esse avevano cooptato anche la burocrazia offrendole l’opportunità di utilizzare la propria posizione con vantaggi economici; tuttavia, questo meccanismo di compatibilità degli incentivi fu spesso foriero di corruzione diffusa fomentava l’insofferenza e il disagio sociale. L’autorevolezza di Deng, il fatto che si fosse rialzato durante la sua carriera politica per ben tre volte e i frutti della crescita che si iniziavano a raccogliere avevano reso la sua leadership molto forte. Durante i diciotto anni delle sue riforme dovette molte volte ricorrere all’ autorità personale per spingere i processi di cambiamento; dopotutto, la Cina era un paese che per oltre duemila anni era stato retto dal sovrano e, anche dopo, con la nascita della Repubblica, Mao ne era stato il capo indiscusso. Tuttavia, se quest’ultimo usò il suo ideale di rivoluzione permanente per destabilizzare il sistema, Deng avrebbe fatto appello alla propria autorità per decentralizzare il potere, riformare la burocrazia e condividere i benefit con lo scopo di ottenere sostegni e consensi per i suoi programmi. La sua teoria riformista, che era stata inserita nella Costituzione del PCC durante il XV Congresso Nazionale del Partito nel 1997, non era sufficiente a soddisfare le nuove contraddizioni nate dallo sviluppo socioeconomico [5] né a difendersi dalle ripetute accuse dell’ala conservatrice perché, le argomentazioni di quest’ultima, erano più coerenti delle teorie riformiste che rimanevano sostanzialmente contraddittorie rispetto ai dogmi socialisti tradizionali [6]. Bisognava fornire al partito una nuova e più solida legittimazione teorico-razionale che potesse incontrare le esigenze di un paese profondamente mutato. Dopo la morte di Deng fu Jiang Zemin ad assumere la guida della Cina. Molte erano le incognite legate alla nuova leadership e, del resto, il mondo si chiedeva se il nuovo leader sarebbe stato all’altezza del ruolo e a raccogliere l’eredità lasciatagli. Jiang era stato scelto per sostituire Zhao Ziyang come segretario generale del PCC nei giorni precedenti l’incidente di Tiananmen, nel giugno 1989. La sua promozione sembrò essere favorita dal fatto che era stato in grado di disinnescare alcune dimostrazioni studentesche di Shanghai evitando conflitti troppo aspri. Toccò quindi a lui formulare nuove politiche mediando tra tutte le fazioni; ma il ritiro di Deng dalla vita pubblica fu solo formale, date le sue articolate relazioni con il partito che aveva stretto durante sua lunga carriera, esercitò una influenza molto forte fino alla sua morte, nel 1997. Jiang usò gli anni in cui Deng era ancora attivo per rafforzare la propria posizione anche sostituendo potenziali oppositori con suoi alleati. Del resto il nuovo leader avrebbe dovuto affrontare questioni molto spinose come quella dell’occupazione del Tibet e dei diritti umani: agli inizi degli anni novanta gli Stati Uniti aumentavano la pressione sulla Cina per il rilascio dei prigionieri politici e la garanzia dei diritti fondamentali per gli oppositori del regime. Ma il paese resisteva alle pressioni: alla fine del 1997, durante la sua visita negli Stati Uniti, Jiang ammise alcuni errori, pur non prendendo impegni circa un cambiamento imminente. Il ritorno di Hong Kong alla Cina è stata un’altra questione delicata da affrontare: quando il 1 luglio del 1997 la Gran Bretagna riconsegnava l’isola mettendo fine a 155 anni di dominio coloniale, la Cina ha dovuto sottoscrivere un accordo affinché il sistema economico di Hong Kong rimanesse identico, così come pure le libertà politiche, per cinquanta anni [7].
Alla morte di Deng, nel febbraio 1997, Jiang riuscì finalmente ad ottenere spazio e visibilità maggiori. La sua statura politica crebbe in modo significativo a seguito di una serie importanti avvenimenti: in primo luogo, il ritorno di Macao alla sovranità cinese nel 1999, in secondo luogo l’adesione della Cina alla WTO nel 2001. Durante il suo governo poi il paese fu scelto per ospitare i giochi olimpici nel 2008 con una ricaduta internazionale di altissimo livello. Contemporaneamente, sul piano interno, Jiang lavorava attivamente per apportare il proprio contributo sul piano dell’elaborazione ideologica; nel 2000, la sua teoria delle “Tre Rappresentatività” (三个代表, sān gè dàibiǎo) si concentrerà, come vedremo, sul ruolo futuro del PCC delineandolo come fedele rappresentante di tutta la società cinese e portatore anche degli interessi delle forze produttive avanzate.
2. Le riforme economiche tra il 1993 e il 2003
Non c’è dubbio che nel periodo che va dal 1993 al 2003, la situazione in Cina si sia stabilizzata e che il paese si sia trasformato da radicale, guidato dalla “dittatura del proletariato”, in una nazione meno rigida e proiettata verso e la realizzazione delle quattro modernizzazioni, con una crescita economica basata su un sistema di incentivi alla produzione. Nel 1994 furono introdotte importanti riforme fiscali che stabilivano una chiara distinzione tra tasse nazionali e locali ed istituivano sia un ente fiscale nazionale che agenzie locali, ciascuna delle quali era responsabile della gestione dei propri introiti. Inoltre, si stabilì che l’imposta sul valore aggiunto, quale principale imposta indiretta riscossa a livello nazionale, venisse condivisa con le amministrazioni locali in una quota fissa di 75/25 [8]. Prima di questa riforma la Cina non aveva alcuna istituzione fiscale centrale, tutte le tasse venivano raccolte dalle amministrazioni locali con evidenti perdite. Nonostante la riforma fiscale ostacolasse la flessibilità nel bilancio delle amministrazioni locali, non eliminava le loro principali fonti di gettito fiscale: oltre il 25% dell’imposta sul valore proveniva dalle imposte sul reddito delle società ad eccezione di quelle statali che erano controllate dall’amministrazione centrale; c’erano poi l’imposta sul reddito individuale e altre imposte per le persone giuridiche. Inoltre, una fonte importante di reddito per le amministrazioni locali era rappresentata dai conti “fuori bilancio ” , non ufficiali, non monitorabili dall’amministrazione centrale. Secondo uno studio del 1996 in alcune provincie questi conti raggiungevano un volume quasi pari a quello dei ai conti di bilancio [9]. Nel 1995 entrava in vigore la nuova legge finanziaria. Con quest’ultima l’amministrazione centrale non avrebbe potuto effettuare scoperti presso la banca centrale per finanziare il deficit che poteva invece essere sostenuto attraverso le obbligazioni governative. Per le amministrazioni locali le norme erano ancora più stringenti: a prescindere dal loro livello, dovevano disporre di un bilancio in pareggio e, oltre a ciò, la legge controllava strettamente le emissioni di obbligazioni limitando i prestiti concessi sul mercato finanziario [10]. Durante il periodo 1991-1997 si seguirono politiche monetarie e fiscali restrittive, i tassi di interesse erano stati ridotti, il flusso di denaro sul mercato era stato distribuito per rivitalizzare l’economia tuttavia l’inflazione aveva registrato il record del 21,7% nel 1994 [11]; il governo dovette intervenire a frenare la lievitazione dei prezzi attraverso l’aumento dell’offerta monetaria e moderando il gettito fiscale. Tra il 1998 e il 2003, furono adottate una politica fiscale attiva e una politica monetaria “prudente”, per cercare così di contrastare gli effetti della crisi finanziaria in Asia, che si era verificata a partire dal 1997 [12]. Le misure miravano all’aumento del reddito per le persone con ridotte possibilità economiche stimolando principalmente la domanda interna. Riducendo i tassi, il governo iniziò a tassare gli interessi dei depositi e ad adeguare la domanda di moneta attraverso operazioni della banca centrale. Intervenne anche riducendo le proprie spese e i debiti per il finanziamento degli investimenti in infrastrutture. Nel 1997, fu estesa su larga scala la privatizzazione delle società statali continuando anche la ristrutturazione economica; circa cento aziende pubbliche furono trasformate diversificandone la produzione per spezzarne il monopolio. Tuttavia sembra che numerosi problemi abbiano ostacolato gli esperimenti di privatizzazione [13]. Di regola, la leadership di una società statale includeva il comitato di partito, il sindacato del lavoratore e il corpo amministrativo della rispettiva unità di lavoro [14]; lo stato sperava che ristrutturando le imprese statali anche dal punto di vista gestionale, istituendo i consigli di amministrazione e un comitato di supervisori, la produttività aumentasse. Tuttavia, la creazione di un nuovo sistema di management fu foriero di difficoltà: nel 1998, ad esempio, nacquero una serie di problemi dovuti soprattutto alla mancanza di competenze gestionali dei nuovi manager. Dopo l’ingresso della Cina nel WTO la privatizzazione diventava ancora più complicata perché c’era da affrontare una competizione globale acerba: in effetti, alcune multinazionali intendevano rinunciare alle transazioni con la Cina, soprattutto a causa dei rischi e dei costi ancora troppo elevati associati agli investimenti di capitale; bisognava gestire anche la nuova urgenza di osservare gli standard internazionali. L’élite riformista cercò di rafforzare la legislazione societaria diversificando la struttura proprietaria delle grandi aziende statali e impiantando un sistema di management moderno. I problemi manifestati sul medio e lungo termine erano certamente agganciati all’assenza di una cultura imprenditoriale, agli assetti burocratici cristallizzati così come alla mancanza di stimoli alla produttività. Per questo motivo, mentre il processo di privatizzazione cercava di minare il predominio dello statalismo e della burocrazia, le riforme del sistema giudiziario iniziavano a giocare un ruolo fondamentale. Nel marzo del 1999, la Costituzione fu nuovamente modificata (il quarto cambiamento dal 1982) e il diritto alla proprietà privata vi fu formalmente integrato riconoscendolo così quale componente obbligatoria dell’economia cinese [15]. Fu dichiarata la disponibilità del PCC a rappresentate anche l’imprenditoria privata e la nuova classe che nasceva: bisognava cioè rappresentare tutti e, in definitiva, la proprietà privata, così come la prosperità economica, non dovevano più essere considerati oppositivi ed antitetici alla costruzione del socialismo cinese. Tuttavia, la Cina non ha mai promosso né incoraggiato il capitalismo selvaggio: la leadership sapeva che era necessario guardare agli errori dell’Occidente per riuscire a fare di meglio. La concorrenza aspra del mercato imponeva politiche di bilanciamento e compensazione attraverso le quali si sarebbero dovuti arginare fallimenti associati alla crescita troppo rapida quali, ad esempio, la disoccupazione e il lievitare del debito pubblico.
3. Il riorientamento ideologico di Jiang Zemin
Con i fatti di Tienanmen si era dimostrato al mondo di essere disposti a qualsiasi cosa pur di mantenere l’unità e non seguire le orme dell’Unione Sovietica e del blocco orientale. Non solo: si era ben chiarito che non si era disposti ad avviare alcun confronto rispetto alla partecipazione democratica. Tuttavia, era chiaro che alcune richieste quali l’intervento sulla corruzione diffusa, l’inflazione e l’aumento delle diseguaglianze sociali, andavano discusse. Il partito necessitava di tenere alti la legittimazione e il consenso; la de-ideologizzazione di Deng Xiaoping degli anni ottanta si era fatta sentire soprattutto tra i quadri che sembravano sempre meno interessati alla teoria marxista. Per Deng, il rapido sviluppo economico era stato più importante dell’ideologia e con il suo viaggio nel sud per rilanciare le riforme, fatto agli inizi del 1992, sembrava aver dato priorità ancora una volta alla spinta economica ponendola al di sopra di ogni dibattito politico. Anche se la crescita degli anni novanta aveva dato ragione al leader, il partito si rendeva conto che ai vecchi ideali del socialismo si stavano progressivamente sostituendo nuove ideologie che considerava deleterie, prima tra tutte quella dell’individualismo. Si stava anche perdendo il contatto con la popolazione e in particolare con quelle classi che avevano costituito lo zoccolo duro del consenso; contemporaneamente, emergevano nuove categorie: imprenditori, professionisti, dirigenti delle imprese statali, artisti, intellettuali… Insomma, una classe media urbana completamente nuova che andava inquadrata e gestita. Inoltre, la mancanza di strumenti che veicolassero principi ideologici aveva favorito la corruzione e gli abusi tra i quadri del partito. Nel 1995, l’organo di vigilanza aveva registrato oltre duemila casi di corruzione [16]. Qiao Shi a quel tempo presidente del Congresso Nazionale del Popolo, sosteneva con forza la trasparenza politica e sottolineava il ruolo importante della democrazia nel sistema del centralismo. Durante la Terza Sessione dell’VIII Congresso Nazionale del Popolo nel marzo 1995 iniziò a circolare l’idea di rafforzare la democrazia socialista e la costruzione della legalità (加强 社会主义 民主 法制 建设, jiāqiáng shèhuì zhǔyì mínzhǔ fǎzhì jiànshè), ricordando che anche i membri del partito dovevano sottostare alle leggi. Li Ruihuan presidente del Comitato nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo cinese, promise l’appoggio al partito e Jiang Zemin non avrebbe potuto non mettersi all’ opera.
3.1. Educare alle “Tre Attenzioni”
Alla fine del 1998, la dirigenza del PCC decise di concentrarsi sul lancio della campagna delle “Tre Attenzioni” [17]. Già alla fine nel 1995 Jian Zemin aveva lanciato l’iniziativa di prestare attenzione alla politica (讲 政治jiǎng zhèngzhì). In un incontro in preparazione al V Plenum del XIV congresso del partito ammoniva i quadri a prendere seriamente la disciplina con discrezione e sensibilità; essi, cioè, non avrebbero dovuto discostarsi dall’obiettivo primario che era quello di servire il popolo lavorando non solo per il progresso economico ma anche a favore dell’ideologia [18]. Si trattava essenzialmente di una spinta moralizzatrice che esortava soprattutto i quadri a porre la propria attenzione su tre elementi chiave: “prestare attenzione allo studio ” (讲 学习, Jiǎng xuéxí,), “prestare attenzione alla politica” (讲政治, Jiǎng Zhèngzhì) e “prestare attenzione alla rettitudine” (讲正气 Jiǎng zhèngqi). Il “Prestare attenzione allo studio” includeva non solo studiare la teoria di Deng Xiaoping, ma anche acquisire conoscenze nuove tenendosi al passo con i tempi. Nel campo della politica invece, l’esortazione era a rispettare i modelli (表率, biǎoshuài) e cioè la linea fondamentale del partito discutendone in maniera metodologicamente ortodossa. L’aspetto della “rettitudine” o “integrità” implicava che i membri continuassero a detenere i tradizionali e vecchi stili di lavoro usati durante la rivoluzione combattendo le degenerazioni e le derive etiche. I modelli per tale il comportamento erano lo “spirito di partito” (党性, dǎngxìng), l’imparzialità (公正 无私, gōngzhèng wúsī), la “fermezza di fronte all’adulazione” (刚直 不 阿gāng zhí bù ā) e la “conformità delle parole con le azioni” (言行一致, yánxíng yīzhì). Si trattava di un richiamo morale in un momento in cui molti dei valori che avrebbero dovuto accompagnare la costruzione del socialismo sembravano essere superati a favore dell’individualismo e della corsa al benessere. Anche se il PCC ha sempre impiegato le campagne ideologiche come strumento per l’ indottrinamento di massa, l’ uso ne era stato ridotto a partire dalla metà degli anni ottanta (con l’eccezione del periodo post-Tienanmen, tra il 1989 e il 1991); tuttavia la campagna per le “Tre Attenzioni” così come quella successiva per le “Tre Rappresentanze” invertirono la tendenza; la copertura mediatica fu molto intensa ed incideva pesantemente sulla condotta dei membri del partito che venivano puniti severamente in caso di corruzione; Cheng Kejie (vicepresidente del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo) [19] e Hu Changqing (vice-governatore della provincia dello Jiangxi) [20] furono condannati alla pena capitale proprio sull’ onda di questa nuova spinta moralizzatrice il cui bersaglio ultimo era la corruzione diffusa. Insieme alle misure per punire severamente i funzionari corrotti vennero implementate anche quelle per promuovere e lodare i membri che si erano distinti nel rispetto delle regole, ciò inviava un messaggio chiarissimo: il partito era certamente energico ed autoritario ma anche in grado di rigenerare se stesso poiché la corruzione non era né endemica né sistemica, piuttosto il risultato di immoralità individuale.
3.2. Le Tre Rappresentanze
Nel febbraio 2000, durante un viaggio nel Guangdong, Jiang Zemin introduceva la sua nuova dottrina politica delle “Tre Rappresentanze” (三个代表,sān gè dàibiǎo ) [21]. Secondo la nuova teoria, che mirava a legittimare l’esistenza dei nuovi ceti sociali, assenti prima delle riforme, il partito avrebbe dovuto rappresentare:
1. I bisogni di sviluppo delle forze produttive avanzate (中国先进社会生产力的发展要求, Zhōngguó xiānjìn shèhuì shēngchǎnlì de fǎ zhǎn yāoqiú)
2. Gli orientamenti della cultura cinese avanzata. (中国先进文化的前进方向; Zhōngguó xiānjìn wénhuà de qiánjìn fāngxiàng)
3. Gli interessi fondamentali della maggioranza della popolazione cinese (中国最广大人民的根本利益; Zhōngguó zuì guǎngdà rénmín de gēnběn lìyì)
L’obiettivo era quello di trasformare il Partito Comunista Cinese in un partito aperto che inglobasse, neutralizzandolo, il nuovo ceto emerso dalle riforme: bisognava rappresentare tutti perché fossero “alleati”. Effettivamente, nel corso degli anni, il numero delle persone che potevano ancora essere definite come “nemici di classe” continuava a ridursi, mentre aumentava il numero di persone che non avrebbero rappresentato per il regime alcuna minaccia: …Le esperienze storiche acquisite dal Partito fin dalla sua fondazione possono essere riassunte come segue: il nostro partito deve sempre rappresentare i requisiti per lo sviluppo delle forze produttive avanzate del paese, l’orientamento della cultura avanzata cinese e gli interessi fondamentali della stragrande maggioranza della popolazione. Questi sono i requisiti inesorabili per mantenere e sviluppare il socialismo nonché la conclusione logica che il nostro Partito ha raggiunto attraverso una dura sperimentazione e una diffusa prassi [22].
Secondo Zhang Quanjing, coordinatore generale del PCC per la campagna delle Tre Attenzioni, gli obiettivi di quest’ultima sarebbero stati coerenti con i requisiti delle Tre Rappresentanze e che, anzi, ci sarebbe stata complementarietà [23]. Essa giaceva nel fatto che le due campagne condividevano il comune obiettivo di mostrare un partito che, non solo era energico, ma anche capace di adattarsi alle condizioni storiche, politiche e sociali mutate. E se le Tre Attenzioni richiamavano al rigore e alla disciplina dell’ortodossia socialista le Tre Rappresentanze facevano però notare che era necessario modulare progetti e aspettative delle nuove forze produttive nonché trend culturali profondamente mutati. A partire dal 2001, Jiang Zemin promuoveva l’idea di “Governare il paese con la virtù” (以 德 治国,yǐ dé zhìguó) che doveva essere unito con quello di “Governare il paese con la legge (以 法治 国,yǐ fǎzhì guó). I due principi erano complementari; se era vero che il rispetto delle leggi e del diritto aveva naturalmente la priorità, coltivare le virtù morali sarebbe stato il complemento necessario per la costruzione di uno stato e di un’economia forti [24].
Il contributo di Jiang Zemin alle teoria marxista rappresentò uno strumento ideologico importante, che rafforzava la sua posizione all’ interno del partito ed avrebbe aperto la strada alla teoria della “Società armoniosa” di Hu Jintao prima e alla campagna anticorruzione di Xi Jinping in seguito.
4. La politica estera
La brutalità con la quale erano state soppresse le manifestazioni del 1989 ebbe le sue conseguenze sul piano internazionale. Ciò costringeva la Cina ad adeguare la sua politica estera per far fronte alle conseguenze nate dall’incidente. Soprattutto nei due settori prioritari, le relazioni con gli Stati Uniti e le relazioni con il Giappone, la politica estera è stata costretta a subire trasformazioni inaspettate, non intenzionali e indesiderate. Inoltre, piuttosto che sfidare l’egemonia mondiale degli Stati Uniti, Pechino aveva disperatamente bisogno del loro aiuto per lo sviluppo dell’economia. In una tale circostanza politica, i diritti umani difficilmente avrebbero dovuto diventare una questione importante delle relazioni sino-americane [25]. Con ciò va anche ricordato che il governo degli Stati Uniti stava ancora sostenendo il regime di Taiwan nonché il Dalai Lama in esilio in India. Così, sul piano internazionale la questione dei diritti umani diventava invece prioritaria anche rispetto a tutte le altre controversie importanti: sicurezza, commercio e proprietà intellettuale passavano in secondo piano davanti al problema della democrazia. Nel 1997 Jiang si recò negli Stati Uniti su invito del presidente Clinton e fu questa la prima visita di un presidente cinese dopo undici anni. Tuttavia, durante il suo soggiorno che pure vide la ratifica di molti accordi importanti [26] non mancarono momenti di tensione; nel corso della visita ad Harvard, la prima di un capo di stato cinese nei 360 anni di storia dell’università, ci furono pesanti proteste per la politica cinese in Tibet. Durante i suoi quarantacinque minuti di discorso arrivavano le grida dei manifestanti all’esterno: Anche se ho settantuno anni, le mie orecchie sono molto buone, ebbe a dire Jiang più tardi, mentre parlavo ho sentito i megafoni all’esterno, ho creduto che l’unico approccio per me fosse di parlare ancora più forte di loro [27]. Effettivamente le reazioni alla sua visita furono contrastanti: il governatore di New York, George Pataki, si disse essere troppo impegnato per incontrare il presidente cinese. Il sindaco Rudolph Giuliani si rifiutò di parlargli citando il mancato rispetto dei diritti umani …[28] Anche sulla questione di Tiananmen Jiang, interrogato, non mancò di esprimersi: Va da se che potremmo avere avuto delle carenze nel nostro lavoro, così come commesso errori, tuttavia abbiamo agito costantemente per migliorarlo… [29] C’era ancora un evidente problema nella legittimazione della leadership che Jiang non poteva formalmente ammettere ma che, di fatto, poteva complicare le relazioni internazionali. Già Deng si era reso conto che la Cina avrebbe dovuto agire con prudenza sia per verificare e capire quale tipo di ordine avrebbe sostituito il modello bipolare sia per guadagnare tempo ed evitare la strada l’isolamento internazionale. Il pragmatismo e l’intuizione del leader permisero non solo alle critiche internazionali di calmarsi, ma anche il ritiro delle sanzioni (a parte l’embargo per le armi). Intanto il paese si preparava gradualmente al cambiamento dello scenario internazionale ponendo al centro le questioni riguardanti lo sviluppo economico interno che diventavano così il fulcro dell’agenda politica. Con il tempo la partecipazione del paese all’interno delle organizzazioni multilaterali è stata accettata, soprattutto grazie alla “diplomazia sottile” messa in atto [30]. Già nella Costituzione del 1982 si rifletteva l’idea di una politica estera che promuovesse la cooperazione e la pace nella totale indipendenza del singolo stato: la Cina sviluppa costantemente un politica estera indipendente e si unisce ai cinque principi del rispetto reciproco per la sovranità, per l’integrità territoriale, per la non aggressione, per la non interferenza negli affari domestici di altri paesi, per l’uguaglianza e il beneficio reciproco e per la convivenza pacifica nello sviluppo di relazioni economiche e culturali (con altri paesi) [31]. A tale politica sarà conforme il quadro giuridico determinato dal documento “Una politica estera indipendente verso la pace” approvato dalla presidenza di Jiang Zemin [32]. Nel documento si ribadisce che la Cina persegue tenacemente una politica indipendente verso la pace, incentrata sulla protezione dell’indipendenza, della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale, creando un ambiente internazionale favorevole alla riforma e aprendosi al mondo esterno, garantendo pace e promozione dello sviluppo globale. Questa indipendenza si concretizzava nel fatto che per quanto riguarda gli affari internazionali (la Cina) determina sia la sua posizione che le sue politiche in base agli interessi fondamentali della gente, insieme ai popoli di altri paesi e alle sue decisioni. (La Cina) non si umilia mai con nessun grande potere o gruppo di paesi [33]. Il documento propone una visione multilaterale e non egemonica delle relazioni internazionali per la salvaguardia della pace in tutto il mondo sostenendo che ogni paese è uguale all’interno della comunità internazionale indipendentemente dal fatto di essere grande o piccolo, forte o debole, ricco o povero [34]. Sulla base di questa affermata uguaglianza ogni paese dovrebbe accontentarsi di ciò che ha facendo ricorso a consultazioni pacifiche piuttosto che usare la forza o minacciando di usarla: nessun paese dovrebbe interferire negli affari interni di un altro paese se il pretesto è quello di invadere o sovvertire altri paesi. Nel documento, infine, si afferma che la Cina promuove la creazione di un ordine internazionale equo e razionale, basandosi sui cinque principi della coesistenza pacifica [35]. Inoltre, ribadisce l’intenzione di impegnarsi in relazioni di amicizia e cooperazione con tutti promuovendo politiche costruttive sia a livello regionale che con i paesi in via di sviluppo, svolgendo un ruolo attivo all’interno di attività multilaterali diplomatiche, che appaiono come una forza determinante nel mantenimento della pace e della stabilità [36]. Si è molto discusso sul significato di questo multipolarismo: certamente esso va ricercato nel modo in cui la leadership cinese ha visto ed interpretato il mondo dopo la caduta del muro di Berlino. Da questo punto di vista esso appare come una risposta alla posizione egemonica degli Stati Uniti e alla sua durata [37]. Nel 1990, lo stesso Deng aveva ritenuto che, essendo crollati i vecchi equilibri, si stava delineando un nuovo ordine che avrebbe potuto essere tripolare, quadripolare o, appunto, multipolare di cui la Cina e l’Unione Sovietica, sia pur quest’ultima ormai molto indebolita, avrebbero rappresentato due poli importanti. Tra gli accademici e gli osservatori cinesi esistono vari orientamenti sulla questione della multipolarità. Secondo alcuni Europa, Cina e Giappone già bilancerebbero il potere degli Stati Uniti; secondo altri invece la transizione verso l’istituzione di un sistema multipolare non sarebbe ancora completata [38].
4.1. Il Multipolarismo di Jiang Zemin
Il concetto di multipolarismo (多极化主义, duō jí huà zhǔyì) appare in seguito alla visita di Jiang Zemin a Mosca nel 1997; da allora, è stato spesso utilizzato per spiegare l’idea che la Cina aveva dell’ordine internazionale; si trattava cioè di un mondo dove ciascuno cooperava per mantenere equilibri all’ interno della comunità internazionale insieme al controllo delle Nazioni Unite [39]. Secondo il Ministero degli Affari Esteri ad esempio, il multipolarismo aiuta sia a indebolire sia a limitare l’egemonismo e la politica del potere, focalizzata sulla creazione di un ordine internazionale equo che promuove la pace e lo sviluppo in tutto il mondo [40]. Anche se l’intento sembrava quello di depotenziare l’egemonia degli Stati Uniti, non c’è tra i documenti ufficiali una chiara correlazione tra la promozione di un multipolarismo attivo e l’indebolimento di questi ultimi; tuttavia la maggior parte degli osservatori ritiene plausibile e chiaro l’obiettivo di supportare nuovi equilibri che marginalizzassero la preponderanza di alcuni stati. A partire da questa impostazione è possibile delineare una continuità all’interno del riformismo cinese che punta a un multilateralismo flessibile, che vede nell’azione congiunta dell’intera comunità, anziché negli sforzi del singolo, l’unica possibilità di risolvere problemi di portata mondiale. Nel suo rapporto al XV Congresso del Partito Comunista Cinese nel 1997, Jiang Zemin riaffermava l’idea di un mondo che stava profondamente cambiando in cui: I rapporti tra grandi potenze sono soggetti ad aggiustamenti profondi e significativi, le organizzazioni internazionali e intercontinentali appaiono come più attive e la situazione dei paesi in via di sviluppo si sta consolidando [41]. Quindi, lo sviluppo della tendenza del multipolarismo contribuisce alla pace, alla stabilità e alla prosperità in tutto il mondo; in effetti, il desiderio di pace, la ricerca di cooperazione e la promozione dello sviluppo, tutti insieme, appaiono come un segno prevalente dei tempi, dato che è possibile per un lungo periodo, evitare una nuova guerra mondiale e garantire un ambiente internazionale favorevole, in modo pacifico, mantenendo un buon rapporto con i paesi vicini [42]. Nonostante ciò Jiang sottolineava anche che: la mentalità della guerra fredda è ancora presente e sia l’egemonismo sia la politica del potere continuano a presentarsi come una grave minaccia alla pace e alla stabilità internazionale; quindi, l’espansione dei blocchi militari e il ristabilimento delle alleanze militari non permetteranno di difendere la pace né la sicurezza.
D’altra parte, prosegue: Il divario tra paesi ricchi e poveri continua ad allargarsi e i conflitti locali derivanti da tensioni etniche, religiose o territoriali, continuano a verificarsi di volta in volta [43], quindi il mondo sarebbe evidentemente stato lontano dalla pace. Durante il XVI Congresso nel 2002, Jiang dimensionava la capacità del paese di adattarsi a uno scenario che di rapidi cambiamenti, affermando che: la Cina ha risposto con fermezza ad una serie di eventi internazionali inaspettati, sostenendo la sovranità e la sicurezza del paese e avendo superato sia le difficoltà che i rischi derivanti dalla sfera economica o politica [44]. Jiang Zemin quindi ereditò definitivamente la visione di Deng di un mondo multipolare, in cui la Cina avrebbe agito da polo fondamentale nella sua capacità di mantenere la crescita economica [45]. La questione dell’egemonismo (霸权主义,bàquán zhǔyì) è un concetto presente nelle dichiarazioni politiche e nelle comunicazioni congiunte della leadership; è discutibile se l’accusa di egemonizzare fosse rivolta più o meno verso un paese specifico. Probabilmente essa aveva come obiettivo un certa tipo di politica per cui, indipendentemente dal paese che l’avesse praticata, la Cina si sarebbe opposta. A questo proposito, ad esempio, quando il Vietnam invase la Cambogia alla fine degli anni ’70, la Cina accusò il Vietnam di perseguire una politica egemonica nel sud dell’Asia. Durante gli anni settanta e ottanta all’interno del vocabolario cinese, l’egemonismo si configurava come il comportamento di Stati che cercavano di dominare attraverso strumenti militari. In seguito alla disgregazione dell’Unione Sovietica, l’accusa era rivolta agli Stati Uniti e al loro tentativo di occidentalizzare o dividere la Cina, minando la legittimità del Partito Comunista e separare Taiwan dalla Cina. In tempi più recenti il termine è stato usato in modo meno assertivo, apparendo quale anello di congiunzione tra due punti centrali della politica estera: da un lato la non ingerenza negli affari interni quale principio di rispetto, dall’ altra parte, la questione della riforma dell’ordine internazionale insieme a la creazione di una nuova e più equa politica [46]. Tutto sommato quindi la diplomazia onnidirezionale promossa da Deng continuava ad essere perseguita con progressivi miglioramenti sostenuti anche dallo sviluppo economico e dall’ interdipendenza che creava; analogamente la direttiva dei “ventiquattro ideogrammi” fu promossa ed implementata quale cornice della politica estera cinese in questa fase di transizione.
4.2. La politica regionale
In retrospettiva, la politica regionale della Cina ha attraversato tre fasi di evoluzione; negli anni Sessanta l’ostilità verso il regionalismo asiatico era evidente, la leadership maoista sosteneva che l’ASEAN altro non fosse che uno strumento dell’anticomunismo usato dall’ imperialismo [47]. Tuttavia, dopo la fine della guerra fredda la Cina ha gradualmente cambiato la sua posizione fino a partecipare attivamente al regionalismo asiatico proprio a partire dalla metà degli anni novanta. Durante il periodo che va dal 1990 fino al 2000, il paese si è dedicato all’integrazione regionale che è stata caratterizzata da negoziati di libero scambio e da altre forme di cooperazione economica. Catalizzata dalla crisi finanziaria asiatica nel 1997-98 e guidata dai bisogni economici delle riforme, la partecipazione della Cina alla cooperazione regionale non rappresentava più un tentativo di esportare il comunismo piuttosto un’esigenza economica pragmatica. Così, sebbene il paese abbia stabilito una cooperazione in varie aree con i paesi limitrofi, le politiche regionali si riflettevano soprattutto negli accordi commerciali e nella loro implementazione. Nonostante la conferma della politica dei ventiquattro ideogrammi, nel 1991 è entrata nell’ Asia Pacific Corporation (APEC) ed ha partecipato, nello stesso anno, alle operazioni di peacekeeping della Nazioni Unite in Cambogia; analogamente nel 1994 partecipava al Forum Regionale dell’ASEAN (ARF). Ma è stato a partire dal 1997 che il paese ha iniziato a compiere grandi sforzi per essere proattiva nel regionalismo; una concomitanza di eventi favoriva questi sforzi. Innanzitutto la morte di Deng permise a Jiang Zemin di muoversi più liberamente con le proprie iniziative diplomatiche; in secondo luogo, Hong Kong era stata restituita dalla Gran Bretagna, il che consentiva alla Cina di creare relazioni multilaterali con il sud-est asiatico. Nel 2001, ospitava l’incontro del vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) a Shanghai istituendo anche la Shanghai Cooperation Organization e, nel 2002, ha sostenuto trentacinque zone di libero scambio per “ASEAN +3”. Nel 2002, Cina Giappone e Corea lanciavano anche l’ambiziosa proposta di creare una zona di libero scambio tra (CJK FTA) i cui negoziati sarebbero poi stati avviati nel 2012. Progressivamente si creavano le premesse di una piattaforma innovativa che incoraggiava la cooperazione Nord-Sud nell’Asia orientale collegando i paesi più ricchi con quelli meno sviluppati; nel 2006, la Cina diventava ufficialmente un osservatore dell’Associazione dell’Asia Meridionale per la Cooperazione Regionale (SAARC), che comprende l’India, il Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal e Sri Lanka. Nel febbraio del 2011, l’ASEAN lanciava la proposta di negoziare un Partenariato Economico Globale Regionale (RCEP) con altri partner e, alla fine di agosto 2012, l’ASEAN, Cina, Giappone, Corea del Sud, India, Australia e Nuova Zelanda avviavano i negoziati per la sua costituzione. Nelle aspettative della Cina la politica di cooperazione avrebbe dovuto stabilire relazioni basate sulla fiducia e sui benefici reciproci attraverso consultazioni paritarie con altri paesi; si configurava così un regionalismo progettato per essere né chiuso, né esclusivo. Alla cerimonia di lancio della SCO Jiang Zemin dichiarava che era necessario che esso aderisse a quattro principi: 1) innovatività 2) pragmatismo 3) solidarietà 4) apertura [48]. Jiang esplicitava ulteriormente il suo pensiero sul regionalismo durante la quinta conferenza annuale della Asian Development Bank, il 10 maggio 2002. Nella fattispecie, sarebbe stato necessario promuovere politiche di comprensione reciproca e coesistenza armoniosa a vantaggio dello sviluppo asiatico, attuare il principi di eguale consultazione, reciprocità dei benefici ed interesse comune, implementare i meccanismi di cooperazione esistenti continuando ad esplorarne di nuovi e, infine, promuovere un regionalismo aperto. Analogamente, il 23 giugno del 2004, il premier Wen Jiabao ribadiva che la cooperazione asiatica avrebbe dovuto aderire ai cinque principi di base della coesistenza pacifica al fine di salvaguardare la pace e la stabilità dell’Asia. Sarebbe stato necessario promuovere la cooperazione asiatica in modo completo, a partire da quella economica e rafforzare gli scambi in modo inclusivo così da aumentare e migliorare il livello delle relazioni [49].
5. Conclusioni
A partire dalla metà degli anni ’90 quindi la Cina ha permanentemente implementato audaci riforme del settore statale, dirigendosi verso la privatizzazione delle imprese pubbliche quali motori della transizione. Ha anche razionalizzato il sistema giudiziario istituendo una serie di nuove leggi in materia di finanza, commercio globale, prezzi, tassazione, investimenti, fallimento e imprese. L’applicazione dello stato di diritto ha anche facilitato la creazione di nuove istituzioni fondamentali del mercato, tra cui la China Securities Regulatory Commission (CSRC), il sistema dei contratti e la gestione del mercato del lavoro, sistemi innovativi di distribuzione sui mercati dei prodotti e dei capitali, nonché l’attuazione di queste decisioni per mezzo di agenti, broker e altri mediatori. La creazione di una burocrazia razionale e lo sviluppo del settore delle spese sociali hanno quindi contribuito significativamente al processo di transizione. Al fine di rafforzare queste misure, a partire dal 2004, il governo ha ripetutamente lanciato campagne anti-corruzione, puntando a una governance efficiente e a una reputazione “onesta”, che è continuata durante tutto il periodo della presidenza Hu Jintao. Tra tutti gli sforzi di cambiamento presentati, l’apertura, l’imprenditorialità, la flessibilità, la sostenibilità e la stabilità si sono distinti come i pilastri delle riforme istituzionali e come passaggi principali verso il cambiamento che ha anche comportato la liberazione, in una certa misura, dalle restrizioni imposte nel tempo dal Partito Comunista, nel suo tentativo di controllare il sistema economico del paese. Infine, queste misure di decentralizzazione e deregolamentazione hanno indebolito la rigidità ideologica e gli interventi burocratici iperattivi del precedente sistema di pianificazione stimolando il ruolo della concorrenza di mercato, che ha portato alla crescita economica e all’integrazione orizzontale e verticale. Tutte queste misure sono state sostenute da riforme del sistema fiscale e finanziario, al fine di rafforzare la concorrenza di mercato nello spazio globale, e di stimolare la libera circolazione, facilitando l’accumulo di capitale fisico.
La dottrina delle “Tre Rappresentanze” è stata un passaggio fondamentale nel costruire la transizione verso una Cina nuova. Innanzitutto significava riconoscere e legittimare il ceto produttivo imprenditoriale, poi lo si inglobava nella nuova visione della società che ancora prevedeva il famoso “arricchirsi è glorioso” di Deng Xiaoping purché questo non delegittimasse il Partito e l’etica socialista. Si tratta di un nodo fondamentale per comprendere la politica di riaggiustamento di quel periodo. Così, se negli anni ottanta si era data la stura ad un impetuosa crescita che stava profondamente incidendo anche sulla coesione sociale, con Jiang Zemin assistiamo ad una organizzazione ordinata e razionale dell’economia alla quale doveva però seguire un riallineamento etico della società.
La politica estera del periodo in questione può essere ritenuta oggetto di una riflessione notevole e che ha determinato le posizioni che la Cina continua ad assumere nei confronti delle relazioni internazionali. Il ruolo cardine riconosciuto alle Nazioni Unite nella risoluzione delle dispute, l’insistenza verso il multipolarismo, il rifiuto del concetto di egemonia e, non ultima, la promozione delle idee di equità e pacificazione non sono cosa da poco. Gli sforzi fatti per far riemergere il paese dal fondo dei contesti internazionali dove era finito a causa dei provvedimenti verso le proteste dell’ ‘89 non possono passare inosservati e il , tutto sommato, mortificante viaggio di Jiang Zemin negli Stati Uniti ne è una delle testimonianze più evidenti. Contemporaneamente, il rafforzare le politiche regionali ha avuto un’importanza declinata in due sensi: da un lato c’era la necessità di creare nell’area un clima favorevole allo sviluppo economico, dall’altro bisognava mettere al centro, conducendo un’ottima politica di vicinato, importanti alleati asiatici rispetto allo scacchiere internazionale. In definitiva, si può sostenere che il periodo in questione sia stato determinante nella costruzione della Cina di cui il mondo avrebbe iniziato ad accorgersi solo qualche anno dopo: un paese moderno, fortemente proiettato nel futuro, capace di gestire crisi importanti e con una visione delle relazioni internazionali che rifiuta polarizzazioni rigide perché, sostanzialmente, la pace è il primo requisito perché tutti possano crescere.
Note sull’autore
** Daniela Caruso è sinologa, da diversi anni si occupa delle trasformazioni storiche della Cina contemporanea con un particolare sguardo all’evoluzione del welfare, ma anche delle politiche culturali e scientifiche. Attualmente è docente di Studi sulla Cina presso l’Università Internazionale per la Pace delle Nazioni Unite, la cui struttura di Roma è delegata a rappresentarla nel Sud Est europeo, nel Medio Oriente, nel bacino del Mediterraneo e nell’Africa Settentrionale e Sub-sahariana. È stata visiting professor alla Tshingua University di Pechino dove ha tenuto seminari di comunicazione interculturale. Membro dell’European Association for Chinese Studies (EACS), membro direttivo del WCSA (World Complexity Science Academy), docente presso L’École des hautes études en sciences sociales e il dipar timento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha coordinato progetti di ricerca internazionali inerenti l’interculturalità, le politiche sanitarie in Cina, le migrazioni e le relazioni tra la Cina e il Mediterraneo. Autrice di numerose pubblicazioni in lingua inglese, le sue due ultime monografia in lingua italiana, “Quarant’anni di Cina.- la storia di un’ascesa che sta cambiando il mondo” del 2019 così come quella in uscita, “La Cina tra identità nazionale e globalizzazione. Promozione e impresa culturale come strumenti di diplomazia e coesione sociale” del 2022 sono pubblicate da Eurilink University Press.
Note
[1] F. Schurmann, Ideology and Organisation in Communist China, Berkeley 1966, p. 18.
[2]Deng Xiaoping aveva affermato piuttosto apertamente nel suo discorso al 12 ° Congresso Nazionale: “nessun paese straniero dovrebbe aspettarsi che la Cina diventi il suo vassallo (附庸fuyong) … minando gli interessi della Cina stessa”.” SWDX, 3, pp. 12-13.
[3] Wang Xiaoqiang, Vice direttore dell’Istituto per la ricerca sulla ristrutturazione del sistema economico citato in: Wei-Wei Zheng, Ideology and Economic Reform Under Deng Xiaoping 1978-1993, no. 9, London 1996, pp. 1-2.
[4] I Quattro Principi Cardine (四项基本原则, Sì-xiàng Jīběn Yuánzé) sanciti da Deng Xiaoping nel 1979: 1) Aderire alla via socialista 2) Aderire “dittatura democratica del popolo” 3) Aderire alla leadership del Partito comunista 4) Aderire al marxismo-leninismo e al pensiero di Mao Zedong.
[5] Zhang Hong, Sun Yang, In Search of Re-ideologization and Social Order; In: A. J. Nathan, Zhang Hong, S. R. Smith “Dilemmas of Reform in Jiang Zemin’s China” London 1999, pp. 33–49.
[6] K. Misra, Curing the Sickness and Saving the Party: New-Maoism and New-Conservatism in the 1990s; in S. Hua, “Chinese Political Culture”, 133–60. New York: 2001, pp. 133-160.
[7] Il primo Luglio 1997 la colonia britannica tornava sotto la sovranità cinese a seguito di una serie di lunghe negoziazioni tra la Cina e la Gran Bretagna. La transizione di Hong Kong era un evento di enorme portata politica e sollevava una serie di complessi anche di natura pratica, anche perché gli accordi previsti dalle due potenze riguardanti il futuro di Hong Kong avevano precedenti nel campo della prassi internazionale.
[8] S. Fischer, Socialist Economy Reform: Lessons of the First Three Years, American Economic Association, “Papers and Proceedings” May 1996 pp 390-395
[9] Yang Pexin, Contract System – An Inevitable Road to Prosperity of Enterprises, Beijing 1996, pp.6-8.
[10] Zhang Le-yin, Chinese Central – Provincial Fiscal Relationships, Budgetary Decline and the Impact of the 1994 Fiscal Reform: An Evaluation, “The China Quarterly” No 157 March 1999 pp 115-141.
[11] Yang Pexin, Contract System….pp. 26-27.
[12] La crisi finanziaria investì l’Asia a partire dal 1997, durando circa un anno. Iniziò in Tailandia con il crollo del baht. I tentativi di difendere la moneta, prima attraverso il ricorso alle riserve di valuta, poi mediante svalutazioni sempre più incontrollate e il rialzo dei tassi di interesse, non ebbero seguito alcuno, se non quello di spingere nuovi speculatori ad approfittare dell’ulteriore debolezza della divisa e provocare il fallimento. La fuga dei capitali, sospinta dal timore di ulteriori svalutazioni alimentava il circolo vizioso della crisi finanziaria gettando in difficoltà gravi le banche e le imprese. Con il diffondersi della crisi, la maggior parte del Sud-est asiatico e del Giappone ha visto valute in calo, mercati azionari svalutati nonché un aumento vertiginoso del debito privato. Per approfondimenti cfr: R. Wade, The Asian Debt and development crisis of 1997, “World Development”, Vol. 26 Issue 8, August 1998, pp.1535-1553.
[13] Jiao Jihong, China’s Economic Reform of State – Owned Enterprises, Beijing 2002, pp. 86-87.
[14] La danwei, o “unità di lavoro”, costituiva l’organizzazione di base del lavoro nella Cina urbana nate durante il periodo maoista. Le unità di lavoro includevano scuole ed asili per l’educazione dei figli, alloggi per tutti i membri della famiglia, ambulatori e mense pubbliche. Dalla metà degli anni Ottanta, questa forma di organizzazione industriale, tipica di un’economia pianificata, è entrata in una fase di declino. Oggi il termine danwei o, più correttamente yongren danwei, viene comunemente utilizzato per indicare l’impresa, il datore di lavoro.
[15] Zhang Gengyuan, Zhu Shuizhi, Chen Dazhong, Stories of China’s reform and opening-up ,Beijing 2005, pp. 35-39.
[16] Wang Gungwu, Zheng Yongnian (Damage Control: The Chinese Communist Party in the Jiang Zemin Era, Singapore 2003, and p.353.
[17] “中央召开电视电话会议对县级以上领导党性党风教育作出部署, Zhōngyāng zhàokāi diànshì diànhuà huìyì duì xiàn jí yǐshàng lǐngdǎo dǎngxìng dǎng fēng jiàoyù zuòchū bùshǔ” (“Il governo centrale ha tenuto una teleconferenza per alzare il morale tra i leader più alti del livello della contea”), 人民日报 Renmin Ribao (Quotidiano del Popolo), 6 dicembre 1998.
[18]江泽民, 领导干部一定要讲政治,Lǐngdǎo gànbù yīdìng yào jiǎng zhèngzhì, (“I leader devono prestare attenzione alla politica”). Discorso tenuto il 27 settembre 1995, presso il Dipartimento di Propaganda del PCC; in: “讲学习,讲政治,讲正气 Jiǎng xuéxí, jiǎng zhèngzhì, jiǎng zhèngqì (“Prestare attenzione allo studio, prestare attenzione alla politica, prestare attenzione alla rettitudine”), Pechino 1996, pp.314-318.
[19] Cheng Kejie Sentenced to Death for Bribery, “People’s Daily”. 31 July 2000. http://en.people.cn/200007/31/eng20000731_46885.html
[20] Rise & Fall of Hu Changqing, “People’s Daily”, 14 April 2000. http://en.people.cn/english/200004/14/eng20000414_38924.html
[21]Jiang Zemin, 在新的历史条件下, 我们当如何做到三个代表? (Zai xinde lishi tiaojian xia, womendang ruhe zuodao sange daibiao? In questa nuova era storica come puo il nostro partito, raggiungere le Tre rappresentatività?); in: “Jiang Zemin, 论三个代表 (“Jiang Zemin, Saggio sulle Tre Rappresentatività”), Pechino 2001. Il volume raccoglie dodici discorsi di Jiang Zemin relativi a questa tematica.
[22] Dal Report di Jiang Zemin al 16 ° Congresso CPC, 8 novembre 2002, in “Selected Works of Jiang Zemin”, Beijing, 2013, Vol. III, p. 519.
[23] 三讲强调教育的中央协调员张全敬强调:贯彻三个代表思想贯彻三讲教育活动;(Zhongyang sanjiang jiaoyu lianxi huiyi fuzeren Zhang Quanjing qiangdiao: ba xuexi guanche ‘sange daibiao’ sixiang guanchuan ‘sanjiang’ jiaoyu quanguocheng,, Zhang Quanjing, coordinatore centrale della formazione sulle Tre Attenzioni, Implementare l’apprendimento delle Tre Rappresentanze il pensiero attraverso le attività educative delle Tre Attenzioni)
[24] Li Peichao, Logical thinking on Marx ethical thoughts, “Contemporary World & Socialism journal”, 2007, p.4.
[25] I sostenitori dei diritti umani come ad esempio Amnesty International non dimenticavano il fatto che in Cina esistessero evidenti violazioni dei diritti umani. Tuttavia, era necessario che la Cina non ricadesse più in errori espliciti per evitare che gli interessi dei due paesi venissero compromessi.
[26] Durante la visita del Presidente Jiang negli Stati Uniti, entrambe le parti hanno concluso una serie di accordi sull’aumento degli scambi e della cooperazione tra i due paesi nei settori del commercio, della protezione ambientale, dell’energia, della scienza, della tecnologia, della cultura e degli armamenti. Cfr: Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China, President Jiang Zemin visited the United States: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18030.shtml
[27] Cit in:J. Pomfret, L. H. Sun, Beijing made mistakes, Jiang said, “The Washington Post”, November 2, 1997.
[28] CNN, Thousands protest Jiang’s visit to Harvard, November 1, 1997. Cfr: http://edition.cnn.com/WORLD/9711/01/jiang/
[29] J. Pomfret; L. H. Sun, Ibidem.
[30] Shen Wei, In the Mood for Multilateralism? China’s Evolving Global View, Centre Asie Ifri, Working Paper, July 2008, www.ifri.org.
[31] Constitution of the People’s Republic of China, Beijing, 2004, 5th edition, p. 6.
[32] Ministry of Foreign Affairs of the Peoples’ República of China, “China’s Independent Foreign Policy of Peace”, 18.08.2003, http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/wjzc/t24881.htm
[33] Ministry of Foreign Affairs of the Peoples’ Republic of China, “China’s Independent Foreign Policy of Peace”, 18.08.2003, http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/wjzc/t24881.htm
[34] Ibidem
[35] FAM-PRC, China’s Independent…, ibidem.
[36] Ibidem.
[37] Huan Xiang, consigliere per la sicurezza nazionale di Deng, aveva lanciato il dibattito sulla multipolarità nel 1986 evidenziando i punti di debolezza delle superpotenze ed evidenziando come il triangolo strategico Cina-Stati Uniti-Unione Sovietica sarebbe stato il terreno per un multipolarismo. Cfr: Kai He, Neoclassical Realism and China’s Foreign Policy, Arizona State University, March 2006.
[38] Cfr: Wang Jisi, Multipolarity Versus Hegemonism:Chinese Views of International Politics in http://www.cssm.org.cn/view.php?id=21083
[39] Cheong Li, Limited Defensive Strategic Partnership: Sino-Russian rapprochement and the driving forces, Journal of Contemporary China, vol. 16, no. 52, p. 483 e Yong Deng, China’s Strategic Partnerships with Russia, the European Union and India, Journal of Strategic Studies, vol. 30, No. 4-5, August-October 2007, p. 882.
[40] In: Jing Men, EU-China Relations: Problems and Promise, Jean Monnet/ Robert Schuman Paper Series, vol. 8, No. 13, June 2008, http://www6.miami.edu/eucenter/publications/MenEUchinaLong08edi.pdf
[41] Jiang Zemin, Report at the 15th National Congress of the Communist Party of China, 12 September 1997, in www.fas.org/news/china/1997/970912-prc.htm.
[42] Ibidem
[43] Ibidem.
[44] China Daily, XVI CPC Party Congress Opens in Beijing, 8.11.2002, http://english.people.com.cn.
[45]Cfr: C. Layne, The Unipolar Illusion: Why New Great Powers will Rise, International Security, vol. 17, no. 4, Cambridge 1993, pp. 5-51.
[46] Deng Xiaoping aveva già parlato in questi termini in un suo discorso alle Nazioni Unite: “gli affari di ogni paese dovrebbero essere gestiti dalla sua stessa gente” e “il popolo dei paesi in via di sviluppo ha il diritto di scegliere e decidere il suo sistema sociale ed economico”. Cfr: Speech By Chairman of the Delegation of the People’s Republic of China, Deng Xiaoping, At the Special Session of the U.N. General Assembly, April, 10, 1974.
[47] Li Yifang, 论中国与东盟关系的演变, 荆州师范大学学报 (Lùn zhōngguó yǔ dōngméng guānxì de yǎnbiàn, jīngzhōu shīfàn dàxué xuébào no. 3, 2003, p. 73); Sull’evoluzione della relazione tra Cina e ASEAN, Rivista dell’ Università normale di Jingzhou, no. 3, 2003, p. 73.
[48] Si veda il discorso di Jiang Zemin: Migliorare la solidarietà e la cooperazione e creare un secolo luminoso, tenuto alla riunione inaugurale della SCO il 15 giugno del 2001; http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002- 06/05/content_425593.html
[49] Durante la terza riunione dei ministri degli esteri sul dialogo sulla cooperazione asiatica del 23 giugno 2004, con il suo discorso Wen Jiabao offriva proposte per promuovere la cooperazione asiatica. Cfr. http://news.sina.com.cn/o/2004-06-23/02202879943s.shtml.
(Featured Image Source: Wikimedia; Wikimedia)