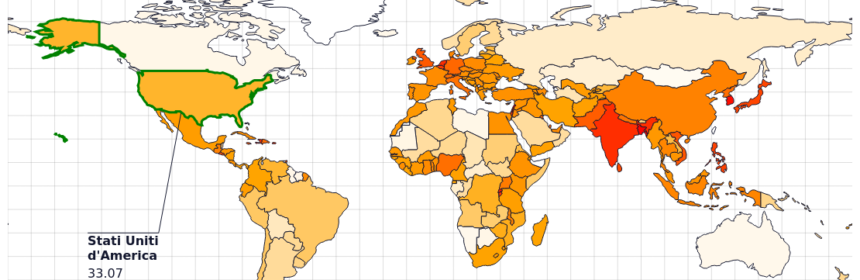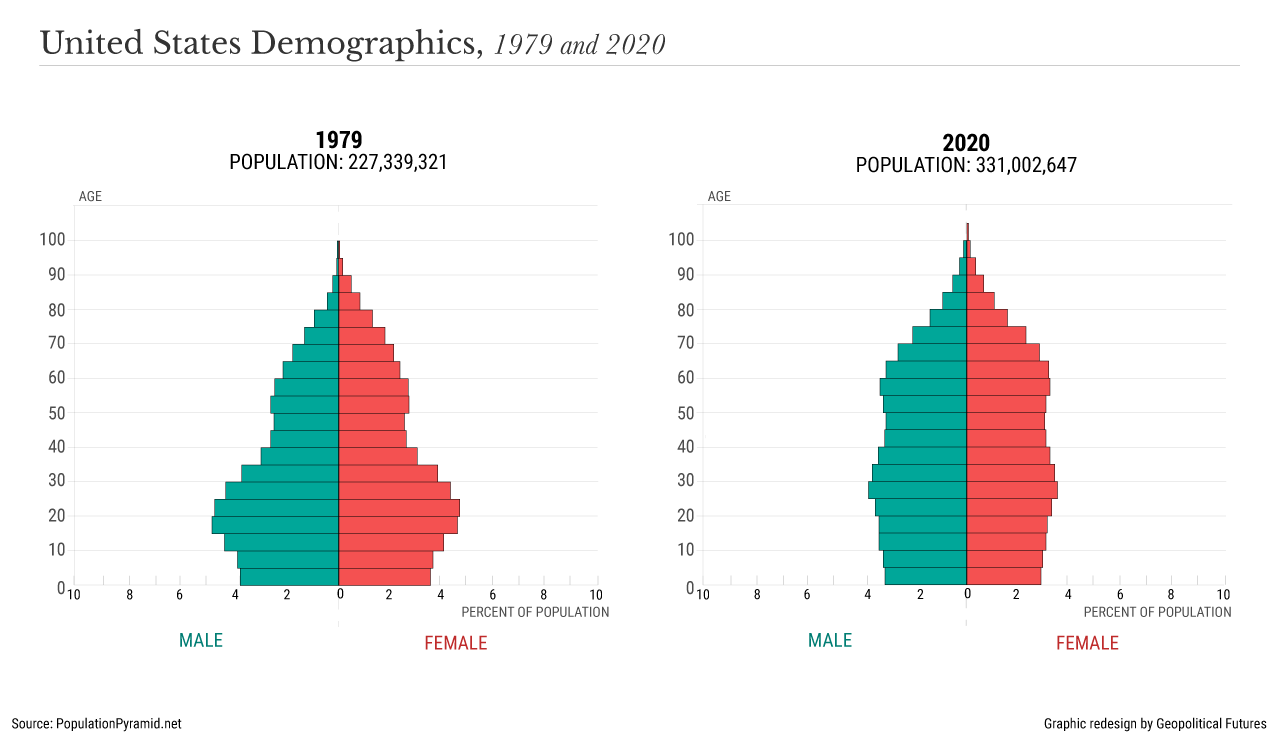Salti di paradigma, salti nel vuoto
Gli Stati Generali del regno di Francia vengono convocati dal re di Francia e di Navarra Luigi XVI l’8 agosto 1788. Essi chiamano a consigliare il sovrano i rappresentanti dei tre Stati o Ordini in cui è tradizionalmente suddiviso il regno di Francia. Adalberone, vescovo di Laon (947 ca. -1030) nel “Carmen ad Rodbertum regem” li ripartisce in Oratores, Bellatores, Laboratores, riferendosi analogicamente alla Divina Monotriade. La tripartizione in Ordini rispecchia l’antichissima tripartizione indoeuropea in caste, ad esempio la tripartizione hindu tra bràhmana (sacerdoti), kshàtrya (guerrieri), vàisya e shùdra (contadini, artigiani, commercianti, etc.).
All’interno di ciascun Ordine – tra pari – le deliberazioni vengono prese a maggioranza, per testa; il voto finale degli Stati Generali, che approva i suggerimenti da porgere al sovrano, viene espresso per Ordini, nonostante il rapporto numerico tra componenti il Primo e Secondo Stato e componenti il Terzo sia, all’incirca, del 3% rispetto al 97%.
Il 6 maggio 1789, all’ Hotel des Menus Plaisirs di Versailles, nella sala ribattezzata per l’occasione Sala dei Tre Ordini, i rappresentanti del Terzo Stato deliberano all’unanimità il voto finale per testa. Si uniscono a loro 47 rappresentanti (su 270) del Secondo Stato, la nobiltà, e 114 rappresentanti (su 291) del Primo Stato, il clero. Il voto pone termine all’ultima forma politica sopravvissuta che rispecchi il più antico carattere distintivo della civiltà indoeuropea.
La risultanza politica del voto del 6 maggio 1789 – un evento puntuale, che si consuma in pochi minuti – è stata preceduta da secoli di dibattito metafisico, filosofico, teologico, antropologico, e da secoli di storia in cui si infrange la Cristianità, si scontrano e decadono Chiesa e Impero, i due “Soli” del “De Monarchia” dantesco; e sorgono, proponendosi come Terzo Sole dell’umanità – parola che esprime un concetto nuovo e un nuovo programma culturale e politico – i Lumi. L’alto numero di rappresentanti del Primo (39%) e del Secondo Stato (17%) che, contro gli interessi del proprio Ordine, votano con i rappresentanti del Terzo, illustra meglio d’ogni analisi quale sia il senso comune prevalente nel regno di Francia, che all’epoca è culturalmente egemone in Europa.
Ecco: questo è un salto di paradigma.
Un salto di paradigma anzitutto metafisico, filosofico, teologico, antropologico; e per logica conseguenza, anche politico. L’aspetto della realtà formalmente espresso e politicamente tradotto dalla tripartizione indoeuropea – le diverse facoltà dell’animo umano, la gerarchia interiore in cui vanno ordinate perché l’uomo si individui compiutamente, l’ordine politico che la rispecchia in quanto “la polis è l’uomo scritto in grande” – non cessa per questo di esistere: sopravvive nel linguaggio e nelle inclinazioni personali, oltre che, ovviamente, nelle biblioteche. Viene però disattivata, nell’effettualità politica e nella coscienza che le società inaugurate da quel voto hanno di sé. C’è, ma non si dice e non si pensa. A volte, si attiva: ad esempio quando si combatte, e nel soldato come tecnico delle armi spunta il guerriero; o quando dal sacerdote come burocrate dell’istituzione ecclesiastica e assistente sociale spunta l’uomo di preghiera; o quando dall’artigiano e dal lavoratore spunta l’artista.
Segnalo ai naviganti che c’è in vista un altro salto di paradigma, al confronto del quale il salto di paradigma datato 6 maggio 1789 sembrerà il saltello di un bambino di due anni.
Lo segnalo adesso, mentre è ancora in discussione in DDL Zan, perché se verrà varato, discuterne dopo potrebbe dar luogo a spiacevoli conseguenze per il sottoscritto (i processi costano e possono finir male).
Lo so che sembra assurdo, ridicolo, paradossale tirare in ballo parole ed eventi così grossi – “salto di paradigma”, ”rivoluzione francese” – per una leggina come il DDL Zan, che magari nemmeno passerà al Senato. Ho letto in questi giorni i commenti in proposito di molte persone intelligenti, spesso di sinistra ma anche di destra, che si possono riassumere così: “Quanto rumore per nulla, i problemi dell’Italia sono ben altri” (segue elenco problemi, a volte ben ragionato). Penso che queste persone intelligenti si sbaglino. È più che comprensibile che si sbaglino, perché da un canto gli altri problemi ci sono eccome, e sono molto grandi e gravi; dall’altro, è sempre difficile individuare in tempo reale gli eventi puntuali che segnano svolte qualitative nella storia. Un uomo non geniale ma tutt’altro che stupido o incolto come Luigi XVI, la sera della presa della Bastiglia scrisse nel suo diario: “Oggi, niente.”
Qual è insomma questo salto di paradigma che, secondo me, si profila all’orizzonte? Non faccio il misterioso e ve lo dico subito. È il concetto di “genere”, impiegato come ordinatore principale e anzi esclusivo del concetto di “uomo”. Scrivo “anzi esclusivo” perché il concetto di “genere” non si limita più a combattere con altri e incompatibili ordinatori del concetto di “uomo” nel Kampfplatz filosofico. Ha condotto e continua a condurre questa battaglia nel teatro d’operazioni filosofico, con esiti alterni: non si profila, per esso, una vittoria schiacciante o sicura. Esso ha però trasposto la battaglia per l’egemonia dal campo filosofico al campo giuridico, sociale e politico, e in questo diverso teatro di operazioni ha trovato alleati molto potenti.
Il concetto di “genere”, nelle sue varie declinazioni a me note, presenta un minimo comun denominatore: è sempre riconducibile alla soggettività dell’individuo. A quel che l’individuo desidera (il suo orientamento erotico) all’idea che l’individuo si forma di sé (la sua identità, il nome segreto con cui si chiama) a quel che l’individuo vuole divenire (ad esempio, trasformarsi da maschio in femmina e viceversa). In sintesi, il concetto di “genere” presuppone la sovranità assoluta dell’individuo su se medesimo, la sua totale libertà di decidersi, insomma la sua radicale autonomia, nel senso fortissimo di libertà d’essere norma a se medesimo, e persino di mutare ad libitum la norma che lo definisce e lo identifica, in buona sostanza lo crea. Il concetto di “genere” prefigura, insomma, un “uomo-individuo autocreatore”.
Nel passaggio dal Kampfplatz filosofico al campo di battaglia dell’effettualità sociale e politica – ove si propone l’obiettivo di divenire l’ordinatore esclusivo del concetto di “uomo” – il concetto di “genere” prende correttamente di mira il suo nemico principale. Il suo nemico principale è il più antico e potente ordinatore del concetto di “uomo”, ossia l’insieme concettuale “maschio – femmina”.
L’insieme concettuale “maschio – femmina” è indissolubile, perché “maschio” si definisce in rapporto a “femmina”, e “femmina” si definisce in rapporto a “maschio”. Nessuna delle due parole, e delle realtà che designano, ha significato se non in rapporto all’altra. “Maschio-femmina” è l’ordinatore logicamente e cronologicamente più antico del concetto “uomo”.
“Uomo” è sempre “uomo maschio” oppure “uomo femmina”, “uomo femmina” oppure “uomo maschio”. Ciò che non è né maschio né femmina è “neutro”, ossia, etimologicamente, “né l’uno né l’altro”: e non è “uomo”. Tutti i linguaggi umani di cui abbia notizia si formano sulla base dell’antichissimo ordinatore “maschio-femmina”. Così si formano i generi grammaticali – maschile, femminile, neutro – e così si formano le parole e l’ innumerevole foresta di metonimie e metafore grazie alle quali comunichiamo, comprendiamo, cantiamo, sogniamo.
Salvo errore (non sono onnisciente) ciò avviene in tutte le culture e le lingue dell’uomo, senza riguardo alla latitudine e all’epoca. Ovviamente, il fatto che l’uomo si pensi e comprenda se stesso in conformità all’insieme “maschio-femmina” implica anche, per conseguenza logica, che l’uomo si pensi e senta in rapporto necessario, primordiale, a un Altro/Altra che, rispetto alla sua individualità empirica, è sempre distinto e separato: non meno diverso che uguale, tanto alieno quanto identico; un fatto curioso ed enigmatico che egli vede rispecchiato, nella sua vita quotidiana, sia dal fatto imperativo che tutti gli uomini, maschi e femmine, nascono dall’incontro sessuale di un uomo-maschio e un uomo-femmina, sia dalla forza altrettanto imperativa dell’attrazione erotica per l’altro sesso: quando la prova, ovviamente, come è normale che sia, nel senso più forte della parola “norma”: perché se l’attrazione erotica per l’altro sesso non fosse norma, l’uomo si sarebbe estinto da un pezzo.
Anche da questo minimo sunto che ho abbozzato, risulta chiaro come il sole per quale motivo il concetto di “genere” debba designare come proprio nemico principale l’insieme concettuale “maschio-femmina” che ordina il concetto di “uomo”: perché esso è radicalmente incompatibile con la sovrana, assoluta libertà dell’individuo di essere norma a se stesso, di mutarla a suo piacimento, e insomma di crearsi da sé. Se il concetto di “uomo” comprende l’uomo-maschio e l’uomo-femmina – i due avatar dell’uomo che nella realtà si presentano sempre come individui separati – nessun singolo individuo potrà mai coincidere con l’intero concetto di “uomo”, compierlo, esaurirlo, esperirlo per intero; nessun individuo empirico potrà mai essere tutto l’uomo, l’individuo assoluto capace di sovrana, perfetta libertà di conoscersi, esperirsi, compiersi, autodeterminarsi e autocrearsi.
Ecco allora che il concetto di “genere”, nella sua battaglia per farsi ordinatore esclusivo del concetto di “uomo”, propone – e tenta di imporre per via politica – un nuovo concetto di “uomo”: quello di un individuo empirico, un singolo quidam de populo, che conquista il diritto, garantito dall’imperio della legge positiva, di essere al contempo sia maschio sia femmina, più tutto il fluido ventaglio delle posizioni intermedie tra maschio e femmina; e di sanzionare il proprio nemico, l’insieme “maschio-femmina”, ove voglia esercitare il proprio antico privilegio di esclusivo ordinatore del concetto di “uomo”: ad esempio, nel matrimonio, ma persino nel linguaggio.
Il matrimonio, la più antica istituzione simbolica volta alla riproduzione della specie e alla sua integrazione nella cultura, non deve più essere riservato all’uomo-maschio e all’uomo-femmina, ma dev’essere esteso all’uomo-individuo autocreatore, e a lui adeguato. Se all’uomo-individuo autocreatore non è biologicamente possibile riprodurre la specie, gli è disponibile il surrogato della tecnica, o l’ausilio servile di uomini-maschio e uomini-femmina. Questo obiettivo, di eccezionale importanza per il rilievo simbolico impareggiabile del matrimonio, è già stato raggiunto nel paese egemone dell’Occidente, con la sentenza della Corte Suprema federale del 2015 ( caso Obergefell vs. Hodges).
Più difficile, lunga e complicata la riforma del linguaggio, che in ogni suo frammento reca l’impronta del nemico, ma l’opera è iniziata con la battaglia sui pronomi, volta ad escludere e vietare per legge il maschile e il femminile in quanto “discriminatori”: ciò che in effetti sono, perché “discriminano”, ossia “differenziano” l’uomo-maschio e l’uomo-femmina.
I possenti alleati che il concetto di “genere” e l’uomo-individuo autocreatore che esso intende affermare hanno trovato nel mondo sono molti. Il più forte sul piano della comunicazione è l’accesso, ormai assicurato, al ruolo simbolico di “vittima”, che gli garantisce forza contrattuale sul piano simbolico ed efficacia propagandistica.
Si tratta di una trascrizione del ruolo – chiave della vittima sacrificale nel cristianesimo, che trasferendosi sul piano secolare si inverte di 180°. Nel cristianesimo, la vittima sacrificale per antonomasia è una delle Persone della SS. Trinità, la Quale, sacrificandosi e rinnovando il proprio sacrificio nella Messa fino alla fine dei tempi, risarcisce e riscatta la colpa dell’umanità. Il colpevole è l’uomo, la vittima è Dio, che amandolo si sacrifica per la sua salvezza. Nella trascrizione secolarizzata, vittima sacrificale è chi sia stato discriminato e oppresso dal Potere, riflesso terreno dell’unico attributo divino del quale è impossibile ridere. Colpevole è dunque il Potere-Dio, vittima l’uomo defraudato che esige di eguagliarsi a Lui, e in quanto sua vittima esige risarcimento e riscatto. In questo senso, direbbe de Maistre, l’intera civiltà moderna post rivoluzione francese è un’espressione di risentimento contro Dio; e l’uomo-individuo autocreatore, per l’evidente ragione che sta mirando a ricrearsi daccapo e da sé, sarebbe la manifestazione più patente di questo risentimento, e della conseguente volontà di risarcimento e rivincita.
Sul piano sociale, il più potente alleato dell’uomo-individuo autocreatore è la logica del capitalismo liberale, che tende a dissolvere tutti i legami sociali e comunitari, e giustifica la propria dinamica mediante due argomenti soli: 1) performatività (ossia, perché funziona) 2) conferisce sempre maggiore libertà agli individui (e solo agli individui). Entrambi questi suoi tratti caratteristici manifesterebbero la sua superiorità e insuperabilità, in un orizzonte di indefinito progresso: verso dove non si sa, ma non è importante sapere. S’intravvede oltre l’arcobaleno un “uomo nuovo”, radicalmente trasformato, più bello, longevo, felice, buono, vitale; ma saggiamente, come un tempo Marx si rifiutava di scrivere il menu per le osterie dell’avvenire, anche il capitalismo liberale evita di dettagliare il menu per il ristorante del transumano, anche perché alcun anticipazioni di cui si chiacchiera toglierebbero l’appetito ai più affamati.
La logica capitalistico-liberale, poi, intende l’individuo nella forma semplificata dell’ homo oeconomicus, ossia di un autonomo centro di interessi (se considerato dall’esterno, oggettivamente) e di un centro di bisogni e desideri (se considerato dall’interno, soggettivamente). A regolare sia interessi, sia bisogni e desideri dell’individuo, è preposta la sola legge positiva, indefinitamente modificabile per via procedurale, e alla quale è proibito rifarsi a fondamenti valoriali o metafisici capaci di dare giudizi assiologici in merito alle proprie modificazioni, o di porvi limiti. Quel che non c’è nel kit dell’ homo oeconomicus spetta alla scienza studiare e definire come “uomo biologico”; e lì c’è tanto lavoro analitico da fare, che può fattivamente occupare gli scienziati fino alla fine dei tempi.
Non è difficile capire quanto simili e affini siano il concetto di uomo-individuo autocreatore e l’individuo come lo intende la logica capitalistico-liberale. Da queste somiglianze e affinità nasce una produttiva e possente alleanza, che ormai si traduce sul piano politico statale al più alto livello, come ostendono eventi pubblici clamorosi quali l’illuminazione della Casa Bianca con la luce arcobaleno per festeggiare la sentenza sul matrimonio same-sex della Corte Suprema, e di recentissimo, la luminaria con i colori della medesima cauda pavonis alchemica che accende gli stadi ove si giocano, alla presenza delle autorità, i campionati europei di calcio.
Ecco descritto, nei suoi tratti minimi essenziali, il salto di paradigma che si profila a un orizzonte non molto lontano. Le sue conseguenze sfidano l’immaginazione più esaltata. Anche perché, almeno a parere di chi scrive, questo salto di paradigma è un salto verso un concetto di uomo che, alla lettera, non esiste nella realtà: esso, infatti, non descrive la realtà, ma la prescrive; e tanto peggio per la realtà, se si ribella.
Ci si può impegnare, ed effettivamente ci si sta impegnando a fondo, per farlo esistere: ma non esiste ora, né potrà esistere mai. Via via che la prescrizione implicita in questo nuovo salto di paradigma sarà implementata, essa dovrà, con sempre maggior coerenza e caparbietà, derealizzare porzioni sempre più ampie di realtà: della realtà dell’uomo, e dunque della realtà del mondo.
Si tratta insomma – sempre a mio avviso – di un salto di paradigma che è anche un vero e proprio salto nel vuoto. Non so se abbiamo il paracadute.
That’ s all, folks.