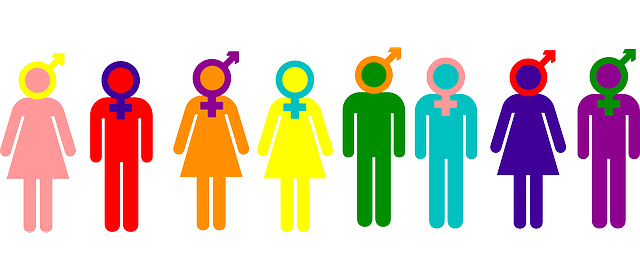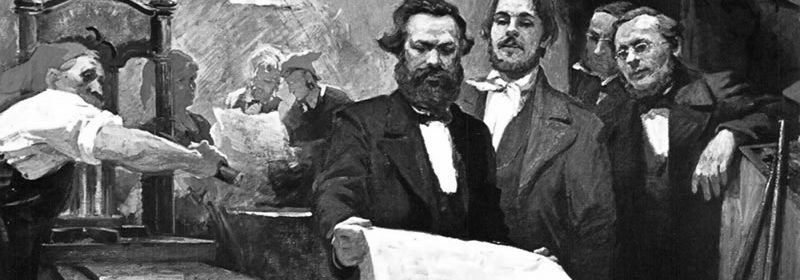Intervista a Gennaro Scala a cura di Luigi Tedeschi
1) Nella attuale transizione dal mondo unipolare a quello multipolare è d’obbligo interrogarsi sulla conformazione che assumerà il nuovo ordine mondiale. Con l’impero americano tramontano anche il suo sistema politico – economico e la sua legittimazione ideologica: l’universalismo globale neoliberista. Il falso universalismo americano (in quanto particolarismo assunto a valore universale), aveva soppiantato le narrazioni ideologiche universaliste dello storicismo novecentesco. Il primato globale americano ha abrogato i principi di Vestfalia, resuscitando dall’oblio della storia il concetto di “nemico assoluto”, quale legittimazione delle guerre americane come “guerre sante”, secondo la definizione di Danilo Zolo. La fine dell’ordine internazionale vestfaliano è stata efficacemente descritta da Giulio Sapelli: “L’Europa non riesce neppure a immaginare perché ha abbandonato – accompagnata ahimè dagli Usa – i principi di Vestfalia ed è ritornata alla disgrazia dei «wilsonismi» che miracolosamente si accesero – ma a che prezzo! – nel primo dopoguerra. Come una malattia infettiva, li vediamo risorgere dopo l’intermezzo del dominio intellettuale kissingeriano della diplomazia. Il suo posto è stato preso dagli avversari di Machiavelli e dai seguaci di Leo Strauss, tanto eroico moralmente quanto inetto e catastrofico intellettualmente. E quando un personaggio simile guida la storia c’è veramente da temere”. Senza principi universalisti, la ragion di stato degenera in volontà di potenza. Uno stato assurge al rango di potenza nel consesso di altre potenze, secondo parametri prefissati. Non è errato concepire il multilateralismo come negazione dell’universalismo (vedi Dugin), dato che ogni soggetto internazionale trae riconoscimento in base a valori universalmente riconosciuti in un contesto mondiale? Non è quindi necessario che un nuovo ordine mondiale sia strutturato sulla base di un pluriverso multilaterale ispirato ad un universalismo (certamente ancora tutto da definire), dato che, come afferma Lucio Caracciolo “la potenza assoluta è impossibile”?
La questione dell’universalismo è cruciale. Oggi è all’orizzonte il fallimento dell’universalismo occidentale «liberale», qualche decennio fa abbiamo visto il fallimento dell’universalismo comunista sovietico. Capire il fallimento del secondo aiuta a capire il fallimento del primo, anche perché in un certo qual modo i due universalismi si sorreggevano a vicenda. Nel mio libro Per un nuovo socialismo ho cercato di descrivere come l’ideologia marxiana si struttura come un universalismo alternativo a quello inglese, ma ne mutua la caratteristica di fondo di essere appunto un universalismo, lo stesso Marx era sostanzialmente favorevole all’imperialismo inglese, pur criticandone in varie occasioni la barbarie, perché avrebbe creato dappertutto le condizioni per la rivoluzione comunista che doveva essere globale, come globale era l’espansione inglese. Questo universalismo si rivelava funzionale all’Unione Sovietica del dopoguerra perché era una sfida globale all’influenza globale del sistema americano. Il comunismo fu un’ideologia universalista che faceva presa al di fuori dell’Unione Sovietica, influente anche in paesi del campo occidentale come l’Italia, la Francia, e che ebbe un ruolo importante nei movimenti di liberazione coloniale del dopoguerra.
Tuttavia, l’universalismo comunista sovietico subisce uno scacco con l’ascesa della potenza cinese. Per quel che ne so, è stato poco studiato il ruolo avuto dal quasi conflitto russo-cinese nella crisi e successivo crollo del sistema sovietico, secondo me fu decisivo. I cinesi rifiutarono la dottrina Breznev di ingerenza nei paesi appartenenti al campo dell’influenza sovietica ed arrivarono nel 1969 ad un quasi conflitto con la Russia. Sebbene la Cina non facesse parte del Patto di Varsavia, essa era considerata un paese «fratello», ma comunque subordinato al «paese guida» del comunismo mondiale. Questo era evidentemente incompatibile con l’aspirazione all’autonomia della Cina che allora iniziava la sua ascesa. Successivamente, nel 1971, ci fu il viaggio di Kissinger in Cina, e iniziava allora quel rapporto speciale degli Usa con la Cina che secondo Arrighi fu il modo in cui gli Usa superarono la crisi di accumulazione degli anni ‘70, ma che fu anche crisi politica del sistema globale degli Usa (sconfitta in Vietnam). Portare la Cina nel proprio campo fu un grosso colpo per l’Unione Sovietica e una vittoria per gli Usa che invertirono un trend negativo, ma si ponevano le basi per l’ascesa della potenza cinese, attualmente il principale avversario degli Usa. Diciamo che la Cina è stato il grosso scoglio contro cui si sono infranti sia il globalismo sovietico sovietico che quello liberale.
I limiti dell’ideologia universalista sovietica, inoltre, sono venuti alla luce con la guerra in Ucraina. Credo che avesse ragione Putin quando ricordava, in un discorso del 21 Febbraio 2022, che l’Ucraina fu una creazione leniniana e «ora “discendenti riconoscenti” hanno demolito e demoliscono i monumenti a Lenin in Ucraina». Si narra che Kruscev abbia regalato la Crimea all’Ucraina una sera in cui era ubriaco, probabilmente si tratta di un aneddoto, ma da un’idea della leggerezza con cui si diede corpo a questa entità statale chiamata Ucraina. Nel dopoguerra i sovietici mescolarono città e aree abitate da popolazione non solo russofone ma di etnia russa, nonché regioni come la Crimea che sono strategiche e irrinunciabili per la potenza russa, con popolazioni come quelle che vivono nella Galizia, una volta appartenente all’impero austro-ungarico, che non sono di cultura russa, e in essa non si riconoscono, e che accolsero con favore l’invasione nazista. In questa area nacque l’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini, filo-nazista, guidata da Bandera, la cui eredità, coltivata dai servizi segreti statunitensi, è continuata nell’Ucraina del dopoguerra, dando vita ad organizzazioni neo-naziste come Svoboda e Pravy Sector, che hanno giocato un certo ruolo nel colpo di stato di Maidan, e quale braccio armato dei settori più favorevoli al conflitto con la Russia.
Possiamo dire che la presenza di un nemico come l’Urss ha reso la politica estera statunitense più realistica. Kissinger, ma anche altri importanti esponenti come Kagan, avevano un’attenta considerazione dei rapporti di forza e studiavano attentamente la realtà delle altre nazioni e del loro principale avversario, l’Urss, mentre l’attuale ideologia «liberale» secondo la descrizione di John Mearsheimer, pretende di dar forma ad un mondo che non si preoccupa di studiare e conoscere.
Tra gli ispiratori di questo tipo di ideologia vi sarebbe appunto Leo Strauss, considerato filosofo guida dei neocon. Personalmente, non conosco la sua filosofia, quindi mi mantengo su delle considerazioni di carattere generico. Mearsheimer, in un testo in cui mostra il carattere irrealistico e illusorio dell’«ideologia liberale» riporta una citazione di Strauss, secondo cui «the more we cultivate reason, the more we cultivate nihilism: the less are we able to be loyal members of society.» In pratica l’esito della filosofia sarebbe nichilistico, con essa si raggiunge la consapevolezza che non esiste nessuna verità. Mentre Nietzsche lo dice apertamente, Strauss nasconde questa verità dell’assenza di verità (il che sarebbe pur sempre l’affermazione una verità, contraddizione classica del relativismo, ma non ci formalizziamo…). Il filosofo sarebbe colui che è consapevole dell’impossibilità di affermare delle verità su ciò che è bene e male, ma questa verità la possono sopportare solo pochi eletti, per cui bisogna essere disposti a raccontare a fini pratici ai «semplici» le platoniane «nobili bugie» sul bene e male.
Sarebbe interessante approfondire il ruolo di Strauss, non è quello che intendo fare in questa occasione. Da quanto detto possiamo invece trarre delle indicazioni sulle caratteristiche specifiche dell’ideologia dell’«esportazione della democrazia» che ha dominato il periodo della cosiddetta globalizzazione, il suo carattere sostanzialmente irrealistico (fortemente sottolineato da Mearsheimer), e nichilistico, l’idea che non esista una realtà di cui tener conto, ma di poter dar forma al mondo secondo i propri «principi», a cui tra l’altro neanche si crede. È una forma di «volontà di potenza», intendendo con questo termine non la ricerca della potenza, ma una caratteristica della cultura occidentale descritta da Heidegger, ma non solo, l’analisi di Agamben riguardante la nascita di un nuovo concetto di volontà con il creazionismo cristiano, costituisce un rilevante contributo nella più precisa definizione del termine. Ne ho scritto nel mio lavoro sull’Ulisse dantesco, in cui ho cercato di mostrare la precoce e geniale identificazione dantesca di ciò che oggi chiamiamo volontà di potenza.
Per Heidegger la volontà di potenza nicciana è solo il compimento di un lungo percorso della cultura europea-occidentale, non riguarda la sola Germania, e lo stesso Nietzsche non è altro che la sua espressione più rappresentativa. Possiamo dire che l’ideologia dell’«esportazione della democrazia e dei diritti umani» è in continuità con l’espansionismo globale europeo, ne ha raccolto l’eredità. Il «cattivismo» nicciano, intendeva invertire la decadenza che ha origine dall’aver posto da parte di Platone il valore nel bene, e nella successiva creazione di un Dio buono, rovesciando il discorso platonico, ma restando sempre nel suo ambito, come osserva Heidegger, poiché anche quello di Nietzsche è un discorso di carattere morale, anche se di una morale «inaudita» che assume al contrario di quella platonica il valore del male, cioè la morale barbarica della «bestia bionda» capace di commettere a cuor leggero le peggiori stragi, una violenza necessaria per invertire la decadenza dell’Europa e ristabilire la sua supremazia.
Con l’ideologia dell’«esportazione della democrazia e dei diritti umani» il valore torna ad essere posto nel bene (qualcuno ha definito gli Usa «l’impero del bene»), l’origine del ben noto e irritante «buonismo» che ha imperversato nel discorso pubblico, ma si tratta delle fandonie moralistiche che è necessario raccontare alla plebe, poiché il fine reale è l’affermazione degli Usa quale unica potenza mondiale. Siamo sempre nell’ambito della volontà di potenza per i connotati del nichilismo, dell’irrealismo e del soggettivismo che sorreggono un espansionismo senza limiti, una volontà di potenza che incontra il suo limite nella presenza di altre «volontà di potenza», di cui una prassi politica che non voglia essere fallimentare deve tener conto. Questo soggettivismo è stato favorito dal fatto che per un certo periodo gli Usa potevano effettivamente considerarsi come l’unica potenza mondiale, ma ciò non significava che potevano modellare il mondo a proprio piacimento.
Di solito si sottolinea il ruolo dei neocon (abbreviazione di neo-conservatori) nel promuovere l’interventismo statunitense, tuttavia, si tratterebbe di un conservatorismo differente da ciò che intendiamo in Europa con questo termine. Di loro, i neocon ci hanno messo l’interventismo, ma ciò che è stato «esportato» con le guerre statunitensi degli anni della «globalizzazione», sia dai democratici che dai repubblicani, sono stati i «valori liberali» della democrazia e dei diritti umani, naturalmente deprivati di ogni significato reale, poiché democrazia e diritti umani non si esportano a suon di bombe, ma queste erano le «noble lies» da raccontare alla popolazione perché il fine reale difendere il bene superiore dell’affermazione degli Usa quale unica potenza mondiale. La devastazione dell’Iraq fu il culmine delle guerre «vittoriose» degli Usa, dimostrazione della grande potenza degli Usa nel «riportare all’età della pietra gli stati canaglia» (Bush), esercitata contro nazioni incapaci di opporre difesa alla supremazia tecnico-militare degli Usa, ma disastrose sul piano dell’influenza statunitense nel mondo, a detta dello stesso Mearsheimer, contrario alla guerra in Iraq, fortemente voluta dai «neocon», nei quali un ruolo non trascurabile aveva la lobby ebraica e la politica israeliana che principalmente volle questa guerra.
L’ideologia dell’esportazione della democrazia e dei diritti umani, che ha retto la politica estera degli Usa negli anni della «globalizzazione», è stata una forma di volontà di potenza. La menzogna dei «bombardamenti umanitari» poteva avere corso soltanto su un nichilismo che comporta uno svuotamento del significato stesso del linguaggio. Ad un tale livello di menzogna la comunicazione stessa perde significato, un nichilismo che non è solo dei neocon, ma che è diventato proprio della cultura statunitense e occidentale, come ben messo in luce da Todd nel suo libro sulla «disfatta dell’Occidente». Le balle raccontate durante le guerre per «l’esportazione della democrazia» (ricordiamo Powell con la provetta in mano che provava la presenza di armi chimiche in Iraq) segnava un decadimento del sistema dei media, che è continuato ad ha raggiunto nuovi livelli con la guerra contro la Russia. Marco Travaglio in qualche suo articolo ha fatto la raccolta delle balle stratosferiche che sono state pubblicate sui media dopo l’inizio della guerra in Ucraina. È qualcosa che va oltre la propaganda, è una forma di auto-intossicazione di un sistema che ha perso il contatto con la realtà. Media, riviste, giornalisti, intellettuali non hanno solo la funzione di indottrinare la popolazione, ma devono anche correggere con «l’esame di realtà» la politica dei propri governi. Questa funzione ormai è svolta da pochissimi confinati in piccole nicchie che ancora vengono concesse in internet (ma sottoposte ad una censura sempre incombente), lo stesso Mearsheimer, che non è certo un sovversivo, ma uno che ragiona nell’ottica della difesa della potenza statunitense, non viene più pubblicato su quotidiani e riviste di grande tiratura, ma deve limitarsi agli articoli pubblicati sul proprio blog e alle interviste pubblicate su youtube, come un «influencer» qualsiasi.
Giulio Sapelli auspica in un’intervista che si possa abbandonare la «teoria anti-realista neocon degli allievi di Leo Strauss, e tornare alla teoria e pratica realista in politica estera». Certo, la politica kissingeriana era più realistica, anche per la presenza di un nemico reale, e non alquanto fittizio e creato ad arte come il «terrorismo islamico» non certo in grado neanche di scalfire la potenza statunitense, tuttavia gli esponenti attuali di questo realismo come Mearsheimer criticano il carattere fallimentare della politica estera statunitense, ma perché incapace di mantenere la supremazia statunitense, concentrandosi sul compito di contenere la Cina. Bisognerà vedere cosa si intende con l’obiettivo di contenere la Cina, se ciò comporterà prima o poi una guerra, e che tipo di guerra, con la Cina.
Il globalismo statunitense è erede della lunga storia del globalismo europeo, soprattutto nella fase dell’egemonia inglese. Frenato dalla presenza dell’Unione Sovietica, è emerso solo in forma aperta con il crollo dell’Urss, sfociando in aperta volontà di potenza. Una inversione di rotta rispetto a questa storia non avverrà senza conflitti, tanto esterni, quanto interni, essendo una caratteristica di sistema, comporterebbe un cambiamento di sistema. Tuttavia, io credo che dopo un periodo di conflitti, sarebbe possibile giungere ad un assetto multipolare fatto di un mondo suddiviso in zone, occupate da diverse civiltà. In fondo, questa è stata la realtà del mondo prima del balzo in avanti sul piano dell’organizzazione sociale e della tecnica militare della civiltà europea rispetto alle altre civiltà che l’ha proiettata in tutto il mondo, abbattendo le muraglie cinesi e trascinando le altre civiltà nel «progresso» (per dirla con il Manifesto di Marx ed Engels). Varie specie animali sono territoriali, ad es. i branchi di lupi che si suddividono il territorio, ogni branco evita di muoversi in quello degli altri, per evitare dannose contese. Dovrebbero esserne capaci anche gli esseri umani.
Un cambiamento di rotta si impone ora che l’«Occidente» si trova di fronte delle potenze reali capaci di resistergli, a meno che non voglia abbattere potenze quali la Cina o la Russia, ma quest’ultima ha già chiarito che in caso di minaccia esistenziale verranno usate le armi atomiche. Fa parte della dottrina politica-militare ufficiale (non credo che facciano tanto per dire). Per quanto personalmente sia critico della politica occidentale, non sono né filo-russo, né filo-cinese, appartengo pur sempre alla cultura europea, di cui l’Italia fa parte, anche se non si sa più bene in cosa consiste questa appartenenza, quale sia la nostra identità, credo però che queste potenze esistano, non solo la Cina e la Russia, non dimentichiamo l’India, la Turchia, l’Iran. Sarà necessario e legittimo contendersi degli spazi con loro. E’ impossibile, invece, tornare ad un mondo in cui l’Occidente sia la sola potenza dominante. Ma fare i conti con questa realtà del mondo non sarà per noi facile.
Ritengo Dugin una figura molto rappresentativa, in quanto espressione dell’importanza del fattore dell’identità culturale, innegabile, come ci dice il fatto che le potenze che si oppongono al globalismo statunitense sono tutte eredi di grandi civiltà storiche, ma si tratta di un’estremizzazione in senso opposto di ciò che mancava all’ideologia sovietica comunista, quale forma di universalismo. Significativa la sua visione della storia come «noomachia», ovvero come la lotta tra diversi Nous (il termine greco con cui si intende mente, intelletto, coscienza) che sarebbero all’origine delle diverse culture (che si concretizza in un progetto editoriale di una ventina di volumi con cui si intende analizzare il Nous di svariati popoli). L’identità culturale è cruciale, ma è un errore questa ipostatizzazione che la personifica in un Nous, specifico per ogni popolo, determinato dal conflitto tra diversi Logos (quello di Dioniso, di Apollo, indicati da Nietzsche, e quello di Cibele «scoperto» da Dugin). La cultura (intesa nel senso di civiltà) è un fattore cruciale che si conserva nel tempo, ma si conserva nell’incontro-scontro con altre culture-civiltà. È un fuoco che va continuamente alimentato, e non è culto delle ceneri, per dirlo con una famosa massima. Per alimentare questo fuoco è necessario il confronto con un altre cultura-civiltà, pur correndo il rischio del conflitto. Proprio per diversificarsi ogni cultura ha bisogno di un terreno comune con le altre culture, costituito dalla comune appartenenza al genere umano. Il rischio, nel caso di Dugin, è di considerare chiusa in se stessa ogni cultura-civiltà, personificata, mitologizzata e ipostatizzata in Nous, e che dal giusto rifiuto del falso universalismo, si ricada nel particolarismo che ignora la comune appartenenza al genere umano.
Sono d’accordo, è necessario ricercare una nuova forma di universalismo. Va trovato un terreno comune di comunicazione tra le varie culture, anche nel conflitto, anzi soprattutto nel conflitto, perché non degeneri in conflitto distruttivo per tutte le parti in lotta.
Per questo di grande utilità resta il comunitarismo di Costanzo Preve, che possiamo considerare principalmente come una forma di critica all’universalismo comunista. Quando scriveva Preve, durante il periodo della globalizzazione, guardava soprattutto agli Stati quali principale fattore di resistenza comunitaria al rullo compressore della globalizzazione statunitense. Ora che la Cina e anche la stessa Russia si autodefiniscono come «stati-civiltà» (ne parleremo meglio più avanti), dobbiamo andare oltre alla classica «questione nazionale» su cui tanto hanno dibattuto nel movimento comunista, considerandola all’interno dell’identità culturale, che possiamo considerare come uno dei passaggi comunitari fondamentali e ineliminabili tra l’individuo e il genere.
Respingendo l’accusa di «localismo», con cui si vuole intendere particolarismo, anti-universalismo, scriveva Preve in Elogio del comunitarismo:
«Il comunitarismo, così come ho cercato di delinearlo, resta la via maestra all’universalismo reale, intendendo per universalismo non un insieme di prescrizioni dogmatiche “universali”, ma un campo dialogico di confronto fra comunità unite dai caratteri essenziali del genere umano, della socialità e della razionalità. Quando si parla di universalismo, infatti, non si deve pensare a un insieme di prescrizioni, bensì a un campo dialogico costituito da dialoganti che hanno imparato a capire le lingue degli altri, anche se forse non le parlano con un accento perfetto.»
Singolare che l’accusa di localismo sia ripresa da Mimmo Porcaro in una nuova edizione di Elogio del comunitarismo (per la casa editrice casa editrice Inschibboleth, che comprende inoltre un testo inedito di Preve sempre sul comunitarismo), il quale evidentemente non ha ben compreso il testo previano di cui ha scritto la prefazione. Porcaro, da quanto scrive, mi sembra che sia un nostalgico dell’universalismo comunista, invece Preve prese atto del fallimento del comunismo storico e cercò di correggerne il difetto fondamentale a partire appunto da questa forma di universalismo che non aveva retto alla prova della storia.
Dopo il fallimento dei falsi universalismi, ritrovare la strada dell’universalismo autentico non è solo qualcosa di auspicabile, ma direi addirittura necessario proprio oggi in cui il conflitto tra le varie potenze appare come inevitabile, se non vogliamo che questo conflitto degeneri in scontro frontale con le inevitabili immani conseguenze. Potrà apparire paradossale, ma proprio il conflitto rende necessario a trovare un linguaggio e regole comuni (un «campo dialogico» come scrive Preve) per regolare questo conflitto. Esso passa per un universalismo che non oblitera le identità nazionali e quella forma di identità culturale di lungo periodo rappresentata dalle civiltà storiche.
2) L’ordine mondiale unilaterale americano scaturito dalla dissoluzione dell’URSS, è ormai in fase di avanzata decadenza. Le cause del suo conclamato fallimento sono evidenti: alla fine del bipolarismo USA – URSS, non ha fatto seguito una nuova Yalta, cioè un nuovo equilibrio internazionale. L’autoreferenza dell’unica superpotenza superstite, ha fatto venire meno il necessario confronto dialettico tra i protagonisti nella geopolitica mondiale. E’ infatti dal confronto / scontro tra una pluralità di soggetti geopolitici, in cui ciascuno assimila dalla controparte avversaria gli elementi politico – culturali dell’altro, che si genera quella necessaria dialettica tra le parti che rende possibile l’instaurazione di un ordine internazionale. La geopolitica mondiale non si struttura dunque su questo processo dialogico / dialettico da cui scaturisce un equilibrio tra il pluriverso delle potenze mondiali? L’ordine / disordine unilaterale degli USA, non è fallito perché globale, ma non internazionale e fondato non su una filosofia della storia, ma sul presupposto ideologico astratto di concepire il suo avvento come la fine e/o il fine della storia, cioè l’ordine in cui la storia fosse giunta al suo definitivo compimento sia nei suoi cicli temporali che nella sue finalità ultime?
L’ordine di Yalta seguì alla seconda guerra mondiale, in seguito al crollo di uno degli attori principali di questo ordine, non vi è stato un nuovo ordine, ma il tentativo degli Usa di affermarsi come unica potenza mondiale (la «globalizzazione»), il che in realtà ha accresciuto il disordine mondiale, tuttavia risulta già oggi chiaro che questi due decenni di «globalizzazione» sono stati un interregno, durante il quale vi è stata l’ascesa della potenza cinese, e il ritorno della potenza russa che si è spogliata della sua veste sovietica, nonché l’ascesa di altre potenze riunite sotto i cosiddetti Brics, che non è una vera e propria alleanza, ma riflette più o meno l’insieme delle nazioni che non si riconoscono nella subordinazione alla supremazia statunitense. Questo «nuovo mondo» è ancora agli inizi, anche se si è abbastanza già ben delineato, e una sua piena affermazione non avverrà senza conflitti, che sono già in corso, la guerra in Ucraina è già una guerra dell’«Occidente allargato» contro la Russia. Bisognerà fare in modo che tali conflitti non assumano la forma dello scontro diretto e frontale, come durante le due guerre mondiali, dato il tipo di armi oggi disponibili. Magari sarà una guerra strisciante che durerà decenni, «senza limiti» secondo il titolo di un significativo libro di due militari cinesi, ma senza limiti nel senso che investirà varie sfere, dall’azione bellica classica, così come investirà l’economia, la sfera culturale, le comunicazioni, internet ecc. Se invece prendesse la forma di un confronto militare diretto, quasi inevitabilmente comporterebbe l’utilizzo delle armi nucleari, e nessuno può immaginare cosa verrà dopo, anche se come ho già detto in altre occasioni non credo che sarà la fine dell’umanità (risvolto apocalittico della credenza nell’onnipotenza della Tecnica), ma di sicuro qualcosa di paragonabile ad un nuovo diluvio universale (per dirlo in termini biblici).
Comunque, credo che se ci sarà un nuovo ordine sarà solo al termine di questo conflitto appena iniziato. Sono convinto che un ordine multipolare sia possibile, ovvero il mondo suddiviso in grandi spazi, ognuno con un proprio ordine interno. Penso invece che chi crede che il multipolarismo sia solo una fase di passaggio conflittuale che vedrà il suo assestamento con la nascita di una nuova potenza egemone sia in errore, in quanto estrapola le dinamiche della storia europea che è stata fatta di tante «egemonie» (come descritto nella World-systems theory) e ne fa un modello universale. Credo che diverse potenze possano con-vivere sulla Terra definendo un proprio spazio, anche se poi sarà uno spazio variabile, con zone di influenza continuamente ridefinite, ma dal conflitto indiretto e limitato, perché oggi conflitto diretto tra due potenze significherebbe conflitto atomico.
3) L’unilateralismo americano si è imposto come unico modello economico, politico e culturale su scala globale. Mentre nell’ambito geopolitico il mondo americanocentrico, dopo rilevanti e ripetute sconfitte politico – militari degli USA sembra in via di dissoluzione, dal punto di vista culturale non sembra invece registrare sintomi di decadenza. L’americanismo si è diffuso a livello globale come stile di vita individualista, libertario e relativista dal punto di vista etico – morale, consumista ed economicista nella vita sociale e radicato nel pensiero unico nelle espressioni artistico – culturali della società. L’americanismo è stato inoltre supportato dal progresso tecnologico dell’era digitale, che ha profondamente inciso sulla psicologia delle masse, contribuendo massicciamente allo sradicamento delle identità culturali specifiche dei popoli. Al tramonto dell’unilateralismo americano, non fa infatti riscontro anche la fine del modello socio – culturale americanista. Pertanto, non va delineandosi un mondo multipolare in cui l’americanismo potrebbe sopravvivere anche alla fine del primato americano? Come mai non si è finora sviluppata una contro – cultura anti – globalista alternativa al modello americanista? Perché alla omologazione cosmopolita americanista non si contrappone un multilateralismo, quale pluriverso della multiformità delle culture identitarie?
In effetti, l’egemonia occidentale ha lasciato il segno, quel certo modello di vita di cui parlavi si è affermato in tutto il mondo, favorito dal fatto paradossale che le altre civiltà proprio per difendersi dall’espansionismo occidentale ne hanno dovuto adottare alcuni aspetti. C’è da notare però che questo modello di vita è in profonda crisi proprio nel paese dominante. Dario Fabbri in una conferenza pubblica ha affrontato il tema della «depressione americana», intendendo propriamente il disagio psichico, la depressione che si ritiene abbia colpito un terzo della popolazione, insieme ad altri indici di disagio profondo, quali il tasso di suicidi (tre volte quelle europeo), il tasso di omicidi, le stragi di massa, l’obesità di massa. La «narrazione» di Fabbri, come al solito suggestiva, attribuiva la «depressione americana» alla crisi del ruolo americano nel mondo quale nazione che incarna una «missione speciale», ma non considerava l’incidenza dello stile di vita statunitense individualista e radicalmente anticomunitario, e in quanto tale contrario alla natura dell’essere umano quale essere sociale. Difficile negare che l’isolamento e lo svuotamento del contenuto della vita individuale che tale modo di vita comporta abbia un ruolo non trascurabile nel generare tale diffusione di un profondo disagio psichico e morale. Magari altre popolazioni del mondo, come quella cinese e anche russa, che da poco hanno potuto assaporare qualcosa del tanto agognato e propagandato «benessere» del consumismo occidentale, la casa con tutte le comodità, l’automobile, l’abbondanza di cibo (ma di dubbia qualità), le vacanze ecc.. inebriate dalla novità sono poco inclini a vederne gli aspetti negativi e anche distruttivi. Credo che anche su questo aspetto si giocherà il conflitto, se tra le varie potenze in competizione vi sarà chi riuscirà a creare un modello di vita che pur superando la povertà crei meno infelicità rispetto all’american way of life, meno individualista e più capace di includere la popolazione e darle un senso di appartenenza, avrà un’importante carta da giocare, potendosi proporre effettivamente come modello alternativo da seguire.
Credo che che in generale questa diffusione dello stile vita occidentale sia un fatto superficiale e transitorio. L’identità culturale continua ad essere presente, come testimonia la presenza stessa della Cina, della Russia, dell’India, dell’Iran, della Turchia, che sono eredi delle grandi civiltà storiche.
4) Con il fallimento dell’unilateralismo neoliberista americano, tornano di attualità le problematiche ideologiche e politiche novecentesche. Occorre dunque elaborare un bilancio storico dell’era del primato americano impostosi dall’implosione dell’URSS ai nostri giorni. Occorre innanzi tutto rilevare che tutti i mali che l’Occidente imputava al socialismo reale sovietico, quali l’egualitarismo, la struttura massificata della società, il dirigismo economico, il totalitarismo ideologico e politico, sembrano essere stati ereditati ed esasperati dal capitalismo globalista. L’egualitarismo è stato compiutamente realizzato dalla generalizzata proletarizzazione dei ceti medi, la massificazione su scala globale è conseguenza dell’imposizione di un unico modello economico – sociale fondato sulla produzione e sul consumo di massa, il dirigismo economico assumerà dimensioni globali con la rivoluzione digitale del Grande Reset, il pensiero unico scaturito dall’ideologismo liberale si impone mediaticamente come totalitarismo culturale e politico assoluto. Da tali considerazioni, non emerge che l’avvento del capitalismo globale non abbia rappresentato il superamento delle ideologie novecentesche, ma solo l’esasperazione dei loro aspetti più negativi? L’avvento di un nuovo ordine multilateralista non costituisce l’occasione storica per la riproposizione di quelle istanze di giustizia sociale, così come di quelle idealità utopiche che prefiguravano una umanità riconciliata, già patrimonio della cultura novecentesca? Altrimenti, non è largamente prevedibile il rischio che il nuovo ordine multilaterale possa tramutarsi in una competizione geopolitica tra capitalismi di dimensione non più globale ma continentale?
L’«egualitarismo» odierno lo definirei una forma di plebeizzazione (mi si passi il termine), che vede un vertice oligarchico con una plebe alla base, formata di una massa destrutturata e impoverita tanto sul piano materiale che culturale. Le diseguaglianze sono sul piano economico sono enormi, e stando ad una mappa mondiale del coefficiente di Gini che ritrovo su Wikipedia, la situazione è piuttosto simile negli Usa, in Cina e in Russia, che non incarnano dei «modelli alternativi» come erano una volta volevano essere l’Urss e il comunismo. C’è chi guarda alla Cina e alle sue «grandi capacità di sviluppo», anche se può essere nient’altro che una forma accelerata di industrializzazione che nei paesi occidentali c’è già stata. La Cina non sembra un modello granché alternativo al capitalismo occidentale, anche se io credo che si tratti comunque di un sistema diverso che andrebbe studiato. Certo si può imparare da tutti, però non credo che risolveremo il nostro problema interno guardando alla Cina, dovremo risolverlo noi. Per questo, non mi interessa molto la diatriba se il sistema cinese sia o meno socialista. In Cina la politica sembra essere maggiormente alla guida rispetto all’occidente dove predomina l’economia, si tratta di un modello dirigista e meritocratico di ispirazione confuciana, che però gode di un consenso popolare di base dovuto alla capacità di far uscire un miliardo e passa di cinesi dalla povertà e di ridare dignità alla Cina quale grande civiltà storica. Ma è un modello che si basa su presupposti culturali differenti dai nostri, quindi difficile da importare. Credo che gli intellettuali comunisti come Carlo Formenti che sulla scorta dell’ultimo Arrighi guardano alla Cina come «sistema socialista» e potenziale nuovo egemone mondiale, e punto di riferimento per il rilancio del «socialismo», siano nostalgici di quell’universalismo che non avrà più ragion d’essere in un mondo multipolare che vedrà la presenza di diverse potenze, senza una potenza egemone a livello globale. La Cina non potrà essere un nuovo egemone mondiale come sono state le nazioni europee e gli Stati Uniti. Inoltre, credo che le nazioni europee, e l’Italia, per motivi geopolitici, economici e culturali debbano guardare più alla Russia che alla Cina. Esattamente il contrario di quanto sta avvenendo, sono stati infatti tagliati dei legami proficui di scambio che hanno peggiorato la nostra crisi economica. La completa subordinazione alla fallimentare politica statunitense testimonia il grave stato in cui versiamo, dovuto a classi politiche completamente inette e subordinate agli Usa.
Non vedo effettivamente grandi movimenti politici che vogliano far fronte allo stato di effettiva decadenza dell’Occidente palesatosi con la «prova di realtà della guerra», così ben descritto da Emanuel Todd nel suo libro sulla «disfatta dell’Occidente». Forse è questo il problema più grave, l’incapacità delle nazioni occidentali, soprattutto quelle europee, di affrontare un mondo in profonda trasformazione, come testimonia la volontà di proseguire una guerra già persa con la Russia, senza nessun obiettivo preciso se non quello di trascinare questa guerra per non voler prendere atto della sconfitta.
La definizione di un’identità europea risulta quasi impossibile, in quanto l’Europa è una civiltà che ormai appartiene al passato, che non ha saputo raggiungere una forma di unità interna, conclusasi con due guerre mondiali. Successivamente ci si è subordinati agli Usa, dando vita a questo non luogo chiamato Occidente, ma appare già come una soluzione di breve durata. Mentre è possibile immaginare che gli Usa, dopo un periodo di conflitti e crisi interna possano trovare un proprio modo di stare al mondo e convivere con le altre potenze, non riesco invece ad immaginare come possano farlo le nazioni europee, senza scivolare nel piano inclinato di un rapido declino. Da questo credo derivi la subordinazione e l’attaccamento cieco e disperato agli Usa, che rischia di far diventare le nazioni europee mero strumento della politica statunitense.
Accumulazione capitalistica e imperialismo, ovvero espansione senza limiti, a-territoriale e globale, nascono insieme, possiamo dire sono la stessa cosa. Ciò fu già ben compreso da Dante come ho cercato di mostrare nel mio saggio Il folle volo in Occidente. La tragicommedia di Ulisse. La prima accumulazione capitalistica della storia quella fiorentina, nella forma del capitale accumulato dalle famiglie dei Bardi e dei Peruzzi, finanziò, dal lato inglese, la «guerra dei cent’anni», la prima delle innumerevoli guerre interne europee. L’Italia comunale vede i primi vagiti di quella formazione sociale che chiamiamo “capitalismo” che in tappe successive ha visto un enorme sviluppo tecnico ed economico, e, allo stesso tempo, l’espansione in tutto il mondo alla ricerca di materie prime e mercati. Nel momento in cui tale espansione raggiunge i suoi limiti nella presenza di altre potenze, si impone un cambiamento di sistema, a partire dall’Occidente dove tale sistema sociale è nato e si è affermato.
L’impoverimento, la desertificazione, l’atomizzazione sociale, la devastazione culturale e la mancanza di prospettive dovute alla incapacità di adeguarsi ad un mondo che cambia, purtroppo da parte non solo delle classi dominanti, ma riguardanti il decadimento dell’intera collettività, sono le cause della mancanza di movimenti sociali, nonostante il continuo peggioramento delle condizioni di vita delle classi popolari, eccettuata la breve stagione del «populismo» che si è caratterizzato per la sua debolezza e inconsistenza.
Di fronte agli ulteriori e inevitabili shock vi sarà un’effettiva reazione collettiva, oppure prevarrà la presente incapacità di reagire? Lo sapremo solo vivendo, per dirla con Lucio Battisti.
5) Al primato unilaterale americano ha corrisposto l’espandersi a livello globale di un nuovo modello neoliberista in cui l’economia finanziaria prevale sull’economia della produzione industriale. Pertanto, con il venir meno del primato dell’industrialismo, è scomparsa anche la dicotomia borghesia / proletariato e con essa la dialettica della lotta di classe. Sembra tuttavia che nella struttura elitaria verticalizzata della società neoliberista, estesa su scala globale, si siano riprodotti i presupposti rivoluzionari del materialismo storico – dialettico della filosofia di Marx. Tale prospettiva è ben delineata in un saggio di Flores Tovo dal titolo “Considerazioni sul presente storico”: “C’è un fatto tuttavia che bisogna sottolineare, ossia che il negletto e vituperato Marx, sembra che abbia avuto ragione nella sua analisi sul capitalismo proprio nei giorni nostri. I presupposti concreti e reali per attuare una rivoluzione anticapitalista si sono tutti realizzati. La concentrazione del potere finanziario è in mano a poche decine di persone; la socializzazione del lavoro con il macchinismo automatico è stato imposto (il “Gestell” heideggeriano) in tutti i settori delle società; l’altro grado di sviluppo tecnico ha comportato l’avvento dell’automazione; i ceti medi, sia quelli nuovi, che quelli tradizionali stanno scomparendo, per cui la proletarizzazione è un fatto compiuto. Infine l’impoverimento delle masse sta avanzando sempre più a livello mondiale”. Aggiungasi inoltre che l’attuale capitalismo è in una fase di declino irreversibile in quanto esso può sussistere artificialmente solo mediante incessanti emissioni di liquidità e tassi a zero, salvo poi generare inflazione e gravi crisi del debito. Non si sta inverando dunque, la previsione marxiana secondo cui il capitalismo sarebbe collassato per l’incapacità di generare forze produttive? Non dunque configurabile l’avvento del multilateralismo, come l’esito di una lotta di classe instauratasi nel contesto geopolitico globale tra Nord (USA e Occidente – classe dominante) e Sud del mondo (gruppo del BRICS e paesi terzi – classe dominata), che comporti la crisi e il collasso del capitalismo?
Sicuramente, abbiamo ancora noi oggi, eufemisticamente, un problema con il Capitale, e in questo senso l’analisi marxiana resta indispensabile, come giustamente scrive Tovo, ma proprio per recuperarne quanto è ancora valido è necessaria la previana «correzione comunitaria» di quella forma di universalismo storicamente fallimentare che apparteneva tanto a Marx quanto al comunismo storico. Credo che vada abbandonata la prospettiva del comunismo quale utopia globalista, ma conservato il socialismo quale forma di ripristino del controllo della politica sul potere del Capitale, in forme nuove che sono tutte da ripensare.
Nel mio libro Per un nuovo socialismo ho proposto un diverso modello di spiegazione delle rivoluzioni storiche, quali forme di ristrutturazione interna dovuta al conflitto esterno, nel caso della Francia come ristrutturazione della struttura statale, e relativo esercito (l’introduzione della leva di massa fu un’innovazione decisiva introdotta dalla Rivoluzione francese), per vincere il conflitto con l’Inghilterra, nel caso della rivoluzione russa come forma di modernizzazione per affrontare il pericolo dell’espansione europea, concretizzatasi con l’invasione nazista. In generale, le rivoluzioni (ovvero le forme più o meno profonde di ristrutturazione interna di una società), sono un portato della guerra. Se guardiamo all’esperienza storica guerra e rivoluzione viaggiano insieme. Nel caso l’attuale oligarchia dominante in Occidente, che ha devastato le sue stesse società, che versano in uno stato di effettiva decadenza (secondo il quadro complessivo che ha delineato Todd), dovesse subire una sconfitta nella guerra appena iniziata, potrebbe avere «seri problemi» interni. Già qualche segno si vede negli Stati Uniti.
6) La contrapposizione tra unilateralismo americano e multilateralismo è sorta sulla base delle rivendicazioni identitarie da parte dei paesi non allineati con l’Occidente, spesso identificati dalla potenza americana come “nemico assoluto” o “stati canaglia”. Al dissolversi dell’unilateralismo americano e delle sue pretese di occidentalizzazione del mondo, potrebbe dunque subentrare, non ad una comunità geopolitica mondiale formata da imperi continentali, ma ad una frantumazione del mondo in tante piccole potenze conflittuali sorte su base etnico – regionale. Tale fenomeno è già in atto e rappresenta una delle contraddizioni più evidenti prodotte da un processo di globalizzazione che, oltre ad omogeneizzare il mondo, secondo le sue premesse ideologiche, ha generato innumerevoli frammentazioni e conflitti tra nazioni e/o etnie la cui identità si richiama ad origini mitico – storiche spesso assai labili. Tale processo di disgregazione, ha condotto alla progressiva erosione della coesione interna degli stati nazionali. Il multilateralismo dunque, non potrebbe degenerare in una “Caoslandia” geopolitica globale da cui non scaturirà un nuovo ordine mondiale, ma bensì un bellum omnium contra omnes incontrollabile e senza soluzioni di continuità? Non a caso, i principali attori geopolitici dei BRICS non sono gli stati nazionali, ma la Cina, la Russia, l’India, l’Iran, quegli “stati – civiltà” eredi degli antichi imperi multinazionali?
Credo che le potenze che si oppongono all’egemonia statunitense non mostrino grandi problemi interni. La Russia ha dimostrato la sua coesione interna con la guerra in Ucraina, l’eredità del suo sistema imperiale funziona, le popolazioni di cultura islamica presenti al suo interno dopo la conclusione delle guerre in Cecenia, non creano più grossi problemi, anzi i ceceni hanno combattuto in Ucraina e per un certo periodo, all’inizio della guerra, hanno avuto anche un certo protagonismo. Grandi problemi interni non hanno la Cina e l’Iran. I processi di disgregazione sembrano esservi maggiormente laddove non vi è una potenza che faccia da centro ordinatore. La rivista Limes ha individuato una grande fascia del mondo chiamata «caoslandia» afflitta dalla conflittualità di cui parlavi. Vi è il grande problema della civiltà arabo-islamica che non è riuscita ad effettuare la modernizzazione necessaria per resistere all’espansionismo occidentale (diversa è la questione dell’Iran e della Turchia che si richiamano all’eredità di civiltà storiche ben definite). Così come è il caso dell’Africa che non è riuscita a sviluppare al proprio interno una potenza in grado di resistere alle potenze estere. In generale, in queste aree le conflittualità locali e la frammentazione sono alimentate da potenze esterne, soprattutto occidentali.
La questione degli stati-civiltà è di grande importanza. Così si autodefiniscono sia la Cina che la Russia. Vi è in merito un interessante libro di Zhang Weiwei sull’«ascesa della Cina come stato-civiltà», che sarebbe l’unico autentico stato-civiltà data la sua continuità millenaria, ma il termine è stato raccolto dallo stesso Putin che ha definito la stessa Russia uno «stato-civiltà». L’identità dovuta all’appartenenza ad una comune civiltà, è diversa dall’identità etnica, in quanto diverse etnie o anche Stati con diverse lingue, culture, e religioni possono riconoscersi nella appartenenza ad una comune cultura-civiltà. Sulla questione della civiltà vi è un’ampia tradizione di studi che fanno capo a Braudel, ma di grande interesse restano, secondo me, le intuizioni di un grande storico come Toynbee, anche il testo di Huntington sullo «scontro di civiltà» non è da buttare, perché contiene un riconoscimento dell’importanza del fattore cultura-civiltà, nonostante l’uso strumentale che ne ha fatto una certa destra per affermare l’esistenza di un inesistente «pericolo islamico».
Il motivo per cui viene valorizzato il fattore dell’identità della cultura-civiltà è dovuto alla sua rilevanza storica, visto che appunto la Russia, la Cina, l’Iran, l’India, la Turchia sono eredi delle civiltà storiche, valorizzare questa identità ha, inoltre, un valore strategico a lungo termine perché invece l’Occidente la propria identità l’ha smarrita.
Gli stati-civiltà non sono semplicemente il ritorno degli antichi imperi (come scrive Christopher Coker in un libro dedicato agli «stati-civiltà», ma senza realmente prendere sul serio l’argomento, perché, si sa, l’unica vera civiltà è quella occidentale), ma sono gli imperi del passato che hanno attraversato la pressione modernizzatrice dell’espansionismo occidentale. Hanno delle caratteristiche dello stato moderno (non sono retti dall’imperatore, dallo zar, dal sultano o dallo scià), ma conservano delle caratteristiche degli imperi di cui sono eredi. In generale, ritengo che questa eredità imperiale non ha i limiti dello stato-nazione classico europeo, a cui è necessaria una certa omogeneità culturale, e sia maggiormente efficace nel gestire i «grandi spazi» raccogliendo al proprio interno diverse etnie, identità religiose e culturali, assegnandogli un proprio territorio. Mentre il multiculturalismo occidentale realizza un melting pot, un minestrone frullato di diverse identità, che devono convivere nello stesso spazio, che nei periodi di crisi può diventare esplosivo. Il cosiddetto multiculturalismo occidentale è in realtà un distruttore nichilistico delle identità culturali sia della propria che di quella altrui.
In generale, credo che gli «stati-civiltà» siano una nuova formazione storica rispetto allo «stato-nazione» europeo, che andrebbe studiata attentamente.
7) Dal tramonto del primato dell’unilateralismo americano, emerge una chiara e definitiva confutazione dell’ideologia della «fine della storia» di Francis Fukuyama, che aveva inaugurato l’era della globalizzazione capitalista all’indomani della dissoluzione dell’URSS. La storia dunque non è mai un processo compiuto, ma un continuo divenire dagli esiti imprevedibili. Questa rivincita della storia sulla post – storia comporterà un profondo riorientamento della geopolitica globale. Se dunque all’unipolarismo americano subentrerà il multipolarismo, non dovrà essere necessariamente instaurato un nuovo ordine mondiale in cui il primato dei diritti individuali cederà il passo a quello dei diritti collettivi? Ai diritti dell’uomo non dovrebbero essere anteposti i diritti dei popoli in quanto il mondo multipolare è per definizione una struttura geopolitica comunitaria a livello mondiale? Gli stati sono i soggetti che costituiscono la comunità del mondo multipolare. Ma la concezione dello stato nazionale del ‘900, quale entità rappresentativa delle identità dei popoli è stata stravolta dall’avvento del cosmopolitismo globalista. Le identità dei popoli subiscono del resto trasformazioni nel corso della storia. L’identificazione poi della nazione con l’etnicità è un relitto astorico dei secoli passati. Afferma infatti a tal riguardo Alain de Benoist in una recente intervista: “La vera natura dell’uomo, è la sua cultura (Arnold Gehlen): la diversità delle lingue e delle culture deriva dalla capacità dell’uomo di affrancarsi dalle limitazioni della specie. Voler fondare la politica sulla bioantropologia equivale a fare della sociologia un’appendice della zoologia, e impedisce di comprendere che l’identità di un popolo è innanzitutto la sua storia”. Se quindi l’identità di un popolo coincide con la sua storia e la sua cultura, attualmente le culture identitarie, proprio perché scaturiscono da valori e periodi storici premoderni, sono trasversali agli stati. Assistiamo infatti al proliferare a livello mondiale di conflitti interni agli stati, a contrapposizioni insanabili tra opposte culture, visioni del mondo, che assumono di volta in volta carattere religioso, politico, culturale, sociale. Spaccature verticali della società con effetti destabilizzanti per gli stati, si manifestano ovunque nel mondo, (con particolare violenza proprio negli USA). Sembrano delinearsi due fronti contrapposti a livello globale, tra l’ideologismo liberal della modernità e le culture ispirate al comunitarismo identitario. Un nuovo ordine mondiale non scaturirà quindi da profonde trasformazioni storiche e geopolitiche globali che comporterebbero una guerra civile mondiale attualmente ancora a livello potenziale?
L’identità culturale è un fattore costitutivo della natura umana, sono d’accordo con de Benoist e in quanto tale si stabilisce differenziandosi dalle altre culture, per questo la diversità culturale è una ricchezza, una cultura omogenea per tutta l’umanità sarebbe un livellamento che comporterebbe la scomparsa di ogni cultura. L’identità culturale come fattore costitutivo della natura umana è implicita anche nel comunitarismo previano. La differenziazione culturale comporta il rischio del conflitto, diciamo che fa parte della vita, ma non necessariamente. Anche la costituzione di una famiglia possiamo dire fa parte della natura umana, ma l’attaccamento alla propria famiglia non comporta necessariamente l’odio per le famiglie altrui, anzi direi che essere soddisfatti della propria vita familiare rende più inclini ad apprezzare e rispettare le famiglie altrui. Ma avendo presente che però la famiglia assume forme diversissime, e a volte anche patologiche, come la «famiglia nucleare» occidentale che ha finito per distruggere l’idea di famiglia stessa, una delle cause delle patologie dell’individualismo occidentale. Lo stesso si può dire dell’identità culturale, anche in questo caso, l’autentico apprezzamento delle altre culture passa per il riconoscimento e l’attaccamento alla propria identità culturale.
Come dicevo precedentemente gli «stati-civiltà» sono maggiormente in grado di far fronte ai particolarismi identitari, che sono l’altra faccia del livellamento culturale indotto dalla globalizzazione, e allo stesso tempo alimentati e sfruttati dall’Occidente. Senza dubbio un nuovo ordine mondiale non si affermerà senza conflitti, e un effetto caotico pericoloso (una caoslandia, per dirla con quelli di Limes, in cui rischia di ricadere anche l’Italia) potranno averlo quelle forme di identità nazionale, etnica, culturale, religiosa che non sapranno a ricondursi a forme di identità a più ampio raggio e più lungo termine come l’appartenenza ad una comune civiltà.
8) Il nuovo ordine multilaterale non potrà che ripristinare i principi di Vestfalia. Si preannuncia allora un ritorno al ‘900? No, perché siamo in una fase storica che succede naturalmente al ‘900. L’ideologia astorica liberale sarà archiviata dai suoi stessi fallimenti. L’unilateralismo americano è infatti in coerente continuità storica con l’eurocentrismo anglosassone otto / novecentesco e ne rappresenta sua evoluzione in dimensioni globali. Esso si è rivelato incompatibile con la realtà storica perché geneticamente incapace di concepire l’ “altro” da sé. Ma l’avvento del multilateralismo comporterà anche la deglobalizzazione del mondo? In realtà le potenze emergenti del BRICS sono coinvolte nei processi evolutivi della globalizzazione, quali la rivoluzione digitale e la transizione green. Anzi, la Cina è destinata a svolgere un ruolo di protagonista nella quarta rivoluzione industriale. Ci si chiede pertanto, come sia concepibile un ordine multilaterale senza un profondo riorientamento dell’economia globale. Alla globalizzazione non dovrebbe subentrare la creazione di tante aree economiche integrate su scala continentale? Ma soprattutto, è concepibile un multilateralismo senza un processo di deglobalizzazione geopolitica e dedollarizzazione economica? Il multilateralismo infine, come svolta epocale, non si identifica con una deocidentalizzazione del mondo che prefiguri nuovo modello di sviluppo?
La «pace di Vestfalia» seguì alla conclusione della «guerra dei trent’anni», e alle devastanti guerre di religione e civili che insanguinarono l’Europa, allora le potenze europee convenirono sulla necessità di accordarsi su una forma di regolazione dei rapporti e di conflitti tra gli stati, questi accordi ancora osservati durante il periodo delle guerre napoleoniche, in cui ancora si rispettava il principio di non coinvolgere la popolazione civile, furono distrutti con l’affermarsi della «guerra totale» durante le due guerre mondiali, in cui la distruttività e l’assenza di regole nella condotta dei conflitti superarono ogni limite.
Un comportamento come quello degli Usa che hanno impiccato Saddam Hussein, ucciso e profanato il cadavere di Gheddafi, processato e fatto morire in carcere Milosevic, è un’eredità delle due guerre mondiali dove si è persa ogni regola nella condotta della guerra e si è passati dal justus hostis alla criminalizzazione del nemico, come osservava Zolo sulla scorta di Schmitt.. Questa eredità è così forte che appare quasi assurdo affermare che in guerra si debbano osservare delle regole, è noto il detto «in amore e in guerra tutto è lecito». Voglio invece affermare che questa è un’eredità di un preciso periodo storico, e che invece in guerra devono essere osservate delle regole.
Durante le ultime guerre statunitensi ogni volta il nemico ha subito una «redutio ad hitlerum», hitler-milosevic, hitler-saddam, Ma è stato il caso di quel periodo particolare della «globalizzazione» e si è esercitato contro nazioni incapaci di difendersi rispetto alla supremazia tecnica statunitense. Oggi gli Usa sono molto più riluttanti a lanciarsi in un intervento militare contro l’Iran, fortemente voluto da Israele, quale compimento del progetto di un «nuovo Medio Oriente» (Benjamin Netanyahu) che ora passa per la liquidazione prossima al genocidio della popolazione palestinese. Probabilmente il progetto incontrerebbe il favore anche dei vertici americani, se non sapessero che un attacco all’Iran non sarebbe quasi a costo zero (in termini di danni militari subiti). È finito il tempo delle «dimostrazioni di potenza» come è stato nel caso della Jugoslavia, dell’Iraq, della Libia, per non parlare della fallimentare, tanto costosa quanto inutile militarmente guerra in Afghanistan.
È fondamentale ritrovare il principio del justus hostis nel conflitto in corso. Ciò vuol dire che il conflitto inevitabile tra gli Usa e le potenze che gli si oppongono, non dovrà superare certi limiti, dovrà assumere la forma di una competizione legittima, in cui è assente la criminalizzazione del nemico. Come scriveva Schmitt ne Il nomos della terra i principi di Vestfalia con il passaggio dalla justa causa belli allo justus hostis resero possibile «il fatto stupefacente che per duecento anni in terra europea non ha avuto luogo una guerra di annientamento». Il conflitto con la Russia e la Cina non può assumere la forma della guerra di annientamento, in questo senso va sicuramente superata l’eredità delle due guerre mondiali ed è necessario il ritorno «principi di Vestfalia» estesi a livello globale. Magari cominciando con il porre fine alla sciocca retorica anti-putiniana.
Il carattere fallimentare delle guerre del periodo della «globalizzazione» sembra abbia reso più ragionevole la politica militare statunitense, resta da capire come gli Usa possano adeguarsi ad un mondo multipolare essendosi costituiti come sistema globale, sostenuto sia dalla «spada» delle basi militari sparse in tutto il globo, sia dall’«oro» del dominio del dollaro. La dimensione finanziaria è strettamente legata a quella militare, la perdita di influenza militare accresce la «de-dollarizzazione», questa a sua volta riduce gli strumenti finanziari per il mantenimento del sistema delle basi in tutto il mondo. È chiaro che la crisi di questo sistema proseguirà, e potrebbe arrivare in un arco di tempo non prevedibile a dei punti di rottura. Come l’Occidente a guida statunitense affronterà questa crisi non è possibile saperlo. Vi sarà il caos interno, di cui ci sono già molti segni? Vi sarà un colpo di testa nel tentativo di «risolvere» il problema annientando militarmente le potenze che si oppongono agli Usa? Ancora non si vedono le forze che possono avanzare l’unica soluzione del problema, cioè fine della globalizzazione finanziaria e drastica riduzione delle basi militari statunitensi nel mondo, re-industrializzazione e ricreazione di un mercato interno basato su una drastica riduzione delle diseguaglianze, in generale ritorno della politica al comando rispetto al «predominio dell’economia». Tale ultima soluzione passa necessariamente per la sconfitta delle attuali oligarchie dominanti, ma non si vedono al momento le forze politiche potenzialmente in grado di farlo.
Ritornare a fare la guerra come durante le due guerre mondiali avrebbe degli effetti apocalittici data l’entità delle potenze in gioco e la distruttività delle armi odierne. A osservare la guerra in Ucraina si direbbe che vi sia un tacito accordo sulla presenza di limiti («linee rosse») che non devono essere superati, la Russia ha voluto chiarire fin dall’inizio il carattere limitato della sua guerra (definita «operazione speciale»), l’«Occidente allargato» non interviene direttamente e non fornisce all’Ucraina armi con cui colpire direttamente il territorio russo. Reggeranno questi taciti accordi, si manterrà il principio che non bisogna superare certi limiti? Questo lo possiamo solo sperare, nonché diffondere in modo organizzato la consapevolezza della pericolosità del conflitto in corso, date le immani conseguenze seguenti al superamento di certi limiti. Ma, altra grave lacuna da registrare, è l’assenza, al momento, di un significativo movimento politico contro la guerra.
La «de-occidentalizzazione» la auspico, la chiamerei «de-globalizzazione» «de-universalizzazione» ovvero superamento del falso universalismo in cui è caduto l’«Occidente», auspico, in quanto italiano ed europeo, il ritrovamento di noi stessi, del rapporto con le nostre radici culturali, nella consapevolezza che la civiltà europea è crollata con le due guerre mondiali, e questo rende molto difficile ritrovare la nostra identità culturale che sarebbe tutta ri-costruire. Una massima di Goethe recita: «Tutto può perdere un uomo fin quando rimane se stesso». Trasposta a livello collettivo tale massima ci dice che l’identità culturale è il bene maggiore, quando viene smarrita si perde tutto. Abbiamo rinunciato alla nostra identità, ricevendone in cambio il «benessere», un termine ingannatore, perché non siamo diventati più felici, anzi è vero il contrario. Questo è il problema più difficile da affrontare, e riguarda principalmente le nazioni europee. Si spera che dato il fallimento della «globalizzazione» si segua un percorso diverso, ma siamo ancora gli inizi di una nuova era e si fatica a trovare la strada.
ll sito www.italiaeilmondo.com non fruisce di alcuna forma di finanziamento, nemmeno pubblicitaria. Tutte le spese sono a carico del redattore. Nel caso vogliate offrire un qualsiasi contributo, ecco le coordinate:
postepay evolution a nome di Giuseppe Germinario nr 5333171135855704 oppure iban IT30D3608105138261529861559 oppure PayPal.Me/italiaeilmondo
oppure https://it.tipeee.com/italiaeilmondo/
Su PayPal, Tipee, ma anche con il bonifico su PostePay, è possibile disporre eventualmente un pagamento a cadenza periodica, anche di minima entità, a partire da 2 (due) euro (pay pal prende una commissione di 0,52 centesimi)