Riportare tutto a casa, di AURELIEN
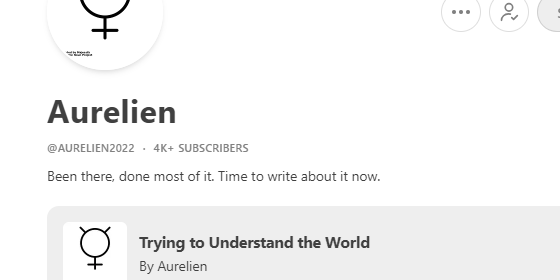
Riportare tutto a casa
Se non possiamo fare il mecenate laggiù, lo faremo qui.
Questi saggi saranno sempre gratuiti e potrete sostenere il mio lavoro mettendo un like, commentando e, soprattutto, trasmettendo i saggi ad altri e ad altri siti che frequentate.
Ho anche creato una pagina Buy Me A Coffee, che potete trovare qui.☕️ Grazie a tutti coloro che hanno già contribuito.
Grazie anche a coloro che continuano a fornire traduzioni. Le versioni in spagnolo sono disponibili qui, e alcune versioni italiane dei miei saggi sono disponibili qui. Anche Marco Zeloni sta pubblicando alcune traduzioni in italiano. Philippe Lerch ha gentilmente tradotto in francese un altro dei miei saggi (vedi ultima voce) che, a quanto vedo, sta già riscuotendo successo. Grazie Philippe.
Negli ultimi mesi, il malcontento di lunga data per le politiche migratorie dei governi occidentali, e soprattutto europei, si è fatto più acuto. I partiti che fanno dell’immigrazione un problema hanno ottenuto buoni risultati alle elezioni (da ultimo nei Paesi Bassi), i politici che prima tergiversavano sono costretti ad accettare che il problema (o i problemi) esistono davvero, e il problema si sta facendo strada nei media, nelle statistiche dei sondaggi d’opinione e si collega alle preoccupazioni per la crescente illegalità e violenza nelle città europee. Ma l’aspetto più sconcertante dell’intera situazione è che i governi, da cui ci si aspetterebbe che si accorgano di una causa politica popolare quando questa salta su e giù e agita le mani davanti a loro, si sono trovati in uno stato di catatonica negazione assoluta dell’esistenza di qualsiasi problema. Ecco quindi il tentativo di spiegare perché ritengo che ci sia un enorme divario tra i governanti e i governati.
Ed è un divario enorme. La cosa curiosa del “dibattito sull’immigrazione” è che si tratta di un non-dibattito, un dibattito che non deve avere luogo. Le grandi linee del dialogo dei sordi degli ultimi dieci anni circa possono essere schematizzate come segue:
Le persone: Per favore, qualcuno si accorga dei problemi causati dalla massiccia immigrazione dell’ultima generazione e faccia qualcosa.
Le élite. Non c’è nessun problema. Vergognatevi anche solo per aver suggerito che ci sia. Solo i nazisti vogliono parlare di immigrazione.
E non sto esagerando. L’immigrazione e i problemi che ne derivano sono diventati come uno di quegli argomenti di cui i miei genitori non volevano parlare quando ero giovane, perché “non era bello”. Leggete, ad esempio, questo magistrale resoconto dei retroscena dei recenti “disordini” di Dublino, pubblicato su Naked Capitalism da un residente e osservatore di lunga data. Oppure guardate la prosa e il ragionamento contorto di questo articolo del Grauniad sull’incredibile impennata dei crimini con armi da fuoco in Svezia, ora il Paese più pericoloso d’Europa ad eccezione dell’Albania, e che non ha nulla, assolutamente nulla, a che fare con l’immigrazione, anche se la violenza è in gran parte opera di bande di immigrati e ha luogo in aree ad alta penetrazione di immigrati. Si tratta invece di povertà e disuguaglianza che, come sappiamo, sono infinitamente peggiori in Svezia che, ad esempio, in Romania.
Dal punto di vista della politica pratica, questo è folle. Rifiutarsi di parlare di immigrazione non è una politica e, secondo il più cinico dei calcoli, lascia uno spazio aperto a coloro che sono pronti a pronunciare la parola e a suggerire che l’immigrazione ha prodotto problemi che devono essere affrontati dai governi. In Francia è diventato un luogo comune dire che i principali partiti politici non potrebbero fare di più per garantire la vittoria di Marine Le Pen alle elezioni del 2027 se ci provassero, ma questo non lo rende meno vero. Come si spiega allora il silenzio quasi suicida sull’argomento da parte dell’establishment occidentale? Vorrei fare una serie di proposte, dalle più banali a quelle estremamente tendenziose, e vedere cosa ne pensate.
In primo luogo, ovviamente, sarebbe necessario un grande sforzo. Bisognerebbe riconoscere gli errori, trovare i soldi, reclutare il personale, portare avanti la costruzione e così via. Soprattutto, qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità. È molto più facile, alla fine, lasciare che le cose continuino ad andare alla deriva, e lasciare che siano un problema di qualcun altro, potendo al contempo assumere una posizione moralmente superiore. Per i governi che non fanno più nulla, e anzi mancano sempre più della capacità di base di fare qualcosa, questa è praticamente la soluzione di default. Ma non credo che questo spieghi molto da solo. Dopo tutto, ai governi non costerebbe nulla riconoscere almeno l’esistenza di un problema, ma non lo fanno nemmeno. Anzi, sprecano capitale politico e danneggiano le loro prospettive politiche facendo il contrario. Cosa sta succedendo?
Forse può essere d’aiuto considerare la principale spiegazione che è stata avanzata per la volontà, o addirittura la smania, dei governi occidentali di adottare una politica di immigrazione di massa nell’ultima generazione o giù di lì. Non c’è bisogno di soffermarsi sull’invecchiamento della popolazione: l’alto tasso di disoccupazione tra le persone in età lavorativa significa che ci sono già molti lavoratori, e ce ne saranno anche nel prossimo futuro. È vero, naturalmente, che gli europei hanno storicamente richiesto cose come salari e condizioni di lavoro decenti, protezione dell’occupazione e così via, mentre gli immigrati, che non hanno scelta, di solito possono essere costretti ad accettare di peggio. Ma l’idea che l’immigrazione di massa fosse solo la ricerca di una forza lavoro flessibile e sfruttabile non regge.
Tanto per cominciare, anche se foste il tipico datore di lavoro avido e arraffone che cerca di risparmiare sui costi del personale, non vorreste almeno una forza lavoro in grado di fare il proprio lavoro? Diciamo che gestite una catena di supermercati a basso prezzo e che impiegate molta manodopera immigrata in ruoli umili. Ebbene, secondo le statistiche del governo francese dello scorso mese, solo il 50% circa dei quattordicenni nelle scuole francesi sa leggere e scrivere a un livello accettabile. (Circa il 20% è analfabeta funzionale e questo è vero da alcuni anni). Inevitabilmente, queste cifre sono molto peggiori nelle aree più povere e tra la popolazione immigrata. Forse non è importante se diventerai un influencer di YouTube o un artista rap. Ma se non lo sei? Se non sai leggere e scrivere correttamente, non puoi lavorare come cassiere, non puoi passare il test per guidare un camion, non puoi nemmeno impilare la merce sugli scaffali giusti. Allo stesso modo, un numero crescente di immigrati arriva come minore non accompagnato e non impara mai a parlare correttamente il francese, perché non sono mai state destinate risorse all’insegnamento della lingua. Dopodiché le prospettive di lavoro sono, diciamo, non ottimali. Il risultato è che in molti quartieri medio-bassi un quarto o un terzo della classe non riesce a parlare il francese abbastanza bene da seguire correttamente le lezioni, il che rovina le cose per tutti. Ma non parliamo di questo.
Ora, per quanto stupido sia il datore di lavoro medio o il politico di destra, deve essergli venuto in mente che avere una forza lavoro flessibile e a basso costo non ha alcun valore se i lavoratori non sono in grado di svolgere il proprio lavoro. Infatti, è comune incontrare datori di lavoro che in privato deplorano il fatto di non riuscire a trovare personale qualificato per il lavoro, a prescindere da quanto lo paghino. Allo stesso modo, è noto che la maggior parte degli hotel delle principali città europee impiegano cameriere provenienti dall’Europa dell’Est che non parlano la lingua locale e cercano di cavarsela con qualche parola di inglese. (Sarebbe stato bello se qualcuno avesse previsto questi problemi una generazione fa e avesse investito denaro per risolverli, o addirittura per evitare che si verificassero). Non credo quindi che le spiegazioni economiche siano sufficienti, tanto più che ora ci sono più potenziali lavoratori a basso costo e disperati che posti di lavoro, e ne arrivano sempre di più.
Quindi cos’altro potrebbe essere? E in particolare, perché le persone che non traggono vantaggi economici dall’immigrazione di massa la sostengono comunque? Una ragione, suggerisco, è il fascino dell’esotico. Quando ero giovane, si accettava che ci fossero ampie parti del mondo che non si sarebbero mai viste, a meno che non si fosse ricchi o si avesse un lavoro che comportava viaggiare o lavorare all’estero. Oggi non è così diverso come si potrebbe pensare, soprattutto in questi tempi di insicurezza, ma la gente non lo accetta più così facilmente, perché le immagini del mondo intero sono a portata di mano e ci sono potenti interessi economici che cercano di farci credere che possiamo permetterci di andarci. E per la maggior parte di quello che io chiamo il Partito Esterno (la parte subalterna della Casta Professionale e Manageriale, la PMC) la vita è in realtà piuttosto monotona e noiosa, e le vacanze significano Grecia o forse Disneyland con milioni di altre famiglie a un costo esorbitante. Ma se non puoi andare in India o in Thailandia, e non vuoi andare in Afghanistan, beh, forse loro possono venire da te, sotto forma di ristoranti, negozi, cibi esotici al supermercato, sushi di tanto in tanto, questo genere di cose. E per molti membri del Partito Esterno, questa è praticamente la somma totale delle loro interazioni con le comunità di immigrati, ad eccezione, forse, di quel brillante e laborioso figlio di un medico indiano che è amico di vostro figlio o figlia, e i cui genitori incontrate a volte.
Forse il silenzio più strano in tutto questo è quello dei partiti della sinistra fittizia che, si potrebbe pensare, sarebbero ben consapevoli dell’impatto dell’immigrazione sul loro nucleo di elettori e starebbero facendo qualcosa per mitigarne gli effetti. Invece no: i leader di questi partiti fanno a gara per difendere quelli che definiscono i diritti degli immigrati, in particolare degli immigrati clandestini, e per abusare e demonizzare chiunque provi anche solo a sollevare l’argomento. Perché? E al contrario, i partiti della Sinistra Nozionale prestano pochissima attenzione alle politiche che fornirebbero un aiuto concreto agli immigrati, come l’istruzione, la sicurezza o la fornitura di alloggi a prezzi accessibili. Perché?
Il punto di partenza, a mio avviso, è il ben noto cambiamento di proprietà dei partiti della vecchia sinistra nell’ultima generazione o giù di lì. È noto che sono stati presi in mano da professionisti della classe media, disinteressati a continuare a costruire una base politica di massa e a governare (quando governavano) con espedienti e focus group. Ma cosa c’entra tutto questo con gli immigrati? Beh, una volta i partiti di sinistra erano fortemente sostenuti dagli elettori immigrati, perché fornivano loro assistenza pratica, e in Francia, ad esempio, molti leader di spicco della sinistra avevano origini immigrate. Conoscevo un anziano francese di origine armena, i cui genitori erano giunti in Francia dopo la Prima guerra mondiale, come molti altri, per sfuggire ai turchi. Ricordava che uno zio, arrivato un po’ più tardi, gli aveva raccontato che gli armeni erano stati accolti a Marsiglia dal Partito Comunista locale, con tessere di iscrizione al Partito e ai sindacati, e che poi si erano presi cura di loro. Oggi sembra tutto così pittoresco e superato. Ma cosa è cambiato?
Dobbiamo capire che i partiti della sinistra nozionistica sono ora controllati non da leader provenienti dai sindacati o dal governo locale e dalle comunità locali, ma dai discendenti (e a volte dagli stessi personaggi) di quei noiosi gruppi di marxisti che si trovavano nelle università negli anni Settanta, che non facevano altro che urlarsi addosso e litigare su cosa avesse detto Marx nel 1853, di ecologisti che volevano far esplodere le centrali nucleari o di femministe che ti sputavano in faccia se gli aprivi una porta. Gruppi come questi – e ce n’erano altri, ma tre sono sufficienti – non cercavano il sostegno popolare. Si consideravano gruppi d’avanguardia, seguendo la logica del pamphlet di Lenin del 1905 Che cosa bisogna fare? Lenin, si ricorderà, sosteneva che i tentativi di politici come Jaurès di prendere il potere pacificamente attraverso le urne e i sindacati erano destinati al fallimento. Era necessario un gruppo affiatato di rivoluzionari professionisti, che avrebbero preso il potere in nome della classe operaia. In effetti, i bolscevichi riuscirono dove i movimenti popolari di massa avevano fallito, generando una corrente di pensiero elitaria, dalla Scuola di Francoforte alla Nuova Sinistra degli anni Sessanta, che riteneva che la gente comune fosse stupida e quindi incapace di organizzarsi e portare avanti una rivoluzione. Ma gli attivisti illuminati, di classe media e con una formazione universitaria, sapevano cosa era bene per la classe operaia, per le donne, per i bambini, per l’istruzione, per l’ambiente e per una dozzina di altre cose, e non c’era appello contro i loro giudizi. Soprattutto, come ricordo che i militanti del partito laburista dicevano negli anni ’80, non si poteva parlare di “placare l’elettorato”.
Questa è la mentalità, e queste sono alcune delle stesse persone, che hanno controllato i partiti della sinistra nozionistica in tempi moderni. E tutto ciò che è accaduto è stato l’estensione dell’atteggiamento paternalistico nei confronti delle classi inferiori ignoranti, anche agli immigrati. Così ora la sinistra fittizia pretende di parlare per loro e di sapere cosa vogliono e di cosa hanno bisogno. Hanno bisogno di marce contro il razzismo e di ONG, ma non di istruzione o lavoro. Hanno bisogno di protezione contro il “razzismo istituzionale” della polizia, ma non contro la criminalità di cui le loro comunità soffrono in modo sproporzionato. In Francia, ad esempio, dove si piange e si stridono i denti per la violenza tra coniugi, è difficile denunciare i maschi di origine immigrata, per paura di scatenare polemiche politiche, anche se tutti riconoscono che i problemi maggiori sono in quelle società. Le associazioni di donne musulmane che protestano contro la violenza domestica o le molestie sessuali non vengono ascoltate: anzi, le femministe hanno incoraggiato queste donne a tacere, per paura di “stigmatizzare” la loro comunità.
Per generazioni, gli immigrati hanno votato per i partiti di sinistra perché erano rappresentati in modo sproporzionato tra i poveri e gli indigenti e avrebbero beneficiato dei governi di sinistra. In una misura considerevole, l’inerzia fa sì che lo facciano ancora, ma alla sinistra fittizia di oggi non importa. Il suo messaggio alla comunità degli immigrati, così come al resto dei suoi tradizionali sostenitori, è: “Zitti e votate per noi”: Zitti e votate per noi, e non aspettatevi nulla. Così, l’anno scorso, un gruppo di donne delle pulizie che lavoravano per il gruppo Accor Hotels in un hotel in una delle zone più malfamate di Parigi ha ottenuto una vittoria sulla retribuzione e sulle condizioni dopo un lungo sciopero. Quasi tutte provenivano da comunità di immigrati. Eppure non c’è stato un solo antirazzista, una sola femminista, un solo intersezionista che abbia sposato la loro causa o che ne abbia parlato. La loro vittoria è stata riportata in poche righe dai media vicini al PMC.
E questo viene notato. A livello locale, i partiti della sinistra nozionistica non cercano più di fare appello alle comunità di immigrati in quanto tali. Stringono accordi con i “leader delle comunità” locali, spesso figure religiose, ma a volte, diciamo, individui legati alla criminalità, che portano voti in cambio di posti di lavoro in municipio e sovvenzioni per le loro organizzazioni. Anche questo viene notato, ed è per questo che in molti Paesi europei il voto degli immigrati si sta spostando a destra, mentre la sinistra fittizia abbandona qualsiasi politica che possa convincerli a continuare a sostenerla. Dopo tutto, se la principale politica pubblicizzata dal partito della sinistra nozionistica locale alle elezioni è una campagna contro la “transfobia” nelle scuole, perché mai i pii immigrati di prima generazione, da poco naturalizzati, provenienti da un Paese musulmano dovrebbero votare per loro?
A lungo termine, e anche per il più arrogante dei partiti d’avanguardia, questo è un suicidio. Ma a breve termine, permette ai partiti della sinistra fittizia di continuare a usare le comunità di immigrati come serbatoio di voti, attraverso pressioni morali e accordi conclusi in stanze segrete. Inoltre, permette loro di imporre un discorso particolare sulle questioni dell’immigrazione che si adatta ai loro obiettivi. Nel loro discorso, gli immigrati sono figure deboli e indifese, sempre vittime, vittime della discriminazione e dell’emarginazione e incapaci persino di esprimere le proprie rimostranze, per non parlare di cercare di porvi rimedio. Solo i salvatori bianchi possono farlo. Soprattutto, non è ammessa alcuna critica a qualsiasi aspetto del comportamento delle comunità di immigrati, nemmeno da parte di membri di queste comunità, poiché ciò non farebbe altro che rafforzare l’estrema destra e consegnare il Paese nelle mani dei fascisti. O qualcosa del genere.
Ma accettando il fatto che la politica è spesso cattiva, cinica e arrivista, mi sembra che nell’atteggiamento della sinistra nozionistica verso gli immigrati ci debba essere qualcosa di più di questo. Ho un suggerimento, che comporta una deviazione sul tema degli imperi, ma non nel modo in cui probabilmente vi aspettate.
La mente occidentale moderna ha una comprensione bizzarra del concetto di Impero: tanto più che gli Imperi sono stati la principale forza motrice e il principale sistema di organizzazione politica fino a tempi molto recenti. Gli imperi classici (assiro, persiano, romano, moghul, Qing, arabo, ottomano, ecc.) erano essenzialmente imperi di espansione da una regione di origine imperiale, attraverso la guerra e la conquista, e in qualche misura l’assimilazione. Il motivo era spesso l’accaparramento di ricchezze e territori, e in molti casi gli imperi combattevano tra loro, e al controllo di un territorio da parte di uno seguiva il controllo di un altro. La stragrande maggioranza dei Paesi del mondo di oggi erano territori imperiali non più di un secolo fa.
Ma quando oggi si parla di “imperi”, di solito si ha un’impressione poco chiara degli effimeri imperi britannico e francese in Africa, le cui origini sono molto più complesse e in realtà molto più interessanti. Gli imperi marittimi dipendono, ovviamente, dalle navi e fu lo sviluppo di questa tecnologia a consentire i primi imperi europei in America Latina, il cui scopo originario era semplicemente l’accumulo di oro. In seguito i portoghesi stabilirono quello che viene spesso descritto come un “Impero”, ma che in realtà era più che altro una serie di stazioni commerciali, con relazioni politiche molto limitate con i regni africani dell’entroterra. La “Colonia del Capo” olandese era in realtà solo un porto in acque profonde a Simon’s Town, dove le navi olandesi delle Indie Orientali potevano fare rifornimento e riposare. Anche quando gli inglesi sottrassero la “Colonia” agli olandesi, durante le guerre napoleoniche, volevano solo la base navale.
Mi dilungo un po’ su questo punto perché, come dimostrano alcune utili mappe di Wikimedia, fino a circa centocinquant’anni fa la principale potenza coloniale in Africa era di fatto l’Impero Ottomano, e la cultura araba e l’Islam erano stati diffusi lungo la costa orientale dell’Africa dai commercianti provenienti dal Golfo. In confronto, l’impronta europea in Africa era piccola e in gran parte legata al commercio. Le ragioni di questo cambiamento sono state oscurate dalla continua influenza del movimento anticolonialista degli anni Sessanta e dalla relativa letteratura che sosteneva che l’Africa era stata “saccheggiata” dalle potenze coloniali. (In realtà, è vero più o meno il contrario: gli imperi sono stati un pozzo di denaro senza fondo). Ora, tra i motivi reali c’era sicuramente l’avidità: Cecil Rhodes è solo il più famoso degli imprenditori che promisero ai loro governi che le colonie sarebbero state redditizie, per poi essere salvati da quegli stessi governi quando fallirono. E alcuni individui hanno fatto fortuna in seguito, ad esempio con le miniere d’oro in Sudafrica. Ma la storia reale del trionfo delle idee imperiali alla fine del XIX secolo è molto più complessa e variegata di così.
Alcune motivazioni erano economiche e strategiche. Gli inglesi, ad esempio, la cui economia dipendeva dal commercio marittimo, cercavano possedimenti strategici dove poter sostenere la loro Marina, soprattutto dopo il passaggio al carbone, e un approvvigionamento sicuro di materie prime per l’industria. I francesi, dopo il 1870, vedevano nei possedimenti imperiali una riserva di manodopera e di risorse per la successiva guerra con la Germania. Entrambi avevano ragione e gli imperi hanno probabilmente salvato la Gran Bretagna e la Francia in entrambe le guerre del XX secolo.
Ma alcuni erano più strettamente politici. La vasta ricchezza creata in Gran Bretagna, Francia e Germania dalle loro rivoluzioni industriali creò la possibilità di acquisire colonie sia per sostenere l’industria (come già detto), ma soprattutto come simbolo di prestigio e status nel mondo. Avere delle colonie, ad esempio nel 1895, era l’equivalente di avere armi nucleari e di essere un membro permanente del Consiglio di Sicurezza un secolo dopo. Così, i tedeschi, arrivati tardi alla festa dopo l’unificazione, dovettero accontentarsi della Namibia, del Tanganica e del Ruanda per il loro “posto al sole”, a cui pensavano di avere diritto grazie al loro potere economico.
Ma anche se la storia completa dell’ascesa e del declino dell’imperialismo come dottrina è affascinante, e raramente gli viene data sufficiente importanza, in questa sede mi occupo di uno degli aspetti dell’interazione occidentale con l’Africa e il Medio Oriente – che va quindi ben oltre gli imperi in quanto tali – che non viene quasi mai trattato: la dimensione umanitaria. E qui cominciamo ad avvicinarci al nucleo del rapporto tra il pensiero occidentale sulle parti meno fortunate del mondo di un secolo fa e il pensiero occidentale sugli sfortunati immigrati di oggi. E le corrispondenze, in termini di ideologia, strutture e tipo di persone coinvolte, sono piuttosto sorprendenti.
Il primo tipo di interazione, oggi poco ricordato, è quello del lavoro missionario: le fondazioni missionarie, spesso ben finanziate e politicamente influenti, erano le ONG del loro tempo. Naturalmente il lavoro missionario precede di molto l’imperialismo moderno: sono ben note le attività dei missionari cattolici in America Latina e in Giappone a partire dal XVI secolo. Ma il vero impulso è arrivato con l’ascesa del cristianesimo evangelico nelle nazioni protestanti nel XVIII secolo. L’impulso domestico a portare il Vangelo ai poveri e agli indigenti, ad agire per migliorare le condizioni di lavoro e le riforme sociali in patria, si trasformò naturalmente in una preoccupazione per le condizioni del resto del mondo. Le Chiese avevano già inviato “missioni” per sostenere le piccole comunità di coloni e commercianti europei in tutto il mondo, ma dalla fine del XVIII secolo vennero create organizzazioni missionarie (come la famosa London Missionary Society) per portare la Parola di Dio in tutto il mondo. Fin dall’inizio, i missionari hanno posto l’accento sull’istruzione e sull’azione umanitaria, imparando le lingue locali e traducendo la Bibbia. Il loro lavoro li portò spesso a scontrarsi con altri occidentali presenti per motivi più mercenari.
Anche se oggi sembra difficile da accettare, ci sono stati tempi in cui la politica era dominata da persone moralmente serie. In Gran Bretagna, il movimento evangelico ha avuto una grande influenza sulla politica, dato che alcuni politici famosi – tra cui Gladstone, il grande primo ministro riformatore – sono stati profondamente influenzati dalle sue idee. Le riforme dell’epoca – istruzione, condizioni di lavoro, diritto di voto – erano accompagnate dal desiderio di essere ciò che i governi successivi avrebbero definito “una forza per il bene” nel mondo. Gli evangelici erano stati estremamente influenti negli sforzi per porre fine alla tratta degli schiavi nei possedimenti britannici e successivamente avevano contribuito a persuadere Londra a istituire l’Africa Squadron, che pattugliava le coste dell’Africa occidentale, cercando di intercettare i mercanti di schiavi e di liberare gli schiavi. Questi gruppi di pressione si sovrapponevano agli appassionati di opere missionarie e di opere di bene in Africa e altrove. Anche più tardi, quando fu istituito l’Impero britannico formale, gli amministratori coloniali che andarono a gestirlo parteciparono dello stesso fervore morale profondamente serio che portò alle riforme politiche, sociali e governative in Gran Bretagna.
Pur non avendo la stessa tradizione evangelica, i francesi non tardarono a seguire gli inglesi nella diffusione del cristianesimo. Non appena i francesi ebbero strappato il controllo dell’Algeria agli Ottomani e riuscirono a pacificarla, iniziarono a costruire la basilica di Notre Dame d’Afrique, che ancora oggi domina lo skyline di Algeri. Sotto Napoleone III ci furono spedizioni e iniziative coloniali private, ma fu dopo la fondazione della Terza Repubblica nel 1871 che la colonizzazione divenne una causa popolare. Come in Gran Bretagna, fu sostenuta da un gran numero di PMC dell’epoca, come il famoso socialista Jules Ferry, l’architetto di gran parte dell’Impero francese in Africa, che sosteneva nel vocabolario standard dell’epoca che “le razze superiori hanno il dovere di civilizzare le razze inferiori”. (Tuttavia, questa idea fu osteggiata da molti esponenti della destra, che temevano che avrebbe interferito con il buon funzionamento dei mercati).
I francesi, naturalmente, avevano il vantaggio dei principi repubblicani universali risalenti alla Rivoluzione, e proprio l’universalità di questi principi significava che potevano essere applicati con sicurezza a qualsiasi situazione, ovunque. Condividevano anche lo zelo modernizzatore degli inglesi (abolendo la schiavitù, diffondendo l’istruzione e cercando di migliorare lo status delle donne, ad esempio).
Per circa tre generazioni, l’apparato formale degli imperi di Gran Bretagna e Francia, tanto stravagantemente elogiato all’epoca quanto stravagantemente demonizzato in seguito, distolse l’attenzione da molte delle realtà quotidiane che avevano più effetto sulla vita della gente comune. Oltre alle annessioni, alle invasioni, alle ribellioni, alle scoperte di risorse naturali, ai trattati e a tutto il resto, c’erano amministrazioni coloniali che lavoravano alacremente, cercando di introdurre quello che oggi definiremmo “buon governo”. Scrissero leggi, istituirono strutture formali di governo locale, abolirono la schiavitù, cercarono di “modernizzare” società e costumi, costruirono strade e ferrovie e mandarono giovani nativi promettenti a studiare nella madrepatria. E oltre a loro, c’erano grandi reti di insegnanti, medici, ufficiali militari, specialisti tecnici e altri, attratti da un’intera gamma di motivazioni, dalle più elevate alle più mercenarie.
Il che significa che un amministratore coloniale o un missionario che si fosse addormentato cento anni fa e si fosse svegliato oggi, si sarebbe sorpreso di quanto poco fossero cambiate le cose. Come in passato, la concentrazione dei media sugli elementi più noti del rapporto tra Occidente e Resto del mondo può far sembrare che si tratti di un conflitto. In realtà, come in passato, la maggior parte di questa relazione consiste in un potere “morbido” piuttosto che “duro”, ed è gestita oggi dai ministeri dello sviluppo e dalle organizzazioni internazionali. È impressionante, per usare un eufemismo, vedere l’enorme volume di attività finanziate da queste organizzazioni in quasi tutti i settori che si possono pensare: riforma giudiziaria, diritti delle donne, gestione del settore pubblico, redazione legale, media indipendenti, responsabilità della polizia, trasparenza del bilancio, formazione anticorruzione e centinaia di altri. Se dubitate di me, visitate i siti web dell’UE, delle Nazioni Unite, dell’OCSE e dei principali donatori come Canada, Svezia, Germania e altri, e ammirate le pagine e pagine e pagine di progetti che coprono ogni aspetto della vita laggiù. Ci sono persino società di consulenza che vi aiutano a trovare i progetti e newsletter che vi guidano, soprattutto a Bruxelles. Oppure guardate i siti di alcune agenzie di sviluppo nazionali e stupitevi dell’arroganza neocoloniale di funzionari senza alcuna esperienza reale che ingaggiano consulenti senza alcuna esperienza reale per mettere insieme squadre di persone che interferiscano nelle aree più sensibili dei Paesi di altri popoli.
Se vi recate in un’ambasciata di un Paese occidentale di medie dimensioni nel Sud del mondo, scoprirete che, a parte l’ambasciatore e alcuni membri della cancelleria, il personale consolare e forse un addetto alla difesa e uno specialista del commercio, il grosso degli sforzi dell’ambasciata si concentra su questioni vagamente definite “sviluppo”, “governance”, “riforme”, “prevenzione dei conflitti” e “diritti umani”, che sono un codice collettivo per i tentativi di imporre un’agenda PMC al Paese. Ci saranno un paio di giovani entusiasti distaccati dal Ministero dello Sviluppo, che avranno bisogno di interpreti, un po’ di personale assunto localmente che ha studiato all’estero e che parla inglese, che è la lingua in cui l’Ambasciata dovrà in pratica lavorare, e la maggior parte del lavoro effettivo sarà appaltato a ONG locali con personale giovane che ha studiato all’estero e che parla anche inglese. L’argomento più importante sarà probabilmente il genere: l’Ambasciata potrebbe avere un consigliere a tempo pieno per il genere, un ambizioso programma per il genere, sponsorizzare seminari di giovani donne istruite all’estero e assegnare ogni anno un premio speciale a una donna che ha avuto un successo particolare negli affari. (La condizione reale delle donne comuni, soprattutto al di fuori della capitale, non sarà una priorità: i problemi sono comunque troppo grandi). E poi c’è un colpo di stato o una guerra che nessuno ha visto arrivare perché stava facendo altre cose.
Se tutto questo suona come un’accusa un po’ stizzita al fatto che non è cambiato molto negli atteggiamenti dall’epoca coloniale, beh, in un certo senso è così. E probabilmente è peggiorato: cento anni fa, gli amministratori e i missionari coloniali erano più informati e meno invadenti dei loro discendenti. Ma è importante capire due cose. Uno è che, come nel periodo della colonizzazione formale, le persone vengono coinvolte per i motivi più disparati e molte hanno forti imperativi ideologici o morali per quello che fanno. Il Primo Segretario (Sviluppo) medio di un’Ambasciata probabilmente crede di “fare del bene”. E questo a sua volta significa che, come il resto dell’agenda della PMC, i loro progetti sono intrinsecamente virtuosi e non possono mai fallire, possono solo essere falliti. Come ho sempre detto, non c’è nessuno più pericoloso di un idealista.
Ma il secondo punto, direttamente collegato all’epoca coloniale, è forse più importante. Durante quell’epoca, c’era una completa distinzione tra chi lavorava sul campo e chi lavorava nelle organizzazioni e nei governi del Paese d’origine. L’Ufficio per l’Africa a Londra era gestito da persone che in quasi tutti i casi non avevano mai visitato il continente. Allo stesso modo, il personale in loco tornava solo occasionalmente nella madrepatria: un membro del Servizio Civile Sudanese, un’organizzazione governativa molto rispettata all’epoca, poteva essere assunto a Londra, ma avrebbe trascorso tutta la sua vita lavorativa in Sudan, con il diritto forse a una visita in patria qualche volta nella sua carriera. (Il padre di George Orwell, ad esempio, tornava a casa dall’India una volta ogni sette anni). Allo stesso modo, i funzionari delle Società Missionarie o delle numerose organizzazioni di volontariato che inviavano medici e insegnanti all’estero, raramente lasciavano il loro paese.
Non è così bizzarro come sembra. Cento anni fa, per andare da Londra a Khartoum, passando per Alessandria, potevano volerci settimane e costare una fortuna. Oggi, il funzionario del Ministero degli Esteri responsabile per il Medio Oriente può fare un tour introduttivo in dieci giorni. Un secolo fa ci sarebbero voluti sei mesi. In pratica, i responsabili delle politiche, i finanziatori e i leader politici avevano solo una vaga idea di ciò che accadeva sul campo, e chi era sul posto spesso faceva ciò che gli sembrava meglio. Spesso le due cose erano in conflitto, dato che i missionari e gli amministratori coloniali erano sul campo.
Con il passare delle generazioni, naturalmente, la serietà morale di quell’epoca si è affievolita. Il senso del dovere di portare il “buon governo” o la “Parola di Dio” alle popolazioni native è stato sostituito dal desiderio meccanico, e spesso aggressivo, di obbligare altre parti del mondo a ricostruirsi a nostra immagine e somiglianza. Il fervore repubblicano che animava personaggi come Ferry è oggi considerato con imbarazzo in Francia, che ha completamente inghiottito l’ideologia liberale di stampo PMC. Ciò che rimane è proprio questa ideologia liberale vuota e incoerente, e il desiderio di imporla agli altri attraverso il potere politico e finanziario, spesso per motivi carrieristici e per avere un’influenza non riconosciuta su settori sensibili dei governi stranieri. E rimane anche, in forma degenerata, il desiderio di sentirsi bene con se stessi, di far compiere all’estero una serie di atti performativi che confermino che siamo persone meravigliose.
Eppure la globalizzazione offre ogni sorta di nuove opportunità per iniziative performative e autocelebrative. Anziché limitarci a inviare persone laggiù, possiamo portare qui la materia prima del nostro senso di orgoglio e di virtù, in modo da assumere ulteriori pose morali. In effetti, i nostri leader hanno importato le colonie nei nostri Paesi, in modo da poter patrocinare la loro gente come facevamo cento anni fa. Naturalmente, la PMC non si sporcherà le mani con i dettagli pratici, così come non lo facevano un tempo la London Missionary Society o il Ministère des Colonies. Vivono distaccati dagli ingredienti performativi che hanno portato con sé quasi quanto i loro antenati ideologici di un secolo o più fa. Lasciano la gestione concreta della situazione alle forze dello Stato, spesso mal pagate e non considerate (personale del municipio, assistenti sociali, polizia, personale medico e insegnanti, che sono quotidianamente all’opera) e alle organizzazioni caritatevoli, che sono completamente sopraffatte dalla portata dei problemi. Nel frattempo, i PMC nelle loro zone chic delle città si congratulano compiaciuti di quanto siano virtuosi e superiori, e di quanto sia malvagio e spregevole chiunque critichi le loro politiche di immigrazione, o voglia anche solo parlarne.
E questo, forse, è il beneficio finale dell’attuale politica di immigrazione incontrollata: la superiorità morale, che questa volta non deriva da qualcosa che hai fatto, ma solo da ciò che pensi. Ci sono pochi piaceri più squisiti e delicati, dopo tutto, che sedersi a giudicare moralmente gli altri, senza dover fare nulla di concreto. Alcuni decenni fa, Michel Rocard, allora primo ministro di François Mitterrand, disse notoriamente che la Francia non poteva “accogliere tutta la miseria del mondo”. Fu criticato furiosamente per questa affermazione, ma un attimo di riflessione dimostra che aveva ragione: quanto tempo ci vorrebbe, ad esempio, per trovare, trasportare in Francia, ospitare, nutrire e vestire le centinaia di milioni di persone indigenti nel mondo? L’errore di Rocard è stato quello di trattare il linguaggio performativo e normativo come se fosse destinato ad applicarsi al mondo reale, come se si trattasse di una questione di ciò che dovremmo fare, in contrapposizione alla questione molto più importante di ciò che dovremmo dire. Ed evidentemente la PMC non si sta affrettando a offrire ai miserabili del mondo un posto in casa propria. (Diffidate sempre di chi dice “dobbiamo” quando in realtà intende “dovete”).
E ora, credo, ci sono segnali che indicano che questo abile teatrino della superiorità morale sta iniziando a crollare. Come sempre, è impossibile dire a quale velocità avverrà, ma è chiaro che il processo è in corso. Arriva un momento in cui l’intimidazione normativa non funziona più. Per ironia della sorte, basterebbe ascoltare le stesse popolazioni immigrate. Non vogliono marce contro il razzismo e appelli per il disboscamento della polizia. Vogliono posti di lavoro, opportunità e un’istruzione decente per i loro figli, sicurezza nella loro vita quotidiana e libertà dall’influenza delle bande di droga e degli estremisti religiosi. (Qualsiasi amministratore coloniale del 1900, riportato in vita, avrebbe visto esattamente cosa c’era da fare).
Forse in un futuro non troppo lontano organizzeranno una marcia antirazzista e anti-islamofobia, ma non verrà nessuno.
Subscribe to Trying to Understand the World
A newsletter devoted not to polemic, but to trying to make sense of today’s world.



