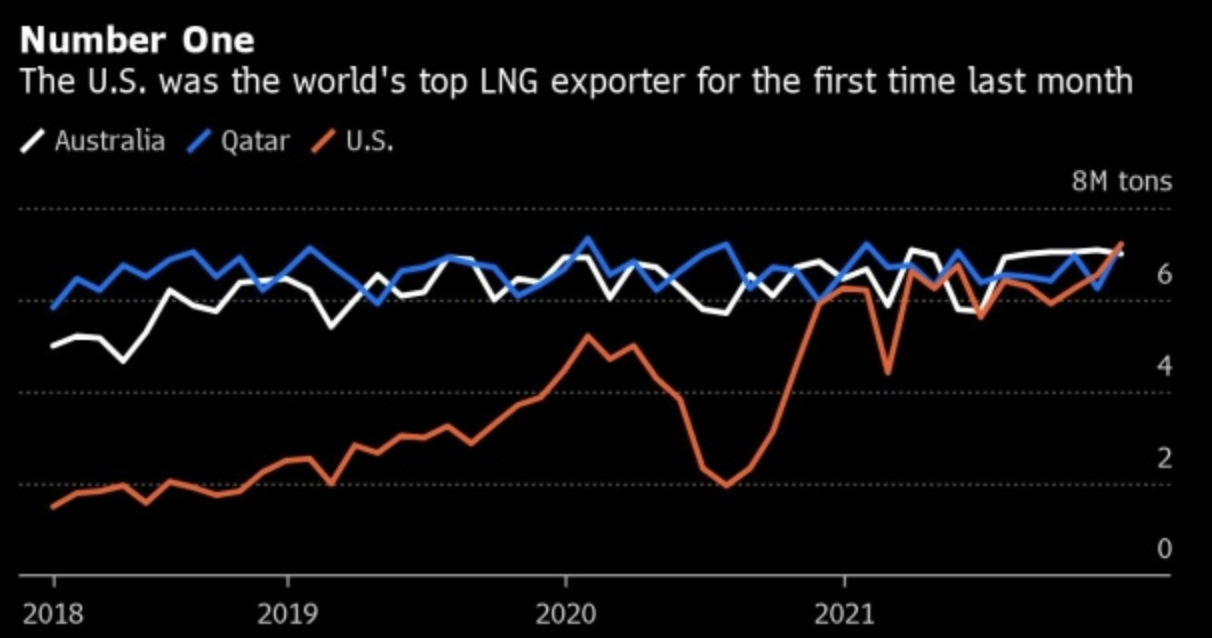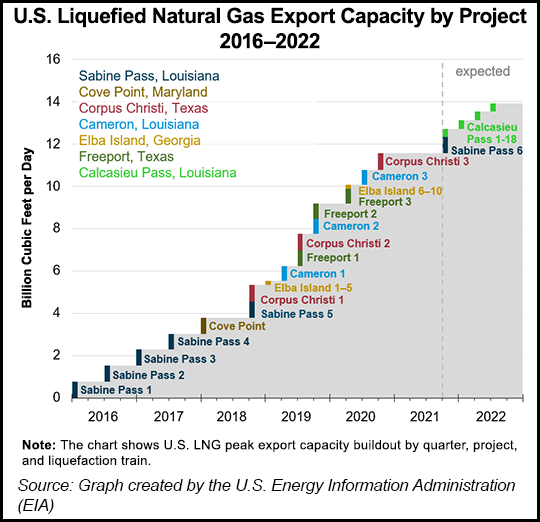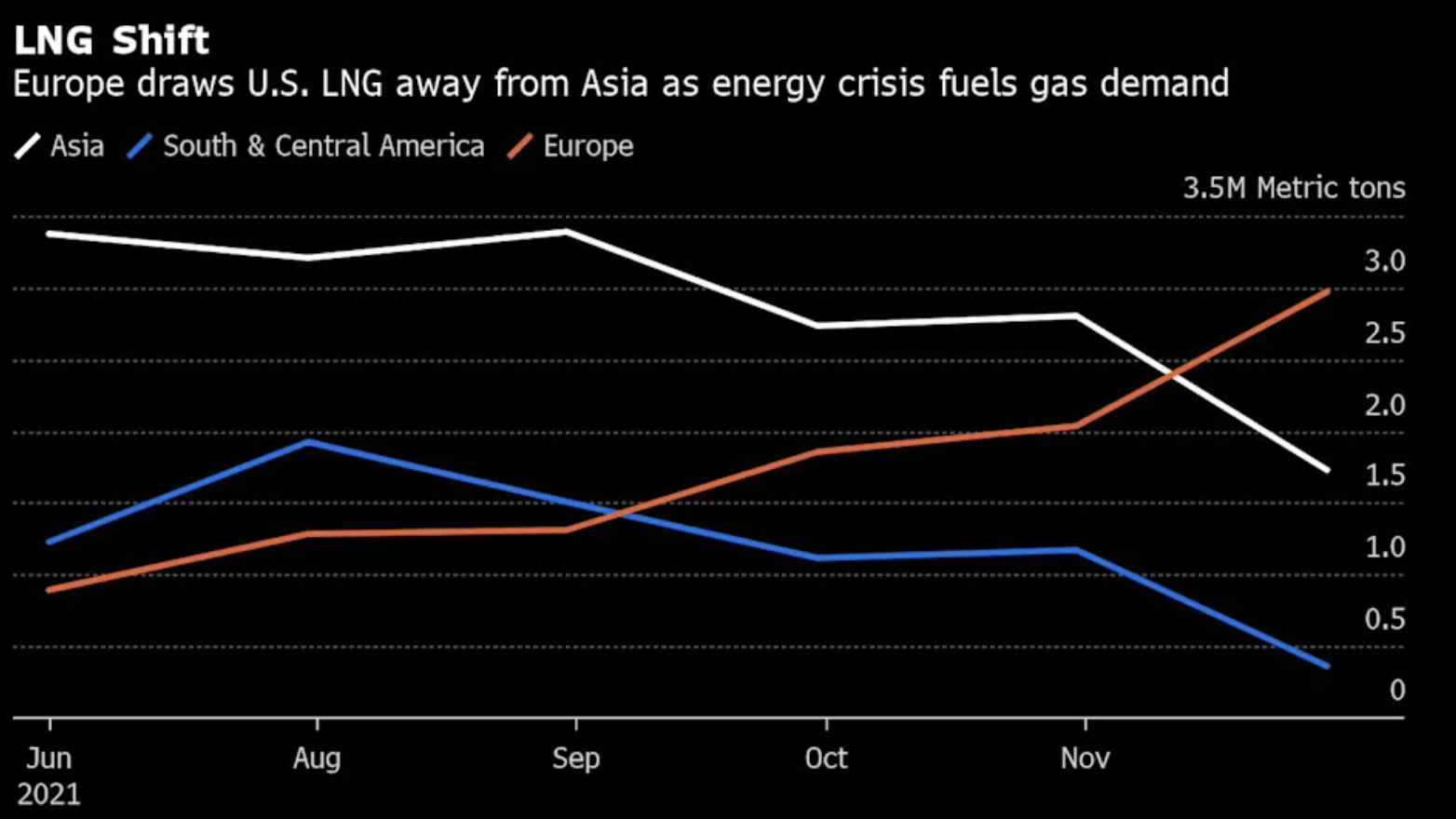Draghi sarà il Presidente della Repubblica?
a cura di Luigi Longo
1.E’ opportuno, in occasione della elezione del Presidente della Repubblica, rileggere l’intervento di Mario Draghi fatto sullo yacht Britannia il 2 giugno 1992 sul progetto di privatizzazione iperliberista in Italia (l’intervento è ripreso dal sito www.ilfattoquotidiano.it del 22/1/2020 e la divisione in paragrafi è mia). Per inciso, fa ridere la boutade apparsa sui mass media che narra di Mario Draghi allievo del grande keinesiano Federico Caffè (della serie “la situazione è drammatica ma non è seria”!).
L’opportunità è data dal fatto che Mario Draghi rappresenterebbe per i pre-dominanti USA e i sub-dominanti europei il Presidente della Repubblica ideale per garantire non solo la totale servitù italiana verso le strategie statunitensi in Italia, in Europa, nel Mediterraneo e nel Medio Oriente (così come è stato per tutti i precedenti presidenti), ma anche la garanzia del controllo dei Fondi Europei del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del debito pubblico, che, per essere chiari, nulla hanno a che fare con lo sviluppo del Paese e per il benessere della maggioranza della popolazione [ si veda la proposta del duo Draghi-Macron di creare una Agenzia del debito dell’Eurozona cedendo i debiti al MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) che imporrebbe una forte riduzione del debito pubblico con tagli drastici sulle spese sociali, per approfondimenti si rimanda a Fabio Bonciani, Il piano Draghi-Macron per cedere i debiti al MES: come trasformare dei numeri in debiti in www.comedonchisciotte.org del 17/1/2022].
Per una riflessione sul ruolo del Presidente della Repubblica ripropongo un mio scritto, apparso su www.Italiaeilmondo.com il 4/9/2018, con il titolo Le istituzioni e il conflitto che introduce una stimolante lettura di Marco Della Luna sulla costituzione del Quirinale.
2.Sono scettico sul fatto che Mario Draghi possa diventare il Presidente della Repubblica per le seguenti ragioni:
la prima: la sua elezione a Presidente comporterebbe, visto il ruolo di garante che dovrà svolgere e considerata la fase storica multicentrica, la formale transizione da una Repubblica democratica ad una Repubblica presidenziale, cioè, l’adeguamento, in pratica, della forma alla sostanza. Trovo arduo, se non impossibile, tale passaggio istituzionale, sia osservando il panorama politico, economico e sociale, sia considerando ed evidenziando che Mario Draghi è un agente strategico esecutore incapace di pensare, né tantomeno di gestire, strategie di sviluppo del Paese;
la seconda: il suo potere esecutivo (mostrato con la faccia gaberiana scolpita nella pietra che con grande autorevolezza spara cazzate) da Presidente del Consiglio, gli permette di eseguire meglio, attraverso lo strumento della pseudo pandemia da Covid-19 (sulla pseudo pandemia si veda Massimo Cascone, intervista a Stefano Dumontet, Morti, vaccini e speculazioni economiche, parte 1 e 2, www.comedonchisciotte.org, del 20/1/2022 e 21/1/2022), le strategie dei pre-dominanti USA (il dominio sull’Europa attraverso la Nato essendo il progetto statunitense dell’Unione Europea esaurito) e dei sub-dominanti europei che occupano spazi istituzionali di potere usando gli strumenti finanziari, monetari, economici, culturali, mediatici e giudiziari per gestire e appropriarsi della ricchezza prodotta dai popoli europei (gestione dei fondi europei, pagamento del debito pubblico, erosione del risparmio privato e delle riserve auree).
E’ sempre utile ricordare che l’Europa non è un soggetto politico e quindi non può esprimere un’idea di sviluppo autonomo in relazione all’Occidente e all’Oriente, avendo da tempo perso ogni identità e peculiarità travolta da un processo di americanizzazione dei territori giunto a saturazione come conseguenza di una grave crisi di civiltà occidentale.
3. Un uomo di potere come Francesco Cossiga, che si divertiva a fottere il potere sempre sotto l’ordine statunitense (Francesco Cossiga con Andrea Cangini, Fotti il potere. Gli arcana della politica e dell’umana natura, Aliberti editore, Roma, 2010), aveva avvisato che “Non si può nominare primo ministro [Mario Draghi, mia precisazione LL] chi è stato socio o lavora per la Goldman Sachs, grande banca di affari americana […] Un vile affarista. E’ il liquidatore, dopo la famosa crociera sul Britannia, della svendita dell’industria pubblica italiana, quando era direttore generale del Tesoro. E immagina cosa farebbe se fosse eletto presidente del consiglio dei ministri. Svenderebbe tutto ciò che rimane ai suoi comparuzzi della Goldman Sachs”.
Il ruolo di Mario Draghi è quello di eseguire le strategie pre-dominanti statunitensi e sub-dominanti europee; per la sua storia, per le funzioni svolte a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, è illuminante, per questo è un pericolo per gli interessi nazionali e le sue articolazioni sociali
Nella corruzione di questo mondo, la mano dorata del delitto può scansare la giustizia, e si vede spesso la legge farsi accaparrare dalla sua preda […] La consuetudine, quel mostro che ogni sensibilità consuma, il demonio delle abitudini, è però anche angelo, quando con lo stesso viso veste di livrea le azioni buone e le malvage, vestito che s’indossa con facilità estrema […] L’abitudine può cambiare lo stampo della natura e domare il diavolo o cacciarlo del tutto, con forza meravigliosa (Shakespeare, Amleto, Mondadori, Milano, 1988, pp.177 e 193).
IL DISCORSO DI MARIO DRAGHI
“Privatizzazioni inevitabili, ma da regolare con leggi ad hoc”: il discorso del 1992 (ma attualissimo) di Mario Draghi sul Britannia
Pubblichiamo il discorso di Mario Draghi, allora direttore generale del Tesoro, alla Conferenza sulle Privatizzazioni tenutasi sullo yacht Britannia, del 2 giugno 1992: l’ex presidente della Bce parlò della vendita delle azioni pubbliche. Un processo con cui, 28 anni dopo, l’Italia fa i conti. Nelle sue parole i mercati come strada per la crescita, la fine del controllo politico, l’idea di public company, ma anche i tanti rischi: “Sarà più difficile gestire la disoccupazione. Non c’è una Thatcher – disse – servono strumenti per ridurre i senza lavoro e i divari regionali. Andranno tutelati gli azionisti di minoranza”. E ancora: “Questo processo lo richiede Maastricht, facciamolo prima noi. Ma va deciso da un esecutivo forte e stabile. Ridurremo il debito”.
La servitù del debito pubblico
Signore e signori, cari amici, desidero anzitutto congratularmi con l’Ambasciata Britannica e gli Invisibili Britannici per la loro superba ospitalità. Tenere questo incontro su questa nave è di per sé un esempio di privatizzazione di un fantastico bene pubblico. Durante gli ultimi quindici mesi, molto è stato detto sulla privatizzazione dell’economia italiana. Alcuni progressi sono stati fatti, nel promuovere la vendita di alcune banche possedute dallo Stato ad altre istituzioni cripto-pubbliche, e per questo la maggior parte del merito va a Guido Carli, ministro del Tesoro. Ma, per quanto riguarda le vendite reali delle maggiori aziende pubbliche al settore privato, è stato fatto poco.
Non deve sorprendere, perché un’ampia privatizzazione è una grande – direi straordinaria – decisione politica, che scuote le fondamenta dell’ordine socio-economico, riscrive confini tra pubblico e privato che non sono stati messi in discussione per quasi cinquant’anni, induce un ampio processo di deregolamentazione, indebolisce un sistema economico in cui i sussidi alle famiglie e alle imprese hanno ancora un ruolo importante. In altre parole, la decisione sulla privatizzazione è un’importante decisione politica che va oltre le decisioni sui singoli enti da privatizzare. Pertanto, può essere presa solo da un esecutivo che ha ricevuto un mandato preciso e stabile.
Altri oratori parleranno dello stato dell’arte in quest’area: dove siamo ora da un punto di vista normativo, e quali possono essere i prossimi passaggi. Una breve panoramica della visione del Tesoro sui principali effetti delle privatizzazioni può aiutare a comunicare la nostra strategia nei prossimi mesi. Primo: privatizzazioni e bilancio. La privatizzazione è stata originariamente introdotta come un modo per ridurre il deficit di bilancio. Più tardi abbiamo compreso, e l’abbiamo scritto nel nostro ultimo rapporto quadrimestrale, che la privatizzazione non può essere vista come sostituto del consolidamento fiscale, esattamente come una vendita di asset per un’impresa privata non può essere vista come un modo per ridurre le perdite annuali. Gli incassi delle privatizzazioni dovrebbero andare alla riduzione del debito, non alla riduzione del deficit.
I debiti da pagare
Quando un governo vende un asset profittevole, perde tutti i dividendi futuri, ma può ridurre il suo debito complessivo e il servizio del debito. Quindi, la privatizzazione cambia il profilo temporale degli attivi e dei passivi, ma non può essere presentata come una riduzione del deficit, solo come il suo finanziamento. (Questo fatto, nella visione del Tesoro, ha alcune implicazioni che vedremo in un secondo momento). Le conseguenze politiche di questa visione sono due. Dal punto di vista della finanza pubblica, il consolidamento fiscale da mettere a bilancio per l’anno 1993 e i successivi non dovrebbe includere direttamente nessun ricavo dalle privatizzazioni. Nel contempo, dovremmo avviare un piano di riduzione del debito con gli incassi dalle privatizzazioni. Ciò implicherà più enfasi del Tesoro sulle implicazioni economiche complessive delle privatizzazioni e sull’obiettivo ultimo di ricostruire gli incentivi per il settore privato.
La centralizzazione della ricchezza finanziaria
Secondo: privatizzazioni e mercati finanziari. La privatizzazione implica un cambiamento nella composizione della ricchezza finanziaria privata dal debito pubblico alle azioni. L’effetto di riduzione del debito pubblico può implicare una discesa dei tassi di interesse. Ma l’impatto sui mercati finanziari può essere molto più importante, quando vediamo che la quantità di ricchezza privata in forma di azioni è piccola in relazione alla ricchezza privata totale e che con le privatizzazioni può aumentare in modo significativo. In altre parole, i mercati finanziari italiani sono piccoli perché sono istituzionalmente piccoli, ma anche perché – forse in modo connesso – gli investitori italiani vogliono che siano piccoli. Le privatizzazioni porteranno molte nuove azioni in questi mercati. L’implicazione politica è che dovremmo vedere le privatizzazioni come un’opportunità per approvare leggi e generare cambiamenti istituzionali per potenziare l’efficienza e le dimensioni dei nostri mercati finanziari.
La crescita selvaggia del mercato
Tre: privatizzazioni e crescita. (In molti casi) vediamo le privatizzazioni come uno strumento per aumentare la crescita. Nella maggior parte dei casi la privatizzazione porterà a un aumento della produttività, con una gestione migliore o più indipendente, e a una struttura più competitiva del mercato. La privatizzazione quindi potrebbe parzialmente compensare i possibili – ma non certi – effetti di breve termine di contrazione fiscale necessaria per un bilancio più equilibrato. In alcuni casi, per trarre beneficio dai vantaggi di un aumento della concorrenza derivante dalla privatizzazione, potrebbe essere necessaria un’ampia deregolamentazione. Questo processo, se da una parte diminuisce le inefficienze e le rendite delle imprese pubbliche, dall’altra parte indebolisce la capacità del governo di perseguire alcuni obiettivi non di mercato, come la riduzione della disoccupazione e la promozione dello sviluppo regionale. Tuttavia, consideriamo questo processo – privatizzazione accompagnata da deregolamentazione – inevitabile perché innescato dall’aumento dell’integrazione europea. L’Italia può promuoverlo da sé, oppure essere obbligata dalla legislazione europea. Noi preferiamo la prima strada.
La mancanza di una strategia di sviluppo nazionale
Le implicazioni di policy sono che: a) un grande rilievo verrà dato all’analisi della struttura industriale che emergerà dopo le privatizzazioni, e soprattutto a capire se assicurino prezzi più bassi e una migliore qualità dei servizi prodotti; b) nei casi rilevanti la deregolamentazione dovrà accompagnare la decisione di privatizzare, e un’attenzione speciale sarà data ai requisiti delle norme comunitarie; c) dovranno essere trovati mezzi alternativi per perseguire obiettivi non di mercato, quando saranno considerati essenziali. Quarto: privatizzazioni e depoliticizzazione. Un ultimo aspetto attraente della privatizzazione è che è percepita come uno strumento per limitare l’interferenza politica nella gestione quotidiana delle aziende pubbliche. Questo è certamente vero e sbarazzarsi di questo fenomeno è un obiettivo lodevole. Tuttavia, dobbiamo essere certi che dopo le privatizzazioni non affronteremo lo stesso problema, col proprietario privato che interferisce nella gestione ordinaria dell’impresa. Qui l’implicazione politica immediata è l’esigenza di accompagnare la privatizzazione con una legislazione in grado di proteggere gli azionisti di minoranza e di tracciare linee chiare di separazione tra gli azionisti di controllo e il management, tra decisioni societarie ordinarie e straordinarie.
La svendita totale del Paese
A cosa dobbiamo fare attenzione, per valutare la forza del mandato politico di un governo che voglia veramente privatizzare? Primo, occorre una chiara decisione politica su quello che deve essere considerato un settore strategico. Non importa quanto questo concetto possa essere sfuggente, è comunque il prerequisito per muoversi senza incertezze. Secondo, visto che non c’è una Thatcher alle viste in Italia, dobbiamo considerare un insieme di disposizioni sui possibili effetti delle privatizzazioni sulla disoccupazione (se essa dovesse aumentare come effetto della ricerca dell’efficienza), sulla possibile concentrazione di mercato, e sulla discriminazione dei prezzi (quest’ultima in particolare per la privatizzazione delle utility). Terzo, occorre superare i problemi normativi. Un esempio importante: le banche, che secondo la legislazione antitrust (l. 287/91) non possono essere acquisite da imprese industriali, ma solo da altre banche, da istituzioni finanziarie non bancarie (Sim, fondi pensione, fondi comuni di investimento, imprese finanziarie), da compagnie assicurative e da individui che non siano imprenditori professionisti. In pratica, siccome in Italia non ci sono virtualmente grandi banche private, gli unici possibili acquirenti tra gli investitori domestici sono le assicurazioni o i singoli individui. Una limitazione molto stringente.
La strategia del Trattato di Maastricht
In ordine logico, non necessariamente temporale, tutti questi passaggi dovrebbero avvenire prima del collocamento. In quel momento, affronteremo la sfida più importante: considerando che una vasta parte delle azioni sarà offerta, almeno inizialmente, agli investitori domestici, come facciamo spazio per questi asset nei loro portafogli? Qui giunge in tutta la sua importanza la necessità che le privatizzazioni siano a complemento di un piano credibile di riduzione del deficit, soprattutto per ridurre la creazione di debito pubblico. Solo se abbiamo successo nel compito di ridurre “continuamente e sostanziosamente” il nostro rapporto tra debito e Pil, come richiesto dal Trattato di Maastricht, troveremo spazio nei portafogli degli investitori. Allo stesso tempo, l’assorbimento di queste nuove azioni può essere accelerato dall’aumento dell’efficienza del nostro mercato azionario e dall’allargamento dello spettro degli intermediari finanziari. Qui il pensiero va subito alla creazione di fondi pensione ma, di nuovo, i fondi pensione sono alimentati dal risparmio privato che da ultimo deve essere accompagnato dal sistema di sicurezza sociale nazionale verso i fondi pensione. Ma un ammanco dei contributi di sicurezza sociale allo schema nazionale implicherebbe di per sé un deficit più elevato. Questo ci porta a una conclusione di policy sui fondi pensione: possono essere creati su una base veramente ampia solo se il sistema nazionale di sicurezza sociale è riformato nella direzione di un sistema meglio finanziato o più equilibrato rispetto a quello odierno.
Il disegno complessivo del disastro
Questa presentazione non era fatta per rispondere alla domanda su quanto possa essere veloce il processo di privatizzazioni – non è il momento giusto per affrontare il tema. L’obiettivo era fornirvi una lista delle cose da considerare per valutare la solidità del processo. La conclusione generale è che la privatizzazione è una delle poche riforme nella vita di un paese che ha assolutamente bisogno del contesto macroeconomico giusto per avere successo. Lasciatemi sottolineare ancora che non dobbiamo fare prima le principali riforme e poi le privatizzazioni. Dovremmo realizzarle insieme. Di certo, non possiamo avere le privatizzazioni senza una politica fiscale credibile, che – ne siamo certi – sarà parte di ogni futuro programma di governo, perché l’aderenza al Trattato di Maastricht sarà parte di ogni programma di governo.
La logica dei mercati
Lasciatemi concludere spiegando, nella visione del Tesoro, la principale ragione tecnica – possono esserci altre ragioni, legate alla visione personale dell’oratore, che vi risparmio – per cui questo processo decollerà. La ragione è questa: i mercati vedono le privatizzazioni in Italia come la cartina di tornasole della dipendenza del nostro governo dai mercati stessi, dal loro buon funzionamento come principale strada per riportare la crescita. Poiché le privatizzazioni sono così cruciali nello sforzo riformatore del Paese, i mercati le vedono come il test di credibilità del nostro sforzo di consolidamento fiscale. E i mercati sono pronti a ricompensare l’Italia, come hanno fatto in altre occasioni, per l’azione in questa direzione. I benefici indiretti delle privatizzazioni, in termini di accresciuta credibilità delle nostre politiche, sono secondo noi così significativi da giocare un ruolo fondamentale nel ridurre in modo considerevole il costo dell’aggiustamento fiscale che ci attende nei prossimi cinque anni.
LE ISTITUZIONI E IL CONFLITTO
a cura di Luigi Longo
Suggerisco la lettura dell’articolo di Marco Della Luna, “Come prevenire un nuovo Euro-golpe” apparso sul sito www.marcodellaluna.info il 29 agosto 2018.
La sua lettura è stimolante perché evidenzia come le istituzioni sono luoghi di conflitto e di gestione del potere (degli agenti strategici sub-dominanti europei) e del dominio (degli agenti strategici pre-dominanti statunitensi).
Bisogna uscire dal campo delle istituzioni come luoghi di interesse generale, come luoghi neutrali dove si curano l’interesse della popolazione e di una nazione; occorre, invece, mettersi nel campo delle istituzioni come parti integranti del conflitto che attraversa la vita sociale di una nazione (con le sue forme di organizzazioni storicamente date) che è inserita nelle relazioni internazionali e nelle dinamiche di conflitto tra le nazioni-potenze che si configurano nelle diverse fasi storiche per il dominio mondiale.
COME PREVENIRE UN NUOVO EURO-GOLPE
di Marco Della Luna
Perché il Quirinale non può contenere il Presidente degli Italiani
Nell’estate del 2018 parecchi editorialisti stanno a congetturare sui possibili modi in cui, probabilmente, per abbattere il governo sovranista e rimetterne su uno europeista e immigrazionista, nel prossimo autunno, in tempo di legge di bilancio, verrà orchestrato un colpo di Stato dai soliti “mercati”, dal duo franco-tedesco, assieme alla BCE, ai “sorosiani”, ai magistrati “progressisti”.
Già i mass media pre-legittimano tale colpo di stato, come lo pre-legittimavano nel 2011, ripetendo a josa il concetto che il pericolo è il sovranismo e l’euroscetticismo, che lo scopo è come vincerli salvando l’integrazione europea, e tacendo completamente sui meccanismi e gli squilibri europei che danneggiano l’Italia a vantaggio di Germania e Francia soprattutto. Si comportano come sicuri che il golpe si farà.
Anche grazie a tali, ricorrenti campagne propagandistiche, l’idea del colpo di Stato degli interessi stranieri col tradimento del Quirinale in loro favore è oramai sentita come qualcosa di rientrante nell’ordine delle cose, di non sorprendente né, in fondo, scandaloso.
In particolare, è chiaro che il Quirinale (la cui cooperazione è indispensabile a un golpe politico, avendo esso la funzione di delegittimare il governo legittimo e legittimare quello illegittimo) è una sorta di rappresentante degli interessi e della volontà delle potenze straniere dominanti sull’Italia; e che la sua forza politica, la sua temibilità e la sua inattaccabilità derivano dal rappresentare esse, non certo dalle caratteristiche personali dei suoi inquilini. Il Quirinale è stato concepito e costruito, nella Costituzione italiana del 1948, al fine di far passare come alto giudizio e indirizzo della più alta Autorità nazionale quelle che invece sono imposizioni di interessi stranieri.
Dico “il Quirinale” e non “il Presidente della Repubblica” perché intendo proprio il Palazzo, come istituzione e ruolo nei rapporti gerarchici tra gli Stati, e non la persona fisica che lo occupa volta dopo volta. L’Italia è uscita dalla 2a Guerra Mondiale non solo sconfitta, ma con una resa incondizionata agli Alleati, e ha così accettato un ruolo subordinato agli interessi dei vincenti, incominciando dalla politica estera, per continuare con quella monetaria e bancaria. Il Quirinale è, costituzionalmente e storicamente, l’organo che ha assicurato la sua obbedienza e il suo allineamento nei molti cambiamenti di governi e maggioranze (corsivo mio, LL)
Certo, rispetto al golpe del 2011, la situazione oggi è diversa, per diverse ragioni:
-perché allora la maggioranza degli italiani voleva cacciare Berlusconi e credeva che cacciarlo avrebbe apportato legalità e progresso, mentre l’attuale governo gode del gradimento di un’ampia maggioranza della popolazione, sicché per rovesciarlo servirebbe molta più violenza di quella bastata nel 2011, oppure bisognerebbe dividere la maggioranza;
-perché da allora la gente ha capito qualcosa dall’esperienza dei governi napolitanici;
-perché Berlusconi non aveva gli appoggi di Washington e Mosca, né un piano B per il caso di rottura con l’UE;
-perché rispetto al 2011 l’eurocrazia ha perso credibilità e forza; perché essa teme le vicine elezioni europee e non può permettersi nuovi soprusi.
Come agire per prevenire un nuovo golpe, dopo tali premesse?
Suggerisco di spiegare alla popolazione il suddescritto ruolo storico e costituzionale del Quirinale, il suo ruolo di garante obbligato di interessi di potenze straniere vincitrici e sopraordinate, spesso in danno agli Italiani. Un ruolo non colpevole proprio perché obbligato, ma che in ogni caso priva il Quirinale della qualità di rappresentante degli Italiani e della autorevolezza, della quasi-sacralità che questa qualità gli conferirebbe. Il Quirinale è piuttosto una controparte dell’Italia.
Già il far entrare questa consapevolezza e questi concetti nella mente e nel dialogo dell’opinione pubblica può indebolire quel potere improprio e nocivo del Quirinale che gli consente di delegittimare i legittimi rappresentanti del popolo, sebbene esso non sia eletto dal popolo ma dalla partitocrazia, e di legittimare la loro illegittima sostituzione; quindi può aiutare la prevenzione di nuovi colpi di palazzo.
Nel tempo, si potrà pensare anche a una riforma nel senso del cancellierato, che dia più potere sul governo al premier, contenendo i poteri politici del Capo dello Stato e il fondo annuo di oltre un miliardo l’anno che egli gestisce – più della Regina Elisabetta; nonché a convertire il palazzo del Quirinale in un museo, trasferendo la sede della presidenza della Repubblica in un luogo dall’aria meno dominante e adatta alle nuove e ridotte competenze.