Il modo americano di fare guerra economica
Washington sta facendo un uso eccessivo delle sue armi più potenti?
By Paul Krugman


L’atrofia dello statecraft americano
Come ripristinare le capacità in un’epoca di crisi
Di Philip Zelikow
Gennaio/Febbraio 2024
Pubblicato il 12 dicembre 2023
Cinta Fosch
Il mondo è entrato in un periodo di forte crisi. Le guerre infuriano in Europa e in Medio Oriente e la minaccia di guerra incombe sull’Asia orientale. Con la Russia, la Cina e la Corea del Nord, gli Stati Uniti devono affrontare tre Stati ostili con armi nucleari e, con l’Iran, un altro sul punto di acquisirle. Al di là dei titoli dei giornali, gli Stati stanno fallendo in Africa, America Latina e Asia sud-occidentale e sono in corso enormi migrazioni. Dopo aver appena superato una pandemia che è stata la crisi più costosa dal 1945, gli Stati Uniti devono ora affrontare altre sfide transnazionali urgenti, come la gestione della transizione energetica in un contesto di deterioramento del clima, il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e un sistema capitalistico globale più sotto pressione di quanto non sia stato per decenni. Ognuna di queste questioni, se spacchettata, presenta una serie di problemi complessi che pochi riescono a comprendere. E su quasi tutte le questioni, che gli americani piacciano o si risentano, le persone nel mondo cercano l’aiuto del governo statunitense, anche solo per organizzare il lavoro.
Gli americani non possono soddisfare questa domanda. La loro offerta di politiche efficaci è limitata. Gli Stati Uniti non hanno l’ampiezza e la profondità di competenze, capacità e know-how nel loro governo contemporaneo. Il problema esiste da decenni, come è stato di volta in volta tristemente evidente. Ciò che è nuovo è il contesto. L’attuale periodo di crisi pone gli Stati Uniti e gli altri Paesi del mondo libero di fronte a una sfida più grande di quella che hanno vissuto in almeno 60 anni. Dovranno coltivare nuove qualità di leadership pratica.
Dire cosa fare è la parte facile. Progettare come farlo è la parte difficile. “Le idee non sono politiche”, osservava Dean Rusk mentre era segretario di Stato americano. “Inoltre, le idee hanno un alto tasso di mortalità infantile”. Un uomo di Stato ancora più esperto, il primo ministro britannico Winston Churchill, ha commentato che “la speranza vola sulle ali, e le conferenze internazionali arrancano in seguito lungo strade polverose”.
Rimanete informati.
Analisi approfondite con cadenza settimanale.
Il “come” è il “mestiere” dello statista. La maggior parte di ciò che il governo degli Stati Uniti fa è distribuire denaro e stabilire regole. Sono relativamente pochi i settori che si occupano di operazioni politiche, soprattutto quelle diplomatiche. Ciò richiede un complesso lavoro di squadra. I funzionari devono padroneggiare le coreografie internazionali, le complessità del diritto e della prassi e una sconcertante varietà di strumenti, culture e istituzioni che attraversano le società. La capacità di fare tutto questo è un’arte in via di estinzione negli Stati Uniti e nel resto del mondo libero. E mentre si affievolisce, al suo posto subentrano le lancette e i luoghi comuni. I funzionari colmano le lacune con riunioni e dichiarazioni.
La limitata disponibilità di una politica statunitense efficace è stata dimostrata tragicamente durante l’epidemia di COVID-19, quando il mondo non è riuscito a creare un’alleanza globale per combattere una pandemia globale. Lo si può vedere oggi in Ucraina, dove il mondo libero sta lottando per sostenere un Paese che combatte una guerra di logoramento. E sta emergendo nella Striscia di Gaza, dove Paesi benintenzionati cercano di aiutare il futuro di Gaza con il suo sostentamento e la sua governance. Senza dubbio ci saranno nuove richieste nei prossimi mesi e anni, e si può discutere su quali di esse Washington e i suoi alleati debbano rispondere. Ma nessuno vuole affrontare un problema e poi fallire. Il successo deve essere definito in modo concreto e pratico. I governi devono mettere in comune in modo più efficace le loro capacità e il loro know-how. Solo così potranno trasformare le speranze in progetti.
L’ERA DELLE EMERGENZE
Tutti e tre i principali partenariati antiamericani degli ultimi cento anni – le potenze dell’Asse nella Seconda Guerra Mondiale, i Paesi comunisti durante la Guerra Fredda e la lega antiamericana di oggi guidata da Cina, Russia e Iran – avevano un nucleo comune. Tutti consideravano gli Stati Uniti (o il Regno Unito ai tempi) come l’ancora di un sistema imperiale dominante che cercava di bloccare le loro aspirazioni. Essi hanno mobilitato altri Paesi che si sentivano a loro volta oppressi. Ma al di là di questo, le partnership non mostravano un piano generale comune. I partner raramente si fidavano l’uno dell’altro. Spesso non si piacevano nemmeno.
Il periodo di forte crisi di questa generazione potrebbe attenuarsi, oppure potrebbe peggiorare notevolmente. La storia delle passate partnership antiamericane umilia le ipotesi compiacenti. Rivela rapidi ricalcoli, svolte veloci, sorprese. Le dittature sono sempre state lacerate da fazioni; le loro intenzioni e i loro piani cambiano improvvisamente, spesso influenzati da dettagli e circostanze apparentemente invisibili. Ciò che è diverso questa volta, rispetto a quelle passate epoche di scontri, è che l’opinione pubblica americana non ha assorbito la gravità dei pericoli e la base industriale del Paese è molto più ristretta e meno agile. Gli Stati Uniti si affidano troppo a polizze assicurative militari poco mirate e non hanno preparato adeguatamente strategie operative plausibili a meno di una guerra diretta.
Nel gennaio 1941, quando gli Stati Uniti erano ancora in pace, il presidente Franklin Roosevelt scrisse a Joseph Grew, suo vecchio amico e compagno di scuola e ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone. “Dobbiamo riconoscere che le ostilità in Europa, in Africa e in Asia sono tutte parti di un unico conflitto mondiale”, scriveva Roosevelt. Ogni parte ha la sua storia. Il presidente sottolineò che “i problemi che dobbiamo affrontare sono così vasti e così interconnessi che qualsiasi tentativo di enunciarli costringe a pensare in termini di cinque continenti e sette mari”. Ha poi proseguito: “Non possiamo stabilire dei piani rigidi e veloci. Ad ogni nuovo sviluppo dobbiamo decidere, alla luce delle circostanze esistenti, quando, dove e come possiamo utilizzare le nostre risorse nel modo più efficace”.
Roosevelt iniziò quindi a raccogliere risorse su scala epica. Il Congresso aveva già ripreso la coscrizione di soldati, marinai e aviatori. All’inizio del 1941, il presidente e la sua squadra convinsero un Congresso aspramente diviso, in un Paese aspramente diviso che non era ancora in guerra, a spendere il dieci per cento del PIL per aiutare gli stranieri. Il denaro fu destinato alle forniture americane per coloro che erano in guerra: Regno Unito, Unione Sovietica e Cina. Il livello equivalente di sforzo oggi sarebbe di circa 2,6 trilioni di dollari, circa 25 volte l’importo che il Presidente Joe Biden ha richiesto nell’ottobre 2023 al Congresso diviso di oggi per l’Ucraina, Israele e altre priorità.
Gli Stati Uniti fanno troppo affidamento su polizze assicurative militari poco mirate.
Gli Stati Uniti e i loro alleati devono ora prepararsi a come potrebbero essere trascinati in quattro guerre diverse – con la Cina, con l’Iran, con la Corea del Nord e con la Russia – e a come questi pericoli potrebbero interagire. L’ipotesi di base della maggior parte dei politici occidentali è che questi rivali siano guidati da regimi fondamentalmente razionali che non correranno il rischio di cercare un cambiamento violento. Questa era l’ipotesi di default un anno prima che la Russia invadesse l’Ucraina. Era l’assunto di default il giorno prima che Hamas invadesse Israele. L’epoca attuale potrebbe rivelarsi un periodo prebellico. Ma americani, europei, giapponesi, sudcoreani e australiani non si stanno coordinando come se fosse così. Nel frattempo, i governi e i media di Cina, Iran e Corea del Nord si sono mobilitati per la guerra. La Russia è già in guerra e si sta preparando per una lunga guerra.
Il livello di conflitto esistente nel mondo è già il più alto da più di una generazione. Basti pensare alla regione che circonda la Striscia di Gaza. Anche prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, la Libia, il Sudan, la Siria e lo Yemen erano già stati sconvolti dal conflitto, con milioni di persone affamate e sfollate. Tutti gli sforzi di mediazione e ricostruzione internazionali per affrontare queste crisi sono andati male. Tutti dimostrano il fallimento dei tentativi di mediazione e di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. In ogni caso, le organizzazioni umanitarie faticano a soddisfare i bisogni e a sostenere il sostegno dei donatori stanchi. Questo conteggio non include gli impegni internazionali in corso in Iraq, Libano e Somalia o nell’Etiopia devastata dalla guerra.
Ci sono poi le richieste in altre regioni e le preoccupazioni transnazionali, come il deterioramento del clima, le rivoluzioni digitali e biologiche e la fragilità della finanza globale. Alcuni di questi problemi si sono aggravati per decenni. Molte delle notizie sulla cooperazione tra il mondo libero sono, ancora una volta, deludenti: problemi nell’orchestrare una transizione energetica globale, con un lavoro frammentato sulle tecnologie verdi, colloqui frustrati sui materiali critici e furiosi disaccordi su come alleggerire gli oneri dei Paesi poveri.
LEZIONI PERSE
In caso di emergenza, le persone hanno bisogno di un’azione efficace. Nessun Paese è più sollecitato degli Stati Uniti a fornirla. Il Paese può sembrare terribilmente potente, in statiche enumerazioni di massa economica o militare, ma il potere applicato – il potere effettivo nel mondo – è qualcosa di molto diverso. È più simile alla misura dell’energia cinetica, che si calcola con la formula 1/2 mv². Il valore della massa viene dimezzato. Il valore della velocità è al quadrato. In statistica, la competenza è la velocità.
La competenza è una funzione delle capacità e del know-how. Quando si tratta di fare cose nel mondo, l’offerta degli americani di entrambe è limitata da due condizioni strutturali profonde. La prima è presente nel Paese, in misura variabile, fin dalla sua fondazione: un senso di distacco. L’America è solitamente distaccata dai problemi esteri, spesso a grande distanza, e anche gli americani si sentono distaccati. Fortunati per la loro geologia e ampiezza continentale, gli Stati Uniti non sono mai dipesi molto dal commercio estero o dalle materie prime straniere. L’interesse pubblico per l’impegno all’estero – politico, militare o economico – è limitato. Più della metà degli americani non possiede un passaporto. Solo un terzo di loro sa trovare Taiwan su una mappa.
Il secondo fattore che limita l’impegno globale degli Stati Uniti è più recente: il repertorio ormai limitato di ciò che possono fare all’estero. Tale repertorio si è drammaticamente ampliato, come del resto è accaduto per molte altre cose, durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda. A metà del XX secolo, i funzionari statunitensi erano famosi in tutto il mondo per il loro know-how, stimati come risolutori di problemi intraprendenti e fantasiosi, in grado di fare quasi tutto in guerra o in pace. Gli Stati Uniti avevano contribuito a organizzare il D-Day, a costruire la prima bomba atomica, a sfamare milioni di persone tra le rovine dell’Europa e dell’Asia, a salvare l’Europa occidentale con il Piano Marshall e a superare il blocco sovietico con il ponte aereo di Berlino. Washington ha persino contribuito a debellare il vaiolo.
Queste e altre azioni straordinarie hanno attinto alla cultura eccezionale e decentralizzata della risoluzione dei problemi del business americano e della pianificazione civica emersa nel XX secolo. La disciplina paradigmatica delle imprese americane dell’epoca era l’ingegneria. Questa cultura del fare ha migliorato il modo in cui la politica è stata progettata e gestita e ha incoraggiato una forte abitudine al lavoro scritto del personale. Era emersa da vasti e stressanti tentativi ed errori, con molte rivalità e confusione.
Il Segretario di Stato americano Antony Blinken mentre parla alle Nazioni Unite a New York, agosto 2023
Eduardo Munoz / Reuters
Le generazioni sono passate, il secolo è finito e poco è stato fatto per preservare o insegnare le vecchie abilità e routine. Le analisi operative scritte sono state sostituite da un numero maggiore di riunioni, con minori sforzi per registrare e riflettere su ciò che era stato detto. A differenza dei metodi insegnati per l’ingegneria, le tecniche di lavoro del personale politico sono raramente riconosciute o studiate. Non esiste un canone con le norme della pratica professionale. Il policymaking americano è diventato procedurale, meno basato sull’ingegneria deliberata e più su congetture improvvisate e abitudini burocratizzate.
Nel frattempo, mentre le montagne del confronto tra superpotenze si sgretolavano con la fine della Guerra Fredda, i contrafforti rimasti cominciavano a sembrare montagne. La NATO e la vittoria della Croazia sulla piccola Serbia nel 1995 hanno alimentato anni di arroganza. Questa sensibilità, mescolata alla grande paura dopo l’11 settembre, ha inaugurato gli anni della nemesi degli Stati Uniti. Castigato, il già esile interesse del pubblico americano per l’impegno all’estero si assottigliò. La corrente protezionistica divenne un fiume in piena. Nel mondo degli studiosi, la moda era quella di criticare la fame di impero degli Stati Uniti, il loro razzismo endemico, il loro militarismo senza fine e il loro capitalismo vorace. Il corollario implicito era che se il governo statunitense era una forza così maligna nel mondo, allora sarebbe stato meglio per tutti se fosse rimasto a casa.
Anche se la comunità di intelligence statunitense è cresciuta e si è sviluppata, la capacità del governo americano di analizzare e risolvere i problemi non è cresciuta. La sua parte politica è diventata debole di personale e scarsamente formata; i funzionari non sono stati quasi mai istruiti sul lavoro politico. Quelli che eccellevano, di solito avevano imparato da soli. Quando c’era bisogno di operazioni, si dovevano assumere appaltatori, che spesso non facevano altro che aggravare i problemi. Sebbene i componenti dell’esercito fossero ancora potenti, la sua struttura di forza – le costosissime portaerei, gli squadroni di aerei e le brigate di truppe di stanza in patria – divenne più simbolica e meno rilevante. Le sanzioni economiche divennero lo strumento di prima istanza. I comunicati e i luoghi comuni coprivano il resto.
CONTRO LA VAGHEZZA
Ma i palliativi di carta non risolveranno le attuali emergenze del mondo. Le generiche dottrine di “moderazione” o “realismo” segnalano atteggiamenti, non risposte. George Marshall lo sapeva bene. Nell’aprile del 1947, Marshall, appena nominato Segretario di Stato e reduce da un lungo viaggio in Europa, tenne un discorso radiofonico nazionale per illustrare al popolo americano l’entità delle riparazioni necessarie nel continente. Li implorò di essere pazienti. I problemi che riguardano direttamente il futuro della nostra civiltà non possono essere risolti con discorsi generici o formule vaghe, con quelle che Lincoln chiamava “astrazioni perniciose””, ha ammonito Marshall. “Richiedono soluzioni concrete per questioni definite ed estremamente complicate”. Lavorando con uno straordinario gruppo di leader europei, Marshall e il suo team trovarono quelle soluzioni, progettando un sistema straordinario che utilizzava i beni americani per cementare nuovi partenariati europei e aiutare i governi europei a raccogliere fondi per la ricostruzione.
In mezzo agli spettacolari fallimenti recenti in Iraq e poi in Afghanistan, vale la pena notare anche alcune storie di successo recenti. Consideriamo il settore militare. Tra il 2015 e il 2019, dopo un anno di tentennamenti, dopo aver imparato dai precedenti passi falsi e con un numero relativamente basso di truppe, gli Stati Uniti hanno contribuito a guidare una straordinaria coalizione straniera che ha liberato le terre invase dallo Stato Islamico, o ISIS, nell’Iraq settentrionale e nella Siria orientale.
Nel campo della salute globale, gli Stati Uniti e i loro partner hanno creato, a partire dal 2003, un piano di emergenza per la lotta all’AIDS, noto come PEPFAR, e il Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria. Progettati tenendo conto delle lezioni dei fallimenti passati, questi programmi hanno ottenuto un ampio sostegno al Congresso e in tutto il mondo. Hanno salvato milioni di vite. Oppure guardiamo alla diplomazia. A partire dal 2005, gli Stati Uniti hanno orchestrato un complesso sforzo globale per accettare lo status nucleare dell’India e sciogliere una generazione di restrizioni. Questa diplomazia ha trasformato le relazioni e aperto il commercio di tecnologie avanzate con quello che oggi è il Paese più popoloso del mondo.
Anche gli Stati Uniti sono stati autori di storie di successo economico. Molti giustamente incolpano la sua incapacità di controllare la speculazione di asset ad alta leva finanziaria per la crisi finanziaria globale. Ma dovrebbero anche riconoscere che, quando la crisi si è diffusa in Europa, i leader americani ed europei hanno fatto tutto il necessario per arrestarla, sostenendo garanzie finanziarie per evitare i default sovrani e impedire che l’eurozona precipitasse nel baratro. Il collasso continentale avrebbe avuto ripercussioni sugli Stati Uniti, e quindi questo successo potrebbe aver impedito il ripetersi della sequenza che ha prodotto la Grande Depressione. Più di recente, prima dell’invasione russa dell’Ucraina, pochi avrebbero previsto che l’Europa, e in particolare la Germania, avrebbe mai potuto staccarsi dall’energia russa. Eppure, dopo l’invasione, una manciata di leader europei, soprattutto tedeschi, ha lavorato con gli americani e ha raccolto la sfida.
Questi e altri successi dimostrano un teorema di possibilità. I governi possono ancora produrre risultati straordinari. Ma per farlo è necessario concentrarsi maggiormente sul “come”. Consideriamo tre emergenze contemporanee come esempi: i fallimenti nella guerra contro il COVID-19, la pericolosa situazione attuale in Ucraina e la sfida a Gaza.
LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE SULLE PANDEMIE
A giudicare dal suo tributo umano ed economico, la pandemia COVID-19 è stata una guerra globale. Sono morte più di 20 milioni di persone. Gli Stati Uniti hanno speso, in termini di politica fiscale discrezionale, circa 5.000 miliardi di dollari. Ma nel gennaio 2020, pochi comprendevano la pandemia che si stava sviluppando. Il cosiddetto playbook sulla pandemia, preparato dall’amministrazione Obama, in realtà non prevedeva alcuno schema. Non c’era un “come”. Non spiegava cosa fare. Quando si trattava di contenere la COVID-19, il libro degli schemi era una pagina bianca.
Quello che i mesi e gli anni successivi avrebbero messo in luce è stato, come in Afghanistan e in Iraq, l’erosione delle capacità operative di gran parte del governo statunitense e il debole affidamento a consulenti di gestione per colmare queste lacune. All’inizio è apparso chiaro che il settore pubblico non disponeva delle risorse necessarie – farmaci, maschere, vaccini – da parte del settore privato. Le scelte su cosa fare erano relativamente facili: quasi tutti volevano test, terapie efficaci e vaccini. I problemi sono sorti nel “come”.
Il presunto successo degli Stati Uniti nella pandemia è stata la gestione da parte del Dipartimento della Difesa dell’operazione Warp Speed, una partnership pubblico-privata per sviluppare e distribuire vaccini. Ma questo successo è più celebrato che compreso. Grazie alle scelte prebelliche di alcuni funzionari dotati, la ricerca e lo sviluppo del coronavirus erano già in fase avanzata quando è scoppiata la pandemia. Il governo degli Stati Uniti e altri avevano già sponsorizzato i primi lavori sulla tecnologia dell’RNA messaggero. Iniziativa improvvisata da burocrati di carriera, esperti esterni e fanatici dell’amministrazione, l’Operazione Warp Speed non ha ottenuto il suo principale successo nello sviluppo del vaccino. Piuttosto, è riuscita ad acquisire e produrre i vaccini su scala. Ha gestito un portafoglio di investimenti in diversi progetti per coprire le sue scommesse sulla tecnologia dell’mRNA non provata e ha pianificato la distribuzione nazionale attraverso le farmacie degli Stati Uniti.
Tuttavia, la produzione di massa di vaccini non è stata integrata in strategie per coordinare la produzione e la distribuzione globale o per convincere le persone a sottoporsi ai vaccini. Le pandemie globali, come le guerre globali, devono essere combattute da alleanze globali. Solo pochi Paesi hanno prodotto vaccini, ma non hanno mai costruito uno sforzo bellico alleato contro il virus. La deludente performance dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che non ha avvertito dell’epidemia né ha coordinato una risposta comune, non è stata la causa di questo fallimento. Costretta dai suoi membri, l’OMS ha rispecchiato il loro fallimento.
I palliativi di carta non risolveranno le attuali emergenze del mondo.
In risposta ai decenni precedenti di scarso lavoro governativo sui vaccini, i filantropi hanno cercato di colmare il vuoto creando insolite istituzioni non profit come Gavi, la Vaccine Alliance, e CEPI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Alcuni dei responsabili politici che hanno promosso l’Operazione Warp Speed volevano utilizzare queste organizzazioni non profit e organizzare un vero e proprio sforzo globale. Quando la proposta dell’Operazione Warp Speed è arrivata al Presidente Donald Trump nell’aprile 2020, i funzionari statunitensi hanno accantonato la costruzione di una coalizione globale e hanno scelto un approccio nazionale. Per reazione, le organizzazioni non profit e i loro sostenitori hanno dovuto improvvisare rapidamente una struttura globale. Aiutati da Francia e Singapore, hanno collaborato con l’OMS per creare l’iniziativa COVID-19 Vaccines Global Access, o COVAX, per distribuire i vaccini in tutto il mondo, in base alle necessità.
A maggio 2020, esistevano quindi due strutture parallele: Operazione Warp Speed e COVAX. Il COVAX è rimasto immediatamente indietro, impiegando mesi per raccogliere fondi. Osservando la scelta degli Stati Uniti, i Paesi europei decisero che dovevano imitare quell’approccio. Il Regno Unito si mise in proprio con un programma ben progettato. L’UE cercò di conciliare i desideri delle autorità sanitarie dei 27 membri. Ma i Paesi europei si stavano spazientendo per la lentezza della Commissione Europea, il braccio esecutivo dell’UE, nell’organizzare uno sforzo comune per i vaccini. Poco dopo la presentazione dell’Operazione Warp Speed, quattro di loro – Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi – hanno annunciato che avrebbero proceduto da soli. I programmi nazionali, più interessati a se stessi, sarebbero quindi diventati il modello.
Per certi versi, la storia è andata bene. I candidati vaccini a base di mRNA funzionarono. L’industria privata si è attivata e ha prodotto dosi di vaccino su scala sorprendente. Alla fine del 2021, l’offerta di vaccini saturava la domanda globale. Sebbene sia stato improvvisato praticamente da un giorno all’altro, il COVAX è stato il motivo principale per cui una frazione sostanziale di persone nei Paesi a basso reddito è stata vaccinata, con l’aiuto dell’UNICEF e di altre organizzazioni. Tuttavia, spinto in fondo alla fila per l’approvvigionamento, il COVAX ha di fatto perso almeno un anno di possibili progressi, lottando invece contro l’accaparramento dei vaccini, le restrizioni all’esportazione e i problemi con i produttori. Questi ritardi hanno causato milioni di ospedalizzazioni e morti evitabili.
Il successo dell’operazione Warp Speed è più celebrato che compreso.
Il nazionalismo dei vaccini non è una sorpresa. In una coalizione globale, i principali produttori non ignoreranno le esigenze della propria popolazione. Ma una coalizione avrebbe potuto pianificare, fin dall’inizio, di tenere visibilmente conto delle esigenze di tutto il mondo. In assenza di tale pianificazione, i Paesi hanno accumulato le proprie forniture fino a quando non sono stati sicuri di avere un’eccedenza, a quel punto alcuni hanno offerto tale eccedenza al COVAX. Il problema è che ci vuole tempo per organizzare campagne di educazione al vaccino, reti di distribuzione e strutture di stoccaggio a freddo e per trovare persone che facciano questo lavoro.
Nel breve periodo, la strategia dei vaccini “America first” di Trump sembrava essere vantaggiosa per gli americani. Poi si è ritorta contro. Le disposizioni “Buy American”, che hanno accompagnato l’uso da parte del governo delle autorità previste dal Defense Production Act per dire alle aziende statunitensi cosa produrre, hanno finito per spingere la maggior parte della produzione per il mercato globale al di fuori degli Stati Uniti. La frammentazione degli approcci nazionali alla selezione dei candidati ai vaccini e alla gestione delle catene di approvvigionamento per la produzione dei vaccini ha creato inutili attriti e duplicazioni, sprechi di investimenti e trattative intricate con l’industria. Si è persa l’opportunità di coordinare in modo più intelligente gli enormi investimenti, gli acquisti e le catene di fornitura nazionali. Il risultato finale ha messo le aziende farmaceutiche al posto di comando.
La guerra contro il COVID-19 si è affidata a poche grandi potenze per aiutare il resto del mondo. Gli Stati Uniti, i principali Paesi europei e le grandi potenze asiatiche non hanno mai unito le forze in modo sufficientemente efficace. Insieme al resto del mondo, ne hanno pagato il prezzo. Non c’è motivo di credere che i pericoli biologici diminuiranno, anzi potrebbero peggiorare. Eppure i politici hanno assorbito poche lezioni su come fare meglio la prossima volta.
LA LOTTA PER L’UCRAINA
Alla fine del 2022, era chiaro che la guerra in Ucraina non sarebbe finita rapidamente. Giustamente ispirati dall’eroica resistenza degli ucraini, molti commentatori e funzionari hanno sottovalutato la Russia. Gran parte del dibattito verteva sul fatto se l’Ucraina avrebbe dovuto raggiungere la vittoria o accettare una situazione di stallo, o se certi sistemi d’arma sarebbero stati gli ingredienti magici di cui il Paese aveva bisogno per vincere. Nel corso del 2023, tuttavia, le condizioni militari, sociali, economiche e finanziarie dell’Ucraina sono diventate sempre più gravi e insostenibili. E sebbene la Russia si sia preparata per una lunga guerra, i sostenitori dell’Ucraina non l’hanno fatto.
Come per la pandemia, la parte del “cosa fare” sembra facile, poiché i cittadini del mondo libero generalmente sostengono la sopravvivenza dell’Ucraina come Paese libero con un futuro pieno di speranza. Sicuramente, si pensa, le risorse e le economie combinate della coalizione possono superare ciò che la Russia e i suoi amici possono fare. Tuttavia, ancora una volta, ciò che emerge è il problema del “come”. Ancora una volta, il mondo libero non ha riunito e mobilitato adeguatamente le proprie risorse.
All’inizio della guerra, i Paesi del G-7 hanno congelato circa 300 miliardi di dollari di attività finanziarie statali russe detenute nelle loro valute. Mai nella storia un aggressore ha lasciato una somma così immensa nelle mani dei Paesi feriti dalla sua aggressione. Nessuno dei membri del G-7 dubita che la Russia abbia commesso le più gravi violazioni del diritto internazionale o che sia legalmente obbligata a risarcire coloro che ha danneggiato. Nessuno può negare che l’economia ucraina sia in condizioni critiche. La questione di cosa fare sembra chiara. Eppure, mentre la guerra termina il suo secondo anno, questa enorme cassaforte di denaro russo, che può cambiare le carte in tavola, rimane praticamente intatta. Non esiste uno scenario plausibile in cui possa tornare in Russia. Le risorse potenzialmente decisive giacciono lì, inerti e inutili per chiunque. Perché?
Per troppo tempo, i pochi funzionari competenti si sono occupati di altre questioni e sono stati scoraggiati da una miriade di argomentazioni legali e finanziarie confuse e spesso superficiali. In privato, alcuni hanno confidato il timore di ritorsioni russe contro le aziende dei loro Paesi. Nel caso tedesco, alcuni temono che i nazionalisti polacchi possano chiedere alla Germania ulteriori risarcimenti per la Seconda Guerra Mondiale.
Un proiettile di artiglieria vicino a Donetsk, Ucraina, novembre 2023
Alina Smutko / Reuters
Tutte queste argomentazioni si stanno lentamente risolvendo grazie alla riscoperta da parte dei giuristi del diritto internazionale della responsabilità dello Stato e delle sue contromisure. Il prossimo passo è la progettazione di un monumentale programma di recupero europeo, ancorato al recupero dell’Ucraina. Tale programma dovrebbe avere due dimensioni. Una è di natura politica. L’Occidente dovrebbe sostenere la ricostruzione e la ripresa in diversi settori, collegando la spesa alle riforme ucraine che faciliterebbero anche il processo di adesione dell’Ucraina all’UE. L’altra dimensione sarebbe un processo sostanziale e minuzioso di richiesta di risarcimento da parte dell’Ucraina e di altri enti statali e privati danneggiati dagli atti illeciti della Russia a livello internazionale, comprese le aziende espropriate e i Paesi poveri vittime degli shock dei prezzi. Il lavoro per istituire questo enorme programma di recupero è appena iniziato.
Per contro, il programma di assistenza militare per l’Ucraina sembrerebbe essere la grande storia di successo. In parte lo è. Ma è in fase di rallentamento. La storia pubblica è dominata dalle discussioni su quali armi inviare all’Ucraina. La vera storia, tuttavia, riguarda il “come” trovare abbastanza armi per cominciare. In teoria, la quantità di armi inviate all’Ucraina dovrebbe essere sufficiente e accessibile se tutti i partner dell’Ucraina mettessero insieme in modo efficiente le loro potenziali risorse e capacità industriali. Questa efficiente messa in comune di risorse non sta avvenendo. A parte le consuete sfide del trasporto, dell’addestramento e della manutenzione che si moltiplicano con ogni nuovo sistema donato, cinque grandi fattori sembrano paralizzare lo sforzo, anche se il Congresso stanzierà i fondi necessari.
In primo luogo, la maggior parte dell’aiuto è venuto dalla riduzione delle scorte. Ormai le branche dell’esercito americano hanno inviato tutte le attrezzature che considerano usa e getta e stanno proteggendo il resto. Spingerli a cedere di più significa fare difficili compromessi tra i rischi. All’inizio dell’era del Lend Lease, questi compromessi venivano spesso risolti alla Casa Bianca, spesso da Roosevelt stesso.
In secondo luogo, le scorte europee erano spesso più utili all’Ucraina, perché gli europei avevano accumulato più scorte. Queste scorte sono state esaurite. Gli alleati degli Stati Uniti in Europa sono in ansia. Sono stati promessi rifornimenti che non sono in vista, mentre si formano code che guardano al 2030.
Lo sforzo di mobilitare risorse per aiutare l’Ucraina è una tragedia.
In terzo luogo, la base industriale della difesa statunitense non può espandersi abbastanza rapidamente per far fronte alle emergenze del prossimo anno o due. Questo pone l’accento su una rapida produzione di massa di sistemi difensivi relativamente poco costosi, come i droni. Questi nuovi sistemi vengono sviluppati da nuovi produttori. Il Dipartimento della Difesa non ama acquistare da nuovi produttori. Non sono “programmi di registrazione”, nel linguaggio del Pentagono, e quindi non hanno una burocrazia di acquisizione associata. Negli anni necessari per raggiungere questa soglia, i nuovi produttori spesso muoiono o vengono acquisiti. Anche se sopravvivono e ricevono un contratto, spesso devono affrontare una selva di controlli sulle esportazioni nell’ambito del Regolamento sul Traffico Internazionale di Armi, un regime governativo statunitense che è un retaggio della Guerra Fredda. L’Ucraina non ha tutto questo tempo.
In quarto luogo, si potrebbe fare molto se il denaro statunitense potesse essere usato più liberamente, anche dall’Ucraina, per acquistare droni e altre armi necessarie da fornitori non americani. Il processo di acquisizione del Pentagono rende difficile spendere i dollari della difesa per gli stranieri. Le aziende statunitensi più influenti preferiscono che le cose rimangano così. Gli americani non sono soli in questo: diversi alleati degli Stati Uniti hanno abitudini comprensibili di protezionismo dell’industria della difesa. Ma queste barriere nazionali sono un lusso in tempo di pace. Nella Seconda Guerra Mondiale, il leggendario P51 Mustang, un caccia di fabbricazione americana, volava con un motore britannico. I leader dovrebbero cambiare radicalmente il modo di acquistare in questo periodo di crisi, riconoscendo che i risultati potrebbero essere vantaggiosi per tutti, anche dal punto di vista finanziario.
In quinto luogo, i grandi appaltatori della difesa non amplieranno la loro base produttiva senza contratti pluriennali. Ma anche se li ottenessero, la base industriale americana è poco flessibile. Gli appaltatori devono inoltre affrontare colli di bottiglia nelle forniture di alcuni componenti critici. La sfida a lungo termine torna quindi all’obiettivo di mettere in comune le risorse del mondo libero. Le basi industriali al di fuori degli Stati Uniti, compresa la stessa Ucraina, sono ancora più carenti.
Lo sforzo di mobilitare risorse per aiutare l’Ucraina è una tragedia. È tragica non solo per le sofferenze degli eroici ucraini. È tragica anche perché alcuni membri del governo statunitense stanno valorosamente cercando di risolvere questi problemi di “come”, sia che sbattano sul tavolo del quartier generale dell’esercito americano a Wiesbaden, in Germania, dove i partner dell’Ucraina cercano di coordinare il loro aiuto militare, sia che lo facciano alla Casa Bianca. Tuttavia, in una nuova era di emergenze, scoprono che la maggior parte delle persone, nella maggior parte dei governi, continua a condurre gli affari come al solito.
GOVERNARE GAZA
La Striscia di Gaza è un problema di politica internazionale da 75 anni. Dal 1948, gli obiettivi internazionali sono stati chiari e limitati: aiutare i palestinesi e prevenire la guerra. Le incursioni da Gaza e le rappresaglie israeliane sono state parte della spirale di violenza che ha portato alla prima occupazione israeliana di Gaza nel 1956. La comunità internazionale ha risposto brillantemente, mostrando alcune delle capacità e dell’energia che l’Occidente era in grado di comandare in quell’epoca.
Nel giro di una settimana, nel novembre 1956, il Segretario generale delle Nazioni Unite Dag Hammarskjold e il suo team, tra cui il diplomatico americano Ralph Bunche, crearono la Forza di emergenza delle Nazioni Unite, una coalizione guidata dal Canada e dall’India e con un forte sostegno da parte degli Stati Uniti. La leadership delle Nazioni Unite e questi tre Paesi guidarono il lavoro. Il Presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower sostenne la strategia dell’UNEF fin dall’inizio, ma rimandò all’India e al Canada il compito di fornire la forza militare. I palestinesi di Gaza si sentivano ancora in guerra con Israele. Ma non ci fu nessuna guerra. L’UNEF mantenne effettivamente la pace sul confine tra Gaza e Israele per dieci anni. Quando la forza fu ritirata nel 1967 su richiesta dell’Egitto, seguì rapidamente la guerra e poi 38 anni di governo militare israeliano.
Nel 2005, quando Israele si è ritirato, gli attori esterni hanno sperato che Gaza fosse governata dall’Autorità Palestinese e diventasse parte di uno Stato palestinese, compresa la Cisgiordania, disposto a svilupparsi pacificamente accanto a Israele. Questa strategia per sostituire l’occupazione israeliana e risolvere il problema della sicurezza è fallita. Hamas, un movimento militare in guerra con Israele, ha poi preso il controllo di Gaza nel 2007, cacciando l’Autorità palestinese. Ha ripreso la guerra, culminata con i sanguinosi raid su Israele del 7 ottobre.
Gli Stati Uniti non saranno e non dovrebbero essere centrali nel governo di Gaza.
Una proposta comune per il futuro di Gaza, che gli Stati Uniti hanno appoggiato, è quella di utilizzare l’attuale guerra per istituire un’AP riconfigurata. La nuova AP sarebbe più competente e legittima di quella attuale, che ha sede in Cisgiordania. Sostituirebbe Hamas e rinnoverebbe i progressi verso la soluzione dei due Stati. Si tratta di un riavvio dell’obiettivo originale perseguito dopo il 2005. All’epoca lavoravo al Dipartimento di Stato e mi occupavo delle scelte politiche e dei negoziati tra Israele e l’Autorità palestinese sul futuro di Gaza e della statualità palestinese. Il “come” di questa strategia è molto più difficile ora. La paura e l’odio reciproci si sono intensificati. Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania si sono moltiplicati. È più probabile che un’Autorità palestinese democraticamente legittima rispecchi Hamas piuttosto che sostituirla. E le capacità e il know-how americani sono più limitati, anche a causa di altre priorità statunitensi.
Per molti, l’attuale crisi a Gaza sembra richiedere un ruolo centrale per gli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti non saranno e non dovrebbero essere centrali nel governare Gaza. Dovrebbero svolgere un ruolo secondario, al massimo, nel fornire aiuti e assistenza alla ricostruzione della Striscia. Potrebbero avere capacità e know-how per aiutare a prevenire futuri attacchi da Gaza contro Israele, ma qualsiasi regime di controllo marittimo e commerciale per arginare il flusso di armi verso Gaza dovrebbe ovviamente essere multilaterale. Come per gli sforzi in Libia, Sudan, Siria e Yemen, i colloqui su Gaza coinvolgono già le Nazioni Unite, un gruppo di Stati occidentali interessati e un gruppo di Stati musulmani interessati.
Mentre gli Stati Uniti si pronunciano su obiettivi generali, l’approccio migliore a Gaza inizierebbe con l’esaminare il menu di soluzioni plausibili sul terreno: nella governance, nel sostentamento e nella sicurezza. I funzionari dovrebbero lavorare sodo sui disegni politici che queste soluzioni potrebbero comportare. Ognuna di esse sarà complessa. Una volta effettuata una parte dell’analisi, dovrebbero chiedersi chi nel mondo possiede beni, conoscenze o persone che possono contribuire a rendere praticabile uno di questi progetti o che possono incentivare coloro che possono farlo. Poi, i responsabili politici dovrebbero vedere dove, tra gli altri Paesi, entrano in gioco gli Stati Uniti. Infine, dovrebbero progettare e difendere il contributo degli Stati Uniti.
ATTO DI RECUPERO
In tutto il mondo libero, l’attuale periodo di crisi ha messo in evidenza lo squilibrio tra le istituzioni di cui disponeva e la qualità degli sforzi di cui ha bisogno ora. I dibattiti pubblici sugli interessi nazionali sono in gran parte scollegati dalle questioni pratiche. A medio termine, il governo statunitense e i suoi partner devono verificare se le loro istituzioni – soprattutto quelle civili che si occupano di finanza, commercio, tecnologia e aiuti umanitari – sono davvero adatte allo scopo. Le persone si incontrano continuamente, ma si sforzano di fare le cose. Alla fine del 2023, la parte economica del governo statunitense stava intraprendendo azioni protezionistiche che sabotavano la cooperazione con gli alleati in materia di tecnologia verde, materiali critici e gestione comune della rivoluzione digitale, nello stesso momento in cui Biden affermava di voler riunire il mondo libero.
Il servizio estero degli Stati Uniti potrebbe essere triplicato e ripensato su base interamente governativa, con una formazione rinnovata, e i costi sarebbero pari a un errore di arrotondamento nel bilancio federale complessivo. Dall’altra parte dell’Atlantico, l’UE dovrebbe sviluppare una migliore strategia di crescita, con una Commissione europea semplificata e processi decisionali più efficaci da parte del Consiglio europeo, il comitato direttivo degli Stati membri dell’UE. Ma l’esperimento europeo di una politica estera comune non ha avuto successo e i governi nazionali devono assumersi le loro maggiori responsabilità in questo periodo di crisi. Per quanto riguarda il potere militare, l’eccessiva dipendenza da un piccolo numero di sistemi americani estremamente costosi e squisiti sembra obsoleta e inaccessibile, persino per gli Stati Uniti. La guerra in Ucraina ha incoraggiato il Pentagono a fare grandi scommesse, ad esempio istituendo la Replicator Initiative, che dovrebbe produrre in massa e mettere in campo migliaia di armi che utilizzano tecnologie emergenti.
Nel prossimo anno o due, se l’Asia orientale rimarrà relativamente tranquilla e la guerra in Medio Oriente non si allargherà all’Iran, l’andamento della guerra in Ucraina potrebbe essere l’indicatore più importante. In quel conflitto si prospetta una rara opportunità. Sono disponibili enormi risorse, grazie all’eccessiva fiducia dell’aggressore nel lasciare centinaia di miliardi di dollari e di euro in Stati rispettosi della legge. Un programma di recupero di portata storica potrebbe dare all’Ucraina il futuro che il suo popolo desidera, indipendentemente da dove finirà la linea di battaglia. Le risorse potrebbero alleggerire gli oneri dell’allargamento dell’UE e rinvigorire il progetto. Fare bene il lavoro è un’enorme sfida di progettazione politica. Ma una lezione del Piano Marshall è che il successo genera successo.
Il talento operativo che i politici occidentali hanno dimostrato nel ventesimo secolo non era nei loro geni. È stato l’accumulo di un’esperienza duramente acquisita e di una cultura che ha rafforzato la professionalità pratica, comprese le nuove e difficili abitudini di cooperazione con i partner internazionali. C’è solo un modo per recuperare queste abilità: esercitarle di nuovo.
PHILIP ZELIKOW è Senior Fellow presso la Hoover Institution dell’Università di Stanford. Storico, ex diplomatico statunitense ed ex direttore esecutivo della Commissione sull’11 settembre, ha lavorato per cinque amministrazioni presidenziali.
ll sito www.italiaeilmondo.com non fruisce di alcuna forma di finanziamento, nemmeno pubblicitaria. Tutte le spese sono a carico del redattore. Nel caso vogliate offrire un qualsiasi contributo, ecco le coordinate: postepay evolution a nome di Giuseppe Germinario nr 5333171135855704 oppure iban IT30D3608105138261529861559 oppure PayPal.Me/italiaeilmondo Su PayPal, ma anche con il bonifico su PostePay, è possibile disporre eventualmente un pagamento a cadenza periodica, anche di minima entità, a partire da 2 (due) euro (pay pal prende una commissione di 0,52 centesimi)

Supponiamo che un’azienda del Perù voglia fare affari con un’azienda della Malesia. Non dovrebbe essere difficile per le aziende concludere un accordo. L’invio di denaro attraverso i confini nazionali è generalmente semplice, così come il trasferimento internazionale di grandi quantità di dati.
Ma c’è una fregatura: che le aziende se ne rendano conto o meno, le loro transazioni di informazioni e dati finanziari saranno quasi certamente indirette e passeranno probabilmente attraverso gli Stati Uniti o istituzioni su cui il governo americano ha un controllo sostanziale. In questo caso, Washington avrà il potere di monitorare lo scambio e, se lo desidera, di bloccarlo – in altre parole, di impedire alla società peruviana e a quella malese di fare affari tra loro. In realtà, gli Stati Uniti potrebbero impedire a molte aziende peruviane e malesi di commerciare beni in generale, tagliando in gran parte i Paesi fuori dall’economia internazionale.
Parte di ciò che è alla base di questo potere è ben noto: gran parte del commercio mondiale è condotto in dollari. Il dollaro è una delle poche valute accettate da quasi tutte le principali banche e certamente la più utilizzata. Di conseguenza, il dollaro è la valuta che molte aziende devono utilizzare se vogliono fare affari internazionali. Non esiste un vero e proprio mercato in cui l’azienda peruviana possa scambiare i soles peruviani con i ringgit malesi, per cui le banche locali che facilitano questo commercio di solito usano i soles per comprare i dollari statunitensi e poi i dollari per comprare i ringgit. Per farlo, però, le banche devono avere accesso al sistema finanziario statunitense e devono seguire le regole stabilite da Washington. Ma c’è un altro motivo, meno noto, per cui gli Stati Uniti detengono un potere economico schiacciante. La maggior parte dei cavi in fibra ottica del mondo, che trasportano dati e messaggi in tutto il pianeta, passa attraverso gli Stati Uniti. E dove questi cavi approdano negli Stati Uniti, Washington può monitorare il loro traffico – in pratica registrando ogni pacchetto di dati che consente alla National Security Agency di vederli. Gli Stati Uniti possono quindi facilmente spiare ciò che fanno quasi tutte le aziende e tutti gli altri Paesi. Possono determinare quando i loro concorrenti minacciano i loro interessi ed emettere sanzioni significative in risposta.
Lo spionaggio e le sanzioni di Washington sono il tema di Underground Empire: How America Weaponized the World Economy, di Henry Farrell e Abraham Newman. Questo libro rivelatore spiega come Washington sia arrivata a comandare un potere così imponente e i molti modi in cui impiega questa autorità. Farrell e Newman raccontano in dettaglio come l’11 settembre abbia spinto gli Stati Uniti a iniziare a usare il loro impero e come le sue numerose parti costitutive si siano unite per limitare la Cina e la Russia. Dimostrano che, sebbene gli altri Stati possano non gradire le reti di Washington, sfuggirvi è estremamente difficile.
Gli autori dimostrano anche come, in nome della sicurezza, gli Stati Uniti abbiano creato un sistema di cui spesso si abusa. “Per proteggere l’America, Washington ha lentamente ma inesorabilmente trasformato le fiorenti reti economiche in strumenti di dominio”, scrivono Farrell e Newman. E come il loro libro chiarisce, gli sforzi degli Stati Uniti per dominare possono causare danni enormi. Se Washington utilizza i suoi strumenti troppo spesso, potrebbe spingere altri Paesi a rompere l’attuale ordine internazionale. Gli Stati Uniti potrebbero spingere la Cina a tagliarsi fuori da gran parte dell’economia mondiale, rallentando la crescita globale. E Washington potrebbe usare la sua autorità per punire Stati e persone che non hanno fatto nulla di male. Gli esperti devono quindi pensare a come limitare al meglio – se non proprio contenere – l’impero degli Stati Uniti.
DATI E DOLLARI
La centralità degli Stati Uniti nella finanza globale e nella trasmissione dei dati non è del tutto inedita. La prima potenza mondiale ha sempre esercitato un controllo straordinario sull’economia e sulle reti di comunicazione del mondo. All’inizio del XX secolo, ad esempio, la sterlina britannica svolgeva un ruolo fondamentale in molte transazioni internazionali e una pluralità di tutti i cavi telegrafici sottomarini globali passava per Londra.
Ma il 2023 non è il 1901. L’epoca odierna è definita da quella che alcuni economisti chiamano “iperglobalizzazione”. Il mondo è molto più interconnesso di un secolo fa. Non si tratta solo del fatto che il commercio globale rappresenta oggi una quota maggiore dell’attività economica rispetto al passato, ma anche del fatto che la complessità delle transazioni internazionali è di gran lunga maggiore rispetto al passato. E il fatto che molte di queste transazioni passino attraverso banche e cavi controllati dagli Stati Uniti conferisce a Washington poteri che nessun governo nella storia ha mai posseduto.
Molti osservatori profani, e non pochi commentatori professionisti, pensano che questo dominio offra agli Stati Uniti grandi vantaggi economici. Ma gli economisti che hanno fatto i conti in genere non credono che la posizione speciale del dollaro contribuisca più che marginalmente al reddito reale degli Stati Uniti, ossia alla quantità di denaro che gli americani guadagnano dopo aver aggiustato per l’inflazione. Non sembrano esserci studi sui benefici economici derivanti dall’ospitare i cavi in fibra ottica, ma è probabile che anche questi benefici siano esigui (soprattutto perché molti dei profitti derivanti dal trasporto dei dati sono probabilmente contabilizzati in Irlanda o in altri paradisi fiscali). Ma Farrell e Newman dimostrano che il controllo degli Stati Uniti sui punti nevralgici dell’economia mondiale offre a Washington nuovi modi per proiettare influenza politica, e che li ha sfruttati.
Gli Stati Uniti hanno iniziato a capitalizzare questi poteri, sostengono gli autori, dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. In precedenza, i funzionari americani erano stati inibiti nell’esercitare la potenza economica degli Stati Uniti dal timore di un eccesso di potere. Ma i funzionari si sono presto resi conto che avrebbero potuto seguire le transazioni finanziarie di Osama bin Laden in modo da rivelare i piani del terrorista e che avrebbero potuto usare la loro influenza finanziaria per interrompere le operazioni di Al Qaeda. Così, dopo l’attacco del gruppo terroristico, Washington ha messo da parte le sue preoccupazioni. Ha ampliato sia la sorveglianza finanziaria che l’uso delle sanzioni.

Per i responsabili politici, l’esercizio di questi poteri si è rivelato facile. I dollari utilizzati nelle transazioni internazionali non sono mazzette di contanti ma depositi bancari, e quasi tutte le banche che detengono tali depositi devono avere un piede nel sistema finanziario statunitense nel caso in cui abbiano bisogno di accedere alla Federal Reserve. Di conseguenza, le banche di tutto il mondo cercano di rimanere nelle grazie dei funzionari statunitensi, per evitare che Washington decida di tagliarle fuori. La storia di Carrie Lam, l’ex amministratore delegato di Hong Kong nominato dalla Cina, ne è un esempio. Come scrivono Farrell e Newman, dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato Lam per le violazioni dei diritti umani, non è stata in grado di ottenere un conto bancario da nessuna parte, nemmeno in una banca cinese. Ha dovuto invece essere pagata in contanti, conservando pile di denaro nella sua residenza ufficiale.
Un esempio meno pittoresco, ma di gran lunga più significativo, del potere degli Stati Uniti è il modo in cui Washington ha cooptato la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, meglio nota come SWIFT. L’organizzazione funge da sistema di messaggistica attraverso il quale vengono effettuate le principali transazioni finanziarie internazionali. In particolare, ha sede in Belgio, non negli Stati Uniti. Tuttavia, poiché molte delle istituzioni che ne fanno parte si affidano alla benevolenza del governo statunitense, dopo gli attentati dell’11 settembre ha iniziato a condividere molti dei suoi dati con gli Stati Uniti, fornendo una stele di Rosetta che Washington poteva utilizzare per tracciare le transazioni finanziarie in tutto il mondo. Nel 2012, il governo statunitense è stato in grado di utilizzare SWIFT e il proprio potere finanziario per escludere efficacemente l’Iran dal sistema finanziario mondiale, con effetti brutali. Dopo le sanzioni, l’economia iraniana ha ristagnato e l’inflazione nel Paese ha raggiunto circa il 40%. Alla fine Teheran ha accettato di ridurre i suoi programmi nucleari in cambio di aiuti. (Nel 2018, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato l’accordo, ma questa è un’altra storia).
Questo è il tipo di potere che gli Stati Uniti ottengono dal controllo dei punti di strozzatura finanziari. Ma come dimostrano Farrell e Newman, ciò che gli Stati Uniti possono fare con il loro controllo sui punti di strozzatura dei dati è probabilmente più notevole. In molti, o forse tutti, i punti in cui i cavi in fibra ottica entrano nel territorio americano, il governo statunitense ha installato degli “splitter”: prismi che dividono i fasci di luce che trasportano le informazioni in due flussi. Un flusso va ai destinatari previsti, ma l’altro va all’Amministrazione per la Sicurezza Nazionale, che utilizza calcoli ad alta potenza per analizzare i dati. Di conseguenza, gli Stati Uniti possono monitorare quasi tutte le comunicazioni internazionali. Babbo Natale forse non sa se siete stati cattivi o buoni, ma la NSA probabilmente sì.
Altri Paesi, naturalmente, possono spiare gli Stati Uniti e lo fanno. La Cina, in particolare, lavora duramente per intercettare la tecnologia americana avanzata. Ma nessuno sa spiare meglio di Washington e, nonostante gli sforzi di Pechino, la Cina non è riuscita a rubare abbastanza segreti da eguagliare l’abilità degli Stati Uniti. Come sottolineano Farrell e Newman, gli Stati Uniti dominano ancora una proprietà intellettuale cruciale: non tanto il software che fa funzionare gli attuali chip per semiconduttori, ma il software utilizzato per progettare nuovi semiconduttori complessi, che è ancora un mercato essenziale. “La proprietà intellettuale statunitense”, dichiarano gli autori, “si snoda lungo l’intera catena di produzione dei semiconduttori, come la lenza di un pescatore con ami spinati ed esca”.
TUTTO QUEL POTERE
Ci sono molti esempi illustrativi di come Washington abbia armato il suo impero sotterraneo, tra cui le sanzioni nei confronti di Lam e Iran. Ma quello che forse mostra meglio come tutti e tre gli elementi dell’impero – il controllo dei dollari, il controllo delle informazioni e il controllo della proprietà intellettuale – si fondano insieme è il sorprendente successo dell’eliminazione della società cinese Huawei.
Solo pochi anni fa, i funzionari americani e le élite della politica estera erano nel panico a causa di Huawei. L’azienda, che ha stretti legami con il governo cinese, sembrava pronta a fornire apparecchiature 5G a gran parte del pianeta e i funzionari statunitensi temevano che questa diffusione avrebbe effettivamente dato alla Cina il potere di origliare il resto del mondo, proprio come hanno fatto gli Stati Uniti.
Washington ha quindi usato il suo impero interconnesso per tagliare le gambe a Huawei. In primo luogo, secondo Farrell e Newman, gli Stati Uniti sono venuti a conoscenza del fatto che Huawei aveva intrattenuto rapporti surrettizi con l’Iran, violando così le sanzioni statunitensi. Poi hanno potuto utilizzare il loro speciale accesso alle informazioni sui dati bancari internazionali per produrre le prove che l’azienda e il suo direttore finanziario, Meng Wanzhou (che è anche la figlia del fondatore), avevano commesso una frode bancaria dicendo falsamente alla società di servizi finanziari britannica HSBC che la sua azienda non stava facendo affari con l’Iran. Le autorità canadesi, su richiesta degli Stati Uniti, l’hanno arrestata mentre viaggiava a Vancouver nel dicembre 2018. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato sia Huawei che Meng di frode telematica e di una serie di altri reati, e gli Stati Uniti hanno utilizzato le restrizioni all’esportazione di tecnologia statunitense per fare pressione sulla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, che fornisce molti semiconduttori cruciali, affinché tagliasse l’accesso di Huawei ai chip più avanzati. Nel frattempo, Pechino ha trattenuto due canadesi in Cina, tenendoli sostanzialmente in ostaggio.
Babbo Natale forse non sa se siete stati cattivi o buoni, ma l’NSA probabilmente sì.
Dopo aver trascorso quasi tre anni agli arresti domiciliari in Canada, Meng ha concluso un accordo in cui ha ammesso molte delle accuse e le è stato permesso di tornare in Cina; il governo cinese ha poi rilasciato i canadesi. Ma a quel punto, Huawei era una forza molto ridotta e le prospettive di un dominio cinese del 5G erano svanite, almeno nel breve termine. Gli Stati Uniti avevano tranquillamente condotto una guerra postmoderna contro la Cina, e avevano vinto.
A prima vista, questa vittoria potrebbe sembrare un’inequivocabile buona notizia. Washington, dopo tutto, ha limitato la portata tecnologica di un regime dittatoriale senza dover ricorrere alla forza. Anche la capacità degli Stati Uniti di tagliare fuori la Corea del Nord da gran parte del sistema finanziario mondiale, o il successo delle sanzioni alla banca centrale russa, potrebbero suscitare giuste acclamazioni. È difficile indignarsi per l’uso di poteri nascosti da parte degli Stati Uniti per bloccare il terrorismo globale, smantellare i cartelli della droga o ostacolare il tentativo del presidente russo Vladimir Putin di sottomettere l’Ucraina.
Tuttavia, l’esercizio di questi poteri comporta chiaramente dei rischi. Farrell e Newman, da parte loro, sono preoccupati per la possibilità di un eccesso di potere. Se gli Stati Uniti usano il loro potere economico troppo liberamente, scrivono, potrebbero minare le basi di tale potere. Ad esempio, se gli Stati Uniti armano il dollaro contro troppi Paesi, questi potrebbero unirsi e adottare metodi di pagamento internazionali alternativi. Se i Paesi si preoccupano profondamente dello spionaggio statunitense, potrebbero posare cavi a fibre ottiche che aggirano gli Stati Uniti. Se Washington impone troppe restrizioni alle esportazioni americane, le aziende straniere potrebbero rinunciare alla tecnologia statunitense. Ad esempio, il software di progettazione cinese non può essere all’altezza di quello statunitense, ma non è troppo difficile immaginare che alcuni regimi accettino una qualità inferiore come prezzo per uscire dalla morsa di Washington.
Finora non è successo nulla di tutto ciò. Nonostante gli interminabili commenti senza fiato sulla potenziale scomparsa del dollaro, la valuta regna sovrana. Infatti, come scrivono Farrell e Newman, il dollaro ha resistito nonostante la “feroce stupidità” dell’amministrazione Trump. La posa di cavi in fibra ottica che bypassano gli Stati Uniti potrebbe essere più facile da realizzare, e chi non è un esperto di tecnologia non sa quanto facilmente il software statunitense possa essere sostituito. Tuttavia, il potere occulto di Washington sembra notevolmente duraturo.

Ma questo non significa che non ci siano limiti a quanto gli Stati Uniti possano spingersi. Farrell e Newman temono che la Cina, che è una superpotenza economica a tutti gli effetti, possa decidere di “difendersi oscurandosi”: tagliando i collegamenti finanziari e informativi internazionali con il resto del mondo (cosa che in parte già fa). Un’azione del genere avrebbe costi economici significativi per tutti. Degraderebbe il ruolo della Cina come officina del mondo, che a suo modo potrebbe essere difficile da sostituire come il ruolo globale del dollaro statunitense.
C’è anche l’ovvio rischio che i Paesi che perdono le guerre senza il fumo delle armi possano reagire scatenando guerre con il fumo delle armi. Come scrivono Farrell e Newman, la militarizzazione del commercio è uno dei fattori che hanno contribuito alla Seconda Guerra Mondiale: Sia la Germania che il Giappone hanno intrapreso guerre di conquista, in parte, per assicurarsi l’accesso alle materie prime che temevano potessero essere tagliate fuori dalle sanzioni internazionali. Lo scenario da incubo per oggi sarebbe se la Cina, timorosa di essere emarginata, reagisse invadendo Taiwan, che gioca un ruolo chiave nell’industria globale dei semiconduttori.
Ma anche se gli Stati Uniti non sfruttano eccessivamente il loro impero sotterraneo e non provocano un conflitto caldo, c’è comunque un motivo importante per preoccuparsi del drammatico potere economico e di dati di Washington: gli Stati Uniti non saranno sempre nel giusto. Washington ha preso molte decisioni di politica estera non etiche e potrebbe usare il suo controllo sui punti di accesso globali per danneggiare persone, aziende e Stati che non dovrebbero essere sotto tiro. Trump, ad esempio, ha imposto tariffe al Canada e all’Europa. Non è difficile immaginare che, se dovesse vincere un secondo mandato, cercherebbe di ostacolare le economie degli Stati europei critici nei confronti delle sue politiche estere o addirittura interne. Non è necessario vedere tutto attraverso la lente della guerra in Iraq o insistere sul fatto che gli Stati Uniti abbiano in qualche modo costretto Putin a invadere l’Ucraina per essere preoccupati della mancanza di responsabilità dell’impero sotterraneo.
REGOLE DELLA STRADA
Farrell e Newman non propongono politiche che possano mitigare questi rischi, se non suggerire che l’impero sotterraneo merita lo stesso tipo di riflessione sofisticata un tempo dedicata alle rivalità nucleari. Tuttavia, evidenziando come la natura del potere globale sia cambiata, il libro offre un enorme contributo al modo in cui gli analisti pensano all’influenza. I politici e i ricercatori dovrebbero iniziare a formulare piani per risolvere questi problemi.
Una possibile soluzione sarebbe quella di creare regole internazionali per lo sfruttamento dei punti di strozzatura economica, sulla falsariga delle regole che hanno limitato le tariffe e altre misure protezionistiche fin dalla creazione dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio, nel 1947. Come ogni economista del commercio sa, il GATT (e l’Organizzazione Mondiale del Commercio che ne è derivata) non si limita a proteggere le nazioni le une dalle altre. Le protegge dai loro stessi istinti negativi.
Sarà difficile fare qualcosa di simile con le nuove forme di potere economico. Ma per mantenere il mondo al sicuro, gli esperti dovrebbero cercare di elaborare regolamenti che abbiano lo stesso effetto moderatore. La posta in gioco è troppo alta per lasciare che queste sfide non vengano affrontate.


Gli Stati Uniti si trovano oggi ad affrontare minacce alla loro sicurezza più gravi di quanto non abbiano fatto negli ultimi decenni, forse mai. Mai prima d’ora si sono trovati ad affrontare contemporaneamente quattro antagonisti alleati – Russia, Cina, Corea del Nord e Iran – il cui arsenale nucleare collettivo potrebbe, nel giro di pochi anni, essere quasi il doppio del proprio. Era dai tempi della guerra di Corea che gli Stati Uniti non dovevano confrontarsi con potenti rivali militari sia in Europa che in Asia. E nessuno ricorda un’epoca in cui un avversario aveva una potenza economica, scientifica, tecnologica e militare pari a quella della Cina di oggi.
Il problema, tuttavia, è che proprio nel momento in cui gli eventi richiedono una risposta forte e coerente da parte degli Stati Uniti, il Paese non è in grado di fornirla. La sua fratturata leadership politica – repubblicana e democratica, alla Casa Bianca e al Congresso – non è riuscita a convincere un numero sufficiente di americani che gli sviluppi in Cina e in Russia sono importanti. I leader politici non sono riusciti a spiegare come le minacce poste da questi Paesi siano interconnesse. Non sono riusciti ad articolare una strategia a lungo termine per garantire che gli Stati Uniti, e i valori democratici più in generale, prevalgano.
Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno molto in comune, ma spiccano due convinzioni condivise. In primo luogo, ciascuno è convinto che il suo destino personale sia quello di ripristinare i giorni di gloria del passato imperiale del suo Paese. Per Xi, ciò significa rivendicare il ruolo dominante che la Cina imperiale aveva un tempo in Asia e nutrire ambizioni ancora maggiori di influenza globale. Per Putin, invece, significa perseguire uno scomodo mix tra il rilancio dell’Impero russo e il recupero della deferenza accordata all’Unione Sovietica. In secondo luogo, entrambi i leader sono convinti che le democrazie sviluppate – soprattutto gli Stati Uniti – abbiano superato il loro apice e siano entrate in un declino irreversibile. Questo declino, a loro avviso, è evidente nel crescente isolazionismo, nella polarizzazione politica e nel disordine interno di queste democrazie.
Prese insieme, le convinzioni di Xi e Putin lasciano presagire un periodo pericoloso per gli Stati Uniti. Il problema non è solo la forza e l’aggressività militare di Cina e Russia. Il problema non è solo la forza e l’aggressività militare di Cina e Russia, ma anche il fatto che entrambi i leader hanno già commesso gravi errori di calcolo in patria e all’estero e sembrano destinati a farne di ancora più gravi in futuro. Le loro decisioni potrebbero portare a conseguenze catastrofiche per loro stessi e per gli Stati Uniti. Washington deve quindi cambiare il calcolo di Xi e Putin e ridurre le possibilità di disastro, uno sforzo che richiederà una visione strategica e un’azione coraggiosa. Gli Stati Uniti hanno prevalso nella Guerra Fredda grazie a una strategia coerente perseguita da entrambi i partiti politici attraverso nove presidenze successive. Oggi è necessario un approccio bipartisan simile. Qui sta il problema.
Gli Stati Uniti si trovano in una posizione unica e insidiosa: devono affrontare avversari aggressivi con la propensione a sbagliare i calcoli, ma incapaci di riunire l’unità e la forza necessarie per dissuaderli. Il successo nel dissuadere leader come Xi e Putin dipende dalla certezza degli impegni e dalla costanza delle risposte. Invece, le disfunzioni hanno reso il potere americano erratico e inaffidabile, invitando praticamente gli autocrati inclini al rischio a fare scommesse pericolose, con effetti potenzialmente catastrofici.
LE AMBIZIONI DI XI
L’appello di Xi al “grande ringiovanimento della nazione cinese” è un’espressione che indica che la Cina diventerà la potenza mondiale dominante entro il 2049, centenario della vittoria dei comunisti nella guerra civile cinese. Questo obiettivo include il ritorno di Taiwan sotto il controllo di Pechino. Per dirla con le sue parole, “la completa unificazione della madrepatria deve essere realizzata e sarà realizzata”. A tal fine, Xi ha ordinato alle forze armate cinesi di essere pronte entro il 2027 a invadere con successo Taiwan e si è impegnato a modernizzare l’esercito cinese entro il 2035 e a trasformarlo in una forza di “livello mondiale”. Xi sembra credere che solo conquistando Taiwan potrà assicurarsi uno status paragonabile a quello di Mao Zedong nel pantheon delle leggende del Partito Comunista Cinese.
Le aspirazioni e il senso del destino personale di Xi comportano un rischio significativo di guerra. Così come Putin ha sbagliato disastrosamente i calcoli in Ucraina, c’è il rischio che Xi lo faccia anche a Taiwan. Ha già drammaticamente sbagliato i calcoli almeno tre volte. In primo luogo, allontanandosi dalla massima del leader cinese Deng Xiaoping “nascondi la tua forza, aspetta il tuo tempo”, Xi ha provocato esattamente la risposta che Deng temeva: gli Stati Uniti hanno mobilitato il loro potere economico per rallentare la crescita della Cina, hanno iniziato a rafforzare e modernizzare le loro forze armate e hanno rafforzato le loro alleanze e partnership militari in Asia. Un secondo grande errore di calcolo è stata la svolta a sinistra di Xi nelle politiche economiche, una svolta ideologica iniziata nel 2015 e rafforzata al Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese del 2022. Le sue politiche, dall’inserimento del partito nella gestione delle aziende al crescente affidamento sulle imprese statali, hanno danneggiato profondamente l’economia cinese. In terzo luogo, la politica dello “zero COVID” di Xi, come ha scritto l’economista Adam Posen in queste pagine, “ha reso visibile e tangibile il potere arbitrario del PCC sulle attività commerciali di tutti, comprese quelle degli attori più piccoli”. L’incertezza che ne è derivata, accentuata dall’improvvisa inversione di tale politica, ha ridotto la spesa dei consumatori cinesi, danneggiando ulteriormente l’intera economia.
Se preservare il potere del partito è la prima priorità di Xi, conquistare Taiwan è la seconda. Se la Cina si affida a misure diverse dalla guerra per fare pressione su Taiwan affinché si arrenda preventivamente, è probabile che questo sforzo fallisca. A Xi resterebbe quindi l’opzione di rischiare la guerra imponendo un blocco navale su larga scala o addirittura lanciando un’invasione totale per conquistare l’isola. Potrebbe pensare di compiere il suo destino provandoci, ma che vinca o perda, i costi economici e militari di provocare una guerra per Taiwan sarebbero catastrofici per la Cina, per non parlare di tutti gli altri soggetti coinvolti. Xi commetterebbe un errore monumentale.
Nonostante gli errori di calcolo di Xi e le numerose difficoltà interne del suo Paese, la Cina continuerà a rappresentare una sfida formidabile per gli Stati Uniti. Il suo esercito è più forte che mai. Oggi la Cina vanta più navi da guerra degli Stati Uniti (anche se di qualità inferiore). Ha modernizzato e ristrutturato sia le sue forze convenzionali che quelle nucleari – e sta quasi raddoppiando le forze nucleari strategiche dispiegate – e ha aggiornato il suo sistema di comando e controllo. È in procinto di rafforzare le sue capacità anche nello spazio e nel cyberspazio.
Il senso del destino personale di Xi comporta un rischio significativo di guerra.
Al di là delle sue mosse militari, la Cina ha perseguito una strategia globale volta ad aumentare il suo potere e la sua influenza a livello globale. La Cina è oggi il primo partner commerciale di oltre 120 Paesi, tra cui quasi tutti quelli del Sud America. Più di 140 Paesi hanno aderito alla Belt and Road Initiative, il vasto programma cinese di sviluppo delle infrastrutture, e la Cina possiede, gestisce o ha investito in più di 100 porti in circa 60 Paesi.
A queste relazioni economiche sempre più estese si aggiunge una rete di propaganda e di media pervasiva. Nessun Paese al mondo è al di fuori della portata di almeno una stazione radiofonica, un canale televisivo o un sito di notizie online cinesi. Attraverso questi e altri canali, Pechino attacca le azioni e le motivazioni americane, erode la fiducia nelle istituzioni internazionali che gli Stati Uniti hanno creato dopo la Seconda Guerra Mondiale, e sbandiera la presunta superiorità del proprio modello di sviluppo e di governance, il tutto portando avanti il tema del declino occidentale.
Sono almeno due i concetti invocati da chi pensa che Stati Uniti e Cina siano destinati al conflitto. Uno è la “trappola di Tucidide”. Secondo questa teoria, la guerra è inevitabile quando una potenza in ascesa si confronta con una potenza consolidata, come quando Atene si confrontò con Sparta nell’antichità o quando la Germania si confrontò con il Regno Unito prima della Prima Guerra Mondiale. Un altro è il “picco della Cina”, l’idea che il potere economico e militare del Paese è o sarà presto al massimo, mentre le ambiziose iniziative per rafforzare le forze armate statunitensi richiederanno anni per dare i loro frutti. Pertanto, la Cina potrebbe invadere Taiwan prima che la disparità militare in Asia modifichi lo svantaggio della Cina.
Ma nessuna delle due teorie è convincente. La Prima Guerra Mondiale non è stata affatto inevitabile: è avvenuta a causa della stupidità e dell’arroganza dei leader europei. E le stesse forze armate cinesi sono ben lungi dall’essere pronte per un grande conflitto. Pertanto, un attacco diretto o un’invasione di Taiwan da parte della Cina, se mai dovesse verificarsi, è un’eventualità lontana anni. A meno che, ovviamente, Xi non sbagli gravemente i suoi calcoli, ancora una volta.
IL GIOCO DI PUTIN
“Senza l’Ucraina, la Russia cessa di essere un impero”, ha osservato Zbigniew Brzezinski, politologo ed ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Putin condivide certamente questo punto di vista. Per inseguire l’impero perduto della Russia, ha invaso l’Ucraina nel 2014 e di nuovo nel 2022 – con quest’ultima avventura che si è rivelata un catastrofico errore di calcolo con conseguenze devastanti a lungo termine per il suo Paese. Invece di dividere e indebolire la NATO, le azioni della Russia hanno dato all’alleanza un nuovo scopo (e, in Finlandia e, presto, in Svezia, nuovi potenti membri). Dal punto di vista strategico, la Russia sta molto peggio di prima dell’invasione.
Dal punto di vista economico, le vendite di petrolio alla Cina, all’India e ad altri Stati hanno compensato gran parte dell’impatto finanziario delle sanzioni, e i beni di consumo e la tecnologia provenienti da Cina, Turchia e altri Paesi dell’Asia centrale e del Medio Oriente hanno in parte sostituito quelli un tempo importati dall’Occidente. Tuttavia, la Russia è stata sottoposta a sanzioni straordinarie da parte di quasi tutte le democrazie sviluppate. Innumerevoli aziende occidentali hanno ritirato i loro investimenti e abbandonato il Paese, comprese le compagnie petrolifere e del gas la cui tecnologia è essenziale per sostenere la principale fonte di reddito della Russia. Migliaia di giovani esperti di tecnologia e imprenditori sono fuggiti. Invadendo l’Ucraina, Putin ha ipotecato il futuro del suo Paese.

Per quanto riguarda l’esercito russo, anche se la guerra ha degradato in modo significativo le sue forze convenzionali, Mosca mantiene il più grande arsenale nucleare del mondo. Grazie agli accordi sul controllo degli armamenti, questo arsenale comprende solo poche armi nucleari strategiche in più rispetto agli Stati Uniti. Ma la Russia ha un numero di armi nucleari tattiche dieci volte superiore, circa 1.900.
Nonostante l’ampio arsenale nucleare, le prospettive per Putin sembrano tristi. Dopo che le sue speranze di una rapida conquista dell’Ucraina si sono infrante, sembra che egli conti su una dura situazione di stallo militare per esaurire gli ucraini, scommettendo che entro la prossima primavera o estate l’opinione pubblica in Europa e negli Stati Uniti si stancherà di sostenerli. Come alternativa temporanea a un’Ucraina conquistata, potrebbe essere disposto a prendere in considerazione un’Ucraina paralizzata, uno Stato fantoccio che giace in rovina, con le esportazioni ridotte e gli aiuti esteri drasticamente ridotti. Putin voleva che l’Ucraina facesse parte di un impero russo ricostituito; temeva anche un’Ucraina democratica, moderna e prospera come modello alternativo per i russi della porta accanto. Non otterrà il primo, ma potrebbe credere di poter impedire il secondo.
Finché Putin sarà al potere, la Russia rimarrà un avversario degli Stati Uniti e della NATO. Attraverso la vendita di armi, l’assistenza alla sicurezza e lo sconto su petrolio e gas, sta coltivando nuove relazioni in Africa, Medio Oriente e Asia. Continuerà a usare tutti i mezzi a sua disposizione per seminare divisioni negli Stati Uniti e in Europa e minare l’influenza americana nel Sud globale. Incoraggiato dalla partnership con Xi e fiducioso che il suo arsenale nucleare modernizzato possa scoraggiare un’azione militare contro la Russia, continuerà a sfidare aggressivamente gli Stati Uniti. Putin ha già commesso un errore di calcolo storico; nessuno può essere certo che non ne commetterà un altro.
L’AMERICA COMPROMESSA
Per ora, gli Stati Uniti sembrano essere in una posizione di forza nei confronti sia della Cina che della Russia. Soprattutto, l’economia statunitense sta andando bene. Gli investimenti delle imprese in nuovi impianti produttivi, in parte sovvenzionati da nuove infrastrutture e programmi tecnologici del governo, sono in piena espansione. I nuovi investimenti del governo e delle imprese nell’intelligenza artificiale, nell’informatica quantistica, nella robotica e nella bioingegneria promettono di aumentare il divario tecnologico ed economico tra gli Stati Uniti e tutti gli altri Paesi per gli anni a venire.
Sul piano diplomatico, la guerra in Ucraina ha offerto agli Stati Uniti nuove opportunità. L’avvertimento tempestivo che Washington ha dato ai suoi amici e alleati sull’intenzione della Russia di invadere l’Ucraina ha ripristinato la loro fiducia nelle capacità di intelligence degli Stati Uniti. I rinnovati timori nei confronti della Russia hanno permesso agli Stati Uniti di rafforzare ed espandere la NATO, e l’aiuto militare fornito all’Ucraina ha dimostrato chiaramente che ci si può fidare del rispetto dei suoi impegni. Nel frattempo, il bullismo economico e diplomatico della Cina in Asia e in Europa si è ritorto contro, consentendo agli Stati Uniti di rafforzare le proprie relazioni in entrambe le regioni.
Negli ultimi anni le forze armate statunitensi sono state finanziate in modo sano e sono in corso programmi di modernizzazione in tutte e tre le componenti della triade nucleare: missili balistici intercontinentali, bombardieri e sottomarini. Il Pentagono sta acquistando nuovi aerei da combattimento (F-35, F-15 modernizzati e un nuovo caccia di sesta generazione), oltre a una nuova flotta di aerei cisterna per il rifornimento in volo. L’esercito sta acquistando circa due dozzine di nuove piattaforme e armi e la marina sta costruendo altre navi e sottomarini. L’esercito continua a sviluppare nuovi tipi di armi, come le munizioni ipersoniche, e a rafforzare le sue capacità cibernetiche offensive e difensive. Complessivamente, gli Stati Uniti spendono per la difesa più dei dieci Paesi successivi messi insieme, comprese Russia e Cina.
Purtroppo, però, le disfunzioni politiche e i fallimenti della politica americana stanno minando il suo successo. L’economia degli Stati Uniti è minacciata da una spesa governativa federale in continua crescita. I politici di entrambi i partiti non hanno affrontato il problema del costo vertiginoso dei diritti, come la sicurezza sociale, Medicare e Medicaid. La perenne opposizione all’innalzamento del tetto del debito ha minato la fiducia nell’economia, inducendo gli investitori a preoccuparsi di cosa accadrebbe se Washington andasse effettivamente in default. (Nell’agosto 2023, l’agenzia di rating Fitch ha declassato il rating creditizio degli Stati Uniti, aumentando i costi di prestito per il governo). Il processo di stanziamento del Congresso è stato interrotto per anni. I legislatori hanno ripetutamente fallito nell’approvare singole proposte di legge sugli stanziamenti, hanno approvato gigantesche leggi “omnibus” che nessuno ha letto e hanno forzato la chiusura del governo.
Finché Putin sarà al potere, la Russia rimarrà un avversario degli Stati Uniti.
Dal punto di vista diplomatico, il disprezzo dell’ex presidente Donald Trump per gli alleati degli Stati Uniti, la sua predilezione per i leader autoritari, la sua volontà di seminare dubbi sull’impegno degli Stati Uniti nei confronti degli alleati della NATO e il suo comportamento generalmente irregolare hanno minato la credibilità e il rispetto degli Stati Uniti in tutto il mondo. Ma a soli sette mesi dall’inizio dell’amministrazione del Presidente Joe Biden, il brusco e disastroso ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan ha ulteriormente danneggiato la fiducia del resto del mondo nei confronti di Washington.
Per anni, la diplomazia statunitense ha trascurato gran parte del Sud globale, il fronte centrale della competizione non militare con Cina e Russia. Le ambasciate degli Stati Uniti sono lasciate sproporzionatamente vacanti in questa parte del mondo. A partire dal 2022, dopo anni di abbandono, gli Stati Uniti hanno cercato di riallacciare i rapporti con le nazioni insulari del Pacifico, ma solo dopo che la Cina aveva approfittato dell’assenza di Washington per firmare accordi economici e di sicurezza con questi Paesi. La competizione con la Cina e persino con la Russia per i mercati e l’influenza è globale. Gli Stati Uniti non possono permettersi di essere assenti da nessuna parte.
Le forze armate pagano anche il prezzo delle disfunzioni politiche americane, in particolare al Congresso. Ogni anno, dal 2010, il Congresso non è riuscito ad approvare i disegni di legge sugli stanziamenti per le forze armate prima dell’inizio dell’anno fiscale successivo. Al contrario, i legislatori hanno approvato una “risoluzione di continuazione”, che consente al Pentagono di non spendere più denaro di quanto abbia fatto l’anno precedente e gli vieta di avviare nuove attività o di aumentare la spesa per i programmi esistenti. Queste risoluzioni continue regolano la spesa per la difesa fino all’approvazione di una nuova legge sugli stanziamenti, e sono durate da poche settimane a un intero anno fiscale. Il risultato è che ogni anno, nuovi programmi e iniziative fantasiose non vanno da nessuna parte per un periodo imprevedibile.
Il Budget Control Act del 2011 ha introdotto tagli automatici alla spesa, noti come “sequestro”, e ha ridotto il bilancio federale di 1.200 miliardi di dollari in dieci anni. Le forze armate, che all’epoca rappresentavano solo il 15% delle spese federali, sono state costrette ad assorbire la metà di questi tagli: 600 miliardi di dollari. Con l’esenzione dei costi del personale, la maggior parte delle riduzioni dovette provenire dai conti della manutenzione, delle operazioni, dell’addestramento e degli investimenti. Le conseguenze sono state gravi e durature. Eppure, a partire dal settembre 2023, il Congresso si appresta a ripetere lo stesso errore. Un ulteriore esempio di come il Congresso permetta alla politica di danneggiare concretamente le forze armate è il fatto di aver permesso a un senatore di bloccare la conferma di centinaia di alti ufficiali per mesi e mesi, non solo degradando gravemente la prontezza e la leadership, ma anche, evidenziando le disfunzioni del governo americano in un settore così critico, rendendo gli Stati Uniti lo zimbello dei loro avversari. La conclusione è che gli Stati Uniti hanno bisogno di maggiore potenza militare per far fronte alle minacce che devono affrontare, ma sia il Congresso che il ramo esecutivo sono pieni di ostacoli per raggiungere questo obiettivo.
AFFRONTARE IL MOMENTO
L’epica contesa tra gli Stati Uniti e i suoi alleati da una parte e la Cina, la Russia e i loro compagni di viaggio dall’altra è ben avviata. Per garantire che Washington sia nella posizione più forte possibile per dissuadere i suoi avversari dal commettere ulteriori errori di calcolo strategico, i leader statunitensi devono innanzitutto affrontare la rottura dell’accordo bipartisan che dura da decenni riguardo al ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Non sorprende che, dopo 20 anni di guerra in Afghanistan e in Iraq, molti americani abbiano voluto ripiegarsi su se stessi, soprattutto alla luce dei numerosi problemi interni degli Stati Uniti. Ma è compito dei leader politici contrastare questo sentimento e spiegare come il destino del Paese sia inestricabilmente legato a ciò che accade altrove. Il presidente Franklin Roosevelt una volta osservò che “il più grande dovere di un uomo di Stato è quello di educare”. Ma i presidenti recenti, insieme alla maggior parte dei membri del Congresso, hanno completamente fallito in questa responsabilità essenziale.
Gli americani devono capire perché la leadership globale degli Stati Uniti, nonostante i suoi costi, è vitale per preservare la pace e la prosperità. Devono sapere perché il successo della resistenza ucraina all’invasione russa è fondamentale per dissuadere la Cina dall’invadere Taiwan. Devono sapere perché il dominio cinese del Pacifico occidentale mette in pericolo gli interessi degli Stati Uniti. Devono sapere perché l’influenza cinese e russa nel Sud globale è importante per le tasche degli americani. Devono sapere perché l’affidabilità degli Stati Uniti come alleati è così importante per preservare la pace. Devono sapere perché un’alleanza russo-cinese minaccia gli Stati Uniti. Sono questi i collegamenti che i leader politici americani devono tracciare ogni giorno.
Non è necessario un solo discorso nello Studio Ovale o un discorso al Congresso. È piuttosto necessario un ritmo incalzante di ripetizioni affinché il messaggio venga recepito. Oltre a comunicare regolarmente al popolo americano direttamente, e non attraverso i portavoce, il Presidente deve passare del tempo a bere e cenare e in piccole riunioni con i membri del Congresso e i media per spiegare il ruolo di leadership degli Stati Uniti. Poi, data la natura frammentata delle comunicazioni moderne, i membri del Congresso devono portare il messaggio ai loro elettori in tutto il Paese.

Qual è il messaggio? È che la leadership globale americana ha garantito 75 anni di pace tra grandi potenze, il periodo più lungo degli ultimi secoli. Nella vita di una nazione non c’è niente di più costoso della guerra, né c’è niente che rappresenti una minaccia maggiore alla sua sicurezza e alla sua prosperità. E non c’è nulla che renda la guerra più probabile del mettere la testa sotto la sabbia e fingere che gli Stati Uniti non siano influenzati dagli eventi altrove, come il Paese ha imparato prima della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale e dell’11 settembre. Il potere militare che gli Stati Uniti possiedono, le alleanze che hanno stretto e le istituzioni internazionali che hanno progettato sono tutti elementi essenziali per scoraggiare le aggressioni contro di loro e i loro partner. Come un secolo di prove dovrebbe chiarire, non affrontare gli aggressori non fa altro che incoraggiare altre aggressioni. È ingenuo credere che il successo russo in Ucraina non porterà a ulteriori aggressioni russe in Europa e forse anche a una guerra tra la NATO e la Russia. Ed è altrettanto ingenuo credere che il successo russo in Ucraina non aumenti significativamente la probabilità di un’aggressione cinese contro Taiwan e quindi potenzialmente una guerra tra Stati Uniti e Cina.
Un mondo senza una leadership americana affidabile sarebbe un mondo di predatori autoritari, con tutti gli altri Paesi potenziali prede. Se l’America vuole salvaguardare il suo popolo, la sua sicurezza e la sua libertà, deve continuare ad abbracciare il suo ruolo di leadership globale. Come disse il Primo Ministro britannico Winston Churchill degli Stati Uniti nel 1943, “Il prezzo della grandezza è la responsabilità”.
Ricostruire il sostegno in patria per questa responsabilità è essenziale per ricostruire la fiducia tra gli alleati e la consapevolezza tra gli avversari che gli Stati Uniti rispetteranno i loro impegni. A causa delle divisioni interne, dei messaggi contrastanti e dell’ambivalenza dei leader politici sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo, all’estero si nutrono notevoli dubbi sull’affidabilità americana. Sia gli amici che gli avversari si chiedono se l’impegno e la costruzione di alleanze di Biden siano un ritorno alla normalità o se il disprezzo di Trump per gli alleati “America first” sarà il filo conduttore della politica americana in futuro. Anche gli alleati più stretti stanno facendo delle scommesse sull’America. In un mondo in cui Russia e Cina sono in agguato, questo è particolarmente pericoloso.
Ripristinare il sostegno pubblico alla leadership globale degli Stati Uniti è la massima priorità, ma gli Stati Uniti devono compiere altri passi per esercitare effettivamente questo ruolo. In primo luogo, devono andare oltre il “pivoting” verso l’Asia. Rafforzare le relazioni con Australia, Giappone, Filippine, Corea del Sud e altri Paesi della regione è necessario ma non sufficiente. Cina e Russia stanno lavorando insieme contro gli interessi degli Stati Uniti in ogni continente. Washington ha bisogno di una strategia per trattare con il mondo intero, in particolare in Africa, America Latina e Medio Oriente, dove i russi e i cinesi stanno rapidamente superando gli Stati Uniti nello sviluppo di relazioni economiche e di sicurezza. Questa strategia non dovrebbe dividere il mondo in democrazie e autoritari. Gli Stati Uniti devono sempre sostenere la democrazia e i diritti umani ovunque, ma questo impegno non deve rendere Washington cieca di fronte alla realtà che gli interessi nazionali statunitensi a volte richiedono di lavorare con governi repressivi e non rappresentativi.
Cina e Russia pensano che il futuro appartenga a loro.
In secondo luogo, la strategia degli Stati Uniti deve incorporare tutti gli strumenti del loro potere nazionale. Sia i repubblicani che i democratici sono diventati ostili agli accordi commerciali e il sentimento protezionistico è forte al Congresso. Ciò ha lasciato campo libero ai cinesi nel Sud globale, che offre enormi mercati e opportunità di investimento. Nonostante i difetti della Belt and Road Initiative, come l’enorme debito che accumula sui Paesi beneficiari, Pechino l’ha usata con successo per insinuare l’influenza, le aziende e i tentacoli economici della Cina in decine di Paesi. Inserita nella Costituzione cinese nel 2017, non è destinata a scomparire. Gli Stati Uniti e i loro alleati devono capire come competere con l’iniziativa in modi che sfruttino i loro punti di forza, soprattutto il settore privato. I programmi di assistenza allo sviluppo degli Stati Uniti rappresentano una piccola frazione dello sforzo cinese. Sono inoltre frammentati e scollegati da obiettivi geopolitici statunitensi più ampi. E anche quando i programmi di aiuto statunitensi hanno successo, gli Stati Uniti mantengono un silenzio sacerdotale sui loro risultati. Hanno parlato poco, ad esempio, del Plan Colombia, un programma di aiuti progettato per combattere il traffico di droga in Colombia, o del President’s Emergency Plan for AIDS Relief, che ha salvato milioni di vite in Africa.
La diplomazia pubblica è essenziale per promuovere gli interessi degli Stati Uniti, ma Washington ha lasciato appassire questo importante strumento di potere dalla fine della Guerra Fredda. Nel frattempo, la Cina sta spendendo miliardi di dollari in tutto il mondo per promuovere la propria narrativa. Anche la Russia si sta impegnando in modo aggressivo per diffondere la sua propaganda e la disinformazione, oltre a fomentare la discordia all’interno e tra le democrazie. Gli Stati Uniti hanno bisogno di una strategia per influenzare i leader e le opinioni pubbliche straniere, soprattutto nel Sud del mondo. Per avere successo, questa strategia richiederebbe al governo statunitense non solo di spendere più soldi, ma anche di integrare e sincronizzare le sue numerose e disparate attività di comunicazione.
L’assistenza alla sicurezza dei governi stranieri è un altro settore che necessita di un cambiamento radicale. Sebbene le forze armate statunitensi facciano un buon lavoro di addestramento delle forze straniere, prendono decisioni frammentarie su dove e come farlo, senza considerare sufficientemente le strategie regionali o il modo migliore per collaborare con gli alleati. La Russia ha fornito sempre più assistenza per la sicurezza ai governi africani, soprattutto a quelli con tendenze autoritarie, ma gli Stati Uniti non hanno una strategia efficace per contrastare questo sforzo. Washington deve anche trovare un modo per accelerare la consegna di attrezzature militari agli Stati beneficiari. Attualmente vi è un arretrato di circa 19 miliardi di dollari nella vendita di armi a Taiwan, con ritardi che vanno dai quattro ai dieci anni. Sebbene il ritardo sia il risultato di molti fattori, una causa importante è la limitata capacità produttiva dell’industria della difesa statunitense.

In terzo luogo, gli Stati Uniti devono ripensare la loro strategia nucleare di fronte all’alleanza russo-cinese. La cooperazione tra la Russia, che sta modernizzando la sua forza nucleare strategica, e la Cina, che sta espandendo enormemente la sua forza, un tempo piccola, mette a dura prova la credibilità del deterrente nucleare statunitense, così come l’espansione delle capacità nucleari della Corea del Nord e il potenziale bellico dell’Iran. Per rafforzare il proprio deterrente, gli Stati Uniti devono quasi certamente adattare la propria strategia e probabilmente anche espandere le dimensioni delle proprie forze nucleari. Le marine cinesi e russe si esercitano sempre più insieme e sarebbe sorprendente se non coordinassero più strettamente anche le loro forze nucleari strategiche dispiegate.
A Washington c’è un ampio consenso sul fatto che la Marina statunitense abbia bisogno di molte più navi da guerra e sottomarini. Anche in questo caso, il contrasto tra la retorica e l’azione dei politici è stridente. Per alcuni anni, il budget per la costruzione di navi è rimasto sostanzialmente invariato, ma negli ultimi anni, anche se il budget è aumentato in modo sostanziale, le risoluzioni continue e i problemi di esecuzione hanno impedito l’espansione della Marina. I principali ostacoli a una marina più grande sono di natura finanziaria: la mancanza di finanziamenti più elevati e duraturi per la marina stessa e, più in generale, la mancanza di investimenti nei cantieri navali e nelle industrie che supportano la costruzione e la manutenzione delle navi. Tuttavia, è difficile percepire un senso di urgenza da parte dei politici nel porre rimedio a questi problemi in tempi brevi. Questo è inaccettabile.
Infine, il Congresso deve cambiare il modo in cui stanzia i fondi per il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento della Difesa deve cambiare il modo in cui li spende. Il Congresso deve agire in modo più rapido ed efficiente quando si tratta di approvare il bilancio della Difesa. Ciò significa, soprattutto, approvare i disegni di legge sugli stanziamenti militari prima dell’inizio dell’anno fiscale, un cambiamento che darebbe al Dipartimento della Difesa la necessaria prevedibilità. Il Pentagono, da parte sua, deve correggere i suoi processi di acquisizione sclerotici, campanilistici e burocratici, che sono particolarmente anacronistici in un’epoca in cui agilità, flessibilità e velocità contano più che mai. I leader del Dipartimento della Difesa hanno detto le cose giuste su questi difetti e hanno annunciato molte iniziative per correggerli. La sfida è un’esecuzione efficace e urgente.
MENO CHIACCHIERE, PIÙ AZIONE
Cina e Russia pensano che il futuro appartenga a loro. Per tutta la dura retorica del Congresso e dell’Esecutivo degli Stati Uniti sulla necessità di contrastare questi avversari, l’azione è sorprendentemente scarsa. Troppo spesso vengono annunciate nuove iniziative, ma i finanziamenti e l’effettiva attuazione si muovono lentamente o non si concretizzano del tutto. Le chiacchiere sono a buon mercato e nessuno a Washington sembra pronto ad apportare i cambiamenti urgenti necessari. Ciò è particolarmente sconcertante, poiché in un periodo di aspra partigianeria e polarizzazione a Washington, Xi e Putin sono riusciti a creare un impressionante, anche se fragile, sostegno bipartisan tra i politici per una forte risposta degli Stati Uniti alla loro aggressione. Il potere esecutivo e il Congresso hanno la rara opportunità di lavorare insieme per sostenere la loro retorica sul contrasto alla Cina e alla Russia con azioni di vasta portata che rendano gli Stati Uniti un avversario significativamente più temibile e possano contribuire a scoraggiare la guerra.
Xi e Putin, circondati da yes men, hanno già commesso gravi errori che sono costati cari ai loro Paesi. A lungo termine, hanno danneggiato i loro Paesi. Per il prossimo futuro, tuttavia, restano un pericolo con cui gli Stati Uniti devono fare i conti. Anche nel migliore dei mondi, quello in cui il governo americano avesse un’opinione pubblica favorevole, leader entusiasti e una strategia coerente, questi avversari rappresenterebbero una sfida formidabile. Ma la scena interna di oggi è tutt’altro che ordinata: l’opinione pubblica americana si è ripiegata su se stessa; il Congresso è sceso in battibecchi, inciviltà e ostilità; e i presidenti che si sono succeduti hanno disconosciuto o fatto un pessimo lavoro nello spiegare il ruolo globale dell’America. Per affrontare avversari così potenti e a rischio, gli Stati Uniti devono alzare il tiro in ogni dimensione. Solo così potranno sperare di dissuadere Xi e Putin dal fare altre scommesse sbagliate. Il pericolo è reale.

Nulla nella politica mondiale è inevitabile. Gli elementi alla base del potere nazionale, come la demografia, la geografia e le risorse naturali, sono importanti, ma la storia dimostra che non sono sufficienti a determinare quali Paesi plasmeranno il futuro. Sono le decisioni strategiche che i Paesi prendono che contano di più: come si organizzano internamente, in cosa investono, con chi scelgono di allinearsi e chi vuole allinearsi con loro, quali guerre combattono, quali dissuadono e quali evitano.
Quando il Presidente Joe Biden è entrato in carica, ha riconosciuto che la politica estera degli Stati Uniti si trova in un momento di svolta, in cui le decisioni che gli americani prendono ora avranno un impatto enorme sul futuro. I punti di forza degli Stati Uniti sono enormi, sia in termini assoluti che rispetto ad altri Paesi. Gli Stati Uniti hanno una popolazione in crescita, risorse abbondanti e una società aperta che attrae talenti e investimenti e stimola l’innovazione e la reinvenzione. Gli americani dovrebbero essere ottimisti per il futuro. Ma la politica estera degli Stati Uniti è stata sviluppata in un’epoca che sta rapidamente diventando un ricordo, e ora si tratta di capire se il Paese è in grado di adattarsi alla sfida principale che deve affrontare: la competizione in un’epoca di interdipendenza.
L’era post-Guerra Fredda è stata un periodo di grandi cambiamenti, ma il filo conduttore degli anni ’90 e degli anni successivi all’11 settembre è stata l’assenza di un’intensa competizione tra grandi potenze. Questo è stato principalmente il risultato della preminenza militare ed economica degli Stati Uniti, anche se è stato ampiamente interpretato come la prova che il mondo era d’accordo sulla direzione di base dell’ordine internazionale. L’era post-Guerra Fredda è ormai definitivamente conclusa. La competizione strategica si è intensificata e ora tocca quasi tutti gli aspetti della politica internazionale, non solo il settore militare. Sta complicando l’economia globale. Sta cambiando il modo in cui i Paesi affrontano problemi comuni come il cambiamento climatico e le pandemie. E sta ponendo domande fondamentali su ciò che verrà dopo.
I vecchi presupposti e le vecchie strutture devono essere adattati per rispondere alle sfide che gli Stati Uniti dovranno affrontare da qui al 2050. Nell’era precedente, c’era una certa riluttanza ad affrontare i chiari fallimenti del mercato che minacciavano la resilienza dell’economia statunitense. Poiché le forze armate statunitensi non avevano pari, in risposta all’11 settembre Washington si è concentrata sugli attori non statali e sulle nazioni canaglia. Non si è concentrata sul miglioramento della propria posizione strategica e sulla preparazione a una nuova era in cui i concorrenti avrebbero cercato di replicare i suoi vantaggi militari, poiché non era questo il mondo che aveva di fronte all’epoca. I funzionari hanno anche dato per scontato che il mondo si sarebbe coalizzato per affrontare le crisi comuni, come è successo nel 2008 con la crisi finanziaria, piuttosto che frammentarsi, come sarebbe successo di fronte a una pandemia unica nel secolo. Troppo spesso Washington ha trattato le istituzioni internazionali come se fossero un punto fermo, senza affrontare i modi in cui erano esclusive e non rappresentavano la più ampia comunità internazionale.
L’effetto complessivo è stato che, sebbene gli Stati Uniti siano rimasti la potenza preminente del mondo, alcuni dei suoi muscoli più vitali si sono atrofizzati. Inoltre, con l’elezione di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno avuto un presidente che credeva che le sue alleanze fossero una forma di benessere geopolitico. Le misure da lui adottate per danneggiare tali alleanze sono state celebrate da Pechino e Mosca, che hanno correttamente visto le alleanze statunitensi come una fonte di forza americana piuttosto che come una passività. Invece di agire per plasmare l’ordine internazionale, Trump si è tirato indietro.
Questo è ciò che ha dovuto affrontare il Presidente Biden quando è entrato in carica. Egli era determinato non solo a riparare i danni immediati alle alleanze degli Stati Uniti e alla loro leadership nel mondo libero, ma anche a perseguire il progetto a lungo termine di modernizzare la politica estera degli Stati Uniti per le sfide di oggi. Questo compito è stato messo in forte risalto dall’invasione immotivata dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 e dalla crescente assertività della Cina nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan.
L’essenza della politica estera del Presidente Biden è quella di gettare nuove basi per la forza americana, in modo che il Paese sia nella posizione migliore per plasmare la nuova era in modo da proteggere i propri interessi e valori e far progredire il bene comune. Il futuro del Paese sarà determinato da due fattori: la capacità di sostenere i propri vantaggi fondamentali nella competizione geopolitica e la capacità di mobilitare il mondo per affrontare le sfide transnazionali, dal cambiamento climatico alla salute globale, dalla sicurezza alimentare alla crescita economica inclusiva.
A livello fondamentale, ciò richiede un cambiamento nel modo in cui gli Stati Uniti pensano al potere. Questa amministrazione è entrata in carica convinta che il potere internazionale dipenda da un’economia nazionale forte e che la forza dell’economia non si misuri solo in base alle sue dimensioni o alla sua efficienza, ma anche in base al grado di funzionamento per tutti gli americani e di assenza di dipendenze pericolose. Abbiamo capito che il potere americano si basa anche sulle sue alleanze, ma che queste relazioni, molte delle quali risalgono a più di sette decenni fa, dovevano essere aggiornate e potenziate per le sfide di oggi. Ci siamo resi conto che gli Stati Uniti sono più forti quando lo sono anche i loro partner, e quindi ci siamo impegnati a fornire una proposta di valore migliore a livello globale per aiutare i Paesi a risolvere problemi urgenti che nessun Paese può risolvere da solo. E abbiamo riconosciuto che Washington non può più permettersi un approccio indisciplinato all’uso della forza militare, anche se abbiamo mobilitato uno sforzo massiccio per difendere l’Ucraina e fermare l’aggressione russa. L’amministrazione Biden comprende le nuove realtà del potere. Ed è per questo che lasceremo l’America più forte di come l’abbiamo trovata.
IL FRONTE INTERNO
Dopo la guerra fredda, gli Stati Uniti hanno sottovalutato l’importanza di investire nella vitalità economica del Paese. Nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il Paese aveva perseguito una politica di investimenti pubblici coraggiosi, anche nella ricerca e sviluppo e nei settori strategici. Questa strategia è stata alla base del suo successo economico, ma col tempo gli Stati Uniti se ne sono allontanati. Il governo statunitense ha elaborato politiche commerciali e un codice fiscale che non ponevano sufficiente attenzione sia ai lavoratori americani che al pianeta. Nell’esuberanza della “fine della storia”, molti osservatori sostenevano che le rivalità geopolitiche avrebbero lasciato il posto all’integrazione economica e la maggior parte credeva che i nuovi Paesi entrati nel sistema economico internazionale avrebbero adattato le loro politiche per rispettare le regole. Di conseguenza, l’economia statunitense ha sviluppato preoccupanti vulnerabilità. Mentre a livello aggregato prosperava, sotto la superficie, intere comunità venivano svuotate. Gli Stati Uniti hanno ceduto la leadership in settori manifatturieri critici. Non sono riusciti a fare i necessari investimenti nelle infrastrutture. E la classe media ne ha risentito.
Il Presidente Biden ha dato priorità agli investimenti per l’innovazione e la forza industriale in patria – ciò che è diventato noto come “Bidenomics”. Questi investimenti pubblici non mirano a scegliere vincitori e vinti o a porre fine alla globalizzazione. Consentono di sfruttare gli investimenti privati, piuttosto che sostituirli. E rafforzano la capacità degli Stati Uniti di garantire una crescita inclusiva, di costruire la resilienza e di proteggere la sicurezza nazionale.
L’amministrazione Biden ha varato i nuovi investimenti più consistenti degli ultimi decenni, tra cui il bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act, il CHIPS and Science Act e l’Inflation Reduction Act. Stiamo promuovendo nuove scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale, dell’informatica quantistica, delle biotecnologie, dell’energia pulita e dei semiconduttori, proteggendo al contempo i vantaggi e la sicurezza degli Stati Uniti attraverso nuovi controlli sulle esportazioni e regole sugli investimenti, in collaborazione con gli alleati. Queste politiche hanno fatto la differenza. Gli investimenti su larga scala nella produzione di semiconduttori e di energia pulita sono aumentati di 20 volte dal 2019. Ora stimiamo che gli investimenti pubblici e privati in questi settori ammonteranno a 3,5 trilioni di dollari nel prossimo decennio. E la spesa per l’edilizia nel settore manifatturiero è raddoppiata dalla fine del 2021.
La politica estera degli Stati Uniti è stata sviluppata in un’epoca che sta rapidamente diventando un ricordo.
Negli ultimi decenni, le catene di approvvigionamento degli Stati Uniti per i minerali critici sono diventate fortemente dipendenti dagli imprevedibili mercati esteri, molti dei quali dominati dalla Cina. Per questo motivo l’amministrazione sta lavorando per costruire catene di approvvigionamento resilienti e durature con partner e alleati in settori vitali – tra cui i semiconduttori, la medicina e le biotecnologie, i minerali critici e le batterie – in modo che gli Stati Uniti non siano vulnerabili alle interruzioni dei prezzi o delle forniture. Il nostro approccio comprende minerali importanti per tutti gli aspetti della sicurezza nazionale, comprendendo che i settori delle comunicazioni, dell’energia e dell’informatica sono essenziali quanto il tradizionale settore della difesa. Tutto ciò ha messo gli Stati Uniti in condizione di assorbire meglio i tentativi di potenze esterne di limitare l’accesso americano a fattori produttivi critici.
Quando questa amministrazione si è insediata, abbiamo scoperto che, sebbene le forze armate statunitensi siano le più forti al mondo, la loro base industriale soffriva di una serie di vulnerabilità non affrontate. Dopo anni di investimenti insufficienti, invecchiamento della forza lavoro e interruzioni della catena di approvvigionamento, importanti settori della difesa erano diventati più deboli e meno dinamici. L’amministrazione Biden sta ricostruendo questi settori, investendo nella base industriale dei sottomarini e producendo munizioni più critiche, in modo che gli Stati Uniti possano produrre ciò che è necessario per sostenere la deterrenza in regioni competitive. Stiamo investendo nel deterrente nucleare statunitense per garantirne la continua efficacia mentre i concorrenti aumentano i loro arsenali, segnalando al contempo l’apertura a futuri negoziati sul controllo degli armamenti se i concorrenti sono interessati. Stiamo inoltre collaborando con i laboratori e le aziende più innovative per garantire che le superiori capacità convenzionali degli Stati Uniti si avvalgano delle tecnologie più recenti.
Le future amministrazioni potrebbero essere diverse dalla nostra sui dettagli di come sfruttare le fonti interne di forza nazionale. Questo è un argomento legittimo da discutere. Ma in un mondo più competitivo, non c’è dubbio che Washington debba abbattere la barriera tra politica interna ed estera e che i grandi investimenti pubblici siano una componente essenziale della politica estera. Il Presidente Dwight Eisenhower lo fece negli anni Cinquanta. Lo stiamo facendo di nuovo oggi, ma in collaborazione con il settore privato, in coordinamento con gli alleati e concentrandoci sulle tecnologie d’avanguardia di oggi.
TUTTI INSIEME ORA
Le alleanze e le partnership degli Stati Uniti con altre democrazie sono state il loro più grande vantaggio internazionale. Hanno contribuito a creare un mondo più libero e stabile. Hanno contribuito a scoraggiare le aggressioni o a contrastarle. E hanno fatto sì che Washington non fosse mai costretta ad agire da sola. Ma queste alleanze sono state costruite per un’epoca diversa. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti le hanno sottoutilizzate o addirittura minate.
Il Presidente Biden è stato chiaro fin dal suo insediamento sull’importanza che attribuiva alle alleanze statunitensi, soprattutto alla luce dello scetticismo del suo predecessore nei loro confronti. Ma ha capito che anche coloro che hanno sostenuto queste alleanze negli ultimi tre decenni hanno spesso trascurato la necessità di modernizzarle per competere in un’epoca di interdipendenza. Di conseguenza, abbiamo rafforzato queste alleanze e partnership in modi concreti che migliorano la posizione strategica degli Stati Uniti e la loro capacità di affrontare le sfide comuni. Ad esempio, abbiamo mobilitato una coalizione globale di Paesi per sostenere l’Ucraina che si difende da una guerra di aggressione non provocata e per imporre costi alla Russia. La NATO si è allargata fino a includere la Finlandia, presto seguita dalla Svezia, due nazioni storicamente non allineate. La NATO ha anche modificato la sua posizione sul fianco orientale, ha dispiegato una capacità di risposta ai cyberattacchi contro i suoi membri e ha investito nelle sue difese aeree e missilistiche. Inoltre, gli Stati Uniti e l’UE hanno intensificato notevolmente la cooperazione in materia di economia, energia, tecnologia e sicurezza nazionale.
Stiamo facendo qualcosa di simile in Asia. In agosto, abbiamo tenuto un vertice storico a Camp David che ha consolidato una nuova era di cooperazione trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, portando al contempo le alleanze bilaterali degli Stati Uniti con questi Paesi a nuovi livelli. Di fronte ai pericolosi e illeciti programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord, stiamo lavorando per garantire che la deterrenza estesa degli Stati Uniti sia più forte che mai, affinché la regione rimanga pacifica e stabile. Per questo motivo abbiamo concluso la Dichiarazione di Washington con la Corea del Sud e stiamo portando avanti discussioni sulla deterrenza estesa trilaterale anche con il Giappone.

Attraverso l’AUKUS, il partenariato trilaterale di sicurezza tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, abbiamo integrato le basi industriali della difesa dei tre Paesi per produrre sottomarini a propulsione nucleare armati in modo convenzionale e aumentare la cooperazione su capacità avanzate come l’intelligenza artificiale, le piattaforme autonome e la guerra elettronica. L’accesso a nuovi siti grazie a un accordo di cooperazione in materia di difesa con le Filippine rafforza la posizione strategica degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. A settembre, il presidente Biden si è recato ad Hanoi per annunciare che gli Stati Uniti e il Vietnam stanno elevando le loro relazioni a un partenariato strategico globale. Il Quadrilatero, che riunisce Stati Uniti, Australia, India e Giappone, ha dato vita a nuove forme di cooperazione regionale in materia di tecnologia, clima, salute e sicurezza marittima. Stiamo anche investendo in un partenariato del XXI secolo tra Stati Uniti e India, ad esempio con l’iniziativa USA-India sulle tecnologie critiche ed emergenti. Attraverso il Quadro economico per la prosperità nell’Indo-Pacifico, stiamo approfondendo le relazioni commerciali e negoziando accordi, primi nel loro genere, sulla resilienza della catena di approvvigionamento, sull’economia dell’energia pulita, sulla lotta alla corruzione e sulla cooperazione fiscale con 13 partner diversi nella regione.
L’amministrazione sta rafforzando i partenariati statunitensi al di fuori dell’Asia e al di là dei tradizionali confini regionali. Lo scorso dicembre, in occasione del primo vertice dei leader USA-Africa dal 2014, gli Stati Uniti hanno assunto una serie di impegni storici, tra cui il sostegno all’adesione dell’Unione africana al G-20 e la firma di un memorandum d’intesa con il Segretariato dell’Area di libero scambio continentale africana, uno sforzo che creerebbe un mercato combinato a livello continentale di 1,3 miliardi di persone e 3,4 trilioni di dollari. All’inizio del 2022, abbiamo galvanizzato l’azione emisferica sulla migrazione attraverso la Dichiarazione di Los Angeles sulla migrazione e la protezione e abbiamo lanciato il Partenariato delle Americhe per la prosperità economica, un’iniziativa per guidare la ripresa economica dell’emisfero occidentale. Abbiamo anche creato una nuova coalizione con India, Israele, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, nota come I2U2. Questa coalizione riunisce l’Asia meridionale, il Medio Oriente e gli Stati Uniti attraverso iniziative congiunte su acqua, energia, trasporti, spazio, salute e sicurezza alimentare. Lo scorso settembre, gli Stati Uniti si sono uniti ad altri 31 Paesi del Nord America, del Sud America, dell’Africa e dell’Europa per creare il Partenariato per la cooperazione atlantica, con l’obiettivo di investire in scienza e tecnologia, promuovere l’uso sostenibile degli oceani e fermare il cambiamento climatico. Abbiamo costituito un nuovo partenariato informatico globale, che riunisce 47 Paesi e organizzazioni internazionali per contrastare il flagello del ransomware.
Non si tratta di sforzi isolati. Fanno parte di un reticolo di cooperazione che si auto-rinforza. I partner più stretti degli Stati Uniti sono le democrazie e noi lavoreremo con forza per difendere la democrazia in tutto il mondo. Il Vertice per la Democrazia, che il Presidente ha convocato per la prima volta nel 2021, ha creato una base istituzionale per approfondire la democrazia e promuovere la governance, la lotta alla corruzione e i diritti umani, e per far sì che le altre democrazie si facciano carico dell’agenda insieme a Washington. Ma la gamma di Paesi che sostengono la visione di Washington di un mondo libero, aperto, prospero e sicuro è ampia e potente, e comprende Paesi con sistemi politici diversi. Lavoreremo con tutti i Paesi disposti a difendere i principi della Carta dell’ONU, anche quando rafforzeremo una governance trasparente e responsabile e sosterremo i riformatori democratici e i difensori dei diritti umani.
Stiamo anche rafforzando il tessuto connettivo tra le alleanze statunitensi nell’Indo-Pacifico e in Europa. Gli Stati Uniti sono più forti in ogni regione grazie alle loro alleanze nell’altra. Gli alleati nell’Indo-Pacifico sono convinti sostenitori dell’Ucraina, mentre gli alleati in Europa aiutano gli Stati Uniti a sostenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. Gli sforzi del Presidente per rafforzare le alleanze stanno anche contribuendo alla più grande condivisione di oneri degli ultimi decenni. Gli Stati Uniti chiedono ai loro alleati di fare un passo avanti, ma offrono anche loro stessi di più. Circa 20 Paesi della NATO sono sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di spendere il 2% del PIL per la difesa nel 2024, rispetto ai soli sette Paesi del 2022. Il Giappone ha promesso di raddoppiare il suo bilancio per la difesa e sta acquistando missili Tomahawk di fabbricazione statunitense, che rafforzeranno la sua deterrenza nei confronti dei concorrenti con armi nucleari nella regione. Nell’ambito di AUKUS, l’Australia sta effettuando il più grande investimento singolo in capacità di difesa della sua storia, investendo anche nella base industriale della difesa statunitense. La Germania è diventata il terzo fornitore di armi all’Ucraina e sta abbandonando l’energia russa.
UN ACCORDO MIGLIORE
Il primo anno della pandemia COVID-19 ha dimostrato che se gli Stati Uniti non sono disposti a guidare gli sforzi per risolvere i problemi globali, nessun altro si farà avanti. Nel 2020, molti leader mondiali erano a malapena in grado di parlare. Il G-7 ha faticato a riunirsi quando la COVID-19 ha colpito. Invece di coordinarsi strettamente, i Paesi hanno intrapreso sforzi disparati che hanno reso la pandemia più grave di quanto avrebbe potuto essere altrimenti. Il Presidente Biden e la sua squadra hanno sempre creduto che gli Stati Uniti abbiano un ruolo cruciale da svolgere nello stimolare la cooperazione internazionale, che si tratti di economia globale, salute, sviluppo o ambiente. Ma l’esperienza sconvolgente di una crisi globale senza una leadership globale ha segnato questo aspetto nella visione del mondo del Presidente. Guardando all’imponente serie di sfide globali, ci siamo resi conto che non avremmo dovuto limitarci a ripristinare la leadership degli Stati Uniti; avremmo dovuto anche alzare il tiro e offrire al mondo, soprattutto al Sud del mondo, una proposta di valore migliore.
La maggior parte del mondo non è preoccupata dalle gare geopolitiche; la maggior parte dei Paesi vuole sapere di avere partner in grado di aiutarli ad affrontare i problemi che si trovano ad affrontare, alcuni dei quali sembrano esistenziali. Per questi Paesi, la lamentela non è che c’è troppa America, ma troppo poca. Sì, dicono, vediamo le insidie dell’avvicinamento alle grandi potenze autoritarie, ma qual è la vostra alternativa? Il Presidente Biden lo capisce. Dove gli Stati Uniti erano assenti, ora sono competitivi. Dove erano competitivi, ora guidano con urgenza e determinazione. E lo fanno in collaborazione con altri Paesi, cercando di capire come risolvere insieme i problemi più urgenti.
Gli Stati Uniti hanno mantenuto la loro leadership di lunga data nello sviluppo globale, hanno sostenuto i loro investimenti vitali nella salute e nella sicurezza alimentare e sono rimasti il principale fornitore di assistenza umanitaria e di aiuti alimentari d’emergenza in un momento di bisogno globale senza precedenti. Il Presidente Biden è ora alla guida di uno sforzo globale per innalzare ulteriormente le ambizioni. Gli Stati Uniti stanno dando priorità alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Stanno potenziando le banche multilaterali di sviluppo, mobilitando il settore privato e aiutando i Paesi a sbloccare il capitale nazionale. Come pietra miliare di questo sforzo, l’amministrazione sta modernizzando la Banca Mondiale in modo che possa affrontare le sfide di oggi con sufficiente velocità e scala, e stiamo lavorando con i partner per aumentare significativamente i finanziamenti della banca, anche ai Paesi a basso e medio reddito. Stiamo inoltre facendo pressione per trovare soluzioni che aiutino i Paesi vulnerabili ad affrontare in modo rapido e trasparente il debito insostenibile, liberando risorse che consentano loro di investire nel proprio futuro anziché pagare debiti spropositati.
Negli ultimi anni, la Belt and Road Initiative della Cina è stata dominante e gli Stati Uniti sono rimasti indietro negli investimenti infrastrutturali su larga scala nei Paesi in via di sviluppo. Ora, gli Stati Uniti stanno mobilitando centinaia di miliardi di dollari di capitali attraverso il Partenariato del G-7 per le infrastrutture e gli investimenti globali per sostenere le infrastrutture fisiche, digitali, di energia pulita e sanitarie nei Paesi in via di sviluppo.
L’amministrazione Biden comprende le nuove realtà del potere.
Gli Stati Uniti hanno aperto la strada alla salute globale. Stanno investendo più che mai per porre fine a epidemie come l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria come minacce per la salute pubblica entro il 2030. Ha donato quasi 700 milioni di dosi di vaccino COVID-19 a più di 115 Paesi e quasi la metà di tutti i fondi per la risposta globale alle pandemie, e rimane vigile sulle minacce emergenti. Sta aiutando 50 Paesi a prepararsi, prevenire e rispondere alla prossima emergenza sanitaria. La maggior parte delle persone probabilmente non ha sentito parlare dei recenti focolai di malattia da virus di Marburg o di Ebola, perché abbiamo imparato la lezione dell’epidemia di Ebola nell’Africa occidentale del 2014 e abbiamo risposto prima che i focolai nell’Africa orientale, centrale e occidentale diventassero globali.
Nessun Paese può offrire una proposta di valore credibile al mondo se non affronta seriamente il problema del cambiamento climatico. L’amministrazione Biden ha ereditato un enorme divario tra ambizioni e realtà per quanto riguarda la mitigazione delle emissioni di carbonio. Gli Stati Uniti stanno ora guidando la diffusione su scala mondiale di tecnologie energetiche pulite. Per la prima volta, il Paese rispetterà l’impegno nazionale previsto dall’Accordo di Parigi di ridurre le emissioni nette di gas serra e l’impegno globale di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno per i Paesi in via di sviluppo per affrontare il cambiamento climatico. Ha lanciato iniziative congiunte come la Just Energy Transition Partnership con l’Indonesia, che accelererà la transizione del settore energetico del Paese con il sostegno di fonti pubbliche e private.
I nuovi partenariati adatti allo scopo non sono destinati a sostituire le istituzioni internazionali esistenti. L’amministrazione Biden sta lavorando per rafforzare e rinvigorire queste istituzioni, aggiornandole per il mondo di oggi. Oltre a modernizzare la Banca Mondiale, il Presidente ha proposto di dare ai Paesi in via di sviluppo maggiore voce in capitolo nel Fondo Monetario Internazionale. L’amministrazione continuerà a cercare di riformare l’Organizzazione mondiale del commercio in modo che possa guidare la transizione verso l’energia pulita, proteggere i lavoratori e promuovere una crescita inclusiva e sostenibile, continuando a sostenere la concorrenza, l’apertura, la trasparenza e lo Stato di diritto. Il Presidente ha chiesto riforme profonde del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per ampliare il numero dei membri, permanenti e non, e renderlo più efficace e rappresentativo.
Il Presidente sa anche che i Paesi devono essere in grado di cooperare per affrontare sfide che fino a poco tempo fa erano impensabili. Questa necessità è particolarmente urgente per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. Per questo motivo abbiamo riunito le principali aziende statunitensi responsabili dell’innovazione dell’IA per assumere una serie di impegni volontari per sviluppare l’IA in modo sicuro, protetto e trasparente. È per questo che lo stesso governo degli Stati Uniti si è impegnato in tal senso, rilasciando a febbraio una dichiarazione sull’uso militare responsabile dell’IA. Ed è per questo che stiamo sviluppando queste iniziative lavorando con gli alleati, i partner e altri Paesi per sviluppare regole e principi forti per governare l’IA.
La proposta di un valore migliore è un lavoro in corso, ma è un pilastro vitale di una nuova base di forza americana. Non solo è la cosa giusta da fare, ma serve anche agli interessi degli Stati Uniti. Aiutare altri Paesi a rafforzarsi rende l’America più forte e più sicura. Crea nuovi partner e migliori amici. Continueremo a costruire l’offerta affermativa dell’America al mondo. È assolutamente necessario se gli Stati Uniti vogliono vincere la competizione per plasmare il futuro dell’ordine internazionale in modo che sia libero, aperto, prospero e sicuro.
SCEGLIERE LE PROPRIE BATTAGLIE
Negli anni Novanta, la politica di difesa degli Stati Uniti era dominata da questioni relative all’opportunità e alle modalità di intervento nei Paesi devastati dalla guerra per prevenire atrocità di massa. Dopo l’11 settembre, gli Stati Uniti hanno spostato la loro attenzione sui gruppi terroristici. Il rischio di un conflitto tra grandi potenze sembrava remoto. La situazione ha iniziato a cambiare con le invasioni russe della Georgia nel 2008 e dell’Ucraina nel 2014, nonché con la modernizzazione militare a rotta di collo della Cina e le sue crescenti provocazioni militari nei mari della Cina orientale e meridionale e nello stretto di Taiwan. Ma le priorità dell’America non si erano adattate abbastanza velocemente alle sfide di dissuadere le aggressioni delle grandi potenze e di reagire una volta che si sono verificate.
Il Presidente Biden era determinato ad adattarsi. Ha posto fine al coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra in Afghanistan, la più lunga della storia americana, e ha liberato gli Stati Uniti dal sostenere forze militari in ostilità attive per la prima volta in due decenni. Questa transizione è stata indubbiamente dolorosa, soprattutto per la popolazione dell’Afghanistan e per le truppe statunitensi e il personale che vi ha prestato servizio. Ma era necessaria per preparare le forze armate statunitensi alle sfide future. Una di queste sfide è arrivata più rapidamente del previsto, con la brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022. Se gli Stati Uniti stessero ancora combattendo in Afghanistan, è molto probabile che la Russia starebbe facendo tutto il possibile per aiutare i Talebani a bloccare Washington, impedendole di concentrare la sua attenzione sull’aiuto all’Ucraina.
Anche se le nostre priorità si allontanano dai grandi interventi militari, rimaniamo pronti ad affrontare la minaccia duratura del terrorismo internazionale. Abbiamo agito oltre l’orizzonte in Afghanistan – in particolare con l’operazione che ha ucciso il capo di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri – e abbiamo tolto dal campo di battaglia altri obiettivi terroristici in Somalia, Siria e altrove. Continueremo a farlo. Ma eviteremo anche le guerre prolungate per sempre che possono immobilizzare le forze statunitensi e che fanno poco per ridurre effettivamente le minacce agli Stati Uniti.
Per quanto riguarda il Medio Oriente in generale, il Presidente ha ereditato una regione molto sotto pressione. La versione originale di questo articolo, scritta prima degli attacchi terroristici di Hamas in Israele del 7 ottobre, sottolineava i progressi compiuti in Medio Oriente dopo due decenni segnati da un massiccio intervento militare statunitense in Iraq, da una campagna militare della NATO in Libia, da guerre civili furiose, da crisi di rifugiati, dall’ascesa di un califfato terroristico autodichiarato, da rivoluzioni e controrivoluzioni e dalla rottura delle relazioni tra i Paesi chiave della regione. Il documento descrive i nostri sforzi per tornare a un approccio disciplinato alla politica statunitense che dia priorità alla dissuasione dall’aggressione, alla riduzione dei conflitti e all’integrazione della regione attraverso progetti infrastrutturali congiunti, anche tra Israele e i suoi vicini arabi. Ci sono stati progressi materiali. La guerra nello Yemen aveva raggiunto il 18° mese di tregua. Altri conflitti si sono raffreddati. I leader regionali collaboravano apertamente. A settembre, il presidente ha annunciato un nuovo corridoio economico che collega l’India all’Europa attraverso gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, la Giordania e Israele.

La versione originale di questo articolo sottolineava che questi progressi erano fragili e che rimanevano sfide perenni, tra cui le tensioni tra Israele e Palestina e la minaccia rappresentata dall’Iran. Gli attentati del 7 ottobre hanno gettato un’ombra sull’intero quadro regionale, le cui ripercussioni si stanno ancora manifestando, compreso il rischio di una significativa escalation regionale. Ma l’approccio disciplinato in Medio Oriente che abbiamo perseguito rimane fondamentale per la nostra posizione e la nostra pianificazione nell’affrontare questa crisi.
Come ha dimostrato il Presidente Biden recandosi in Israele in una rara visita di guerra il 18 ottobre, gli Stati Uniti sostengono fermamente Israele che protegge i suoi cittadini e si difende dai brutali terroristi. Stiamo lavorando a stretto contatto con i partner regionali per facilitare la fornitura sostenibile di assistenza umanitaria ai civili nella Striscia di Gaza. Il Presidente ha ripetutamente chiarito che gli Stati Uniti sono a favore della protezione della vita dei civili durante i conflitti e del rispetto delle leggi di guerra. Hamas, che ha commesso atrocità che ricordano le peggiori devastazioni dell’ISIS, non rappresenta il popolo palestinese e non difende il suo diritto alla dignità e all’autodeterminazione. Siamo impegnati per una soluzione a due Stati che lo sia. Infatti, le nostre discussioni con l’Arabia Saudita e Israele per la normalizzazione hanno sempre incluso proposte significative per i palestinesi. Se concordata, questa componente garantirebbe che il percorso verso due Stati rimanga percorribile, con passi significativi e concreti compiuti in questa direzione da tutte le parti interessate.
Siamo attenti al rischio che la crisi attuale possa trasformarsi in un conflitto regionale. Abbiamo condotto un’ampia attività diplomatica e rafforzato la nostra posizione militare nella regione. Fin dall’inizio di questa amministrazione, abbiamo agito militarmente quando necessario per proteggere il personale statunitense. Siamo impegnati a garantire che l’Iran non ottenga mai un’arma nucleare. E sebbene la forza militare non debba mai essere uno strumento di prima istanza, siamo pronti e preparati a usarla quando necessario per proteggere il personale e gli interessi degli Stati Uniti in questa importante regione.
Il nostro approccio in Ucraina è sostenibile.
La crisi in Medio Oriente non cambia il fatto che gli Stati Uniti devono prepararsi a una nuova era di competizione strategica, in particolare scoraggiando e rispondendo alle aggressioni delle grandi potenze. Quando abbiamo scoperto che il Presidente russo Vladimir Putin si stava preparando a invadere l’Ucraina, ci siamo trovati di fronte a una sfida: gli Stati Uniti non erano impegnati per trattato nella difesa dell’Ucraina, ma se l’aggressione russa fosse rimasta senza risposta, uno Stato sovrano sarebbe stato estinto e sarebbe stato inviato un messaggio agli autocrati di tutto il mondo: il potere rende bene. Abbiamo cercato di evitare la crisi facendo capire alla Russia che gli Stati Uniti avrebbero risposto sostenendo l’Ucraina e mostrando la volontà di impegnarsi in colloqui sulla sicurezza europea, anche se la Russia non era seriamente intenzionata a farlo. Abbiamo anche utilizzato la divulgazione pubblica, deliberata e autorizzata, di informazioni di intelligence per mettere in guardia l’Ucraina, per riunire i partner statunitensi e per privare la Russia della capacità di creare falsi pretesti per la sua invasione.
Quando Putin ha invaso, abbiamo attuato una politica per aiutare l’Ucraina a difendersi senza inviare truppe americane in guerra. Gli Stati Uniti hanno inviato quantità massicce di armi difensive agli ucraini e hanno chiamato a raccolta alleati e partner per fare lo stesso. Hanno coordinato l’immenso impegno logistico per portare queste capacità sul campo di battaglia. L’assistenza è stata finora suddivisa in 47 diversi pacchetti di assistenza militare, strutturati per rispondere alle esigenze dell’Ucraina che si sono evolute nel corso del conflitto. Abbiamo collaborato strettamente con il governo ucraino sulle sue esigenze e abbiamo lavorato sui dettagli tecnici e logistici per assicurarci che le sue forze avessero ciò di cui avevano bisogno. Abbiamo anche aumentato la cooperazione di intelligence degli Stati Uniti con l’Ucraina, così come gli sforzi di formazione. E abbiamo imposto sanzioni di ampia portata alla Russia per ridurre la sua capacità di condurre guerre.
Il Presidente Biden ha anche chiarito che se la Russia avesse attaccato un alleato della NATO, gli Stati Uniti avrebbero difeso ogni centimetro di territorio alleato, sostenendo questo con nuovi dispiegamenti di forze. Abbiamo avviato un processo con gli alleati e i partner statunitensi per aiutare l’Ucraina a costruire un esercito in grado di difendersi a terra, in mare e in aria e di scoraggiare future aggressioni. Il nostro approccio in Ucraina è sostenibile e, contrariamente a chi dice il contrario, aumenta la capacità degli Stati Uniti di far fronte a qualsiasi contingenza nell’Indo-Pacifico. Il popolo americano riconosce un bullo quando lo vede. Capisce che se gli Stati Uniti dovessero togliere il loro sostegno all’Ucraina, non solo metterebbero gli ucraini in grave svantaggio nel difendersi, ma creerebbero anche un terribile precedente, incoraggiando l’aggressione in Europa e altrove. Il sostegno americano all’Ucraina è ampio e profondo, e durerà.
LA COMPETIZIONE CHE VERRÀ
È chiaro che il mondo sta diventando più competitivo, che la tecnologia sarà una forza dirompente e che i problemi comuni si acuiranno nel tempo. Ma non è chiaro come queste forze si manifesteranno. Gli Stati Uniti sono stati sorpresi in passato (con la crisi dei missili di Cuba nel 1962 e l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1990) e probabilmente lo saranno anche in futuro, a prescindere da quanto il governo si impegni per anticipare ciò che sta per accadere (e le agenzie di intelligence statunitensi hanno azzeccato molte cose, compreso l’accurato avvertimento dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022). La nostra strategia è progettata per funzionare in un’ampia varietà di scenari. Investendo nelle fonti di forza interne, approfondendo le alleanze e i partenariati, ottenendo risultati nelle sfide globali e rimanendo disciplinati nell’esercizio del potere, gli Stati Uniti saranno pronti a portare avanti la loro visione di un mondo libero, aperto, prospero e sicuro, indipendentemente dalle sorprese che si presenteranno. Abbiamo creato, secondo le parole del Segretario di Stato Dean Acheson, “situazioni di forza”.
L’imminente era della competizione sarà diversa da qualsiasi cosa sperimentata in precedenza. La competizione per la sicurezza europea nel diciannovesimo e all’inizio del ventesimo secolo è stata in gran parte una gara regionale tra potenze di medie dimensioni e vicine che alla fine si è conclusa con una catastrofe. La guerra fredda che ha seguito la guerra più distruttiva della storia dell’umanità è stata combattuta tra due superpotenze che avevano livelli di interdipendenza molto bassi. Si è conclusa in modo decisivo e a favore dell’America. La competizione odierna è fondamentalmente diversa. Gli Stati Uniti e la Cina sono economicamente interdipendenti. La competizione è davvero globale, ma non a somma zero. Le sfide comuni che le due parti devono affrontare sono senza precedenti.
Spesso ci viene chiesto quale sarà lo stato finale della competizione degli Stati Uniti con la Cina. Ci aspettiamo che la Cina rimanga un attore importante sulla scena mondiale nel prossimo futuro. Vogliamo un ordine internazionale libero, aperto, prospero e sicuro, che protegga gli interessi degli Stati Uniti e dei suoi amici e fornisca beni pubblici globali. Ma non ci aspettiamo uno stato finale trasformativo come quello che ha portato al crollo dell’Unione Sovietica. La competizione avrà un andamento altalenante: gli Stati Uniti guadagneranno, ma anche la Cina. Washington deve bilanciare il senso di urgenza con la pazienza, comprendendo che ciò che conta è la somma delle sue azioni, non la vittoria in un singolo ciclo di notizie. E abbiamo bisogno di un senso di fiducia costante nella nostra capacità di competere con qualsiasi Paese. Gli ultimi due anni e mezzo hanno stravolto le ipotesi sulle traiettorie relative di Stati Uniti e Cina.
L’imminente era della competizione sarà diversa da quella vissuta in precedenza.
Gli Stati Uniti continuano a intrattenere rapporti commerciali e di investimento sostanziali con la Cina. Ma le relazioni economiche con la Cina sono complicate perché il Paese è un concorrente. Non ci scusiamo se ci opponiamo alle pratiche commerciali sleali che danneggiano i lavoratori americani. E temiamo che la Cina possa approfittare dell’apertura dell’America per utilizzare le tecnologie statunitensi contro gli Stati Uniti e i suoi alleati. In questo contesto, cerchiamo di “de-rischiare” e di diversificare, non di disaccoppiare. Vogliamo proteggere un numero mirato di tecnologie sensibili con restrizioni mirate, creando quello che alcuni hanno definito “un cortile piccolo e un recinto alto”. Da più parti ci è stato rimproverato di essere mercantilisti o protezionisti. Non è vero. Si tratta di misure adottate in collaborazione con altri e focalizzate su un insieme ristretto di tecnologie, misure che gli Stati Uniti devono adottare in un mondo più contestato per proteggere la loro sicurezza nazionale e sostenere un’economia globale interconnessa.
Allo stesso tempo, stiamo approfondendo la cooperazione tecnologica con partner e alleati che la pensano allo stesso modo, anche con l’India e attraverso il Consiglio per il commercio e la tecnologia tra Stati Uniti e Unione Europea, un forum creato nel 2021. Continueremo a investire nelle capacità degli Stati Uniti e in catene di approvvigionamento sicure e resilienti. Continueremo a portare avanti un’agenda che promuova i diritti dei lavoratori per ottenere un lavoro dignitoso, sicuro e sano in patria e all’estero, per creare condizioni di parità per i lavoratori e le aziende americane.
A volte la competizione sarà intensa. Siamo preparati a questo. Stiamo respingendo con forza le aggressioni, le coercizioni e le intimidazioni e stiamo difendendo le regole fondamentali della strada, come la libertà di navigazione in mare. Come ha detto il Segretario di Stato Antony Blinken in un discorso di settembre, “l’interesse illuminato dell’America a preservare e rafforzare questo ordine non è mai stato così grande”. Siamo anche consapevoli che i concorrenti degli Stati Uniti, in particolare la Cina, hanno una visione fondamentalmente diversa.
Ma Washington e Pechino devono capire come gestire la concorrenza per ridurre le tensioni e trovare una via d’uscita alle sfide comuni. Per questo motivo l’amministrazione Biden sta intensificando la diplomazia statunitense con la Cina, preservando i canali di comunicazione esistenti e creandone di nuovi. Gli americani hanno interiorizzato alcune lezioni delle crisi dei decenni passati, in particolare la possibilità di inciampare in un conflitto. L’interazione ad alto livello e ripetuta è fondamentale per chiarire le percezioni errate, evitare gli errori di comunicazione, inviare segnali inequivocabili e arrestare le spirali negative che potrebbero sfociare in una crisi grave. Purtroppo, Pechino sembra aver spesso tratto lezioni diverse sulla gestione delle tensioni, concludendo che i guardrail possono alimentare la competizione come le cinture di sicurezza incoraggiano la guida spericolata. (Si tratta di una convinzione errata. Proprio come l’uso delle cinture di sicurezza dimezza gli incidenti stradali, così la comunicazione e le misure di sicurezza di base riducono il rischio di incidenti geopolitici). Di recente, tuttavia, sono emersi segnali incoraggianti che indicano che Pechino potrebbe riconoscere il valore della stabilizzazione. Il vero banco di prova sarà la capacità dei canali di resistere quando le tensioni inevitabilmente aumenteranno.

Dobbiamo anche ricordare che non tutto ciò che fanno i concorrenti è incompatibile con gli interessi degli Stati Uniti. L’accordo che la Cina ha mediato quest’anno tra l’Iran e l’Arabia Saudita ha parzialmente ridotto le tensioni tra questi due Paesi, uno sviluppo che anche gli Stati Uniti desiderano vedere. Washington non avrebbe potuto cercare di mediare quell’accordo, data la mancanza di relazioni diplomatiche degli Stati Uniti con l’Iran, e non dovrebbe cercare di minarlo. Per fare un altro esempio, Stati Uniti e Cina sono impegnati in una competizione tecnologica rapida e ad alta posta in gioco, ma le due parti devono essere in grado di collaborare sui rischi derivanti dall’intelligenza artificiale. Non si tratta di un segno di debolezza, ma di una chiara valutazione dei rischi derivanti dall’intelligenza artificiale. Riflette una chiara valutazione del fatto che l’intelligenza artificiale potrebbe porre sfide uniche all’umanità e che le grandi potenze hanno la responsabilità collettiva di affrontarle.
È naturale che i Paesi non allineati né con gli Stati Uniti né con la Cina si impegnino con entrambi, cercando di trarre vantaggio dalla competizione e cercando al contempo di proteggere i propri interessi da eventuali ricadute. Molti di questi Paesi si considerano parte del Sud globale, un gruppo che ha una logica propria e una critica distinta dell’Occidente che risale alla Guerra Fredda e alla fondazione del Movimento dei Non Allineati. A differenza di quanto avveniva durante la Guerra Fredda, tuttavia, gli Stati Uniti eviteranno la tentazione di vedere il mondo solo attraverso il prisma della competizione geopolitica o di trattare questi Paesi come luoghi di contesa per procura. Continueranno invece a impegnarsi con loro alle loro condizioni. Washington dovrebbe essere realistica sulle sue aspettative nei confronti di questi Paesi, rispettando la loro sovranità e il loro diritto di prendere decisioni che promuovano i loro interessi. Ma deve anche essere chiaro su ciò che è più importante per gli Stati Uniti. Questo è il modo in cui cercheremo di plasmare le relazioni con questi Paesi: in modo che, nel complesso, siano incentivati ad agire in modo coerente con gli interessi degli Stati Uniti.
Nel decennio a venire, i funzionari statunitensi passeranno più tempo di quanto non abbiano fatto negli ultimi 30 anni a parlare con Paesi con cui non sono d’accordo, spesso su questioni fondamentali. Il mondo è sempre più conteso e gli Stati Uniti non possono parlare solo con chi condivide la loro visione o i loro valori. Continueremo a lavorare per plasmare il panorama diplomatico generale in modo da promuovere gli interessi degli Stati Uniti e quelli comuni. Ad esempio, quando la Cina, il Brasile e un gruppo di sette Paesi africani hanno annunciato di voler perseguire sforzi di pace per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina, non abbiamo respinto queste iniziative per principio; abbiamo chiesto a questi Paesi di parlare con i funzionari ucraini e di offrire garanzie che le loro proposte di soluzione sarebbero state coerenti con la Carta delle Nazioni Unite.
Alcuni dei semi che stiamo piantando ora – gli investimenti in tecnologie avanzate, ad esempio, o i sottomarini AUKUS – richiederanno molti anni per dare i loro frutti. Ma ci sono anche alcune questioni su cui possiamo e vogliamo agire ora, quelle che chiamiamo le nostre “questioni in sospeso”. Dobbiamo garantire un’Ucraina sovrana, democratica e libera. Dobbiamo rafforzare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. Dobbiamo far progredire l’integrazione regionale in Medio Oriente, continuando a controllare l’Iran. Dobbiamo modernizzare la base militare e industriale degli Stati Uniti. E dobbiamo mantenere gli impegni in materia di infrastrutture, sviluppo e clima nei confronti del Sud del mondo.
A NOI LA SCELTA
Gli Stati Uniti hanno raggiunto la terza fase del ruolo globale assunto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nella prima fase, l’amministrazione Truman ha gettato le basi del potere americano per raggiungere due obiettivi: rafforzare le democrazie e la cooperazione democratica e contenere l’Unione Sovietica. Questa strategia, portata avanti dai presidenti successivi, comprendeva uno sforzo globale per investire nell’industria americana, soprattutto nelle nuove tecnologie, dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. L’impegno per la forza nazionale attraverso gli investimenti industriali ha iniziato a ridursi negli anni ’80 e, dopo la guerra fredda, se ne è percepita la scarsa necessità. Nella seconda fase, con gli Stati Uniti senza concorrenti di pari livello, le amministrazioni che si sono succedute hanno cercato di ampliare l’ordine basato sulle regole guidato dagli Stati Uniti e di stabilire modelli di cooperazione su questioni critiche. Quest’epoca ha trasformato il mondo in meglio in vari modi – molti Paesi sono diventati più liberi, prosperi e sicuri, la povertà globale è stata ridotta e il mondo ha risposto efficacemente alla crisi finanziaria del 2008 – ma è stata anche un periodo di cambiamenti geopolitici.
Gli Stati Uniti si trovano ora all’inizio della terza era: quella in cui si stanno adattando a un nuovo periodo di competizione in un’epoca di interdipendenza e sfide transnazionali. Ciò non significa rompere con il passato o rinunciare alle conquiste ottenute, ma significa gettare nuove basi per la forza americana. Ciò richiede la revisione di presupposti di vecchia data se vogliamo lasciare l’America più forte di come l’abbiamo trovata e meglio preparata per ciò che ci aspetta. L’esito di questa fase non sarà determinato solo da forze esterne. Sarà anche, in larga misura, deciso dalle scelte degli Stati Uniti.
EDITOR’S NOTE
Before this article was posted online, a passage in it about the Middle East was updated to address Hamas’s attack on Israel, which occurred after the print version of the article went to press.
(Updated on October 25) A PDF of the print version, which went to press on October 2, is available here.




Tutte le agenzie di intelligence falliscono, spesso in modo spettacolare. Le valutazioni errate della Central Intelligence Agency sul programma nucleare di Saddam Hussein prima della guerra in Iraq, la convinzione dei servizi segreti tedeschi che il presidente russo Vladimir Putin stesse bluffando sull’invasione dell’Ucraina, la certezza di tutti e tre i servizi segreti russi che le forze ucraine si sarebbero rapidamente piegate: il fallimento è il prezzo da pagare in una professione che deve prevedere cosa farà un attore straniero sulla base di informazioni nascoste, incomplete, imperfette e talvolta ingannevoli.
Per i servizi segreti israeliani – tra i meglio addestrati, dedicati e tecnologicamente avanzati al mondo – gli eventi del 7 ottobre sono un fallimento particolarmente doloroso. I mesi e gli anni che seguiranno permetteranno di esaminare a fondo come un apparato di intelligence di livello mondiale, con una vasta e precisa raccolta di informazioni focalizzata sulla Striscia di Gaza e sulla leadership di Hamas, abbia potuto non cogliere le indicazioni di un attacco di tale portata. Ritenendo che la minaccia di Hamas fosse prevedibile e contenuta, Israele ha probabilmente dedicato le sue migliori capacità tecniche e umane di intelligence alle minacce apparentemente più significative dell’Iran e di Hezbollah. Non tutte le risorse di intelligence sono uguali, e ciò che è rimasto a coprire la Striscia di Gaza potrebbe essere stato insufficiente in termini di portata e di capacità.
Tuttavia, spesso viene trascurato nelle autopsie dell’intelligence il ruolo dell’obiettivo stesso. Il fallimento non deriva solo da difetti interni, ma può anche essere indotto da un avversario abile nella negazione e nell’inganno e disposto a usare tattiche prima difficilmente immaginabili. Nascondere un attacco di questa portata e complessità e ottenere una completa sorpresa tattica con un ampio preavviso indica un drammatico aumento delle capacità di intelligence e di sicurezza di Hamas negli ultimi anni. Tali capacità sono state il segno distintivo di un’altra milizia, con la quale Hamas, non a caso, ha recentemente ricucito i legami: Hezbollah. Sia osservando e applicando le tattiche che il gruppo libanese ha appreso in quattro decenni di guerra d’intelligence con Israele, sia, come sembra probabile, ricevendo direttamente addestramento, consulenza e pianificazione a Beirut, Hamas nel suo attacco ha mostrato un’audacia, una ferocia e una raffinatezza che i servizi segreti israeliani e occidentali avrebbero ritenuto possibili solo da Hezbollah.
Rimanete informati.
Analisi approfondite con cadenza settimanale.
Iscriviti
Mentre Israele lotta per riprendere il controllo dei suoi villaggi e dei suoi cittadini, si sta anche preparando a qualcosa che ha cercato di evitare da quando si è ritirato dalla Striscia di Gaza nel 2005: un’invasione di terra e una guerra totale con Hamas sul suo territorio nazionale. Ma con la guerra in atto nel sud, un’altra domanda incombe a nord: cosa farà Hezbollah? Il gruppo libanese è rimasto fuori dai precedenti conflitti tra Israele e Hamas. Ma i responsabili politici israeliani e statunitensi non dovrebbero trascurare il rischio che una guerra prolungata possa indurre Hezbollah a cambiare i propri calcoli, aprendo un conflitto ancora più devastante che potrebbe rapidamente degenerare in una guerra regionale. Anche se Israele concentra le sue forze sulla Striscia di Gaza, insieme ai suoi alleati deve contemporaneamente ristabilire un deterrente a nord, per garantire che Hezbollah continui a rimanere in disparte.
“I NOSTRI CUORI SONO CON VOI
Sia Hamas che Hezbollah hanno a lungo beneficiato del sostegno iraniano. Mentre alimentava l’ascesa di Hezbollah in Libano negli anni ’80 e ’90, Teheran cercava anche opportunità nei territori palestinesi, in un momento in cui Hamas stava emergendo dalla Prima Intifada. Mentre Hezbollah è sciita (come il regime iraniano) e Hamas è sunnita, entrambi mostravano ferocia, fondamentalismo islamico e dedizione alla distruzione di Israele, tutti elementi che si adattavano alla strategia di Teheran di costruire proxy regionali. Così sono iniziati due decenni di sostegno militare, politico e finanziario iraniano a entrambi i gruppi.
Negli anni ’90 e nel decennio successivo, Hezbollah e Hamas hanno stretto legami, come fronti di supporto reciproco nell'”asse della resistenza” iraniano. Hezbollah ha ospitato la leadership di Hamas a Beirut, si è allenato con i campi di combattenti di Hamas nel sud del Libano e nella Valle della Bekaa, nel Libano orientale, e ha contrabbandato armi e materiali nella Striscia di Gaza durante la Seconda Intifada (dal 2000 al 2005). All’inizio degli anni 2010, le due milizie erano partner stretti.
Questi legami sono stati messi a dura prova a partire dal 2011, quando la rivolta siriana è sfociata in guerra civile: Hamas ha scelto di schierarsi dalla parte della strada sunnita contro il regime sostenuto da Hezbollah e dall’Iran del leader siriano Bashar al-Assad, un altro membro dell’asse di resistenza di Teheran. Ma l’alleanza si è ristabilita quando la guerra civile siriana ha iniziato a scemare, soprattutto dopo che Yahya al-Sinwar, da sempre collaboratore di Teheran e di Hezbollah, ha assunto la guida di Hamas nel 2017. Da allora, la partnership si è solidificata, con il Libano che è diventato un hub critico per il coordinamento. Nel 2018, Hamas ha riaperto i suoi uffici politici a Beirut e diversi leader chiave vi si sono trasferiti. Nel 2021, secondo quanto riferito, l’Iran vi ha istituito una “sala operativa congiunta”, con personale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran, di Hezbollah e di Hamas, per coordinare le attività militari, di intelligence e terroristiche contro Israele.
Hezbollah potrebbe aver già cambiato la sua valutazione delle capacità israeliane.
Hamas ha avuto molto da guadagnare da questa partnership. I combattenti di Hezbollah hanno acquisito una notevole esperienza militare partecipando alle guerre in Iraq, Siria e Yemen, oltre che alla lunga guerra ombra del gruppo con i servizi segreti israeliani. Particolarmente preziosa per Hamas è stata l’esperienza di Hezbollah in materia di intelligence, controspionaggio, sicurezza operativa e inganno. Sembra probabile che aspetti chiave dell’attacco di Hamas a Israele siano stati modellati nella sala operativa di Beirut sotto la tutela di Hezbollah.
Nonostante abbia offerto addestramento e sostegno ad Hamas, Hezbollah potrebbe non voler intervenire direttamente nella guerra con Israele iniziata con l’attacco dello scorso fine settimana. Il giorno dopo, il numero due di Hezbollah, Hashim Safi al Din, ha fatto una promessa: “I nostri cuori sono con voi. Le nostre menti sono con voi. Le nostre anime sono con voi. La nostra storia, le nostre armi e i nostri razzi sono con voi”. In questa promessa mancava decisamente qualsiasi indicazione che i soldati di Hezbollah fossero con Hamas. In altri recenti scontri tra Israele e Hamas (nel 2008, nel 2014 e nel 2021), Hezbollah ha offerto sostegno politico e ha condotto occasionali attacchi transfrontalieri per dimostrare la propria determinazione, ma per il resto è rimasto in disparte. Ha diverse buone ragioni per fare lo stesso ora.
In primo luogo, Hezbollah si sta ancora riprendendo da un decennio di combattimenti nelle guerre regionali a sostegno dell’Iran. Quegli sforzi sono costati al gruppo migliaia di vite, milioni di dollari e notevoli scorte di armi e materiali. Ancora oggi, il gruppo è in difficoltà per i continui costi di cura dei feriti e di risarcimento delle famiglie dei “martiri”. Inoltre, in un momento in cui il Libano è particolarmente paralizzato e diviso e in cui gran parte dell’establishment politico nutre risentimento nei confronti di Hezbollah per il suo ruolo nel bloccare l’elezione di un presidente e la formazione di un nuovo governo, il leader del gruppo, Hassan Nasrallah, sarà desideroso di evitare di inimicarsi ulteriormente le altre fazioni politiche e di coinvolgere il Libano in una guerra che la maggior parte dei cittadini vuole evitare. E Nasrallah vorrà evitare di spendere uomini e missili in una lotta che non è, per Hezbollah, esistenziale; in definitiva, le sue forze militari e le sue armi avanzate esistono per garantire il potere in Libano, per scoraggiare Israele e per impiegarle al servizio di Teheran nel caso di una guerra israelo-iraniana.
Le prime azioni di Hezbollah riflettono un desiderio di moderazione. Domenica ha scambiato artiglieria e razzi con le forze israeliane nella contestata regione di confine delle Fattorie di Shebaa; lunedì gli attacchi aerei israeliani, in risposta a un’incursione transfrontaliera di militanti palestinesi, hanno ucciso combattenti di Hezbollah. In risposta, Hezbollah ha scelto di bombardare le installazioni militari israeliane piuttosto che intensificare gli attacchi mirati contro il personale o i civili israeliani, suggerendo di considerare le azioni di Israele in linea con le regole del gioco della risposta proporzionale.
“DEBOLE COME UNA TELA DI RAGNO”
Tuttavia, la moderazione iniziale non dovrebbe essere motivo di compiacimento. In primo luogo, questi scambi di battute lasciano ampio spazio a errori di calcolo e di percezione, in particolare in un momento di forti tensioni, e ciò che una parte vede come una risposta proporzionale, l’altra potrebbe considerarla una drastica escalation. Gli errori di calcolo hanno scatenato una guerra su larga scala nel 2006, dopo che un’incursione di Hezbollah in Israele e il rapimento di soldati israeliani hanno provocato un’invasione totale di Israele. Nasrallah ammise in seguito di non aver previsto una simile reazione.
L’errore di calcolo non è l’unico rischio. Se i combattimenti tra Israele e Hamas continueranno a intensificarsi, Hezbollah, percependo una certa debolezza, potrebbe essere tentato di abbandonare la sua cautela e intervenire. Ciò sarà particolarmente probabile se Israele, i cui leader non vedono altra scelta che lanciare un assalto a tutto campo nella Striscia di Gaza per infliggere un colpo devastante ad Hamas e salvare gli ostaggi israeliani, finirà per impantanarsi in una guerra urbana. Mentre le sue forze vengono martellate e le vittime nella Striscia aumentano, Hamas avrà tutte le ragioni per chiedere aiuto ai suoi partner, facendo pressione su Hezbollah affinché aumenti il suo sostegno.
I leader di Hezbollah potrebbero vedere un’opportunità unica nella generazione di colpire direttamente il nord di Israele.
Hezbollah, nel frattempo, potrebbe aver già cambiato la sua valutazione delle capacità israeliane. Dopo il suo ritiro dal Libano meridionale nel 2000, Nasrallah definì Israele “più debole di una tela di ragno”: minaccioso da lontano ma vulnerabile quando viene sfidato. Sebbene i due decenni successivi abbiano fatto molto per ricordare a Hezbollah le superiori capacità di Israele (e la distruzione che avrebbe potuto provocare nel Libano meridionale), il fallimento militare e di intelligence di Israele negli ultimi giorni ha probabilmente indebolito questo deterrente. Con i soldati israeliani impantanati, l’intelligence israeliana distratta e un alleato sotto pressione, i leader di Hezbollah potrebbero vedere un’opportunità unica nella generazione di colpire direttamente il nord di Israele. In effetti, l’intero apparato militare di Hezbollah – fanteria, operatori speciali, forze missilistiche e droni – è addestrato, orientato e indottrinato proprio per questo scenario. Nasrallah potrebbe fare un passo indietro e chiedersi perché Hezbollah abbia accumulato tutte queste capacità per combattere Israele se non ha intenzione di usarle.
Un attacco si intensificherebbe rapidamente, con poco da impedire che esploda in una guerra regionale su larga scala. Le capacità di Hezbollah gli consentirebbero di attaccare via terra, mare e aria, con il supporto di artiglieria e razzi. I missili di precisione potrebbero colpire le strutture militari e di intelligence israeliane e le infrastrutture chiave, raggiungendo persino i siti sensibili di Gerusalemme e Tel Aviv. Israele, a sua volta, scatenerebbe una devastante campagna aerea in tutto il Libano. I sostenitori di Hezbollah – dall’Iran e dalla Siria alle milizie sciite in Iraq e forse anche in Afghanistan e Pakistan – sarebbero costretti a partecipare alla lotta. In breve tempo, gli Stati Uniti potrebbero essere facilmente coinvolti, con le loro forze e le loro strutture che subiscono attacchi in tutto il Medio Oriente. L’Iran potrebbe rispondere attivando cellule nella regione e oltre.
Uno scenario così terribile è evitabile. Ma per evitarlo sarà necessario rafforzare la deterrenza lungo il confine di Israele con il Libano, dove Hezbollah osserva dall’altra parte. La credibilità di questo deterrente dipenderà in parte dall’efficacia di Israele nel colpire Hamas. Ma richiederà anche sforzi simultanei contro Hezbollah, tra cui segnalazioni (ad esempio, spostando unità militari chiave e armi d’attacco verso il confine settentrionale), dimostrazioni di forza (tra cui dispiegamenti navali sulla costa libanese e pattugliamenti regolari di aerei da combattimento e droni di sorveglianza sulle roccaforti di Hezbollah) e attacchi, se necessario, contro i combattenti di Hezbollah che invadono il territorio israeliano. Anche gli Stati Uniti hanno un ruolo importante da svolgere. Possono sostenere gli sforzi israeliani dispiegando le proprie forze aeree e navali nella regione e comunicando all’Iran e agli Hezbollah che un’ulteriore escalation porterà a sanzioni più pesanti e, nel caso di un conflitto totale, ad attacchi statunitensi contro il gruppo. Ma per ora, un forte deterrente dovrebbe impedire che si arrivi a questo punto.


Nel settembre del 2022, quando i leader mondiali si riunirono a New York per la precedente edizione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, gran parte della settimana fu dominata dagli sforzi dei funzionari occidentali per conquistare i cosiddetti swing states, Paesi tra cui l’India e il Sudafrica, che erano seduti sulla soglia della guerra in Ucraina. Ma molti di questi Paesi non si sono accontentati di far parte di un ordine occidentale non riformato guidato dagli Stati Uniti. Si sono rifiutati di dare il loro pieno sostegno a Kiev, o anche di appoggiare una risoluzione che condannasse la Russia per la sua violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Hanno invece favorito un’agenda che bilanciasse i propri interessi e principi nazionali.
Un anno dopo, l’ambizione era in gran parte la stessa, ma il copione era cambiato. All’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2023, i funzionari occidentali hanno nuovamente lanciato appelli ai Paesi leader del Sud globale. Questa volta, però, questi funzionari hanno calcolato che il modo per ottenere il sostegno e l’appoggio di questi Paesi sull’Ucraina era quello di sostenere nuovi approcci al multilateralismo e ai partenariati per lo sviluppo. Parte di questa campagna è stata guidata da una maggiore consapevolezza delle difficoltà economiche di questi Stati, ma anche la crescente rivalità di Washington con Pechino, che sta cercando di guidare il Sud globale, è una forza trainante. Il braccio di ferro per la guida del Sud globale si è svolto in altre sedi, tra cui i recenti incontri del G-20, dell’ASEAN e dei BRICS.
Gli Stati Uniti e la Cina non sono i soli a tentare di mettere d’accordo questo grande e importante gruppo di Paesi. Alcuni dei principali swing states, in particolare India e Brasile, stanno cercando di guidare questo blocco. Anche il Kenya si sta facendo avanti, almeno per guidare l’Africa, e ha lanciato i suoi appelli all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest’anno, corteggiando gli Stati Uniti con l’offerta di inviare forze di pace ad Haiti, affascinando gli europei con un vertice sul clima in Africa e tenendo la porta aperta sia alla Cina che alla Russia. La leadership del Sud globale, e la leadership del Sud globale, è arrivata a dominare la diplomazia dei vertici internazionali.
Ma tutti questi contendenti devono affrontare realtà politiche interne che compromettono le loro prospettive di conquistare i Paesi in via di sviluppo. La politica populista e i sentimenti isolazionisti vincolano molti leader occidentali. La crescita lenta, anche in Cina, non fa che esacerbare questi vincoli. Nel frattempo, i tentativi dei Paesi leader del Sud globale di creare nuovi accordi internazionali propri hanno avuto un impatto limitato e gli aspiranti leader di Brasilia e Nuova Delhi devono affrontare le proprie pressioni interne.
Al momento non è probabile che emerga un unico leader del Sud globale. Ma dare ai suoi principali membri un posto al tavolo più alto, in un accordo multilaterale più inclusivo, rimane più urgente che mai.
GIOCARE AL RIALZO
La spinta della Cina a fornire infrastrutture a molti Paesi in via di sviluppo ha contribuito a indebolire l’influenza dell’Occidente sul Sud globale. Per gran parte dello scorso decennio, le nazioni occidentali hanno osservato la Cina lanciare la sua Belt and Road Initiative (BRI) da 1.000 miliardi di dollari, e l’interesse si è trasformato in preoccupazione quando Pechino ha firmato accordi infrastrutturali con quasi 150 Paesi. In risposta, le potenze occidentali si sono sentite obbligate ad agire, ma si sono mosse lentamente per formulare fonti alternative di finanziamento delle infrastrutture che promuovessero i valori liberali.
Nel 2019, Australia, Giappone e Stati Uniti hanno lanciato il Blue Dot Network, per guidare gli investimenti verso infrastrutture di alta qualità. Washington voleva portare il piano al G-7 del 2020, ma il vertice è stato annullato a causa della pandemia e i progressi si sono arenati. La percepita mancanza di leadership occidentale è stata poi aggravata dall’incapacità di guidare la fornitura di vaccini nei Paesi in via di sviluppo e di sviluppare una risposta adeguata alla crescente necessità di ridurre il debito.
Lo sforzo del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden di ripristinare l’immagine internazionale degli Stati Uniti dopo il suo insediamento nel 2021 ha incluso anche un rinnovato impegno a migliorare il funzionamento del G7. Al vertice del 2021 in Cornovaglia, il G-7 ha lanciato l’iniziativa Build Back Better World (B3W). La B3W è stata concepita per far fronte a una carenza di infrastrutture globali stimata in 40.000 miliardi di dollari, utilizzando i fondi governativi per mobilitare il capitale privato. L’iniziativa doveva essere di portata globale, con un’attenzione particolare ai Paesi a basso e medio reddito. A differenza della Cina, che si è concentrata su porti, ferrovie e strade, la B3W ha ampliato la definizione di infrastruttura per includere il clima, la salute e la sicurezza sanitaria, la tecnologia digitale e l’equità e la parità di genere.
Un anno dopo, in seguito all’invasione dell’Ucraina e al ridimensionamento del piano Build Back Better di Biden in patria, il G-7 si è riunito in Germania e ha ribattezzato il B3W come Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). L’ambizione è rimasta quella di sbloccare capitali pubblici e privati per investimenti in infrastrutture con particolare attenzione all’energia, al digitale, alla salute e al clima, allineati agli standard occidentali. Gli Stati Uniti intendono investire 200 miliardi di dollari, oltre a un obiettivo generale del G-7 di 600 miliardi di dollari per gli investimenti infrastrutturali nel Sud globale.
APRIRE I RUBINETTI
Dal suo lancio, il PGII ha compiuto lenti progressi, proprio mentre è cresciuta l’ambizione di Washington di ampliare e approfondire il proprio appeal nei confronti del Sud globale. Finora gli Stati Uniti hanno mobilitato solo 30 miliardi di dollari della quota prevista di 200 miliardi.
Rispondendo alle richieste dei Paesi del Sud globale di riformare le strutture delle istituzioni multilaterali create all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, il governo statunitense ha accolto le richieste di ampliare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di renderlo più responsabile nei confronti dell’Assemblea Generale. L’anno scorso, il Presidente Biden ha dichiarato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che gli Stati Uniti avrebbero sostenuto lo sforzo di espandere il numero di seggi permanenti e non permanenti nel Consiglio di Sicurezza. L’amministrazione Biden ha poi appoggiato la decisione del G-20, presa a settembre, di concedere all’Unione Africana un posto al tavolo. Washington sta ora chiedendo al Congresso di aumentare i finanziamenti alla Banca Mondiale di 25 miliardi di dollari.
L’amministrazione Biden sta anche creando partenariati regionali con i Paesi del Sud globale. A margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di quest’anno, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha presieduto un evento che ha lanciato un nuovo partenariato per la cooperazione atlantica. Questo nuovo forum riunisce 32 Paesi – tutti, è stato annunciato, “accomunati dall’impegno per una regione atlantica pacifica, prospera, aperta e cooperativa” – e si concentra sul potenziamento della cooperazione in campo scientifico, tecnologico, della protezione ambientale e dello sviluppo. L’amministrazione sta inoltre lavorando in tutta l’area indo-pacifica per costruire partenariati agili e flessibili, tra cui il Quadrilatero, o Quadrilateral Security Dialogue, con Australia, India e Giappone.
Ma gli Stati Uniti non sono l’unico Paese a farsi avanti. Nel dicembre 2021, l’Unione Europea ha lanciato il Global Gateway, la propria offerta di leadership e influenza tra i Paesi in via di sviluppo. Nell’ambito di questa iniziativa, la Commissione europea attinge ai fondi di sviluppo esistenti dei suoi Stati membri per mobilitare investimenti pubblici e privati per circa 315 miliardi di dollari in infrastrutture entro il 2027, nel tentativo di migliorare i collegamenti con il Sud globale. L’UE mira a costruire partenariati piuttosto che la dipendenza che il BRI ha creato. Ma l’offerta europea, per quanto impressionante, è su scala minore rispetto a quella cinese, e si applicano tutte le regole e gli standard abituali dell’UE, il che crea un’asticella molto più alta da superare per i Paesi beneficiari.
Nel Pacifico, nel tentativo di gestire l’assertività della Cina, il Giappone ha usato la sua leadership del G-7 per corteggiare potenziali partner durante la riunione del gruppo a Hiroshima in maggio. I leader di alcuni Paesi che non fanno parte del G-7 – Australia, Comore, Isole Cook, Brasile, India, Indonesia, Corea del Sud e Vietnam – sono stati comunque invitati a partecipare.
FUORI DALLA FOLLA
Gli sforzi dell’Occidente potrebbero rivelarsi troppo pochi e tardivi per conquistare il Sud globale. Molti di questi Paesi stanno già cercando un proprio ruolo di leadership. La Cina, con il suo programma BRI, spicca. In qualità di maggior creditore ufficiale del mondo e di maggior partner commerciale dell’Africa e del Sud America, ha già fatto le maggiori incursioni, ma anche altri Paesi sono in lizza e utilizzano i vertici globali per promuovere le proprie ambizioni. Ad agosto, i Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) hanno deciso di invitare sei nuovi membri: Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. È stato un tentativo, da parte della Cina in particolare, di formare un rivale del G7.
Al di là di questi vertici internazionali, alcuni Paesi stanno cercando di affermare le proprie speranze di leadership. All’Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest’anno, ad esempio, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha lanciato il suo tentativo di guidare il mondo in via di sviluppo dando al Sud globale una maggiore partecipazione alla governance internazionale e sottolineando il ruolo del Brasile come leader del clima. Ha cercato di posizionare il suo Paese come campione dell’inclusione sociale e si è rifiutato di prendere le parti della Cina o degli Stati Uniti.
Quest’anno, tuttavia, l’India si è distinta e ha perseguito un ruolo sempre più assertivo sulla scena internazionale. A seguito delle crescenti pressioni su Nuova Delhi affinché scegliesse da che parte stare nella guerra in Ucraina, l’India ha invece scelto di giocare il campo e di costruire partnership con diverse grandi potenze e Paesi in via di sviluppo. Quest’anno ha approfondito le sue relazioni strategiche con gli Stati Uniti e ha confermato il suo ruolo centrale nel Quad e nei BRICS.
Ma è la leadership indiana del G-20, durata un anno, che ha rappresentato il suo principale strumento organizzativo, in patria e all’estero. Nuova Delhi ha sfruttato il G-20 per mettere in risalto le sue credenziali di leader dei Paesi in via di sviluppo e di partner delle grandi potenze. Il G-20 è stato messo in scena come un road show composto da centinaia di eventi che si sono svolti nel corso dell’anno e la segnaletica è stata diffusa in tutto il Paese. Gli obiettivi del G-20 sono stati concepiti per essere incentrati sulle persone e sull’inclusione, in settori quali le infrastrutture pubbliche digitali e gli investimenti nella parità di genere. La Dichiarazione dei leader di Nuova Delhi ha chiesto riforme importanti per rimodellare l’ordine multilaterale esistente, in particolare le istituzioni come la Banca Mondiale e il FMI. La dichiarazione è ambiziosa e ha delineato piani audaci per collegare l’India alla Grecia e all’Europa continentale attraverso una rotta ferroviaria e marittima che attraversa il Medio Oriente.
TUTTA LA POLITICA È LOCALE
Il numero di appelli globali rivolti al Sud del mondo è impressionante. Ma questi appelli sono arrivati in ritardo e il divario tra ambizioni e risultati è grande. La politica interna dell’Occidente sta frenando l’istinto al globalismo, così come la stanchezza da vertice. I limiti delle ambizioni occidentali di leadership sono stati particolarmente evidenti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest’anno, dove i leader di Francia e Regno Unito non si sono presentati. E nemmeno quelli di Cina e Russia. Biden era l’unico leader di uno Stato del Consiglio di Sicurezza presente. Il gruppo di ministri e personale di supporto ha fatto ben poco per coprire la clamorosa assenza dei leader delle potenze che esercitano il diritto di veto.
Nel suo discorso all’Assemblea Generale, Biden ha espresso l’ambizione di costruire nuove partnership in grado di affrontare le principali sfide globali. Ma la sua capacità di creare un legame chiaro tra la sua politica estera per la classe media e il sostegno degli Stati Uniti al multilateralismo rimane tenue. Le forze economiche, tra cui il recente sciopero dei lavoratori dell’auto, e le pressioni politiche, che potrebbero portare alla chiusura del governo americano, minacciano la sua capacità di leadership internazionale. Le reazioni dei repubblicani al Congresso potrebbero ostacolare gli sforzi del Presidente per ottenere un maggiore sostegno all’Ucraina. Inoltre, il desiderio di Biden di mantenere contatti diplomatici e di cooperare con Pechino per affrontare il problema del cambiamento climatico lo rende suscettibile di attacchi per essere morbido nei confronti della Cina. L’Europa e gran parte del resto del mondo sono sempre più nervosi per il fatto che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe vincere le elezioni presidenziali americane del 2024 e sconvolgere il periodo di multilateralismo che è stato rafforzato sotto Biden. In questo contesto, la prospettiva che gli Stati Uniti realizzino un’agenda ambiziosa per il Sud globale sembra remota.
Gli appelli rivolti al Sud globale sono arrivati in ritardo e il divario tra ambizioni e risultati è grande.
Gli Stati Uniti non sono i soli a dover affrontare forti pressioni interne. L’Europa è alle prese con le conseguenze della guerra in Ucraina e con il crescente sostegno ai partiti di estrema destra, il che non fa presagire un impegno nei confronti del Sud globale. Il Regno Unito, reduce da un’estate di scioperi e che quest’anno dovrebbe avere la peggiore inflazione del G-7, ha ampiamente abdicato al suo ruolo di leadership tra i Paesi in via di sviluppo, tagliando il suo bilancio per lo sviluppo e abolendo il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale. Anche la Cina è in difficoltà a causa della crescente stagnazione economica. L’India è continuamente assediata da una politica interna divisiva e, sebbene abbia fatto progressi nella riduzione della povertà, non è riuscita a creare una politica più inclusiva o a superare le divisioni basate sull’identità. Il Brasile, dopo un’elezione polarizzata e una transizione turbolenta, è uscito solo di recente da un periodo di leadership altamente divisiva.
Di fronte ai vincoli interni di questi Paesi, la cooperazione internazionale è difficile e ancora più essenziale. Tuttavia, nessuna singola istituzione si pone al di sopra di tutte le altre. Le istituzioni multilaterali nate dal desiderio di respingere l’Occidente hanno mostrato pochi segni di essere in grado di costruire un consenso o una serie di priorità per il Sud globale. L’espansione dei BRICS, ad esempio, manca di credibilità come forum alternativo per la leadership, dal momento che i suoi due membri più potenti, India e Cina, difficilmente la pensano allo stesso modo. La dichiarazione dei leader del G20 a Nuova Delhi, incentrata su un multilateralismo riformato, è certamente ambiziosa, ma è meno chiaro se questi accordi potranno essere attuati. E il Brasile, il prossimo Paese ospitante, avrà bisogno di costruire lo slancio. Il G-20 potrebbe essere più importante per consentire un dialogo attivo e sostenuto che per ottenere risultati.
È anche difficile immaginare il G-7 come un serio contendente per la leadership del Sud globale. L’affiatamento del forum e la sua coesione basata sui valori sono impressionanti, così come lo sforzo di integrare un secondo livello di partner alle sue riunioni. Ma il resto del mondo è stato escluso e si sta muovendo. Forse non esiste più un’unica istituzione che possa essere una panacea. Ma in assenza di un’alternativa valida, sarà necessario uno sforzo sostenuto per riformare le istituzioni multilaterali esistenti. Ciò significa aggiornare i membri e fornire le risorse finanziarie che possono consentire alle istituzioni di realizzare le loro ambizioni. Queste istituzioni devono essere sostenute da un gruppo di istituzioni più piccole e agili, in grado di muoversi rapidamente per risolvere una serie di problemi sempre più complessi e diversificati. In ultima analisi, tuttavia, l’impegno a costruire un multilateralismo efficace dovrà essere forgiato in patria.

Il ritorno del Sud globale
Il realismo, non il moralismo, guida una nuova critica del potere occidentale
Di Sarang Shidore
31 agosto 2023
Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a Johannesburg, agosto 2023
Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a Johannesburg, agosto 2023
Pagina url
https://www.foreignaffairs.com/world/return-global-south-critique-western-power
Richiedi i permessi di stampa
La guerra della Russia in Ucraina ha ricordato agli osservatori occidentali che esiste un mondo al di fuori delle grandi potenze e dei loro alleati principali. Questo mondo, composto prevalentemente da Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina, ha resistito a schierarsi chiaramente nel conflitto. La guerra ha quindi acceso i riflettori sul Sud globale come fattore importante della geopolitica. In effetti, Foreign Affairs ha recentemente dedicato un numero della rivista alla comprensione delle motivazioni del “mondo non allineato”. Il panorama geopolitico odierno non è definito solo dalle tensioni tra gli Stati Uniti e le grandi potenze rivali, Cina e Russia, ma anche dalle manovre delle medie potenze e delle potenze minori.
I Paesi del Sud globale contengono la stragrande maggioranza dell’umanità, ma i loro desideri e obiettivi sono stati a lungo relegati nelle note a piè di pagina della geopolitica. Nella seconda metà del XX secolo, raggruppamenti come il Movimento dei Non Allineati e il G-77 delle Nazioni Unite hanno cercato di promuovere gli interessi collettivi dei Paesi più poveri e decolonizzati in un mondo dominato dalle ex potenze imperiali. La loro solidarietà era sostanzialmente fondata su ideali e su un senso di condivisione di scopi morali che non sempre producevano risultati concreti. Anche prima della fine della Guerra Fredda, il moralismo che ha motivato questi Stati a unirsi ha iniziato a dissiparsi. I decenni unipolari successivi alla fine della Guerra Fredda sembravano aver messo definitivamente da parte il Sud globale come forza evidente.
Oggi, tuttavia, il Sud globale è tornato. Non esiste come gruppo coerente e organizzato, ma come fatto geopolitico. Il suo impatto si fa sentire in nuove e crescenti coalizioni – come il gruppo BRICS, che potrebbe presto espandersi oltre i suoi membri originari, Brasile, Cina, India, Russia e Sudafrica – ma ancor più attraverso le azioni individuali dei suoi Stati. Queste azioni, guidate da interessi nazionali piuttosto che dall’idealismo della solidarietà meridionale, sono più della somma delle loro parti. Stanno iniziando a limitare le azioni delle grandi potenze e a provocarle per rispondere ad almeno alcune delle richieste del Sud globale.
Rimanete informati.
Analisi approfondite con cadenza settimanale.
COSA C’È IN UN NOME?
Il processo di decolonizzazione che ha seguito la Seconda guerra mondiale ha aggiunto alle Nazioni Unite, tra gli anni ’40 e ’70, decine di nuovi Stati nazionali. In un articolo del 1952, lo scienziato sociale francese Alfred Sauvy coniò il termine “Terzo Mondo” per riferirsi a questi Paesi. Egli vedeva un parallelo tra le ex colonie di recente indipendenza e il Terzo Stato “ignorato, sfruttato, disprezzato” della Francia prerivoluzionaria, il segmento della società composto dai cittadini comuni. Dopo la fine della Guerra Fredda e la dissoluzione del “Secondo Mondo” comunista, il termine “Terzo Mondo” sembrava essere diventato obsoleto. Inoltre, è stato considerato peggiorativo nei confronti degli Stati più deboli del sistema internazionale.
Il termine “Paesi in via di sviluppo” è entrato in uso durante i primi anni delle Nazioni Unite. Sebbene continui a essere utilizzato oggi, anch’esso sta gradualmente perdendo il suo favore. Il concetto stesso di classificare i Paesi come “in via di sviluppo” o “sviluppati” è stato criticato per aver implicitamente avallato l’idea di un percorso lineare di sviluppo: le società sono in uno stato arretrato fino a quando non assomigliano a quelle del Giappone, degli Stati Uniti e dell’Europa.
Il termine “Sud globale” evita queste insidie. Anch’esso ha origine nel XX secolo. Il termine è stato utilizzato in un noto rapporto del 1980, North-South: A Programme for Survival, pubblicato da una commissione indipendente guidata dall’ex cancelliere tedesco Willy Brandt, e in un rapporto del 1990, The Challenge to the South: The Report of the South Commission, pubblicato da un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite guidato da Julius Nyerere, allora presidente della Tanzania. Il prefisso “globale” è stato aggiunto negli anni ’90, dopo la fine della Guerra Fredda, forse come conseguenza della crescente popolarità di un altro termine, “globalizzazione”, entrato in voga proprio in quel periodo.
Il Sud globale esiste oggi non come raggruppamento organizzato, ma come fatto geopolitico.
Il Sud globale comprende un’ampia fascia di Stati per lo più (ma non solo) poveri o a medio reddito che si estende dal Sud-Est asiatico e dalle isole del Pacifico fino all’America Latina. Nei primi decenni della decolonizzazione, non era inesatto parlare del Sud globale come di un’entità coerente. Praticamente tutti i suoi Stati erano fortemente segnati dall’esperienza coloniale e dalla lotta per la libertà dal dominio europeo. Quasi tutti erano economicamente deboli e avevano poche industrie. Si sono anche riuniti in forum e istituzioni che promettevano di far nascere una nuova forza vitale nella politica globale con una piattaforma d’azione coordinata. La conferenza di Bandung del 1955 degli Stati africani e asiatici e la fondazione del Movimento dei Non Allineati nel 1961 articolarono una visione di solidarietà basata sull’opposizione al colonialismo e al razzismo, sul sostegno all’economia dirigista, sul rifiuto delle armi nucleari e sulla collaborazione con le Nazioni Unite per mantenere la pace e risolvere le iniquità del sistema internazionale.
Ma già negli anni Sessanta questo movimento si stava incrinando. La devastante sconfitta militare subita dall’India per mano della Cina nel 1962 ha frenato il suo potenziale per plasmare meglio l’unità del Sud globale. Una serie di colpi di stato militari in Stati che vanno dal Cile all’Uganda ha infangato le rivendicazioni morali del movimento. Poco dopo, India e Pakistan iniziarono a sviluppare armi nucleari.
Il crollo dei blocchi che avevano definito la Guerra Fredda e l’unipolarità del dominio statunitense che ne è seguito hanno ulteriormente eroso la coerenza e le rivendicazioni morali del Movimento dei Non Allineati. È sorta la domanda: Rispetto a chi era ormai non allineato? La solidarietà meridionale, a quanto pare, era morta.
MAGGIORE DELLA SOMMA DELLE SUE PARTI
Non così in fretta, però. Mentre l’era unipolare seguita alla fine della Guerra Fredda si allontana, il Sud globale sta tornando a vivere. Ma il suo principio guida questa volta non è l’idealismo, bensì il realismo, con un abbraccio incondizionato agli interessi nazionali e un maggiore ricorso alla politica di potenza.
Come ogni altra meta-definizione (ad esempio, “Occidente”), il termine Sud globale può essere un po’ ambiguo. Ai fini di questa argomentazione, l’appartenenza al G-77, un’organizzazione fondata dalle Nazioni Unite nel 1964, può servire come guida ragionevole alla composizione del Sud globale. Il gruppo, che oggi conta 134 Stati membri, si definisce come “la più grande organizzazione intergovernativa di Paesi in via di sviluppo delle Nazioni Unite, che fornisce i mezzi ai Paesi del Sud” per “migliorare la loro capacità negoziale comune”. Ne fanno parte quasi tutti gli Stati diversi da Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Stati Uniti e Paesi europei, oltre a pochi altri tra cui due grandi potenze, Cina e Russia. Questa definizione più ampia di Sud globale include Stati come la Turchia (un alleato della NATO), i petrostati del Golfo come l’Arabia Saudita e Paesi un tempo poveri come il Cile e Singapore che sono diventati molto più prosperi. Il fatto di essere a basso o medio reddito è solo uno degli indicatori che indicano che uno Stato fa parte del Sud globale. Tra gli altri, il fatto di avere un passato coloniale o di non essere una grande potenza o un alleato di una grande potenza.
I diversi Paesi di questa nuova iterazione del Sud globale condividono diverse caratteristiche. Il ricordo della dominazione coloniale europea, soprattutto in Africa, rimane un fattore che plasma il pensiero geopolitico. Questi Paesi possono aver abbandonato in gran parte le politiche economiche autarchiche a guida statale di un tempo, ma la loro spinta a “recuperare” il ritardo rispetto agli Stati ricchi è un imperativo comune e, se non altro, più urgente. Il loro desiderio di autonomia strategica e di una quota molto maggiore di potere politico nel sistema internazionale è forte e sta diventando sempre più forte, soprattutto tra le medie potenze del Sud globale, come Brasile, Indonesia e Sudafrica.
Molti commentatori si concentrano sull’emergere di istituzioni come il G-20, i BRICS e l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai come emblema del ritorno del Sud globale. Ma concentrandosi sulle coalizioni intergovernative non si coglie il modo più importante in cui il Sud globale si sta affermando: attraverso le azioni dei singoli Stati. Queste azioni diverse e per lo più non coordinate, fortemente fondate sull’interesse nazionale di ciascun Paese, possono avere un impatto superiore alla somma delle loro parti.
Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva a Pechino, aprile 2023
Piscina / Reuters
Gli Stati del Sud globale si concentrano molto sull’attrazione di scambi e investimenti e sulla risalita della catena del valore. Raramente soffrono delle profonde e generalizzate ansie per gli accordi commerciali che hanno attanagliato gli Stati Uniti negli ultimi tempi. Negli ultimi due decenni, la maggior parte di questi Paesi si è aperta alle forze del mercato, pur mantenendo, e talvolta rafforzando, politiche protezionistiche selettive. Negli ultimi anni, le misure adottate dall’Indonesia e dallo Zimbabwe per limitare le esportazioni di nichel e litio, rispettivamente, mirano ad attrarre investimenti di maggior valore dall’estero. La nuova politica cilena sul litio prevede un ruolo molto più importante per lo Stato nell’estrazione e nella lavorazione. Forze simili sono all’opera nella spinta saudita a creare un’industria verde dell’idrogeno e nella spinta indiana ad attrarre la produzione di elettronica. L’ideologia ha lasciato il posto alla sperimentazione pragmatica di modelli economici ibridi.
L’attenzione per il numero uno si estende anche al rifiuto di una nuova dinamica di guerra fredda che contrappone Stati Uniti, Giappone ed Europa a una coalizione di Cina e Russia. Molti Stati del Sud globale sono più ricchi e più intelligenti di quanto non fossero nel ventesimo secolo e hanno imparato a giocare con entrambe le parti per trarre vantaggi per se stessi. Hanno visto per esperienza che una limitata competizione tra grandi potenze ha la sua utilità, ma che una nuova guerra fredda metterebbe in pericolo i loro interessi e sconvolgerebbe le loro società. Alcune guerre per procura potrebbero ancora verificarsi, ma è improbabile che si ripetano le depredazioni su larga scala della Guerra Fredda, quando molte parti dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina hanno subito interventi ripetuti e distruttivi da parte dell’una o dell’altra superpotenza.
Ciò non significa che la cooperazione tra gli Stati Uniti e gli Stati del Sud globale debba necessariamente diminuire. Alcuni di questi Stati potrebbero addirittura stringere rapporti limitati con gli Stati Uniti, o con altre grandi potenze, per promuovere i propri interessi. La convergenza di sicurezza di Nuova Delhi con Washington esiste per bilanciare Pechino e sfruttare le opportunità di “friend shoring”. Ma anche questa alleanza ha dei limiti: È improbabile che l’India contribuisca molto al di là del supporto logistico e forse temporaneo in caso di guerra nel Mar Cinese Meridionale, ad esempio. E l’India segue la propria bussola quando si tratta di Russia, importando armi e sviluppando e producendo congiuntamente il missile BrahMos, che ora sta esportando. Il Vietnam continua a perseguire con ostinazione le rivendicazioni marittime contro la Cina, anche se riesce ad attrarre un’ondata di commercio e investimenti cinesi e resiste a farsi trascinare in una quasi alleanza con gli Stati Uniti. Il Brasile del presidente Luiz Inácio Lula da Silva collabora strettamente con gli Stati Uniti sul cambiamento climatico, pur mantenendo relazioni calorose con le grandi potenze rivali di Washington, Cina e Russia. Il Pakistan ha stretto una profonda partnership militare ed economica con la Cina, mentre le sue relazioni con gli Stati Uniti sono diventate per lo più transazionali.
Gli Stati del Sud globale ottengono un’influenza anche attraverso il potere della negazione. Praticamente tutti gli Stati del Sud globale hanno respinto il regime di sanzioni adottato contro la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina. Alcuni hanno aumentato gli scambi commerciali con Mosca, minando notevolmente l’efficacia delle sanzioni occidentali. Nel 2022, il commercio russo è aumentato dell’87% con la Turchia, del 68% con gli Emirati Arabi Uniti e di ben il 205% con l’India. Altri alleati e partner stretti degli Stati Uniti, come le Filippine, Singapore e la Tailandia, potrebbero agire per limitare la politica degli Stati Uniti in caso di crisi con la Cina.
Gli Stati del Sud globale sono molto insoddisfatti del loro peso nelle istituzioni globali.
Soprattutto, gli Stati del Sud globale rimangono molto insoddisfatti quando si tratta del loro peso nelle strutture decisionali globali. Questa emarginazione è sempre più incoerente con l’effettiva influenza economica che le medie potenze esercitano, un peso che semplicemente non possedevano negli anni Sessanta. Alcuni di questi Stati sono fonti cruciali di minerali, catene di approvvigionamento e, talvolta, innovazioni essenziali per la crescita globale e per la lotta al cambiamento climatico, il che conferisce loro un’influenza maggiore di quella che avevano nel XX secolo.
Questa crescente incongruenza approfondisce anche la loro insoddisfazione nei confronti dell’attuale ordine mondiale e genera l’urgenza di un cambiamento sostanziale, ad esempio nel sistema delle Nazioni Unite. La riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tuttavia, non sarà rapida. L’organismo riflette ancora le realtà geopolitiche del 1945 e la sua espansione è una prospettiva remota. Gli Stati Uniti, inoltre, dominano ancora la finanza internazionale e possono collaborare con i loro alleati principali per minacciare sanzioni secondarie di vasta portata che sono in effetti dirette agli Stati del Sud globale. Ma gli Stati del Sud globale continueranno a cercare una maggiore autonomia e a esercitare una maggiore influenza globale attraverso dichiarazioni pubbliche e proposte che mirano a plasmare o a contestare le norme globali (come i piani di pace per l’Ucraina che alcuni hanno proposto), coalizioni come quella con Cina e Russia nei BRICS, istituzioni regionali e un crescente commercio bilaterale in valute locali.
Gli effetti di questi sforzi potrebbero essere già visibili; è degno di nota il fatto che Washington non abbia ancora imposto importanti sanzioni secondarie nei confronti della Russia. Il G-7 guidato dagli Stati Uniti si è anche affannato a mettere insieme un’iniziativa per le infrastrutture, il Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali, e Washington è stata relativamente cauta nel rispondere ai colpi di stato antifrancesi della fascia del Sahel. Col tempo, il nuovo Sud globale potrebbe costringere le grandi potenze ad accogliere almeno in parte le sue richieste di maggiore voce in capitolo nelle istituzioni internazionali e ad astenersi dalla maggior parte delle attività di guerra per procura.
Il nuovo Sud farà sentire la sua influenza soprattutto attraverso le azioni dei singoli Stati fondate sull’interesse nazionale. Tuttavia, gli echi del coordinamento più profondo dell’era di Bandung si possono sentire in due ambiti. Il primo è il cambiamento climatico. Nei negoziati internazionali, i membri del Sud globale si confrontano collettivamente con i Paesi più ricchi, spingendo per ottenere maggiori finanziamenti per il clima e “riparazioni climatiche”. L’altro ambito, anche se ancora lontano dall’essere realizzato, è la lotta all’egemonia del dollaro. Gli incentivi per il Sud globale a bypassare il regime del dollaro sono forti, ma i principali impedimenti strutturali impediscono una soluzione facile. Il commercio in valute locali è tuttavia in crescita e, in un periodo più lungo, potrebbe emergere una soluzione più completa. Il recente annuncio dell’espansione dei BRICS durante il vertice di agosto a Johannesburg potrebbe favorire entrambi gli sforzi.
UN FATTO GEOPOLITICO, NON UNA SENSAZIONE
L’ampia eterogeneità all’interno del Sud globale e l’ascesa delle medie potenze sollevano alcuni interrogativi sulla durata dell’inquadramento. Il Sud globale potrebbe diventare meno rilevante come fatto geopolitico se i suoi membri dovessero portare avanti serie rivalità tra loro. L’azione per il clima potrebbe anche agire da guastafeste; potrebbe emergere una spaccatura tra gli Stati con una grande impronta di carbonio, come Brasile, India e Indonesia, e gli Stati più piccoli e più poveri, soprattutto in alcune zone dell’Africa, che non contribuiranno mai molto alle emissioni di gas serra, pur dovendo affrontare tutte le loro conseguenze. Anche il divario tra Paesi a medio e basso reddito potrebbe compromettere l’impatto del Sud. Nel corso del tempo, è emersa una sostanziale differenziazione tra i Paesi a medio reddito, come Cile e Malesia, e gli oltre 50 Stati, per lo più africani, che soffrono di gravi crisi del debito.
Tuttavia, tali rotture non sono attualmente in vista. Pochi segnali di grandi rivalità stanno emergendo tra medie potenze come Brasile, India, Indonesia e Sudafrica. La loro separazione geografica e l’assenza di controversie che riguardano i loro interessi centrali garantiranno probabilmente che le relazioni rimangano cordiali nel prossimo futuro. Gli Stati del Sud globale hanno per lo più mantenuto un fronte unito nel chiedere maggiori finanziamenti per il clima alle loro controparti europee e nordamericane. Inoltre, i Paesi del Sud globale a medio reddito si stanno dimostrando sensibili alle esigenze economiche di quelli più poveri; ad esempio, l’India, attualmente presidente del G-20, sta spingendo per la riduzione del debito degli Stati a basso reddito.
Il Sud globale persisterà come fatto geopolitico finché rimarrà escluso dal nucleo centrale delle strutture internazionali di potere. Finché a questi Stati sarà negata una maggiore voce in capitolo nel governo del sistema internazionale (che include, ma va ben oltre, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite), il Sud globale sarà probabilmente una forza di cambiamento, in grado di esercitare pressioni sulle grandi potenze, di mettere in discussione la legittimità di alcune delle loro politiche e di limitare il loro raggio d’azione in ambiti chiave. Mantenere lo status quo dell’attuale ordine globale e resistere alla democratizzazione della sua governance, come sembrano voler fare il leader sistemico degli Stati Uniti e i suoi più stretti alleati (con Cina e Russia che si oppongono anche a modifiche sostanziali del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite), non farà che aumentare l’impazienza per una seria riforma. Nella misura in cui è definito dalla sua distanza dal nucleo dell’ordine internazionale, il nuovo Sud globale perderà la sua coerenza geopolitica solo quando i suoi obiettivi saranno stati sostanzialmente raggiunti.
SARANG SHIDORE è direttore del programma sul Sud globale presso il Quincy Institute for Responsible Statecraft e membro della facoltà aggiunta della George Washington University.
ll sito www.italiaeilmondo.com non fruisce di alcuna forma di finanziamento, nemmeno pubblicitaria. Tutte le spese sono a carico del redattore. Nel caso vogliate offrire un qualsiasi contributo, ecco le coordinate: postepay evolution a nome di Giuseppe Germinario nr 5333171135855704 oppure iban IT30D3608105138261529861559 oppure
| PayPal.Me/italiaeilmondo |
Su PayPal è possibile disporre eventualmente un pagamento a cadenza periodica, anche di minima entità, a partire da 2 (due) euro (pay pal prende una commissione di 0,52 centesimi)
05

Un articolo zeppo di travisamenti e interpretazioni forate, ma utile a comprendere la postura statunitense nel Mediterraneo Orientale. Giuseppe Germinario
Erdogan il sopravvissuto
Washington ha bisogno di un nuovo approccio all’improvvisatore in capo della Turchia
Di Henri J. Barkey
Settembre/Ottobre 2023
Pubblicato il 17 agosto 2023
Clay Rodery
Url della pagina
https://www.foreignaffairs.com/turkey/erdogan-nato-survivor-united-states
A luglio, durante il vertice annuale della NATO a Vilnius, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inaspettatamente approvato la richiesta di adesione della Svezia all’Alleanza. Questa mossa ha provocato un grado di celebrazione e di elogio che raramente i singoli leader ottengono durante un vertice. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha applaudito il “coraggio, la leadership e la diplomazia” di Erdogan. “Questo è un giorno storico”, ha dichiarato il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg.
Vilnius è stata una pausa momentanea in uno schema di attrito scoraggiante tra la Turchia e l’Occidente, in particolare tra la Turchia e gli Stati Uniti. La partnership tra Stati Uniti e Turchia sembra ora essere la relazione più conflittuale all’interno dell’alleanza NATO. Il tentativo di Erdogan di bloccare l’adesione della Svezia è stato, in parte, una ritorsione contro Washington, che aveva punito la Turchia per aver acquistato un sistema di difesa aerea russo. Questa disputa, durata cinque anni, è diventata uno dei conflitti più gravi nella storia delle relazioni tra Stati Uniti e Turchia, esacerbando la sfiducia e provocando recriminazioni.
La Turchia sta soffrendo per problemi interni come l’aumento dell’inflazione, l’afflusso di rifugiati e le conseguenze di un terremoto devastante. Ma in vista delle elezioni presidenziali di maggio, Erdogan ha scelto di addossare i problemi del Paese – soprattutto l’incombente crisi economica – alla porta di Washington. Erdogan ha detto ai turchi che, votando per lui, avrebbero “dato una lezione agli Stati Uniti”.
I politici non devono sperare che l’eventuale sostegno di Erdogan all’adesione della Svezia alla NATO rappresenti un cambiamento di categoria. Il caos che ha portato a Vilnius e la retorica elettorale anti-occidentale di Erdogan rappresentano solo gli ultimi colpi di scena di una spirale di segnali contrastanti, errori di comunicazione e diffidenza che ha caratterizzato le relazioni tra Stati Uniti e Turchia per decenni. George Harris, ex alto funzionario del Dipartimento di Stato, ha pubblicato Troubled Alliance: Turkish-American Problems in Historical Perspective nel 1972; le dinamiche chiave che descrive esistono ancora. Ma a fronte di una marea di rapporti e proposte per riparare le relazioni, anche i legami un tempo stretti tra cittadini statunitensi e turchi hanno continuato a degradarsi costantemente. Anzi, si sono indeboliti a tal punto che un’altra grave crisi, reale o immaginaria, potrebbe infliggere alle relazioni tra Stati Uniti e Turchia un danno che nessuno dei due Paesi sarà in grado di annullare.
Gli Stati Uniti devono adottare un approccio completamente nuovo. Il reset deve iniziare con la comprensione di quanto sia cambiata la Turchia da quando Washington ha impostato la sua modalità predefinita di relazione con Ankara. Washington ha una percezione unica e difficile da eliminare: Ankara è un alleato “normale”. Ha operato in base a questo desiderio anche di fronte a prove contraddittorie, come se il suo comportamento potesse da solo trasformare questo sogno in realtà. Per lo più, Washington ha cercato di evitare le dispute pubbliche, fingendo che i disaccordi fossero banali; il recente rapporto tra Stati Uniti e Turchia può essere definito al meglio come transazionale. Ma l’ambiente di sicurezza intorno alla Turchia si è trasformato e con Erdogan gli Stati Uniti si trovano di fronte a un insolito leader populista-autoritario determinato a ricostruire l’identità turca e gli interessi nazionali per riflettere la propria visione.
Grazie alla sua importanza geopolitica e militare e al suo potenziale economico, la Turchia è un alleato prezioso. Washington non avrà altra scelta che lavorare a stretto contatto con Ankara per raggiungere i suoi obiettivi strategici globali. E per il prossimo futuro, Washington continuerà a doversi confrontare con un leader esigente, spavaldo e imprevedibile come Erdogan, disposto a generare selettivamente crisi che rischiano di danneggiare l’essenza delle relazioni tra i due Paesi.
Eppure c’è un’opportunità unica di cambiare radicalmente le relazioni. Questa opportunità si è aperta per la prima volta quando la partnership è stata messa a dura prova dall’acquisto da parte della Turchia di un sistema di difesa aerea russo. Nel corso di questa vicenda, i leader statunitensi hanno rotto il loro consolidato modello di impegno, punendo in modo inusuale il governo turco per un atto che avrebbe minato la NATO.
Ora è il momento per Washington di fare di questa eccezione una regola. Quando Erdogan incalza l’Occidente, Washington ha sempre temuto che una risposta forte legittimasse le sue provocazioni. Si tratta di un grave errore di valutazione. Gli Stati Uniti devono invece rispondere all’imprevedibilità provocatoria di Erdogan con coerenza e fermezza.
Paradossalmente, questo approccio – e non una vuota pretesa di normalità – è la strada per una relazione ordinaria e affidabile con un alleato indispensabile. Washington si trova ora in una posizione particolarmente favorevole per plasmare a proprio vantaggio il futuro a lungo termine delle relazioni, perché le improvvisazioni sempre più incoerenti di Erdogan e la sua cattiva gestione dell’economia turca sembrano averlo finalmente messo all’angolo.
CAMBIO DI SCENA
Erdogan non è un leader qualunque. Durante i suoi 20 anni di potere, ha trasformato la Turchia, trasfigurando il suo sistema politico per diventare quasi l’unico decisore, sventrando lo Stato di diritto e prendendo il controllo del sistema giudiziario, dei servizi di sicurezza, della banca centrale e della stampa. È facile confondere la Turchia con Erdogan e ridurre il rapporto con il Paese alla valutazione delle sue motivazioni; lo stesso Erdogan lo incoraggia. Ma non si può sviluppare una strategia efficace nei confronti della Turchia senza comprendere il contesto storico più ampio.
Le difficoltà degli Stati Uniti con Ankara derivano, in primo luogo, dalla natura mutevole del contesto di sicurezza della Turchia. Dalla fine della Guerra Fredda, l’ascesa di nuove potenze e la crescente instabilità in Medio Oriente hanno coinciso con il declino del potere statale a livello globale e con l’emergere di problemi complessi come il forte aumento delle migrazioni e degli spostamenti, la crescita del commercio globale di droga e i cambiamenti nelle tecnologie utilizzate in guerra.
La fine della Guerra Fredda ha anche allentato le camicie di forza comportamentali che limitavano la condotta di molti Stati, compresa la Turchia. Durante il suo mandato 1989-93, il presidente Turgut Ozal ha intrapreso riforme economiche che hanno aiutato la Turchia a emergere come potente attore internazionale. Ozal vedeva la Turchia come un ponte tra l’Oriente e l’Occidente. Rappresentando un Paese a maggioranza musulmana ma anche un amico convinto degli Stati Uniti, ha rafforzato i legami economici e politici della Turchia con una serie di alleati in Europa, Medio Oriente e Asia centrale.
Per gli Stati Uniti, la Turchia non è mai stata solo un altro alleato della NATO. La Turchia ha anche fornito piattaforme per proiettare il potere degli Stati Uniti in Medio Oriente, in particolare all’indomani della prima guerra del Golfo; la Turchia è stata un baluardo di stabilità in una regione sempre più fragile. Ma sono stati gli Stati Uniti a sconvolgere per primi questo equilibrio. Dopo gli attentati dell’11 settembre, gli interventi del presidente americano George W. Bush in Medio Oriente hanno scatenato una catena di eventi profondamente destabilizzanti nelle vicinanze della Turchia.
Gli Stati Uniti non intendevano mettere in crisi le loro relazioni con la Turchia. Ma le sue avventure in Medio Oriente hanno avuto immense conseguenze indesiderate. L’Iran, il principale Stato revisionista della regione, si è sentito minacciato dalle forze armate statunitensi poste su due dei suoi confini e ha cercato di difendersi alzando la posta in gioco; l’Iraq è diventato uno Stato federale che includeva un governo regionale del Kurdistan dotato di poteri. I curdi turchi furono incoraggiati e ispirati da questo sviluppo.
La fine della Guerra Fredda ha allentato la camicia di forza che vincolava la Turchia.
E come risultato indiretto dell’intervento statunitense, nel decennio successivo la Primavera araba ha sconvolto la regione. Inizialmente, Erdogan immaginava che la Primavera araba gli avrebbe offerto l’opportunità di aiutare i leader ispirati dai Fratelli Musulmani, come l’egiziano Mohamed Morsi, a prendere il potere al posto di quelli filoamericani. Nel 2013, però, a Istanbul sono scoppiate proteste diffuse, che Erdogan ha visto come una Primavera araba locale, progettata per rovesciarlo.
L’ascesa dello Stato Islamico, noto anche come ISIS, ha portato le tensioni ad un punto di ebollizione. Dopo che l’ISIS ha rapidamente conquistato vaste porzioni di territorio in Iraq e Siria, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama voleva che Erdogan permettesse agli Stati Uniti di utilizzare le basi aeree turche e che la Turchia difendesse meglio il suo confine meridionale in modo che i jihadisti non potessero attraversarlo per unirsi all’ISIS. Ma Erdogan dava per scontato che il presidente siriano Bashar al-Assad sarebbe stato rovesciato. Lo sperava addirittura: Assad, secondo lui, potrebbe essere sostituito da un leader islamista che la Turchia potrebbe influenzare. Ankara non ha quindi dato seguito alle richieste di Obama.
In preda alla disperazione e in assenza di assistenza turca, Washington ha invece collaborato con le Forze Democratiche Siriane, le cui unità curde dominanti avevano stretti legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, un’organizzazione che sia Ankara che Washington considerano un gruppo terroristico. Washington ha fatto un ulteriore passo avanti, inviando truppe statunitensi per addestrare e assistere i curdi siriani. La questione curda è il tallone d’Achille della Turchia; qualsiasi sforzo degli Stati Uniti per aiutare i curdi, come Washington ha fatto per primo in Iraq, è percepito da Ankara come una grave minaccia strategica. Temendo un effetto dimostrativo che avrebbe incoraggiato i cittadini curdi in Turchia, Ankara ha invaso il nord della Siria per tre volte, nonostante le obiezioni degli Stati Uniti, sloggiando l’SDF dalle regioni vicine al confine turco e cacciando i curdi che vivevano lì.
Con un costo enorme in termini di vite umane, l’SDF è riuscito a sottomettere l’ISIS. Ma sia la Turchia che gli Stati Uniti sono rimasti profondamente scontenti: secondo la Turchia, gli Stati Uniti hanno scelto di allearsi con i terroristi nazionalisti curdi e sembravano addirittura sostenere l’autonomia curda ovunque. A Washington sembrava che Ankara appoggiasse tacitamente i terroristi jihadisti.
Nel frattempo, mentre l’arco di instabilità si estendeva, si è diffusa la percezione che gli Stati Uniti si stessero muovendo e allontanando, preparandosi a un pivot verso l’Asia e lasciandosi alle spalle il Medio Oriente. In questo vuoto, Erdogan ha fatto delle mosse coraggiose per cambiare la natura stessa del ruolo della Turchia nell’ordine internazionale.
INVERSIONE DI RUOLO
Dal 2003 fino a circa il 2009, durante i suoi primi anni da primo ministro, sembrava che Erdogan avrebbe emulato Ozal. All’estero, Erdogan ha cercato di rafforzare il peso di Ankara e di aprire le porte liberalizzando l’economia e la politica turca. Si è anche concentrato sul processo di adesione della Turchia all’Unione Europea, che era in fase di stallo.
Queste aperture diplomatiche sono state ben accolte dal popolo turco, dai suoi vicini e dai suoi alleati tradizionali. Nel 2004, il consigliere di Erdogan per la politica estera ha descritto il principio organizzativo della politica estera turca come “zero problemi con i vicini”, segnalando che il nuovo governo turco avrebbe cercato di porre fine ai conflitti che avevano inficiato le sue relazioni estere. Si trattava di un tentativo di costruire un soft power.
In fondo, però, “zero problemi con i vicini” aveva più a che fare con il consolidamento della posizione di Erdogan in patria. Erdogan è salito al potere all’interno di un movimento islamista che si è sempre sentito insicuro e perseguitato. Anche dopo essere diventato primo ministro, ha dovuto difendere la sua legittimità contro una coalizione militare-burocratica a lungo dominante che nutriva profondi sospetti sulle sue radici islamiste.
Erdogan ha sperimentato in prima persona la veemenza di questo antagonismo dell’establishment quando l’esercito turco ha costretto il suo partito politico, il Partito del Benessere, a lasciare il potere con un memorandum pubblico nel 1997. All’epoca Erdogan era sindaco di Istanbul. L’anno successivo, le autorità condannarono Erdogan a dieci mesi di carcere per aver letto pubblicamente una poesia di uno degli autori più venerati della Turchia.
Inizialmente, Erdogan cercò di annullare il governo arbitrario sotto il quale aveva sofferto. Cercare il sostegno dell’estero era un modo per rafforzare la sua posizione contro i militari, che contavano su un’immensa influenza dietro le quinte per governare la Turchia. Ma la coalizione militare-burocratica ha esagerato nelle elezioni presidenziali del 2007. Erdogan ha indetto elezioni parlamentari lampo e la sua vittoria ha segnato la fine dell’influenza dei militari.
Uno striscione di Erdogan a Istanbul, maggio 2023
Murad Sezer / Reuters
In seguito, ha preso sistematicamente il controllo di tutte le principali istituzioni turche: non solo il parlamento e la magistratura, ma anche la stampa e le università pubbliche. Secondo lui, Erdogan è la Turchia e la Turchia è Erdogan. Si è alienato molti dei suoi alleati interni, compresi alcuni che avevano contribuito a portarlo al potere. Lo Stato di diritto è stato sventrato, la “giustizia” arbitraria è diventata il suo marchio di fabbrica e l’arte della politica in Turchia si è ridotta a guardare Erdogan.
Oltre a ristrutturare le istituzioni del Paese, Erdogan ha cercato di rimodellare l’identità della Turchia, ribaltando la visione del fondatore della Repubblica turca, Kemal Ataturk. Ataturk aveva cercato di costruire uno Stato laico, nazionalista, elitario e in qualche modo autarchico, alleato con il mondo industrializzato. La nuova concezione dell’identità turca di Erdogan coniuga il nazionalismo turco con l’Islam. Le due cose sono diventate inseparabili, parte di una tradizione storica continua che risale oltre l’Impero Ottomano fino alla fondazione dell’Islam. Questo legame ha permesso a Erdogan di costruire costrutti religiosi per decisioni controverse. Per giustificare l’obbligo per la banca centrale turca di abbassare i tassi di interesse per combattere l’inflazione, ha fatto riferimento all’opposizione della sua religione all’usura.
Sulla scena internazionale, la visione di Erdogan è espansiva e revisionista; ha cercato di posizionarsi sia come kingmaker che come disgregatore. Ha iniziato ad esprimere questo desiderio quando, nel 2013, ha affermato che “il mondo è più grande di cinque”, riferendosi ai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Da allora ha ripetuto questa affermazione in quasi tutte le riunioni delle Nazioni Unite. Non è una critica irragionevole all’ordine internazionale del secondo dopoguerra. Erdogan ha anche ritenuto che la Turchia meriti un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza.
Allo stesso tempo, Erdogan presenta la Turchia, intesa come civiltà, come una delle principali forze “anti-status quo” e anti-imperialiste. Egli offre una visione in cui il dominio occidentale e il solo dominio occidentale rappresentano la minaccia imperialista contemporanea. La sua concezione dell’imperialismo è quindi limitata: non discute l’imperialismo cinese o russo o quello dell’Impero Ottomano. Nonostante la sua antipatia per Ataturk, Erdogan ha reclutato la memoria di Ataturk per questa causa. Lo studioso di Turchia Nicholas Danforth ha catalogato il modo in cui Erdogan ribattezza Ataturk come “un eroe anti-imperialista per i musulmani e per l’intero Terzo Mondo” e la presidenza di Ataturk come “il primo grande colpo” di un’offensiva anti-imperialista che Erdogan intende vincere.
GIOCO IN CASA
All’inizio del 2010, Erdogan ha abbandonato la sua politica di “zero problemi con i vicini” per adottare un approccio più apertamente conflittuale nei confronti di Paesi come l’Egitto, Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Alla fine ha sposato la dottrina della “Patria Blu”, in precedenza una frangia ultranazionalista che rivendicava l’autorità turca su una parte significativa del Mediterraneo orientale. Per mettere in pratica questa dottrina, nel 2019 Erdogan ha firmato un accordo marittimo con la Libia per affermare la supremazia su una fascia del Mar Mediterraneo, impedendo ad altri Paesi di costruire oleodotti e sfruttare le risorse del fondo marino.
Cipro, Grecia, Stati Uniti, Lega Araba e Unione Europea hanno condannato l’accordo con la Libia. Questo tipo di comportamento provocatorio e imprevedibile sembra aver isolato Erdogan, lasciandolo senza amici nella sua regione, ad eccezione del Qatar. Per mobilitarsi contro la Turchia, nel 2021 Cipro, Egitto, Grecia, Israele, Giordania e Autorità Palestinese hanno creato il Forum del gas del Mediterraneo orientale per sfruttare e commercializzare il gas trovato nelle loro acque.
Erdogan si diverte a sfiorare vere e proprie crisi diplomatiche. Ma sa anche essere pragmatico: per lui tenere gli altri Paesi in bilico è una strategia, parte del suo modo di proiettare il potere. È un massimalista, vuole dimostrare la volontà di attenersi ai suoi obiettivi con più fermezza di quanto facciano i suoi avversari e di spingere le questioni al limite. In un esempio particolarmente drammatico, avvenuto nell’aprile di quest’anno, la Turchia ha bombardato un aeroporto nel Kurdistan iracheno in quello che sembrava essere un tentativo di assassinare Mazloum Abdi, il comandante delle forze curde siriane. Le bombe hanno mancato la pista, probabilmente in modo intenzionale. Ma se avessero colpito il bersaglio, avrebbero potuto uccidere anche diversi membri dell’esercito americano che scortavano il comandante.
Non di rado, i proiettili turchi atterrano ancora scomodamente vicino alle forze americane di stanza nel nord della Siria. L’azione di contrasto ha un senso di potere e Erdogan è in parte motivato dal desiderio di vendetta. Le democrazie occidentali hanno spesso criticato il suo governo, in particolare la sua tendenza a incarcerare gli oppositori. E il suo disagio nei confronti del potere degli Stati Uniti è evidente da tempo. Erdogan ha segnalato che la Turchia cerca una “autonomia strategica” dagli Stati Uniti. Nel 2016, il governo di Erdogan ha imprigionato Andrew Brunson, un pastore americano residente a Smirne, con accuse false. Un anno dopo sono stati arrestati tre cittadini turchi che lavoravano presso i consolati statunitensi. In entrambi i casi, Erdogan si è impegnato nello stile di diplomazia degli ostaggi che Iran e Russia hanno perfezionato.
Ma la politica di Erdogan è pensata tanto per il consumo interno quanto per un pubblico internazionale. La politologa Marianne Kneuer ha sostenuto che “inimicarsi le democrazie liberali ‘occidentali'” è una “strategia di legittimazione” interna di crescente successo per molti leader autoritari. Ogni governante autoritario che sale al potere demolendo un establishment radicato teme sempre che qualcun altro possa fare lo stesso con lui, ed Erdogan non fa eccezione. Non importa quanto gli altri Paesi si oppongano a lui, egli teme soprattutto i propri cittadini. Nel 2013, Istanbul è stata scossa da grandi manifestazioni contro il suo governo; Erdogan temeva che un movimento simile alla Primavera araba avrebbe travolto la Turchia, spazzandolo via.
Poi, nel luglio 2016, Erdogan ha affrontato un tentativo di colpo di Stato, sostenendo che fosse stato orchestrato da Fethullah Gulen, un ex stretto alleato e leader religioso con sede negli Stati Uniti. Dopo il fallimento del colpo di Stato, Erdogan lo ha definito “un dono di Dio”, usandolo come pretesto per scatenare un’ondata di epurazioni senza precedenti nell’esercito, nelle università e in altre istituzioni turche. Molti di questi oppositori percepiti non sostenevano nemmeno Gulen. Sempre sospettoso degli Stati Uniti, Erdogan ha accusato Washington di aver coordinato il colpo di Stato.
CARTA SELVAGGIA
Erdogan si è abituato a lanciare insulti contro i suoi avversari interni senza conseguenze e tende a presumere che la stessa mancanza di ripercussioni valga anche all’estero. Nel 2017, ha suggerito che i leader dei Paesi Bassi erano tutti “residui nazisti”; nel 2020, ha detto che il presidente francese Emmanuel Macron aveva bisogno di “cure mentali”. Accusando il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis di aver cercato di bloccare un accordo di armi turche con gli Stati Uniti, Erdogan ha detto che Mitsotakis “non esiste più per me” e che avrebbe rifiutato di incontrarlo.
Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno un loro presupposto incrollabile e irragionevole: che Ankara sia un alleato genuino. I leader americani non sono abituati a considerare la Turchia come un antagonista e, date le altre complessità della regione, non vogliono immaginare che possa esserlo, anche quando dovrebbero. Già nel 1993, un diplomatico americano di lungo corso ha riconosciuto che “l’inclinazione degli Stati Uniti verso la Turchia si è istituzionalizzata nel corso degli anni” e “i turchi hanno sfruttato i loro vantaggi”.
L’approccio degli Stati Uniti alla Turchia sotto Erdogan ha avuto due temi contrastanti. In uno, la Turchia è un alleato estremamente importante. Nell’altro, il leader turco è un jolly e non vale la pena prenderlo troppo sul serio. (Un esempio: nonostante Erdogan abbia giurato di non incontrare mai più il primo ministro greco, i due si sono incontrati amichevolmente al vertice di Vilnius). In linea di massima, Washington ha guardato dall’altra parte quando Erdogan si è intromesso in Siria e ha minato la lotta contro l’ISIS. Pochi lo ammetteranno, ma un certo grado di denigrazione si cela sotto la superficie della strategia statunitense nei confronti della Turchia, un bigottismo morbido di basse aspettative.
Fino a poco tempo fa, questo approccio un po’ paternalistico faceva il gioco di Erdogan. Anche se derideva il potere degli Stati Uniti, Erdogan poteva dare per scontato il sostegno degli Stati Uniti e della NATO. L’appartenenza alla NATO fornisce alla Turchia armi, sostegno diplomatico e un prestigio che nessun altro Paese mediorientale può vantare. Alla fine del 2010, tuttavia, le relazioni tra Stati Uniti e Turchia si sono rapidamente avviate verso una nuova crisi.
UN ERRORE COSTOSO
Come molti altri alleati degli Stati Uniti, la Turchia ha fatto la fila per acquistare l’F-35, il caccia stealth di quinta generazione degli Stati Uniti. Sperava di acquistarne fino a 100 e, in una dimostrazione di fiducia nei confronti della Turchia e delle sue industrie, Washington ha elaborato un accordo favorevole: Le industrie aeronautiche turche avrebbero dovuto produrre una serie di parti dell’F-35, tra cui le fusoliere, con potenziali ricavi da esportazione dell’ordine di miliardi di dollari. Gli Stati Uniti avrebbero inoltre permesso alla Turchia di fungere da centro di manutenzione per altri clienti dell’F-35. Ma l’accordo è andato in fumo quando, nel 2017, Erdogan ha mediato con il presidente russo Vladimir Putin un accordo da 2,5 miliardi di dollari per l’acquisto del sistema missilistico mobile terra-aria S-400 della Russia.
In tutti i modi possibili, gli Stati Uniti hanno avvertito la Turchia che se avesse proceduto con l’acquisto dalla Russia, sarebbe stata completamente estromessa dal programma F-35, perché l’integrazione del sistema missilistico S-400 nei sistemi NATO avrebbe compromesso le tecnologie sensibili dell’F-35. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiedeva sanzioni contro la Turchia se avesse portato a termine l’accordo sugli armamenti con la Russia.
Anche considerando il passato di Erdogan, la sua insistenza sull’accordo S-400 ha stupito gli osservatori. Ha giustificato la sua mossa come è solito fare, ribaltando la situazione e sostenendo che gli Stati Uniti avevano ingiustamente rifiutato di vendere alla Turchia il loro sistema missilistico equivalente, il Patriot. Non sembrava credere che Washington avrebbe dato seguito alle sue minacce. Ma si sbagliava. Nel 2019, dopo l’arrivo degli S-400, gli Stati Uniti hanno espulso senza troppi complimenti la Turchia dal programma F-35 e hanno imposto sanzioni.
Gli S-400 rimangono in deposito perché il governo turco sa che il loro dispiegamento romperebbe le relazioni con Washington. Oltre a sprecare 2,5 miliardi di dollari per il sistema missilistico, la Turchia ha perso gli esborsi iniziali per l’acquisto degli F-35 e i futuri proventi delle esportazioni, e la sua aeronautica sarà privata di un caccia all’avanguardia disponibile per altri 17 Paesi, tra cui la vicina Grecia, Israele e Romania.
Erdogan vuole posizionarsi sia come kingmaker che come disgregatore.
Di fronte alla prospettiva che le sue forze aeree perdano il loro vantaggio, la Turchia ha chiesto di acquistare dagli Stati Uniti nuovi F-16 e kit di aggiornamento per la flotta esistente. L’amministrazione Biden sostiene questo passo. Ma, a dimostrazione della diminuzione del peso della Turchia a Washington, questa richiesta ha incontrato l’opposizione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti dopo che la Turchia ha preso tempo sull’adesione della Svezia alla NATO e ha ripetutamente effettuato sorvoli militari delle isole greche nel Mar Egeo. Il Congresso è emerso come fulcro dell’opposizione alla Turchia; è probabile che ponga ulteriori condizioni sulle modalità di utilizzo degli F-16 prima di finalizzare qualsiasi vendita.
Per Washington, l’acquisto dell’S-400 da parte di Erdogan ha oltrepassato una linea di demarcazione; ha influito sulle preoccupazioni di Washington in materia di sicurezza. Le minacce di Erdogan di bloccare l’adesione della Svezia alla NATO sono state, in parte, un tentativo di vendetta. Al vertice di Vilnius, Erdogan ha inaspettatamente fatto marcia indietro all’ultimo momento, acconsentendo all’adesione della Svezia.
Erdogan forse sperava che la sua manovra di disturbo avrebbe aumentato la percezione di lui come un prezioso mediatore di potere. Dopo Vilnius, ha raccontato che le sue abili manovre hanno costretto l’Occidente a fare delle concessioni. Ma queste concessioni erano piccole e, alla fine, il risultato di Vilnius ha rappresentato una sconfitta. Nonostante l’attenzione che ha suscitato, le grandi manovre di Erdogan hanno alienato i suoi alleati. Creare un polverone internazionale su una questione vitale come l’adesione della Svezia alla NATO e in un momento così cruciale per la NATO lo ha fatto apparire più piccolo.
NON GIOCARE DI NUOVO, ZIO SAM
Gli Stati Uniti hanno temuto di affrontare la Turchia in parte perché non volevano aggravare una spaccatura. Erdogan ha intessuto una ricca narrativa cospiratoria in Turchia, secondo la quale Washington sarebbe gelosa dei suoi risultati in politica estera, determinata a minare la morale turca sostenendo i gruppi LGBTQ e persino intenzionata a rovesciare il governo turco. In un sondaggio del 2019, oltre l’80% degli intervistati turchi ha indicato gli Stati Uniti come la principale minaccia per la Turchia. Ciò non sorprende, dato il ritmo incalzante della retorica antiamericana che proviene dagli ambienti governativi turchi e dai loro alleati nei media: all’inizio di quest’anno, l’allora ministro degli Interni turco Suleyman Soylu ha dichiarato che qualsiasi aspirante leader turco che persegua politiche filoamericane è un “traditore”.
Ma la reticenza di Washington ha permesso che tra la Turchia e gli Stati Uniti si sviluppasse un profondo divario cognitivo e un deficit di fiducia. Può essere difficile da comprendere per gli americani, ma Ankara li percepisce come costantemente ostili. Indipendentemente dai passi compiuti dagli Stati Uniti, queste mosse tendono a essere fraintese o deliberatamente travisate dalla Turchia.
Nel frattempo, la fiducia degli americani nella Turchia è ai minimi storici. Nessun funzionario americano rischierebbe di riammettere la Turchia nel programma F-35 solo sulla base della promessa che gli S-400 non saranno mai rimossi dal deposito. In effetti, gli Stati Uniti hanno iniziato a investire in nuove infrastrutture navali e aeree in Grecia, tra cui il porto di Alexandroupoli, che sarà presto completato, per evitare la dipendenza dalla Turchia.
Più in generale, è difficile sopravvalutare quanto Erdogan abbia danneggiato l’affidabilità delle istituzioni turche. Le sue statistiche sono inaffidabili, la sua banca centrale è inaffidabile e le decisioni del suo sistema giudiziario sono imperscrutabili. La mancanza di credibilità del sistema giudiziario turco si ripercuote in particolare sulle relazioni con i suoi alleati, che sono sommersi da richieste di estradizione spesso inverosimili per gli oppositori di Erdogan.
Erdogan teme soprattutto i propri cittadini.
Quando Ankara si lamenta che la Svezia o gli Stati Uniti non rimpatriano i “terroristi”, il problema diventa non solo politico ma anche legale. Gli alleati non possono fidarsi dell’equità o della veridicità delle incriminazioni turche o del fatto che le persone estradate in Turchia siano trattate in modo equo. I funzionari occidentali guardano con preoccupazione a casi come quello di Osman Kavala, un filantropo, e Selahattin Demirtas, ex capo del filo-curdo Partito Democratico del Popolo. I due sono stati sottoposti a processi farsa in Turchia, dove sono tuttora detenuti nonostante le sentenze vincolanti della Corte europea dei diritti dell’uomo che ne hanno disposto il rilascio.
La debolezza dello Stato di diritto turco si ripercuote anche sulle relazioni economiche. La guida del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per il clima degli investimenti del 2022 indica le “preoccupazioni sull’impegno del governo [turco] nei confronti dello Stato di diritto” come la causa del basso livello storico di investimenti diretti esteri. Sono state avviate decine di migliaia di indagini contro persone che “insultano” il presidente, e coloro che sono indagati possono perdere il lavoro o essere incarcerati. (Ironia della sorte, questi procedimenti giudiziari fasulli assomigliano a quelli che lo stesso Erdogan ha subito come sindaco di Istanbul). Abusi così evidenti rendono nervosi gli investitori. Gli stranieri non investiranno se non hanno la certezza che le controversie commerciali e le questioni normative saranno giudicate in modo equo.
Per cambiare le cose, Washington deve prendere l’iniziativa. I leader statunitensi devono esprimere con franchezza la preoccupazione che le relazioni tra Stati Uniti e Turchia rischino di deteriorarsi in modo irreparabile. Gli Stati Uniti devono sottolineare che, nonostante le carenze della NATO, l’alleanza persiste per un motivo: i suoi membri condividono non solo interessi ma anche valori. Questo distingue le relazioni degli Stati Uniti con la Turchia da quelle che intrattengono con altre democrazie in difficoltà. Washington può creare forti partnership con governanti populisti-autoritari come il primo ministro indiano Narendra Modi, ad esempio, ma l’India non è un membro della NATO, quindi le aspettative sono diverse.
Fingere che le provocazioni di Erdogan non siano gravi non fa che infiammarlo e incoraggiarlo. Gli Stati Uniti devono contrastare con forza la retorica antiamericana che proviene da Erdogan, dal suo governo e dagli organi di stampa suoi alleati. E devono chiarire che non tollereranno certi comportamenti da parte della Turchia, soprattutto le azioni che mettono in pericolo le vite americane, come i numerosi interventi ravvicinati in Siria e in Iraq.
Sostenitori di Erdogan festeggiano ad Ankara, Turchia, 2023
Umit Bektas / Reuters
I leader americani non possono lamentarsi a intermittenza; devono rispondere all’imprevedibilità di Erdogan con la coerenza. Quando Erdogan oltrepassa un limite, deve esserci una risposta. La sua incoerenza significa che non si possono applicare regole d’ingaggio rigide e rapide a ogni situazione. Ma i leader statunitensi possono esprimere il loro disappunto cancellando incontri e visite con funzionari di alto livello. Possono manifestare una rabbia più significativa, ad esempio organizzando audizioni al Congresso sulle campagne di disinformazione turche.
Gli Stati Uniti trarrebbero beneficio dal coordinamento con altri alleati che subiscono gli affronti di Erdogan. Washington ha già avviato questo processo: lo sviluppo del porto di Alexandroupoli è solo un esempio. I leader statunitensi hanno anche cambiato decisamente il loro approccio nei confronti di Cipro, revocando il lungo embargo sulle armi e impegnandosi più strettamente con Nicosia su una serie di questioni legate alla sicurezza.
L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha creato nuovi dilemmi per le relazioni tra Stati Uniti e Turchia, ma anche nuove opportunità. Putin ed Erdogan, autocrati affini con una profonda diffidenza nei confronti dell’Occidente, hanno iniziato a rivolgersi maggiormente l’uno all’altro per soddisfare esigenze che solo l’altro può fornire. Erdogan si è opposto alle sanzioni contro la Russia, sostenendo che la Turchia “non è vincolata dalle sanzioni dell’Occidente”. Gli Stati Uniti hanno mostrato una certa flessibilità e tolleranza nei confronti delle attività di contrasto alle sanzioni della Turchia; con l’impennata dei prezzi del petrolio e del gas, che ha fatto lievitare il conto delle importazioni della Turchia e ha appesantito le sue partite correnti, il commercio turco-russo è aumentato.
Putin ha accarezzato l’ego di Erdogan permettendogli di svolgere un ruolo in un accordo sul grano che ha permesso all’Ucraina di esportare grano e fertilizzanti attraverso il Mar Nero. Queste esportazioni sono fondamentali per i Paesi in via di sviluppo che devono affrontare gravi carenze alimentari. La Turchia ha anche venduto all’Ucraina i droni Bayraktar. Erdogan si è crogiolato nei plausi ricevuti per il suo ruolo di mediatore. Ma questi eventi rivelano anche quanto la Turchia sia alla disperata ricerca di valuta estera.
AMORE DURO
Erdogan è uscito da Vilnius con le ali tarpate – ed è tornato a casa con un’economia in crisi. Grazie alle riforme attuate da Ozal e, per un certo periodo, da Erdogan, l’economia turca ha ottenuto risultati straordinari nei primi anni di questo secolo. Gli investimenti esteri diretti hanno raggiunto un livello record, passando da 1 miliardo di dollari nel 2000 a 22 miliardi nel 2007.
Ma nell’ultimo decennio, la politica dei bassi tassi di interesse del governo ha incoraggiato una pericolosa cultura del consumo. I cittadini spendono sempre più di una moneta il cui valore sta contemporaneamente crollando. La frenesia dei consumi ha spinto un’esplosione delle importazioni, mettendo sotto pressione le partite correnti della Turchia. Il finanziamento del deficit diventa ogni mese più costoso grazie all’aumento del premio di rischio della Turchia. Il settore manifatturiero turco, che nel 2021 rappresentava il 21% del PIL, rischia di essere gravemente indebolito dall’aumento dei costi dei fattori produttivi. Per evitare una catastrofe, la Turchia dovrà cercare di far leva sulla sua importanza geopolitica per chiedere aiuto agli Stati Uniti.
La popolazione turca può non essere filoamericana; anche gli oppositori di Erdogan nutrono sospetti su Washington. Ma gran parte della popolazione turca ha sofferto sotto l’autoritarismo erratico e la cattiva gestione economica di Erdogan. Nonostante l’ambiente repressivo che ha creato e la paura che genera, lo scorso maggio quasi il 48% degli elettori ha scelto di rimuoverlo dal suo incarico. Gli Stati Uniti hanno la possibilità di rafforzare la società civile turca e i politici dell’opposizione dimostrando che, pur non appoggiando Erdogan, sostengono la Turchia. La chiave sarà l’aiuto economico.
Tutto lascia pensare che quando la crisi turca raggiungerà il suo apice, devasterà l’economia del Paese, già in difficoltà. Di recente, Erdogan ha abbandonato a malincuore la sua lunga dedizione ad abbassare i tassi di interesse in risposta allo stress economico. Ma non è ancora chiaro se egli comprenda l’entità dello sforzo che attende la Turchia.
Erdogan durante una conferenza stampa a Vilnius, Lituania, luglio 2023
Kacper Pempel / Reuters
Nonostante i tentativi di Erdogan di attrarre investimenti dagli Stati del Golfo e di rafforzare il commercio con la Cina, la Turchia è e rimarrà completamente integrata nel sistema economico occidentale. Questa profonda integrazione offre alle potenze occidentali l’opportunità di influenzare la Turchia in meglio. La Germania, i Paesi Bassi, la Svizzera, il Regno Unito e gli Stati Uniti sono storicamente le principali fonti di investimenti diretti esteri della Turchia: nel 2021, ne rappresentavano quasi i due terzi. E i Paesi occidentali restano i principali acquirenti di beni e servizi turchi. Nel 2022, il Regno Unito riceverà il 5,1% delle esportazioni turche, gli Stati Uniti il 6,7%, la Germania l’8,4% e altri dieci Paesi dell’UE il 42,5%.
L’ulteriore aumento delle esportazioni verso l’Occidente sarà un elemento fondamentale per la ripresa economica della Turchia. Le esportazioni in questione sono prevalentemente beni industriali, la cui produzione favorisce la crescita di posti di lavoro ben retribuiti. Ma la Turchia deve ristrutturare in modo significativo le sue istituzioni statali per ampliare l’accesso al mercato delle esportazioni turche e ottenere il consenso dei principali mercati finanziari. Qualsiasi vero salvataggio economico dovrà fare affidamento sulle economie occidentali; Cina, Russia e Medio Oriente hanno relativamente poco da contribuire.
Un piano di stabilizzazione sarà doloroso ma fattibile. La Turchia gode di notevoli vantaggi economici: la sua vicinanza ai mercati europei e mediorientali, la sua forza lavoro istruita e relativamente giovane, e la sua comunità imprenditoriale esperta e integrata con il resto del mondo. La Turchia è ben posizionata per beneficiare del “friend shoring”, una pratica in crescita che consiste nel riposizionare la produzione e le catene di approvvigionamento in Paesi considerati politicamente affidabili.
La Turchia dovrà quasi certamente chiedere assistenza al Fondo Monetario Internazionale. Gli Stati Uniti svolgeranno inevitabilmente un ruolo essenziale nel contribuire a delineare i contorni di un piano del FMI e del suo finanziamento. Ma Washington deve insistere nel subordinare il sostegno del FMI a miglioramenti dello Stato di diritto, come il ripristino dell’autonomia della banca centrale turca e il rafforzamento della credibilità delle istituzioni finanziarie che producono statistiche economiche.
I leader americani devono rispondere all’imprevedibilità di Erdogan con la coerenza.
La Turchia potrebbe aver bisogno di chiedere aiuto economico alla Russia e gli Stati Uniti dovrebbero tollerare alcuni di questi accordi. Ma devono opporsi all’esportazione da parte della Turchia di beni elettronici che aiutano direttamente Mosca a portare avanti la sua guerra contro l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno già sanzionato alcune aziende turche e i leader turchi hanno dichiarato che ridurranno tali esportazioni. La guerra in Ucraina, tuttavia, probabilmente continuerà, aumentando la pressione su Putin e intensificando il suo bisogno di componenti. Lo scorso luglio, Putin ha sospeso l’accordo sul grano che la Turchia aveva aiutato a mediare. Per Washington e Ankara, questa è un’opportunità per avviare una discussione su come coordinare meglio i rapporti con la Russia in futuro.
Come molti leader massimalisti che hanno mantenuto il potere per decenni, Erdogan si è circondato di tirapiedi e ha creato una camera d’eco mediatica in cui la maggior parte delle persone ha poca scelta se non quella di lodarlo. A volte deve pensare di essere infallibile. Ma anche se è un ideologo, Erdogan è anche un pragmatico. Accetterà di apportare cambiamenti, anche quelli che non gli piacciono, se teme che sia in gioco la sua sopravvivenza. E la sua sopravvivenza è ora in gioco.
Durante la crisi dell’S-400, con un cambiamento insolito, Washington è rimasta fedele alla sua posizione, mantenendo esattamente ciò che aveva promesso di fare. Di conseguenza, ha delineato quello che potrebbe essere un metodo più risoluto di impegnarsi con la Turchia in senso più ampio. Ankara deve sapere che non può fare l’eroe su tutto e negoziare all’infinito. Ora gli Stati Uniti devono mantenere la linea. In futuro, Washington non dovrebbe limitarsi a fasciare le ferite superficiali o cercare di ripristinare un’età dell’oro nelle relazioni tra Stati Uniti e Turchia che non è mai esistita. Agendo con fermezza e coerenza, gli Stati Uniti possono creare un nuovo tipo di relazione: una relazione normale, molto più simile a quella che intrattengono con l’Italia o il Portogallo. Devono cogliere l’occasione.
HENRI J. BARKEY è professore Cohen di Relazioni internazionali presso la Lehigh University e Senior Fellow aggiunto per gli studi sul Medio Oriente presso il Council on Foreign Relations.
https://www.foreignaffairs.com/turkey/erdogan-nato-survivor-united-states
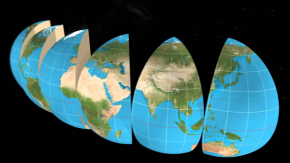
La Cina è pronta per un mondo di disordine
L’America non lo è
Di Mark Leonard
Luglio/Agosto 2023
Pubblicato il 20 giugno 2023
Juanjo Gasull
https://www.foreignaffairs.com/united-states/china-ready-world-disorder
27:11
A marzo, al termine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin si è affacciato alla porta del Cremlino per salutare l’amico. Xi ha detto al suo omologo russo: “In questo momento ci sono cambiamenti come non se ne vedevano da 100 anni e siamo noi a guidare questi cambiamenti insieme”. Putin, sorridendo, ha risposto: “Sono d’accordo”.
Il tono era informale, ma non si trattava di uno scambio improvvisato: “Cambiamenti mai visti in un secolo” è diventato uno degli slogan preferiti di Xi da quando lo ha coniato nel dicembre 2017. Sebbene possa sembrare generico, racchiude perfettamente il modo contemporaneo cinese di pensare all’ordine globale emergente – o, piuttosto, al disordine. Con la crescita del potere cinese, i politici e gli analisti occidentali hanno cercato di determinare che tipo di mondo vuole la Cina e che tipo di ordine globale Pechino intende costruire con il suo potere. Ma sta diventando chiaro che, piuttosto che cercare di rivedere completamente l’ordine esistente o di sostituirlo con qualcos’altro, gli strateghi cinesi hanno cercato di trarre il meglio dal mondo così com’è – o come sarà presto.
Mentre la maggior parte dei leader e dei politici occidentali cerca di preservare l’ordine internazionale esistente basato sulle regole, magari aggiornandone le caratteristiche chiave e incorporando altri attori, gli strateghi cinesi definiscono sempre più il loro obiettivo come la sopravvivenza in un mondo senza ordine. La leadership cinese, da Xi in giù, ritiene che l’architettura globale eretta all’indomani della Seconda guerra mondiale stia diventando irrilevante e che i tentativi di preservarla siano inutili. Invece di cercare di salvare il sistema, Pechino si sta preparando al suo fallimento.
Sebbene Cina e Stati Uniti concordino sul fatto che l’ordine post-Guerra Fredda sia finito, scommettono su successori molto diversi. A Washington, si ritiene che il ritorno della competizione tra grandi potenze richieda un rinnovamento delle alleanze e delle istituzioni alla base dell’ordine successivo alla Seconda Guerra Mondiale, che ha aiutato gli Stati Uniti a vincere la Guerra Fredda contro l’Unione Sovietica. Questo ordine globale aggiornato dovrebbe inglobare gran parte del mondo, lasciando la Cina e alcuni dei suoi partner più importanti – tra cui Iran, Corea del Nord e Russia – isolati all’esterno.
Ma Pechino è sicura che gli sforzi di Washington si riveleranno inutili. Agli occhi degli strateghi cinesi, la ricerca di sovranità e identità da parte di altri Paesi è incompatibile con la formazione di blocchi in stile Guerra Fredda e porterà invece a un mondo più frammentato e multipolare in cui la Cina potrà prendere il suo posto come grande potenza.
In definitiva, la visione di Pechino potrebbe essere più accurata di quella di Washington e più vicina alle aspirazioni dei Paesi più popolosi del mondo. La strategia statunitense non funzionerà se si riduce a una futile ricerca di aggiornare un ordine che sta scomparendo, guidata da un desiderio nostalgico di simmetria e stabilità di un’epoca passata. La Cina, al contrario, si sta preparando per un mondo definito dal disordine, dall’asimmetria e dalla frammentazione, un mondo che, per molti versi, è già arrivato.
SOPRAVVISSUTO: PECHINO
Le reazioni molto diverse di Cina e Stati Uniti all’invasione russa dell’Ucraina hanno rivelato la divergenza di pensiero tra Pechino e Washington. A Washington, l’opinione dominante è che le azioni della Russia siano una sfida all’ordine basato sulle regole, che deve essere rafforzato in risposta. A Pechino, l’opinione dominante è che il conflitto dimostra che il mondo sta entrando in un periodo di disordine, che i Paesi dovranno adottare per resistere.
La prospettiva cinese è condivisa da molti Paesi, soprattutto nel Sud globale, dove le pretese occidentali di sostenere un ordine basato sulle regole mancano di credibilità. Non si tratta semplicemente del fatto che molti governi non hanno avuto voce in capitolo nella creazione di queste regole e quindi le considerano illegittime. Il problema è più profondo: questi Paesi ritengono anche che l’Occidente abbia applicato le sue norme in modo selettivo e le abbia riviste spesso per soddisfare i propri interessi o, come hanno fatto gli Stati Uniti quando hanno invaso l’Iraq nel 2003, le abbia semplicemente ignorate. Per molti al di fuori dell’Occidente, il discorso di un ordine basato sulle regole è stato a lungo una foglia di fico per il potere occidentale. È naturale, sostengono questi critici, che ora che il potere occidentale è in declino, questo ordine debba essere rivisto per dare potere ad altri Paesi.
Da qui l’affermazione di Xi secondo cui si stanno verificando “cambiamenti mai visti in un secolo”. Questa osservazione è uno dei principi guida del “Pensiero di Xi Jinping”, che è diventato l’ideologia ufficiale della Cina. Xi vede questi cambiamenti come parte di una tendenza irreversibile verso il multipolarismo, con l’ascesa dell’Oriente e il declino dell’Occidente, accelerati dalla tecnologia e dai cambiamenti demografici. L’intuizione principale di Xi è che il mondo è sempre più definito dal disordine piuttosto che dall’ordine, una situazione che a suo avviso risale al XIX secolo, un’altra epoca caratterizzata da instabilità globale e minacce esistenziali per la Cina. Nei decenni successivi alla sconfitta della Cina da parte delle potenze occidentali nella prima guerra dell’oppio nel 1839, i pensatori cinesi, tra cui il diplomatico Li Hongzhang – talvolta definito “il Bismarck cinese” – scrissero di “grandi cambiamenti mai visti in oltre 3.000 anni”. Questi pensatori hanno osservato con preoccupazione la superiorità tecnologica e geopolitica degli avversari stranieri, che ha inaugurato quello che oggi la Cina considera un secolo di umiliazioni. Oggi Xi vede i ruoli invertiti. È l’Occidente che si trova ora dalla parte sbagliata di cambiamenti fatali e la Cina che ha la possibilità di emergere come potenza forte e stabile.
Anche altre idee che affondano le radici nel XIX secolo hanno conosciuto una rinascita nella Cina contemporanea, tra cui il darwinismo sociale, che ha applicato il concetto di “sopravvivenza del più adatto” di Charles Darwin alle società umane e alle relazioni internazionali. Nel 2021, ad esempio, il Centro di ricerca per una visione olistica della sicurezza nazionale, un organismo sostenuto dal governo e collegato al ministero della Sicurezza cinese, ha pubblicato National Security in the Rise and Fall of Great Powers, curato dall’economista Yuncheng Zhang. Il libro, che fa parte di una serie di spiegazioni sulla nuova legge sulla sicurezza nazionale, sostiene che lo Stato è come un organismo biologico che deve evolversi o morire e che la sfida della Cina è quella di sopravvivere. Questa linea di pensiero ha preso piede. Un accademico cinese mi ha detto che oggi la geopolitica è una “lotta per la sopravvivenza” tra superpotenze fragili e ripiegate su se stesse, ben lontane dalle visioni espansive e trasformative delle superpotenze della Guerra Fredda. Xi ha adottato questo quadro e le dichiarazioni del governo cinese sono piene di riferimenti alla “lotta”, un’idea che si ritrova nella retorica comunista ma anche negli scritti del darwinismo sociale.
Questa nozione di sopravvivenza in un mondo pericoloso richiede lo sviluppo di quello che Xi descrive come “un approccio olistico alla sicurezza nazionale”. A differenza del concetto tradizionale di “sicurezza militare”, che si limitava a contrastare le minacce provenienti da terra, aria, mare e spazio, l’approccio olistico alla sicurezza mira a contrastare tutte le sfide, siano esse tecniche, culturali o biologiche. In un’epoca di sanzioni, disaccoppiamento economico e minacce informatiche, Xi ritiene che tutto possa essere armato. Di conseguenza, la sicurezza non può essere garantita da alleanze o istituzioni multilaterali. I Paesi devono quindi fare tutto il possibile per salvaguardare il proprio popolo. A tal fine, nel 2021, il governo cinese ha sostenuto la creazione di un nuovo centro di ricerca dedicato a questo approccio olistico, incaricato di considerare tutti gli aspetti della strategia di sicurezza della Cina. Sotto Xi, il Partito Comunista Cinese (PCC) è sempre più concepito come uno scudo contro il caos.
VISIONI CONTRASTANTI
I leader cinesi vedono gli Stati Uniti come la principale minaccia alla loro sopravvivenza e hanno sviluppato un’ipotesi per spiegare le azioni dell’avversario. Pechino ritiene che Washington stia rispondendo alla polarizzazione interna e alla sua perdita di potere globale aumentando la competizione con la Cina. I leader statunitensi, secondo questo pensiero, hanno deciso che è solo questione di tempo prima che la Cina diventi più potente degli Stati Uniti, motivo per cui Washington sta cercando di mettere Pechino contro l’intero mondo democratico. Gli intellettuali cinesi parlano quindi di un passaggio degli Stati Uniti dall’impegno e dal contenimento parziale alla “competizione totale”, che abbraccia politica, economia, sicurezza, ideologia e influenza globale.
Gli strateghi cinesi hanno visto gli Stati Uniti cercare di usare la guerra in Ucraina per consolidare la divisione tra democrazie e autocrazie. Washington ha riunito i suoi partner del G-7 e della NATO, ha invitato gli alleati dell’Asia orientale a partecipare alla riunione della NATO a Madrid e ha creato nuovi partenariati di sicurezza, tra cui l’AUKUS, un patto trilaterale tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, e il Quad (Quadrilateral Security Dialogue), che allinea Australia, India e Giappone agli Stati Uniti. Pechino è particolarmente preoccupata che l’impegno di Washington in Ucraina la porti ad essere più assertiva su Taiwan. Uno studioso ha affermato di temere che Washington stia gradualmente scambiando la sua politica di “una sola Cina” – in base alla quale gli Stati Uniti accettano di considerare la Repubblica Popolare Cinese come l’unico governo legale di Taiwan e della terraferma – con un nuovo approccio che un interlocutore cinese ha definito “una Cina e una Taiwan”. Questo nuovo tipo di istituzionalizzazione dei legami tra gli Stati Uniti e i suoi partner, implicitamente o esplicitamente finalizzato al contenimento di Pechino, è visto in Cina come un nuovo tentativo statunitense di costruire un’alleanza che porti i partner atlantici ed europei nell’Indo-Pacifico. Secondo gli analisti cinesi, si tratta dell’ennesimo esempio dell’errata convinzione degli Stati Uniti che il mondo si stia nuovamente dividendo in blocchi.
Con la sola Corea del Nord come alleato formale, la Cina non può vincere una battaglia di alleanze. Ha invece cercato di fare virtù del suo relativo isolamento e di sfruttare la crescente tendenza globale al non allineamento tra le medie potenze e le economie emergenti. Sebbene i governi occidentali siano orgogliosi del fatto che 141 Paesi abbiano appoggiato le risoluzioni delle Nazioni Unite che condannano la guerra in Ucraina, i pensatori cinesi di politica estera, tra cui il professore di relazioni internazionali e commentatore dei media Chu Shulong, sostengono che il numero di Paesi che applicano le sanzioni contro la Russia sia un’indicazione migliore del potere dell’Occidente. Secondo questa metrica, Chu Shulong calcola che il blocco occidentale contiene solo 33 Paesi, mentre 167 Paesi si rifiutano di unirsi al tentativo di isolare la Russia. Molti di questi Stati hanno un brutto ricordo della Guerra Fredda, un periodo in cui la loro sovranità era schiacciata da superpotenze concorrenti. Come mi ha spiegato un importante stratega della politica estera cinese, “gli Stati Uniti non sono in declino, ma sono bravi a parlare solo con i Paesi occidentali. La grande differenza tra oggi e la Guerra Fredda è che [allora] l’Occidente era molto efficace nel mobilitare i Paesi in via di sviluppo contro [l’Unione Sovietica] in Medio Oriente, Nord Africa, Sud-Est asiatico e Africa”.
Per trarre vantaggio dal calo di influenza degli Stati Uniti in queste regioni, la Cina ha cercato di dimostrare il proprio sostegno ai Paesi del Sud globale. A differenza di Washington, che Pechino vede come una prepotente costrizione dei Paesi a scegliere da che parte stare, la Cina si è rivolta ai Paesi in via di sviluppo dando priorità agli investimenti in infrastrutture. Lo ha fatto attraverso iniziative internazionali, alcune delle quali già parzialmente sviluppate. Tra queste, la Belt and Road Initiative e la Global Development Initiative, che investono miliardi di dollari di fondi statali e privati nelle infrastrutture e nello sviluppo di altri Paesi. Altre sono nuove, tra cui l’Iniziativa di sicurezza globale, che Xi ha lanciato nel 2022 per sfidare il dominio degli Stati Uniti. Pechino sta anche lavorando per espandere l’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, un gruppo di sicurezza, difesa ed economia che riunisce i principali attori dell’Eurasia, tra cui India, Pakistan e Russia, e sta per ammettere l’Iran.
BLOCCATI NEL PASSATO?
La Cina è convinta che gli Stati Uniti si stiano sbagliando nel ritenere che sia scoppiata una nuova guerra fredda. Di conseguenza, sta cercando di superare le divisioni in stile Guerra Fredda. Come ha detto Wang Honggang, alto funzionario di un think tank affiliato al Ministero della Sicurezza di Stato cinese, il mondo si sta allontanando da “una struttura centro-periferia per l’economia e la sicurezza globale e sta andando verso un periodo di competizione e cooperazione policentrica”. Wang e gli studiosi che la pensano allo stesso modo non negano che anche la Cina stia cercando di diventare un proprio centro, ma sostengono che, poiché il mondo sta uscendo da un periodo di egemonia occidentale, la creazione di un nuovo centro cinese porterà in realtà a un maggiore pluralismo di idee piuttosto che a un ordine mondiale cinese. Molti pensatori cinesi collegano questa convinzione alla promessa di un futuro di “modernità multipla”. Questo tentativo di creare una teoria alternativa della modernità, in contrasto con la formulazione post-Guerra Fredda della democrazia liberale e dei liberi mercati come epitome dello sviluppo moderno, è al centro dell’Iniziativa per la civiltà globale di Xi. Questo progetto di alto profilo intende segnalare che, a differenza degli Stati Uniti e dei Paesi europei, che danno lezioni agli altri su temi come il cambiamento climatico e i diritti LGBTQ, la Cina rispetta la sovranità e la civiltà delle altre potenze.
Per molti decenni, l’impegno della Cina con il mondo è stato prevalentemente economico. Oggi, la diplomazia cinese va ben oltre le questioni commerciali e di sviluppo. Uno degli esempi più drammatici e istruttivi di questo cambiamento è il ruolo crescente della Cina in Medio Oriente e Nord Africa. In passato questa regione era dominata dagli Stati Uniti, ma mentre Washington ha fatto un passo indietro, Pechino è entrata in scena. A marzo, la Cina ha messo a segno un importante colpo diplomatico mediando una tregua tra Iran e Arabia Saudita. Mentre un tempo il coinvolgimento della Cina nella regione si limitava al suo status di consumatore di idrocarburi e di partner economico, ora Pechino è un pacificatore impegnato a costruire relazioni diplomatiche e persino militari con i principali attori. Alcuni studiosi cinesi considerano il Medio Oriente come “un laboratorio per un mondo post-americano”. In altre parole, ritengono che la regione rappresenti l’aspetto del mondo intero nei prossimi decenni: un luogo in cui, con il declino degli Stati Uniti, altre potenze globali, come Cina, India e Russia, competono per l’influenza e potenze intermedie, come Iran, Arabia Saudita e Turchia, mostrano i muscoli.
Molti in Occidente dubitano della capacità della Cina di raggiungere questo obiettivo, soprattutto perché Pechino ha faticato a conquistare potenziali collaboratori. In Asia orientale, la Corea del Sud si sta avvicinando agli Stati Uniti; nel Sud-est asiatico, le Filippine stanno sviluppando relazioni più strette con Washington per proteggersi da Pechino; e c’è stato un contraccolpo anticinese in molti Paesi africani, dove le lamentele sul comportamento coloniale di Pechino sono numerose. Sebbene alcuni Paesi, tra cui l’Arabia Saudita, vogliano rafforzare i loro legami con la Cina, sono motivati almeno in parte dal desiderio che gli Stati Uniti si impegnino nuovamente nei loro confronti. Ma questi esempi non devono mascherare la tendenza più ampia: Pechino sta diventando sempre più attiva e sempre più ambiziosa.
RUOTE DI SCORTA E SERRATURE
Anche la competizione economica tra Cina e Stati Uniti sta aumentando. Molti pensatori cinesi avevano previsto che l’elezione del presidente americano Joe Biden nel 2020 avrebbe portato a un miglioramento delle relazioni con Pechino, ma sono rimasti delusi: l’amministrazione Biden è stata molto più aggressiva nei confronti della Cina di quanto si aspettassero. Un economista cinese di alto livello ha paragonato la campagna di pressione di Biden contro il settore tecnologico cinese, che comprende sanzioni contro le aziende tecnologiche cinesi e le imprese produttrici di chip, alle azioni del presidente statunitense Donald Trump contro l’Iran. Molti commentatori cinesi hanno sostenuto che il desiderio di Biden di congelare lo sviluppo tecnologico di Pechino per preservare il vantaggio degli Stati Uniti non è diverso dagli sforzi di Trump per fermare lo sviluppo di armi nucleari da parte di Teheran. A Pechino si è formato un consenso sul fatto che l’obiettivo di Washington non sia quello di costringere la Cina a rispettare le regole, ma di impedirle di crescere.
Questo non è corretto: sia Washington che l’Unione Europea hanno chiarito che non intendono escludere la Cina dall’economia globale. Né vogliono disaccoppiare completamente le loro economie da quella cinese. Al contrario, cercano di garantire che le loro imprese non condividano tecnologie sensibili con Pechino e di ridurre la loro dipendenza dalle importazioni cinesi in settori critici, come le telecomunicazioni, le infrastrutture e le materie prime. Per questo motivo, i governi occidentali parlano sempre più spesso di “reshoring” e “friend shoring” della produzione in questi settori o almeno di diversificare le catene di approvvigionamento, incoraggiando le aziende a basare la produzione in Paesi come Bangladesh, India, Malesia e Thailandia.
La risposta di Xi è stata quella che lui chiama “doppia circolazione”. Invece di pensare alla Cina come a un’unica economia legata al mondo attraverso il commercio e gli investimenti, Pechino è stata pioniera nell’idea di un’economia biforcata. Una metà dell’economia, trainata dalla domanda interna, dal capitale e dalle idee, riguarda la “circolazione interna”, che rende la Cina più autosufficiente in termini di consumi, tecnologia e normative. L’altra metà – la “circolazione esterna” – riguarda i contatti selettivi della Cina con il resto del mondo. Contemporaneamente, anche se diminuisce la sua dipendenza dagli altri, Pechino vuole aumentare la dipendenza degli altri attori dalla Cina, in modo da poter usare questi legami per aumentare il suo potere ed esercitare pressione. Queste idee hanno il potenziale per rimodellare l’economia globale.
L’influente economista cinese Yu Yongding ha spiegato la nozione di doppia circolazione con due nuovi concetti: “la ruota di scorta” e “il blocco del corpo”. Secondo il concetto di “ruota di scorta”, la Cina dovrebbe avere alternative pronte nel caso in cui perdesse l’accesso a risorse naturali, componenti e tecnologie critiche. Questa idea è nata in risposta al crescente ricorso alle sanzioni occidentali, che Pechino ha osservato con preoccupazione. Il governo cinese sta lavorando per proteggersi da eventuali tentativi di tagliarla fuori in caso di conflitto, effettuando enormi investimenti in tecnologie critiche, tra cui l’intelligenza artificiale e i semiconduttori. Ma Pechino sta anche cercando di sfruttare la nuova realtà per ridurre la dipendenza dell’economia globale dalla domanda economica occidentale e dal sistema finanziario guidato dagli Stati Uniti. In patria, il PCC sta promuovendo il passaggio da una crescita trainata dalle esportazioni a una crescita guidata dalla domanda interna; altrove, sta promuovendo lo yuan come alternativa al dollaro. Di conseguenza, i russi stanno aumentando le loro riserve di yuan e Mosca non usa più il dollaro per commerciare con la Cina. L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha recentemente deciso di utilizzare le valute nazionali, anziché il dollaro, per gli scambi commerciali tra i suoi Stati membri. Sebbene questi sviluppi siano limitati, i leader cinesi sperano che l’armamento del sistema finanziario statunitense e le massicce sanzioni contro la Russia portino a ulteriori disordini e aumentino la volontà di altri Paesi di coprirsi dal dominio del dollaro.
Il “body lock” è una metafora del wrestling. Significa che Pechino deve rendere le aziende occidentali dipendenti dalla Cina, rendendo così più difficile il disaccoppiamento. Per questo motivo sta lavorando per legare il maggior numero possibile di Paesi ai sistemi, alle norme e agli standard cinesi. In passato, l’Occidente ha lottato per far accettare alla Cina le proprie regole. Ora la Cina è determinata a far sì che gli altri si pieghino alle sue norme e ha investito molto per aumentare la propria voce in vari organismi internazionali di definizione degli standard. Pechino sta inoltre utilizzando le iniziative Global Development e Belt and Road per esportare il suo modello di capitalismo di Stato sovvenzionato e gli standard cinesi in quanti più Paesi possibile. Se un tempo l’obiettivo della Cina era l’integrazione nel mercato globale, il crollo dell’ordine internazionale post-Guerra Fredda e il ritorno del disordine di stampo ottocentesco hanno modificato l’approccio del PCC.
Xi ha quindi investito molto sull’autosufficienza. Ma come sottolineano molti intellettuali cinesi, i cambiamenti nell’atteggiamento cinese verso la globalizzazione sono stati guidati tanto dalle sfide economiche interne quanto dalle tensioni con gli Stati Uniti. In passato, la forza lavoro cinese, ampia, giovane e a basso costo, era il principale motore della crescita del Paese. Ora la popolazione sta invecchiando rapidamente e ha bisogno di un nuovo modello economico, basato sull’aumento dei consumi. Come sottolinea l’economista George Magnus, tuttavia, per farlo è necessario aumentare i salari e perseguire riforme strutturali che sconvolgerebbero il delicato equilibrio di potere della società cinese. Rilanciare la crescita demografica, ad esempio, richiederebbe aggiornamenti sostanziali al sistema di sicurezza sociale del Paese, che è poco sviluppato e che a sua volta dovrebbe essere pagato con un impopolare aumento delle tasse. Promuovere l’innovazione richiederebbe una riduzione del ruolo dello Stato nell’economia, il che è in contrasto con gli istinti di Xi. Tali cambiamenti sono difficili da immaginare nelle circostanze attuali.
UN MONDO DIVISO?
Tra il 1945 e il 1989, la decolonizzazione e la divisione tra le potenze occidentali e il blocco sovietico hanno definito il mondo. Gli imperi si sono dissolti in decine di Stati, spesso come risultato di piccole guerre. Ma sebbene la decolonizzazione abbia trasformato la mappa, la forza più potente è stata la competizione ideologica della Guerra Fredda. Dopo aver conquistato l’indipendenza, la maggior parte dei Paesi si allineò rapidamente al blocco democratico o al blocco comunista. Anche i Paesi che non vollero scegliere da che parte stare definirono comunque la loro identità in riferimento alla Guerra Fredda, formando un “movimento dei non allineati”.
Entrambe le tendenze sono in evidenza oggi e gli Stati Uniti ritengono che la storia si stia ripetendo, in quanto i politici cercano di far rivivere la strategia che ha avuto successo contro l’Unione Sovietica. Pertanto, stanno dividendo il mondo e mobilitando i propri alleati. Pechino non è d’accordo e sta perseguendo politiche adatte alla sua scommessa che il mondo stia entrando in un’era in cui l’autodeterminazione e il multiallineamento avranno la meglio sul conflitto ideologico.
Il giudizio di Pechino è più probabile che sia accurato perché l’epoca attuale differisce da quella della Guerra Fredda per tre aspetti fondamentali. In primo luogo, le ideologie di oggi sono molto più deboli. Dopo il 1945, sia gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica offrivano visioni ottimistiche e convincenti del futuro che facevano presa sulle élite e sui lavoratori di tutto il mondo. La Cina contemporanea non ha un messaggio simile e la tradizionale visione statunitense della democrazia liberale è stata notevolmente ridimensionata dalla guerra in Iraq, dalla crisi finanziaria globale del 2008 e dalla presidenza di Donald Trump, che hanno fatto apparire gli Stati Uniti meno vincenti, meno generosi e meno affidabili. Inoltre, anziché offrire ideologie nettamente diverse e opposte, Cina e Stati Uniti si assomigliano sempre di più su questioni che vanno dalla politica industriale e commerciale alla tecnologia e alla politica estera. Senza messaggi ideologici in grado di creare coalizioni internazionali, non si possono formare blocchi in stile Guerra Fredda.
In secondo luogo, Pechino e Washington non godono dello stesso dominio globale che l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti avevano dopo il 1945. Nel 1950, gli Stati Uniti e i loro principali alleati (Paesi della NATO, Australia e Giappone) e il mondo comunista (Unione Sovietica, Cina e blocco orientale) rappresentavano insieme l’88% del PIL globale. Oggi, invece, questi gruppi di Paesi insieme rappresentano solo il 57% del PIL globale. Mentre le spese per la difesa dei Paesi non allineati erano trascurabili fino agli anni ’60 (circa l’1% del totale globale), oggi sono pari al 15% e in rapida crescita.
In terzo luogo, il mondo di oggi è estremamente interdipendente. All’inizio della Guerra Fredda, i legami economici tra l’Occidente e i Paesi dietro la cortina di ferro erano molto limitati. Oggi la situazione non potrebbe essere più diversa. Mentre negli anni ’70 e ’80 il commercio tra Stati Uniti e Unione Sovietica si attestava intorno all’1% del commercio totale di entrambi i Paesi, oggi il commercio con la Cina rappresenta quasi il 16% della bilancia commerciale totale degli Stati Uniti e dell’UE. Questa interdipendenza impedisce la formazione di un allineamento stabile di blocchi che ha caratterizzato la Guerra Fredda. Ciò che è più probabile è uno stato di tensione permanente e di alleanze mutevoli.
I leader cinesi hanno fatto un’audace scommessa strategica preparandosi a un mondo frammentato. Il PCC ritiene che il mondo si stia muovendo verso un ordine post-occidentale non perché l’Occidente si sia disintegrato, ma perché il consolidamento dell’Occidente ha alienato molti altri Paesi. In questo momento di cambiamento, è possibile che la dichiarata disponibilità della Cina a permettere ad altri Paesi di mostrare i muscoli renda Pechino un partner più attraente di Washington, con le sue richieste di un allineamento sempre più stretto. Se il mondo sta davvero entrando in una fase di disordine, la Cina potrebbe essere nella posizione migliore per prosperare.
MARK LEONARD è direttore dell’European Council on Foreign Relations e autore di What Does China Think? e The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict.
ll sito www.italiaeilmondo.com non fruisce di alcuna forma di finanziamento, nemmeno pubblicitaria. Tutte le spese sono a carico del redattore. Nel caso vogliate offrire un qualsiasi contributo, ecco le coordinate: postepay evolution a nome di Giuseppe Germinario nr 5333171135855704 oppure iban IT30D3608105138261529861559 oppure
| PayPal.Me/italiaeilmondo |
Su PayPal è possibile disporre eventualmente un pagamento a cadenza periodica, anche di minima entità, a partire da 2 (due) euro (pay pal prende una commissione di 0,52 centesimi)

L’ordine dopo l’impero
Le radici dell’instabilità in Medio Oriente
Di Robert D. Kaplan
8 agosto 2023
Visita al Museo storico Panorama 1453 di Istanbul, maggio 2023
Visita al Museo storico Panorama 1453 di Istanbul, maggio 2023
Murad Sezer / Reuters
Salva questo articolo per leggerlo più tardi
Stampa questo articolo
Url della pagina
https://www.foreignaffairs.com/middle-east/order-after-empire
La storia dell’impero comporta una certa confusione. Nella mente di molti è associato al dominio europeo su vaste aree del mondo in via di sviluppo che ha macchiato per sempre la reputazione dell’Occidente. Ma l’impero ha assunto molte forme non occidentali, soprattutto in Medio Oriente. A partire dalla dinastia omayyade nella Damasco del VII secolo, una serie di califfati musulmani ha stabilito un dominio lontano, a volte esteso al Mediterraneo. Nei secoli successivi, furono seguiti dagli Ottomani, che estesero il loro dominio ai Balcani, e dal Sultanato omanita, che nel XIX secolo si estese dal Golfo Persico a parti dell’Iran e del Pakistan, oltre che all’Africa orientale musulmana. Solo nelle fasi successive della storia dell’impero gli europei hanno rappresentato una parte significativa di questa storia.
In tutto il Medio Oriente, questa variegata esperienza dell’impero ha impedito lo sviluppo di Stati-nazione come quelli europei e contribuisce quindi a spiegare la mancanza di stabilità della regione. In effetti, per molti regimi mediorientali, la questione di come garantire un ragionevole grado di ordine con il minimo grado di coercizione non è stata risolta.
Una delle ragioni principali della violenza e dell’instabilità degli ultimi decenni in Medio Oriente, per quanto sconvolgente per la sensibilità contemporanea, è che per la prima volta nella storia moderna la regione non ha alcun tipo di ordine imposto dall’impero. Il fatto che la democrazia non sia riuscita ad attecchire – anche nei Paesi in cui si è dimostrata promettente, come la Tunisia – è indice dell’eredità debilitante del dominio imperiale. L’impero, fornendo una soluzione sgradevole ma duratura all’ordine, ha impedito ad altre soluzioni di prendere piede.
Rimanete informati.
Analisi approfondite con cadenza settimanale.
La realtà, deprimente ma innegabile, è che gli imperi, in una forma o nell’altra, hanno dominato la storia del mondo (e in particolare del Medio Oriente) dall’antichità fino all’era moderna perché offrivano, almeno in termini relativi, i mezzi più pratici e ovvi di organizzazione politica e geografica. Gli imperi possono lasciare il caos nella loro scia, ma sono anche sorti come soluzioni al caos.
FUORI ORDINE
Per secoli, l’età dell’oro dell’Islam in Medio Oriente è stata un’età imperiale. Questa storia si è svolta principalmente sotto i califfati omayyade e abbaside, ma anche sotto quelli fatimide e hafside. L’impero mongolo poteva essere crudele al di là di ogni misura, eppure i mongoli assoggettarono e distrussero principalmente altri imperi: quello abbaside, quello khwarazmiano, quello bulgaro, quello dei Song e così via. L’impero ottomano in Medio Oriente e nei Balcani e l’impero asburgico in Europa centrale hanno fornito protezione agli ebrei e ad altre minoranze in linea con i valori più illuminati della loro epoca. Il genocidio armeno non si è verificato in un periodo in cui l’Impero Ottomano dominava pienamente la regione, ma durante un periodo in cui i nazionalisti Giovani Turchi stavano per soppiantare l’impero. Il nazionalismo monoetnico, più che l’imperialismo multietnico con la sua qualità cosmopolita, è stato più letale nei confronti delle minoranze.
L’Impero Ottomano, che ha governato il Medio Oriente dall’Algeria all’Iraq per 400 anni, è crollato dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1862, il ministro degli Esteri ottomano, Ali Pasha, avvertì profeticamente in una lettera che se gli Ottomani fossero stati costretti a cedere alle “aspirazioni nazionali”, avrebbero “avuto bisogno di un secolo e di torrenti di sangue per stabilire anche uno stato di cose abbastanza stabile”. In effetti, a più di un secolo dalla scomparsa dell’Impero Ottomano, il Medio Oriente non ha ancora trovato un sostituto adeguato all’ordine imposto dall’impero.
Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le autorità imperiali britanniche e francesi hanno governato gli Stati del Levante e della Mezzaluna Fertile, dal Libano all’Iraq. Poi, durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica sono stati imperiali sia in termini di dinamiche di potere che di influenza sui regimi mediorientali. Gli Stati Uniti avevano alleanze di fatto con Israele e con le monarchie arabe del Nord Africa e della penisola arabica; l’Unione Sovietica sosteneva l’Algeria, l’Egitto di Nasser, lo Yemen del Sud e altri Paesi allineati o simpatizzanti della linea comunista di Mosca.
L’Unione Sovietica si è disintegrata nel 1991 e l’influenza e la capacità degli Stati Uniti di proiettare potere nella regione è diminuita costantemente dopo l’invasione dell’Iraq nel 2003. Purtroppo, senza la presenza dell’impero in qualche forma, la regione è entrata gradualmente in un periodo di turbolenza, con il crollo o la destabilizzazione dei regimi: Libia, Siria, Yemen e così via. La primavera araba ha dimostrato non solo un desiderio di democrazia, ma anche il rifiuto di un regime dittatoriale stanco e corrotto. In breve, senza un certo grado di influenza imperiale, il Medio Oriente, e il mondo arabo in particolare, ha spesso manifestato una “tendenza fissile… alla divisione”, come ha scritto l’arabista Tim Mackintosh-Smith.
INFLUENZA NEGATIVA
L’idea che gli imperi abbiano portato un po’ di ordine e stabilità in Medio Oriente è in contrasto con molti studiosi e giornalisti contemporanei. Secondo l’opinione comune, è l’assenza di democrazia, non l’impero, a spiegare l’instabilità della regione. Questa posizione è comprensibile. Con l’esperienza del colonialismo europeo moderno ancora fresca in molti Paesi, gli studiosi e i giornalisti continuano a preoccuparsi dei crimini commessi da britannici, francesi e altre potenze europee in Medio Oriente, Africa e altrove. Poiché viviamo in un’epoca di espiazione e di revisionismo postcoloniale, è naturale che i misfatti delle potenze europee nei secoli passati si facciano sentire. La sfida consiste nell’andare oltre questi misfatti senza minimizzarli.
Questo non significa che le azioni delle potenze europee in Medio Oriente siano state innocenti; al contrario. Le parti meno stabili della regione oggi sono quelle che portano alcune delle impronte più chiare del colonialismo europeo. I confini completamente artificiali del Levante, ad esempio, sono stati costruiti dal Regno Unito e dalla Francia dopo la Prima guerra mondiale. Così, i confini della Siria e dell’Iraq moderni non riflettono la natura di società tradizionali ben funzionanti che hanno operato a lungo senza confini territoriali rigidi. Gli Stati moderni hanno diviso ciò che avrebbe dovuto essere mantenuto integro, mentre gli imperialisti britannici e francesi cercavano di imporre l’ordine su un paesaggio costituito in parte da un terreno desertico senza caratteristiche. Come ha osservato ironicamente Elie Kedourie, intellettuale del XX secolo e specialista dell’area mediorientale, “Che altro possono essere i confini quando sorgono dove prima non ne esistevano?”.
In effetti, gli oppressivi Stati baathisti sorti in Siria e soprattutto in Iraq nella seconda metà del XX secolo sono stati creati dall’impero europeo. Gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq nel 2003 e il risultato è stato il caos; gli Stati Uniti non sono intervenuti in Siria nel 2011 e il risultato è stato anch’esso il caos. Sebbene molti incolpino la politica statunitense per ciò che è accaduto in entrambi i Paesi, un motore altrettanto importante degli eventi è stata l’eredità del Baathismo, un mix letale di nazionalismo arabo e socialismo nello stile del blocco orientale, concepito in parte sotto l’influenza dell’Europa durante l’era fascista degli anni Trenta da due membri della classe media damascena, uno cristiano e l’altro musulmano: Michel Aflaq e Salah al-Din Bitar. Infatti, non fu solo il colonialismo, ma anche le pericolose ideologie europee del primo Novecento a rendere il Medio Oriente la regione meno stabile di tutte.
L’impero, che un tempo aveva stabilizzato il Medio Oriente, lo ha poi indirettamente destabilizzato.
La tragedia del Medio Oriente dopo il crollo dell’Impero Ottomano ha a che fare tanto con l’interazione dinamica dell’Occidente con la regione quanto con il Medio Oriente stesso. Marshall Hodgson, probabilmente il più grande cronista moderno della storia del Medio Oriente, ha scritto che il “radicato malcontento e lo sconvolgimento” del mondo islamico, espressi attraverso l’anticolonialismo, il nazionalismo e l’estremismo religioso, sono in ultima analisi reazioni al suo maggiore contatto con il minaccioso mondo industriale e postindustriale alle sue periferie, di cui l’imperialismo occidentale è stato naturalmente un sottoprodotto.
Naturalmente, l’Europa e gli Stati Uniti non avevano intenzione di creare questa reazione. Ma il dinamismo dell’Occidente nel regno delle idee e della tecnologia ha travolto e modernizzato forzatamente le terre dell’ex Impero Ottomano, amplificando gli effetti negativi dell’imperialismo. Così, il marxismo, il nazismo e il nazionalismo, tutte idee radicate nell’Occidente moderno, hanno influenzato gli intellettuali arabi che vivevano in Medio Oriente e in Europa e hanno fornito il progetto per i regimi che sono culminati nel dominio del maggiore e del minore degli Assad in Siria e di Saddam Hussein in Iraq. Un’autopsia di questi Paesi in frantumi rivelerebbe non solo agenti patogeni locali ma anche occidentali. L’Impero, che un tempo aveva stabilizzato il Medio Oriente, lo ha poi indirettamente destabilizzato.
Consideriamo la Siria. Tra il 1946 e il 1970, il Paese ha vissuto 21 cambi di governo, quasi tutti extralegali, tra cui dieci colpi di Stato militari. Nel novembre 1970, il generale dell’aviazione baathista Hafez al-Assad, membro della setta alawita, un ramo dell’Islam che ha affinità con lo sciismo, prese il controllo con un colpo di Stato calmo e incruento, un “movimento correttivo”, come lo definì. Assad avrebbe governato fino alla sua morte naturale, avvenuta 30 anni dopo. Si è rivelato una delle figure più storiche, anche se sottovalutate, del Medio Oriente moderno, trasformando una repubblica delle banane virtuale – il Paese più instabile del mondo arabo – in uno Stato di polizia relativamente stabile. Ma anche Assad, che ha gestito uno Stato meno sanguinario e meno repressivo di quello di Saddam in Iraq, non è stato in grado di governare a volte senza un’abissale barbarie. In risposta a una violenta rivolta contro il suo governo da parte di estremisti musulmani sunniti, nel 1982 uccise circa 20.000 persone nella città di Hama, dominata dai sunniti, con una repressione tanto efficace quanto brutale. Il prezzo da pagare per evitare l’anarchia è stato molto alto, rendendo il successo dell’anziano Assad nel raggiungere la stabilità in Siria alquanto incerto. Questa è stata l’eredità dell’imperialismo ottomano e francese.
Oppure prendiamo il caso della Libia, che è composta da regioni disparate e manca di qualsiasi coesione storica a parte il suo passato coloniale. La Libia occidentale, nota come Tripolitania, è più cosmopolita e storicamente ha gravitato verso Cartagine e la Tunisia. D’altra parte, la Libia orientale, o Cirenaica, è conservatrice e ha storicamente gravitato verso Alessandria d’Egitto. Le terre desertiche intermedie, compreso il Fezzan a sud, hanno solo identità tribali e subregionali. Sebbene gli Ottomani riconoscessero tutte queste unità separate, all’inizio del XX secolo i colonizzatori italiani le hanno fuse in un unico Stato, che si è rivelato così artificiale che, come nel caso della Siria e dell’Iraq, è stato spesso impossibile da governare se non con i mezzi più estremi. Quando il dittatore Muammar Gheddafi è stato rovesciato nel 2011, esattamente 100 anni dopo la presa di potere italiana, lo Stato si è semplicemente disintegrato. Come per la Siria e l’Iraq, il destino della Libia mostra quanto possano essere letali le conseguenze dell’imperialismo europeo.
ADATTO A UN RE
Per contro, Paesi come l’Egitto e la Tunisia, le cui origini sono precedenti sia al colonialismo europeo sia all’Islam stesso, hanno avuto vita più facile. Quest’ultimo, ad esempio, è sostenuto da una distinta identità pre-islamica sotto i Cartaginesi, i Romani, i Vandali e i Bizantini. I regimi di questi Paesi possono essere sterili e oppressivi, ma l’ordine che impongono non è in discussione. Il problema è come rendere questi sistemi meno prepotenti. Eppure anche la Tunisia ha lottato da quando la sua rivolta popolare ha dato vita alla Primavera araba alla fine del 2010. Il Paese ha continuato coraggiosamente a camminare come una democrazia nella sua capitale e in altre grandi città, anche se il controllo centrale nelle province e nelle zone di confine si è indebolito, fino a quando l’anno scorso è scivolato di nuovo nell’autocrazia sotto il presidente Kais Saied. Ciononostante, la Tunisia rimane l’esempio più promettente di esperimento democratico nella regione. Ciò dimostra quanto sia stato difficile in Medio Oriente copiare il modello politico dell’Occidente per stabilire un ordine non coercitivo. Invece della democrazia, l’autocrazia modernizzatrice – a sua volta derivata dall’imperialismo europeo – ha fornito la risposta più pronta allo spettro dell’anarchia.
I regimi meno oppressivi del Medio Oriente sono stati le monarchie tradizionali di Giordania, Marocco e Oman. Grazie alla loro intrinseca e faticosamente conquistata legittimità storica, sono stati in grado di governare con il minimo grado di crudeltà, pur essendo autoritari. Il laboratorio hobbesiano del Medio Oriente dimostra che, insieme all’impero, la monarchia è stata la forma di governo più naturale. L’Oman, ad esempio, ha funzionato per decenni come una dittatura reale assoluta con politiche un po’ progressiste e modeste libertà individuali. È una prova tra le tante che il mondo non può essere diviso in dittature malvagie e democrazie esemplari, ma piuttosto in molte sfumature grigie intermedie. I corrispondenti esteri generalmente lo capiscono, ma gli intellettuali e i politici di New York e Washington lo capiscono meno.
Ne sono testimonianza l’Arabia Saudita e gli sceiccati del Golfo Persico, in cui esiste un vero e proprio contratto sociale tra governanti e governati. I governanti forniscono una governance competente e prevedibile e transizioni di potere fluide, consentendo una qualità di vita invidiabile; in cambio, le popolazioni non mettono in discussione il loro potere. La ricchezza petrolifera ha avuto molto a che fare con tutto ciò. Ma i governanti del Golfo hanno anche dimostrato un empirismo duro e machiavellico, più amorale che immorale. Ritengono che l’anarchia scatenata dai numerosi tentativi di democrazia durante la Primavera araba sia la prova che l’Occidente non ha lezioni utili da insegnare loro.
DIGNITÀ, NON DEMOCRAZIA
Naturalmente, questa non è ancora tutta la storia. Il Medio Oriente va avanti, anche se non in modo lineare. La tecnologia digitale, compresi i social media, ha appiattito le gerarchie e reso più forti le masse, che di conseguenza chiedono sempre meno soggezione e sempre più conto ai potenti. I dittatori sono ossessionati dall’opinione pubblica in un modo che non hanno mai usato nel Golfo Persico e altrove. Nel frattempo, anche se gli imperi marittimi di portoghesi, olandesi e britannici hanno contribuito a inserire il Medio Oriente in un sistema commerciale mondiale nella prima epoca moderna e in quella contemporanea, l’intensità di questa interazione sta travolgendo la regione con il passare del tempo. Il futuro del Medio Oriente sarà caratterizzato da una fusione ancora maggiore con l’Occidente e con le numerose correnti trasversali della globalizzazione. Questo potrebbe cambiare la politica della regione. Ma proprio perché l’era dell’impero in Medio Oriente è durata così a lungo – da prima della nascita dell’Islam, in effetti – nessuno dovrebbe aspettarsi una rapida fine di questa instabile fase post-imperiale. Dopo tutto, nel mondo della politica non c’è nulla di più perenne della ricerca di un ordine.
Naturalmente, la regione non ha ancora chiuso con l’impero. Gli Stati Uniti, sebbene indeboliti dalla guerra in Iraq, rimangono la forza esterna più dominante in termini di sicurezza e di dispiegamento militare, con basi aeree e marittime che circondano gran parte della penisola araba tra la Grecia a nord-ovest, l’Oman a sud-est e Gibuti a sud-ovest. Nel frattempo, la Belt and Road Initiative cinese prevede una rete di rotte energetiche dal Golfo Persico alla Cina occidentale, ancorata da un porto all’avanguardia sulla punta sud-occidentale del Pakistan. Pechino, con una base militare a Gibuti, prevede altre basi simili a Port Sudan e a Jiwani, al confine tra Iran e Pakistan. Inoltre, il governo cinese ha investito decine di miliardi di dollari in un polo industriale e logistico lungo il Canale di Suez in Egitto e in infrastrutture e altri progetti sia in Arabia Saudita che in Iran.
Gli Stati Uniti e la Cina non hanno colonie o territori sotto mandato. Non governano persone al di fuori dei propri confini. Ma hanno interessi imperiali. E in questo momento storico, tali interessi richiedono stabilità, non guerra, soprattutto perché gli investimenti cinesi stanno integrando sempre più profondamente la Cina nel funzionamento interno delle economie mediorientali. Il recente accordo tra Arabia Saudita e Iran, siglato con la Cina, per ristabilire relazioni bilaterali formali, e la risposta pubblica dell’amministrazione Biden, indicano come l’impero, o piuttosto una sua versione non vincolata, possa ancora contribuire a stabilizzare il Medio Oriente. E con una relativa stabilità, i regimi potrebbero essere incentivati ad allentare un po’ i controlli interni per generare società più imprenditoriali in grado di sopravvivere ai rigori di un’economia globale più connessa e più rigida. Il regime saudita, ad esempio, nonostante il suo record abissale in materia di diritti umani, ha aperto costantemente la sua società allentando le restrizioni sulle donne e integrandole nella forza lavoro. Questo processo è seguito con attenzione in tutto il mondo arabo e potrebbe costituire un modello per regimi più flessibili e per resistere all’Islam politico.
Il giornalista Robert Worth, dopo anni di approfonditi reportage nel mondo arabo per il New York Times, ha scritto che, in definitiva, ciò che gli arabi vogliono non è tanto la democrazia quanto la karama, o dignità: uno Stato, democratico o meno, “che protegga i suoi sudditi dall’umiliazione e dalla disperazione”. L’impero, sia esso ottomano o europeo, forniva stabilità ma poca dignità; l’anarchia non fornisce né l’una né l’altra. Una governance più consultiva, alla maniera delle riforme delle monarchie tradizionali del Marocco e dell’Oman, può tracciare una via di mezzo. È in questa direzione che può risiedere la migliore speranza per la continua evoluzione del Medio Oriente, anche se non seguirà necessariamente un copione occidentale.
ROBERT D. KAPLAN è titolare della cattedra Robert Strausz-Hupé in Geopolitica presso il Foreign Policy Research Institute. È autore del libro di prossima pubblicazione The Loom of Time: Between Empire and Anarchy, From the Mediterranean to China (Random House, 2023), da cui questo saggio è tratto.
https://www.foreignaffairs.com/middle-east/order-after-empire
ll sito www.italiaeilmondo.com non fruisce di alcuna forma di finanziamento, nemmeno pubblicitaria. Tutte le spese sono a carico del redattore. Nel caso vogliate offrire un qualsiasi contributo, ecco le coordinate: postepay evolution a nome di Giuseppe Germinario nr 5333171135855704 oppure iban IT30D3608105138261529861559 oppure
| PayPal.Me/italiaeilmondo |
Su PayPal è possibile disporre eventualmente un pagamento a cadenza periodica, anche di minima entità, a partire da 2 (due) euro (pay pal prende una commissione di 0,52 centesimi)